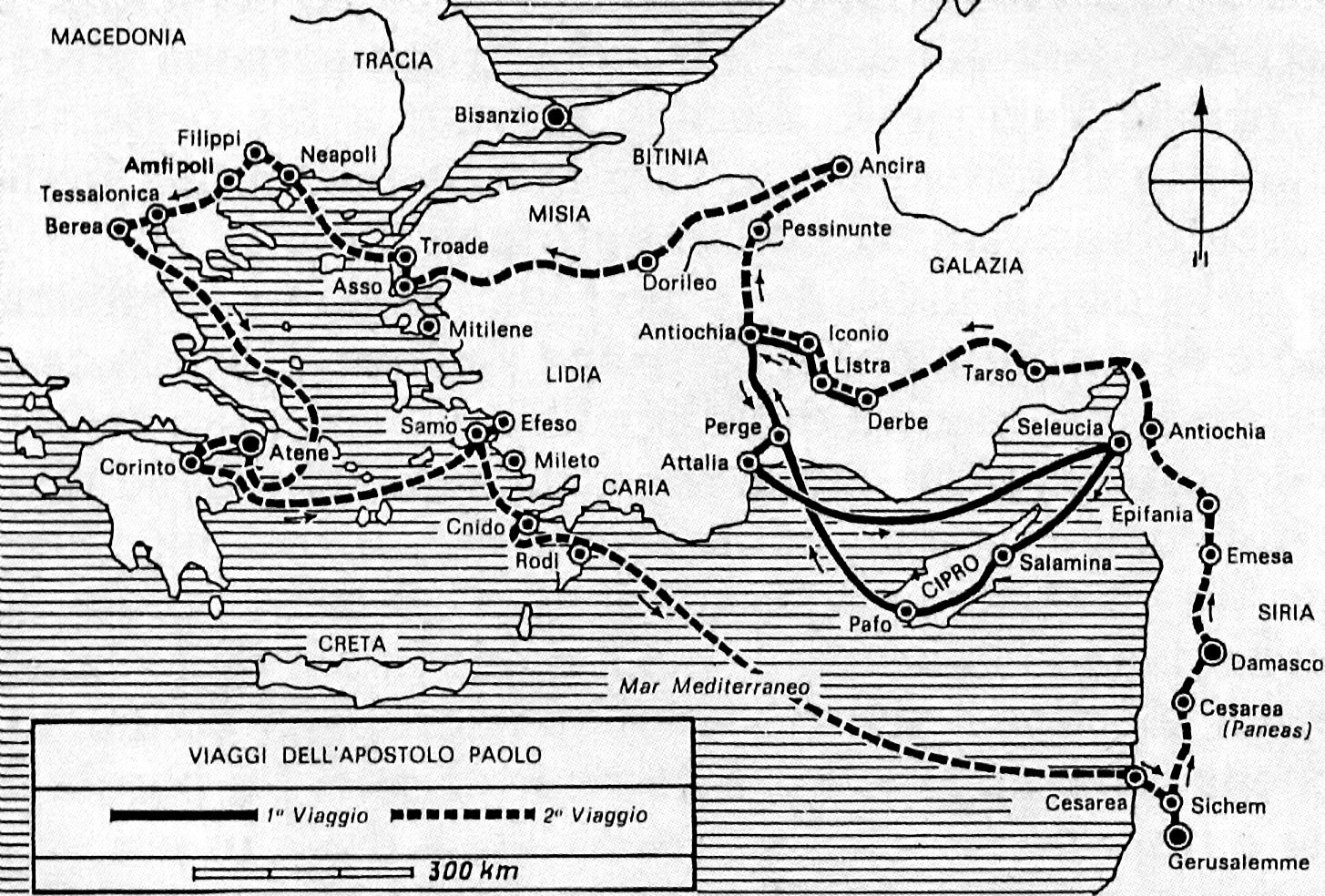
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
Mikos Tarsis
GLI APOSTOLI TRADITORI
GLI SVILUPPI DEL CRISTO IMPOLITICO
Premessa - Capitoli: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Commento di Mac - Giacomo il Minore
Il presente commento agli Atti degli apostoli non ha la pretesa di porsi come una ricerca di tipo storico, in quanto non si sono messe a confronto fonti diverse.
Il commento è semplicemente una riflessione culturale, in cui elementi di teoria politica o di critica dell’ideologia risultano prevalenti. In tal senso si è accuratamente evitato di sbilanciarsi in giudizi sull’attendibilità dei fatti narrati, mettendoli a confronto con versioni discordanti, e ci si è limitati a osservare che, in virtù di determinate interpretazioni critiche, i fatti esaminati avrebbero potuto essersi svolti diversamente e, a volte, si è anche cercato di dimostrarlo astrattamente.
Si è altresì rinunciato consapevolmente a fare riferimenti alle opere storiche di Giuseppe Flavio, anche quando sarebbe stato opportuno, semplicemente perché, ai fini dell’economia del nostro discorso, non sarebbe servito, in quanto alle tesi qui elaborate si può credere solo nella misura in cui si ritiene sufficiente la coerenza interpretativa, non storica ma teorica, che le supporta.
D’altra parte Flavio è stato – come noto – un ebreo traditore degli ebrei, come gli apostoli sono stati cristiani traditori del Cristo, e tutti scrivono sotto il diktat di Roma: dunque per quale ragione si dovrebbe dare più ragione a Flavio che non ai redattori del Nuovo Testamento?
Questo per dire che le fonti storiche, di per sé, non servono affatto per determinare la verità dei fatti, poiché esse stesse sono falsate o falsificate. La storia è maestra di falsità proprio perché scritta da chi detiene il potere, o direttamente o, come appunto nel caso del Nuovo Testamento o delle Antichità giudaiche di Flavio, indirettamente. Parteggiare per una fonte piuttosto che per un’altra ha un senso molto relativo.
Se, in virtù di concezioni ateistiche, avessimo dovuto dar ragione alle fonti pagane, che ignorano quasi del tutto l’esistenza del Cristo, avremmo sicuramente fatto un errore colossale. Su Cicerone sappiamo tutto, eppure oggi chi avrebbe il coraggio di sostenere che contro Caligola aveva torto? E forse si è mai visto un libro che abbia parteggiato per Bruto e Cassio contro Cesare?
Di fronte al Nuovo Testamento ci si deve in sostanza rassegnare e ragionare per così dire e concessis, come faceva Kierkegaard col caso Adler. Cioè non avendo strumenti o fonti differenti da usare per dimostrare determinate tesi, si deve in ultima istanza dare per scontato che la versione dei fatti del Nuovo Testamento sia quella più verosimile, pur sapendo che ad essa è sottesa una precisa ideologia, che tende a mistificare la realtà dei fatti, ovvero il contenuto che dà a questi fatti un qualche significato.
Questo commento, se si vuole, parte dal presupposto che aveva l’inglese Samuel Brandon1, secondo cui il Nuovo Testamento è nel complesso una menzogna, poiché i cristiani volevano dimostrare ai romani che gli unici colpevoli della crocifissione del Cristo erano stati gli ebrei. Se vogliamo usare un'espressione molto sintetica, potremmo dire che il senso del Nuovo Testamento si pone a un duplice livello. Anzitutto come mistificazione dell'operato politico-eversivo del Cristo (cui cercherà di porre rimedio, inutilmente, la posizione dei fratelli Zebedeo). In secondo luogo come compromesso tra il fariseismo eretico di Paolo da un lato, ch'era volto a eliminare definitivamente l'idea di un primato storico, etico, teologico-politico di Israele nei confronti del paganesimo e, dall'altro, la linea giudaico-ortodossa inaugurata dai parenti giudei del Cristo, per i quali certamente il Cristo era risorto (come voleva il galileo Pietro), ma non per sconvolgere i princìpi fondamentali del giudaismo. Tale compromesso salterà per aria dopo il 70, rendendo vincenti le tesi paoline.
L’obiettivo principale del commento è dunque quello di cercare di scoprire, usando le stesse fonti cristiane, dove sia possibile rinvenire, negli Atti degli apostoli, le tracce del tradimento del messaggio originario del Cristo, cioè le tracce della mistificazione, le quali sono state frutto di un lungo e complesso lavoro redazionale, in cui mani abilissime hanno saputo mescolare, in maniera molto efficace, episodi veridici con altri del tutto inventati, al punto che un lettore ingenuo finisce col considerare tutto o quasi tutto vero, come è appunto successo negli ultimi duemila anni di esegesi confessionale (quella critica possiamo farla risalire, come origine, ad alcuni esponenti della Sinistra hegeliana).
Gli ebrei non sono stati come i greci, che s’inventavano favole in cui bisognava fingere di credere. Gli ebrei, ovvero i cristiani, hanno inventato storie la cui verosimiglianza diventava, in virtù della fede, oro colato. Essi hanno saputo prendere le cose dalla realtà, salvo un particolare, la cui importanza era però in grado di falsificare tutto il resto.
Trovare il bandolo della matassa è un’impresa disperata, e noi non possiamo fare altro che lavorare – come direbbe Althusser – su dei fantasmi, cioè sul «non detto», mistificato da un «detto» coerente, non banale, sulla base peraltro di un’ideologia che non parla mai da sola, in maniera esplicita, ben individuabile, ma sempre per mezzo di parole e fatti che alla resa dei conti, cioè alla luce di un’analisi razionale, laico-umanistica, risultano incredibilmente ambigui, non tanto perché inverosimili, quanto perché volutamente manipolati.
Sotto questo aspetto la letteratura ebraico-cristiana resta superiore a qualunque altra letteratura.
torna suCap. 1
[1]Nel
mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto
quello che Gesù fece e insegnò dal principio
[2]fino
al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era
scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo.
[3]Egli si
mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di
Dio.
[4]Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la
promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da
me:
[5]Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete
battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni».
[6]Così
venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è
questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?».
[7]Ma
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti
che il Padre ha riservato alla sua scelta,
[8]ma avrete forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e
fino agli estremi confini della terra».
[9]Detto questo, fu
elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo.
[10]E poiché essi stavano fissando il cielo mentre
egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti si
presentarono a loro e dissero:
[11]«Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è
stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
[12]Allora
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un
sabato.
[13]Entrati in città salirono al piano superiore
dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea,
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo
Zelòta e Giuda di Giacomo.
[14]Tutti questi erano assidui e
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la
madre di Gesù e con i fratelli di lui.
[15]In quei giorni
Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il numero delle persone
radunate era circa centoventi) e disse:
[16]«Fratelli, era
necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu
predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda,
che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù.
[17]Egli
era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro
ministero.
[18]Giuda comprò un pezzo di terra con i
proventi del suo delitto e poi precipitando in avanti si squarciò
in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere.
[19]La cosa è
divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che
quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Akeldamà,
cioè Campo di sangue.
[20]Infatti sta scritto nel libro dei
Salmi:
La sua
dimora diventi deserta, e nessuno vi abiti,
e:
il
suo incarico lo prenda un altro.
[21]Bisogna
dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in
cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a
noi,
[22]incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in
cui è stato di tra noi assunto in cielo, uno divenga, insieme
a noi, testimone della sua risurrezione».
[23]Ne furono
proposti due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto,
e Mattia.
[24]Allora essi pregarono dicendo: «Tu, Signore,
che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai
designato
[25]a prendere il posto in questo ministero e apostolato
che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui
scelto».
[26]Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte
cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
*
Si ritiene che l’autore degli Atti degli Apostoli, scritti non prima del 135, sia Luca, poiché questi esordisce facendo un riferimento al suo vangelo: in realtà il testo è stato scritto da più redattori, esattamente come i vangeli, con la differenza che mentre i vangeli, rispetto al messaggio originario del Cristo, rappresentano una sorta di compromesso e sono quindi carichi di molte ambiguità e contraddizioni, gli Atti invece sono chiaramente un testo orientato verso la difesa della predicazione di Paolo di Tarso, e quindi costituiscono la legittimazione definitiva dello snaturamento spiritualistico operato ai danni del messaggio del Cristo.2
Nei vv. 1-8 viene elaborato il mito dell’ascensione, conseguente a quello della resurrezione, che è presente in tutti i vangeli come aggiunta spuria alla scoperta della tomba vuota. Col mito revisionista della resurrezione gli apostoli propagandarono l’immediato ritorno trionfale del Cristo, per la ricostituzione del regno davidico in funzione antiromana. Col mito dell’ascensione posticipano questo ritorno a un futuro imprecisato, rinunciando definitivamente al regno politico-nazionale di stampo davidico: di qui l’equiparazione etica e politica di ebrei e pagani, che verrà continuamente rimessa in discussione negli Atti dagli elementi più filo-ebraici tra i primi cristiani.
Dopo la morte di Gesù i discepoli temevano di restare a Gerusalemme. Probabilmente erano ritornati in Galilea, come vuole il finale evangelico di Marco. Ad un certo punto (e qui è difficile dire «quando», anche se certamente non prima del 70), calmatasi l’ostilità ebraico-romana nei loro confronti, e visto che Gesù «non ritornava», gli apostoli devono esser rientrati a Gerusalemme per prendere un’importante decisione circa il futuro del loro movimento, che rischiava di disgregarsi: in gran segreto infatti elaborarono il mito spiritualista e quindi politicamente conservatore dell’ascensione, proprio per rispondere a quanti chiedevano l’ora del ritorno del Cristo (mito in cui evidentemente non tutti credevano).
Il secondo aspetto da sottolineare in questo racconto è che mentre il mito della resurrezione viene collegato al Gesù scomparso, l’ascensione invece la si vuole collegare alla comparsa del suo sostituto: lo Spirito, un concetto, questo, del tutto astratto e tipicamente ellenistico (la Galilea era senz’altro più soggetta della Giudea a influenze del genere). Cioè a un riferimento concreto, seppur distorto da interpretazioni falsificanti, si sostituisce una rappresentazione simbolica, idealistica, facilmente manipolabile, com'è già ben visibile nel quarto vangelo. È dunque plausibile che il concetto di «assunzione» sia un’interpolazione redazionale, successiva al definitivo crollo della nazione israelitica, in quanto Pietro conclude il suo discorso a Gerusalemme ribadendo l’importanza che il sostituto di Giuda sia «testimone della resurrezione di Cristo», cioè sia disposto a credere in questa falsificazione della realtà (nessun apostolo, infatti, aveva mai visto il Cristo redivivo). Tale testimone doveva essere stato anche un discepolo della prima ora, cioè doveva aver conosciuto il Cristo «incominciando dal battesimo di Giovanni» (gli esegeti han creduto di ravvisare in queste parole una conferma del battesimo del Cristo ad opera di Giovanni; in realtà l’affermazione sta semplicemente ad indicare una concomitanza spazio-temporale tra la missione del Cristo e quella di Giovanni). Pietro non parlò mai né di «ascensione» né di «Pentecoste».
Il testo in oggetto vuole mostrare che fra i Dodici, al momento di prendere questa storica decisione per il futuro del movimento, era presente la consapevolezza della loro collegialità, cioè il fatto che nessuno di loro avrebbe potuto sostituire Gesù e continuarne il messaggio senza il consenso degli altri. Con la morte di Gesù muore anche il suo messaggio e inizia il messaggio degli apostoli (resurrezione, ascensione, spirito santo, figlio di dio ecc.), per quanto il concetto di «Dodici» venga qui usato come un artificio letterario a sfondo ecclesiologico. Nella realtà i Dodici non esistevano più già al momento della formulazione delle due tesi petrine relative alla «morte necessaria» del Cristo e alla sua «resurrezione». Quando si inizia a parlare di «ascensione» e di «Pentecoste», gli apostoli erano già morti da tempo.
L’elenco del v. 14 viene dato in ordine d’importanza onorifica non politica: Pietro, Giovanni ecc. Sarà la Chiesa romana a stravolgere questi e altri passi rivendicando per Pietro e quindi per la propria sede un primato privo di fondamenta storiche e ideologiche. Tra i discepoli c’erano anche la madre di Gesù (il padre evidentemente era già morto o scomparso) e i fratelli di lui (il termine può includere anche le sorelle) di sangue, che facevano comunque parte del movimento nazareno3. Pietro viene presentato al v. 15 come il più autorevole (al mito della resurrezione egli certamente aveva non poco contribuito) e Luca, enfaticamente, fa notare che al suo cospetto i discepoli erano tutti «assidui e concordi» (v. 14), quando in realtà sappiamo che Giovanni Zebedeo gli fu particolarmente ostile, in quanto non condivideva l’idea di usare il concetto di «resurrezione» per attendere passivamente il ritorno glorioso di Cristo.
Il terzo aspetto da sottolineare è la rinuncia a ricostituire il regno davidico e la decisione di propagandare il messaggio di Gesù (riveduto e corretto) in tutto l’impero romano, a tutti i pagani. Quindi finisce il primato della politica e della nazione d’Israele: il regno da realizzare non è più terreno ma celeste, non è temporale ma solo spirituale, non è nazionale ma universale, non c'è più liberazione dalle contraddizioni sociali e dall'oppressione straniero ma solo redenzione dal peccato originale.
Poiché questi aspetti matureranno piuttosto lentamente o comunque si svilupperanno pienamente solo a partire dalla predicazione di Paolo, non sarebbe azzardato sostenere che tutto il racconto dell’ascensione in realtà non va considerato come una premessa del racconto degli Atti, bensì come un epilogo che l’autore ha voluto usare come prologo. Questo vale anche per il racconto della Pentecoste. Essi non solo non hanno alcun fondamento storico, non solo hanno un chiaro intento apologetico, ma le riflessioni teologiche che li hanno prodotti risalgono probabilmente a un tempo di molto posteriore a quello ch’essi lasciano supporre. Non sarebbe azzardato sostenere che i miti dell'«ascensione» e della «Pentecoste» siano stati formulati non dopo la tragedia del 70, ma addirittura dopo l'ultima sconfitta militare del giudaismo contro Roma.
Ma la parte più significativa di questo capitolo è il discorso di Pietro, che dell’ascensione rappresenta per così dire la giustificazione teorica.
Pietro esordisce paragonando, con una certa forzatura, Giuda ad Achitofel (2 Sam 17,23), e lo fa perché in realtà vuole paragonare Gesù a Davide, mostrando che Gesù gli era superiore (Achitofel il Ghilonita tradisce Davide e s’impicca perché tradito a sua volta da Assalonne, che aveva tramato contro Davide). Andava tuttavia spiegata una differenza sostanziale: Davide non morì in seguito al tradimento, Gesù sì. Tra i due non può esistere una continuità di tipo politico. Di qui la duplice esigenza, da parte di Pietro, di presentare agli occhi dei discepoli un traditore mille volte peggiore di Achitofel (At 1,18) e, nel contempo, di presentare un Cristo mille volte più importante del re Davide, proprio perché il tradimento di Giuda era stato per così dire previsto dall'economia salvifica di Dio-padre (At 1,16).
Nel racconto di Pietro infatti, Giuda muore come un «criminale comune» preso dai rimorsi (ha venduto il messia per denaro), non muore come un «idealista politico» vittima di una propria strategia fallimentare; stranamente non si parla neppure di suicidio, ma di una caduta accidentale: «precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere» (v. 18); il che però ha il sapore di un’esecuzione sommaria.
Pietro ha bisogno di dire queste cose perché vuole ricollegare gli avvenimenti tragici della morte di Cristo con la storia d’Israele, al fine di sostenere che tutto era già stato predetto. Pietro considera il tradimento «necessario», in quanto appunto prefigurato nel rapporto tra Davide e il suo fidato consigliere. L’uso strumentale (apologetico) delle citazioni veterotestamentarie, spesso riportate anche in maniera errata, sarà una costante della fase revisionista della primitiva comunità cristiana.
Il sillogismo politico di Pietro è infatti molto semplice e di presa efficace sui discepoli: se il tradimento di Giuda era stato preannunciato (dalle profezie o da fatti analoghi accaduti in precedenza), allora la morte di Gesù è stata necessaria. E se è stata necessaria, Giuda va sostituito, proprio per continuare inalterato il messaggio di Gesù.
In realtà che questo messaggio non venga proseguito così com’era stato detto, è dimostrato dal fatto che Pietro vuole che Giuda venga sostituito da una persona che abbia accettato sia il mito della resurrezione che quello dell’ascensione (v. 22). Da notare che Pietro non propone alcuna persona, né tanto meno impone la propria volontà: la proposta dei nomi viene fatta dalla comunità e si usa la prassi del sorteggio. Questo a testimonianza non solo dello spirito collegiale tra i Dodici e i discepoli, ma anche della tendenza revisionista già abbondantemente condivisa tra quei cristiani.
Il ragionamento deterministico di Pietro era conseguente al fatto ch’egli non riteneva opportuno proseguire sulla strada della rivoluzione politica antiromana intrapresa dal Cristo. Infatti, se avesse accettato il tradimento di Giuda e la morte di Gesù come mera possibilità virtuale (e non come necessità soteriologica), avrebbe certamente posto all’ordine del giorno il problema della sostituzione non di Giuda ma dello stesso Cristo.
Accettando invece e del tradimento e della morte la necessità metafisica o comunque l’ineluttabilità teologica (dovuta alle fonti bibliche, ispirate da Dio), Pietro era costretto a trasformare Gesù in un superuomo insostituibile e a fare dei Dodici una mimesi delle vecchie tribù d’Israele. Sicché proprio mentre egli sosteneva di voler continuare il messaggio del Cristo, in realtà lo tradiva, e in maniera non meno dolorosa di quanto aveva già fatto Giuda.
torna suCap. 2
[1]Mentre
il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo.
[2]Venne all’improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta
la casa dove si trovavano.
[3]Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro;
[4]ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
[5]Si
trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che
è sotto il cielo.
[6]Venuto quel fragore, la folla si
radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva
parlare la propria lingua.
[7]Erano stupefatti e fuori di sé
per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse
tutti Galilei?
[8]E com’è che li sentiamo ciascuno
parlare la nostra lingua nativa?
[9]Siamo Parti, Medi, Elamìti
e abitanti della Mesopotàmia, della Giudea, della Cappadòcia,
del Ponto e dell’Asia,
[10]della Frigia e della Panfilia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène,
stranieri di Roma,
[11]Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e
li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di
Dio».
[12]Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un
l’altro: «Che significa questo?».
[13]Altri
invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di
mosto».
[14]Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri
Undici, parlò a voce alta così: «Uomini di
Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto
questo e fate attenzione alle mie parole:
[15]Questi uomini non
sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del
mattino.
[16]Accade invece quello che predisse il profeta
Gioèle:
[17]Negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io effonderò
il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie
profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani
faranno dei sogni.
[18]E
anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò
il mio Spirito ed essi profeteranno.
[19]Farò
prodigi in
alto nel
cielo e segni
in basso sulla
terra, sangue,
fuoco e nuvole di fumo.
[20]Il
sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che
giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido.
[21]Allora
chiunque invocherà il nome del Signore sarà
salvato.
[22]Uomini
d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret
– uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,
prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera
sua, come voi ben sapete –,
[23]dopo che, secondo il
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi
l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete
ucciso.
[24]Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce
della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in
suo potere.
[25]Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo
sempre il Signore innanzi a me; poiché egli sta alla mia
destra, perché io non vacilli.
[26]Per
questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia
lingua; ed anche la mia carne riposerà nella
speranza,
[27]perché
tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi, né
permetterai che il tuo Santo veda la corruzione.
[28]Mi
hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la
tua presenza.
[29]Fratelli,
mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che
egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra
noi.
[30]Poiché però era profeta e sapeva che Dio
gli aveva giurato
solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente,
[31]previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne vide
corruzione.
[32]Questo
Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo
testimoni.
[33]Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver
ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha
effuso, come voi stessi potete vedere e udire.
[34]Davide infatti
non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore
al mio Signore: siedi alla mia destra,
[35]finché
io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi.
[36]Sappia
dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete
crocifisso!».
[37]All’udir tutto questo si sentirono
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che
cosa dobbiamo fare, fratelli?».
[38]E Pietro disse:
«Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo
riceverete il dono dello Spirito Santo.
[39]Per voi infatti è
la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli
che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio
nostro».
[40]Con molte altre parole li scongiurava e li
esortava: «Salvatevi da questa generazione
perversa».
[41]Allora coloro che accolsero la sua parola
furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila
persone.
[42]Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane
e nelle preghiere.
[43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e
segni avvenivano per opera degli apostoli.
[44]Tutti coloro che
erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in
comune;
[45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
[46]Ogni
giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a
casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di
cuore,
[47]lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il
popolo.
[48]Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati.
*
La Pentecoste è una descrizione simbolica di un fatto reale: la decisione che ad un certo punto prese la primitiva comunità cristiana di continuare il messaggio di Gesù in forme e modi non originari.
Nel racconto appare evidente che la storica decisione venne presa dall’intero collegio apostolico, benché i 28 capitoli degli Atti parlino delle vicende di pochissimi apostoli e soprattutto di quelle che un discepolo diretto del Cristo non fu mai stato: Paolo di Tarso.
Che la decisione la si voglia qui far apparire come presa unanimemente dal consiglio è testimoniato simbolicamente dal fatto che le «lingue di fuoco» scendono contemporaneamente sui Dodici, determinando conseguenze analoghe (glossolalia). Quanto però fosse davvero «unanime» è difficile dirlo (il vangelo di Giovanni parla p.es. di un Tommaso scettico). In ogni caso il cosiddetto «primato di Pietro», sostenuto dalla Chiesa romana, non trova qui alcun riscontro. Pietro anzi dovette rinunciare categoricamente a diventare capo degli apostoli il giorno stesso in cui si rese conto che il messaggio originario di Cristo non poteva essere continuato, ovvero che poteva esserlo in altre forme e modi solo sulla base di una decisione collegiale.
Anche in Atti 9,32 s. la coppia Pietro-Giovanni presto si divide e della predicazione di Giovanni non si saprà più nulla. Si ha come l’impressione che Pietro abbia usurpato quello che doveva essere, secondo il lascito testamentario del Cristo in croce (Gv 19,25), il diritto di successione di Giovanni alla guida del movimento nazareno: cosa che l’autore degli Atti ha del tutto trascurato, facendo in modo di mascherare il più possibile tale usurpazione, su cui però Giovanni torna nella chiusa del suo vangelo (21,18 s.).
La Pentecoste insomma è l’espressione di un tradimento ben orchestrato: gli apostoli trasformano l’esperienza messianica del Cristo, politica per definizione, in un’esperienza mistica o spiritualistica, in virtù della quale la liberazione d’Israele dai romani diventa niente di più che una semplice redenzione personale dal peccato d’aver ucciso o d’aver lasciato uccidere il messia.
Conseguenza di ciò è che gli apostoli (qui per bocca di Pietro) iniziano a predicare l’uguaglianza universalistica non degli oppressi ma di tutti gli uomini (inizialmente di tutti i giudei): è il cosmopolitismo cristiano, qui preannunciato da Pietro, ma che in realtà verrà messo in atto da Paolo, a testimonianza che anche questo racconto, come quello del capitolo precedente, di storico ha ben poco.
In effetti, se anche volessimo dare per scontato che Pietro abbia pronunciato tale discorso nei termini riportati da Luca, è da escludere che il cosmopolitismo riguardasse anche il mondo pagano: questa infatti sarà un’acquisizione del paolinismo, che il petrinismo si troverà ad accettare obtorto collo. In quel momento significava semplicemente l’uguaglianza di tutti «i giudei osservanti di ogni nazione» (v. 5).
Il revisionismo c’era, ma non in maniera così plateale come avverrà in Paolo. Lo scopo del discorso di Pietro era quello di trasformare l’esigenza di una liberazione politica della nazione d’Israele dal dominio romano nell’esigenza di affermare un’uguaglianza etico-morale di tutti i giudei sparsi nell’impero romano, resasi necessaria anche a motivo del fatto che tra gli ebrei della diaspora e i giudei della madrepatria (e l’episodio di Stefano lo dimostrerà) non correva buon sangue. I capi giudei, in particolare, venivano accusati da un lato di essere ideologicamente troppo chiusi e rivolti al passato e politicamente di assumere atteggiamenti troppo acquiescenti nei confronti dei romani.
Pietro però ribalta i termini della questione: se i giudei della madrepatria si pentono d’aver ucciso il Cristo e se tutti i giudei accettano l’idea della resurrezione, si possono impostare su basi nuove i rapporti tra Giudea e Diaspora, cioè si può allargare il raggio d’azione del messianismo di Gesù, rivestito, beninteso, di un involucro idealistico.
Il discorso di Pietro, a ben guardare, è tutto volto a giustificare il tradimento degli apostoli, di cui lui fu l’artefice principale. Egli si rende conto che i tempi permangono drammatici (parla di «ultimi giorni», (v. 17), ma ne conclude (pensando anche di dare una spiegazione al mistero della tomba vuota) che agli uomini non resta che attendere «il giorno del Signore» (v. 20), cioè il ritorno sulla terra del Salvatore.
Pietro mostra in due modi d’essere convinto del ritorno glorioso e imminente del Cristo redivivo: dicendo, da un lato, che era stato ucciso «secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio» (v. 23) e dicendo, dall’altro, che era «risorto» perché «non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere» (v. 24). Quanto egli fosse personalmente convinto di queste cose è difficile dirlo. Pietro sicuramente avvertiva forte l’esigenza politica di tenere unito il movimento nazareno, e se in quel momento l’unico modo per dimostrarlo era quello di raccontare cose del tutto fantasiose, che con l’esigenza di una politica rivoluzionaria c’entravano ben poco, ciò non deve stupirci, poiché qui si ha a che fare con una popolazione tradizionalmente molto religiosa, oltre che politicamente agguerrita.
Semmai è il fine ultimo del suo discorso che deve lasciarci perplessi. Egli infatti, ritenendo la morte del messia come necessaria alla manifestazione gloriosa del suo imminente ritorno (la parusia), finiva con l’interpretare la tomba vuota come un invito alla rassegnazione e alla passività politica.
Sarà proprio da questa falsa interpretazione della scomparsa del Cristo che nascerà l’esigenza di riallacciare i rapporti con le autorità giudaiche costituite, offrendo a queste la possibilità di credere nella messianicità del Cristo risorto (v. 36), in cambio della rinuncia cristiana a lottare politicamente per l’abbattimento del compromesso tra potere giudaico e potere romano, in forza del quale il Cristo fu giustiziato.
Le autorità ovviamente avrebbero dovuto accettare la decisiva differenza tra Davide e Cristo (v. 29 ss.). Il Cristo è più grande di Davide esclusivamente perché è «risorto» e la resurrezione ha valore in quanto rende inutile la lotta politica. In questo senso però ci si può chiedere se l’esigenza di diffondere il concetto di uguaglianza universalistica di tutti gli ebrei «sparsi nel mondo» (e in seguito di tutti gli uomini), sia contestuale o posteriore all’idea che la cosiddetta «resurrezione» di Cristo avrebbe dovuto ricostituire, ipso facto, il regno davidico.
La rinuncia all’impegno politico rivoluzionario è ben attestata anche dal fatto che Pietro, in maniera regressiva, ripropone il battesimo di Giovanni «riveduto e corretto», cioè amministrato «nel nome di Gesù Cristo» per ricevere «il dono dello Spirito Santo» (v. 38). Pietro chiama alla penitenza per la morte del messia tutti coloro che non fecero niente per salvarlo dall’esecuzione capitale, ma anche coloro che ne avrebbero voluto attendere il ritorno senza far nulla per meritarselo.
È singolare tuttavia che, mentre per il Battista il battesimo doveva servire unicamente come occasione simbolica per predisporsi moralmente alla venuta di un regno di liberazione dai romani, per l’apostolo Pietro lo stesso battesimo serve per rinunciare all’idea di dover lottare politicamente per ottenere questo stesso regno. Pietro recupera il valore di una cosa che il Cristo aveva già superato.
Si può quindi sostenere, in sintesi, che mentre col concetto di «resurrezione» si predicava il ritorno imminente del Cristo glorioso, per la restaurazione del regno davidico, col concetto di «ascensione» si posticipa questo ritorno a un futuro imprecisato, e col concetto di «Pentecoste» si afferma che il suo ritorno si realizza subito in maniera mistica, attraverso lo Spirito Santo che effonde le sue virtù morali sui battezzati. È quindi difficile pensare che i concetti di «ascensione» e «Pentecoste» siano potuti appartenere alla predicazione petrina; è più facile pensare che siano un prodotto dei discepoli della predicazione paolina.
*
In questo capitolo vi è anche la descrizione delle caratteristiche fondamentali della primitiva comunità cristiana: 1. insegnamento apostolico, 2. fratellanza e condivisione materiale dei beni posseduti, 3. non più attività politica ma simbolica o religiosa: eucarestia e preghiere (v. 42). Il tutto infarcito da «senso del timore» e culto degli apostoli (v. 43).
La comunità materiale era elementare ma efficace, almeno nei limiti che la costituivano: «chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (v. 45). Da sottolineare che in Luca l’assenza di proprietà privata, ovvero la gestione collettiva dei beni appare come condizione irrinunciabile della stessa comunione spirituale. Gli aspetti sono inscindibili: lo si comprende laddove egli parla di «unione fraterna» e di «comunione», senza specificare alcunché.
Quando nella Chiesa cristiana avranno fatto il loro ingresso i ceti medi e medio-alti della società, il realismo e la concretezza della comunità primitiva cominceranno ad essere progressivamente trascurati (l’episodio di Anania e Saffira può essere letto come il tentativo di arginare un fenomeno del genere). A partire da quel momento la prassi comunionale non terrà più conto degli aspetti materiali dell’esistenza, ma si limiterà a sviluppare tutta una teologia moralistica del dovere per i ricchi e della pazienza per i poveri, che ancora oggi permane inalterata negli ambienti ecclesiastici di potere. Per i bisogni straordinari ci si appellerà alle diverse offerte ed elemosine, più o meno volontarie (vedi l’uso delle decine, delle collette ecc.).
La comunione materiale resta primitiva soprattutto perché non prevede la collettivizzazione dei principali mezzi produttivi (la terra, gli strumenti del lavoro...), né la socializzazione del lavoro e della vita commerciale e artigianale. Al massimo si prevede la fondazione di casse comuni per l’affronto di bisogni particolari di piccola e media entità.
La comunità poteva reggersi in piedi solo se gli aderenti già lavoravano in proprio o presso terzi, o comunque se la maggioranza disponeva di un minimo di capitali. È da escludere quindi che al suo interno fossero presenti vasti strati del proletariato nullatenente (schiavi, coloni, contadini liberi fortemente indebitati...).
Una distribuzione democratica del denaro («secondo il bisogno»), in assenza di socializzazione dei mezzi produttivi, altro non poteva significare che elargizione temporanea e limitata di una determinata quota dei fondi a disposizione. A questa comunità mancava completamente un progetto rivoluzionario sulla società: essa era soltanto un mezzo per difendersi dagli eccessi della società schiavistica e dagli abusi finanziari dello Stato romano. Parte del proletariato (la plebe) vi poteva accedere, ma senza sperare, di regola, in una vera emancipazione sociale né quindi in un vero protagonismo politico. È vero che qui ancora non siamo in presenza dello sfruttamento del «contadino cristiano» da parte dell'«imprenditore cristiano», ma il passo sarà breve.
Di sicuro una comunità del genere, che peraltro continuava a «frequentare il tempio» di Gerusalemme, pur facendo le agàpi o le eucarestie nelle case private (v. 46), non costituiva una minaccia per l’ordine pubblico. Essa «godeva le simpatie di tutto il popolo» (v. 47), anche se le istituzione romane ci metteranno tre secoli prima di capire che i cristiani non solo erano diversi dagli ebrei, ma erano anche migliori dei pagani.
torna suCap. 3
[1]Un
giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le
tre del pomeriggio.
[2]Qui di solito veniva portato un uomo,
storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta
del tempio detta «Bella» a chiedere l’elemosina a
coloro che entravano nel tempio.
[3]Questi, vedendo Pietro e
Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro
l’elemosina.
[4]Allora Pietro fissò lo sguardo su di
lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi».
[5]Ed
egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche
cosa.
[6]Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né
argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, cammina!».
[7]E, presolo per la mano
destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si
rinvigorirono
[8]e balzato in piedi camminava; ed entrò con
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.
[9]Tutto il
popolo lo vide camminare e lodare Dio
[10]e riconoscevano che era
quello che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del
tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era
accaduto.
[11]Mentr’egli si teneva accanto a Pietro e
Giovanni, tutto il popolo fuor di sé per lo stupore accorse
verso di loro al portico detto di Salomone.
[12]Vedendo ciò,
Pietro disse al popolo: «Uomini d’Israele, perché
vi meravigliate di questo e continuate a fissarci come se per nostro
potere e nostra pietà avessimo fatto camminare
quest’uomo?
[13]Il
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha
glorificato il suo servo Gesù,
che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli
aveva deciso di liberarlo;
[14]voi invece avete rinnegato il Santo
e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino
[15]e
avete ucciso l’autore della vita. Ma Dio l’ha risuscitato
dai morti e di questo noi siamo testimoni.
[16]Proprio per la fede
riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo
che voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest’uomo
la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi.
[17]Ora,
fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, così come i
vostri capi;
[18]Dio però ha adempiuto così ciò
che aveva annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il
suo Cristo sarebbe morto.
[19]Pentitevi dunque e cambiate vita,
perché siano cancellati i vostri peccati
[20]e così
possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed
egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè
Gesù.
[21]Egli dev’esser accolto in cielo fino ai
tempi della restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin
dall’antichità, per bocca dei suoi santi
profeti.
[22]Mosè infatti disse:
Il Signore vostro
Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri
fratelli; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà.
[23]E
chiunque non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di
mezzo al popolo.
[24]Tutti
i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito,
annunziarono questi giorni.
[25]Voi siete i figli dei profeti e
dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando
disse ad Abramo:
Nella tua
discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra.
[26]Dio,
dopo aver risuscitato il suo servo, l’ha mandato prima di tutto
a voi per portarvi la benedizione e perché ciascuno si
converta dalle sue iniquità».
*
Questo racconto viene messo, a livello redazionale, subito dopo quello che descrive la vita e l’organizzazione della primitiva comunità cristiana semplicemente per dimostrare che quest’ultima non si poneva nel contesto sociale dominato dallo schiavismo e dall’oppressione romana come una sorta di isola felice, immune dalle stridenti contraddizioni dell’epoca. Luca vuole anzi evidenziare come la comunità si considerasse al servizio di tutta la collettività, senza distinzioni di classe o di ceto, avendo come unico obiettivo quello di soddisfare dei bisogni sociali.
Il bisogno in questione è quello di uno «storpio fin dalla nascita» (v. 2), che chiedeva la carità ogni giorno «presso la porta del tempio detta Bella» (ib.): cosa che fece anche nei confronti di Pietro e Giovanni. I due apostoli si fermano e Pietro chiede allo storpio di «guardarli in faccia», come se Luca volesse mostrare che l’uomo era talmente abituato a ricevere pochissimo che le sue suppliche erano ormai solo un segno di disperazione. Probabilmente stupìto, lui si volse, aspettandosi in questo caso «di ricevere qualche cosa» (v. 5). Pietro però rinuncia a fargli la carità e anzi dichiara, non senza ostentazione, di non avere «né argento né oro» (v. 6) – come se lo storpio se li aspettasse! – ma di potergli elargire un bene molto più prezioso: la salute.
Il testo vuol mettere in evidenza una certa superiorità politica della comunità cristiana nei confronti di quella giudaica, la quale, ritenendo inadatto il questuante a una sequela, si sarebbe limitata esclusivamente all’elemosina. Pietro invece ha la pretesa di compiere un «miracolo», mostrando che il cristianesimo sa andare persino oltre le tradizionali questioni di stampo politico, la prima delle quali restava ovviamente quella della liberazione nazionale d’Israele. Il racconto infatti vuole porsi in maniera apologetica nei confronti della rinuncia alla lotta di liberazione, ovvero nei confronti della speranza di un regno solo «nei cieli».
La presenza del miracolo sublima l’assenza di un regno terreno impossibile, sicché la guarigione non viene data (come nei vangeli) per indurre fiducia in un regno terreno di giustizia e libertà prossimo venturo, ma proprio per rinunciarvi. Non è propositiva ma regressiva: questo prescindendo dal fatto che negli stessi vangeli le guarigioni e i prodigi in genere spesso venivano usati, in maniera redazionale, per mascherare situazioni politiche che avrebbero potuto risultare scomode al lettore romano, che andava invece rassicurato sulla natura del tutto pacifica di un movimento dal passato eversivo come quello cristiano (o nazareno).
La frase di Pietro è quanto mai illuminante in proposito: «non possiedo né argento né oro», cioè «non sono in grado di garantirti il benessere del regno che il messia aveva promesso di realizzare», «ma quello che ho te lo do», ed è il surrogato individuale alla mancata realizzazione di un regno per tutti.
La comunità cristiana, avendo consapevolezza delle esigenze forti di liberazione, non può dare l’elemosina, in quanto questa non risolverebbe il problema della povertà; può dare però l’illusione di credere che in nome di una giustizia ultraterrena la povertà non sia sulla terra un problema reale. Il miracolo della guarigione sarebbe la prova che l’illusione ha un fondamento.
Sotto questo aspetto è persino irrilevante sapere se la guarigione debba intendersi nel senso «fisico» della parola o non piuttosto in quello «psicologico-morale», come «salvezza interiore». Quando non sarà più necessario credere nei miracoli, in quanto la fede cristiana nella giustizia meramente ultraterrena avrà conquistato masse di seguaci, e si rinuncerà definitivamente, con Paolo, all’esigenza di un regno terreno di liberazione, l’elemosina tornerà ad essere l’unico modo di affrontare il problema della povertà.
Nel racconto il guarito è pago di sé, entra nel tempio insieme agli apostoli e mostra una fede quasi scontata, senza avere quella sensibilità, così tipica nei vangeli, che mette in relazione la guarigione con l’attesa del regno. Mentre nei vangeli le guarigioni si ponevano solo come «segni» di qualcos'altro, possibilmente da realizzazione hic et nunc; ora invece l'apostolo Pietro compie un miracolo per dimostrare la verità della resurrezione: infatti «nel nome di Gesù Cristo il Nazareno» lo compie; una pretesa che non ha nulla a che vedere con un'istanza politica di liberazione, ma esclusivamente con un messaggio di natura «teologica».
Fino al cap. 2 Pietro è convinto che la verità della resurrezione avrebbe dovuto essere dimostrata dallo stesso Cristo, col suo ritorno trionfale e imminente sulla terra. Ora invece egli sembra aver rinunciato alla possibilità, in tempi brevi, di questa dimostrazione, e siccome tra i fedeli serpeggia sempre più forte lo scetticismo, la guarigione miracolosa viene in soccorso alle incapacità di una debole leadership cristiana. Il miracolato infatti è totalmente privo di quella attesa messianica così caratteristica nei vangeli. È Pietro che deve convincerlo che il Nazareno è (ancora) il messia, seppure in forme e modi del tutto diversi: infatti è risorto e va pregato «nel tempio, lodando Dio» (v. 8). Pietro viene qui raffigurato in maniera caricaturale.
Mentre nei vangeli le guarigioni venivano concesse in via del tutto straordinaria, al fine di dare speranza a chi tra le fasce sociali più deboli manifestava maggiore rassegnazione o disperazione (anche se non è da escludere che questa prassi sia stata una mistificazione del vangelo di Marco, il prototipo di tutti gli altri), qui invece il miracolo viene usato come strumento per credere nella mistificazione operata dai capi della Chiesa cristiana nei confronti del messaggio di Cristo.
*
Nel suo secondo discorso Pietro, dovendo ancora affrontare la questione della possibilità di ripristinare l’antico regno davidico, ha bisogno di usare con maggiore prodigalità i suoi sofismi religiosi. «I tempi della consolazione», cioè del regno davidico, giungeranno soltanto dopo che gli ebrei avranno accettato di credere nella resurrezione di Cristo, di cui il miracolo del questuante rappresenta una sorta di caparra. Il Cristo tarda a venire non perché tragicamente scomparso, ma semplicemente perché gli uomini non credono nella sconfitta della morte e quindi nel fatto ch’egli opera ancora per mezzo degli apostoli.
Questo modo un po’ goffo di procedere, in quanto l’incredulità religiosa viene usata come pretesto per rinunciare alla speranza politica, rende indirettamente Pietro latore di una inaspettata smentita circa la presunta autenticità dei racconti di apparizione descritti nei vangeli. Come noto, infatti (se diamo per scontato che i vangeli siano stati scritti prima degli Atti), il Cristo redivivo era apparso a decine se non centinaia di persone nelle ultime pericopi di Giovanni 21, Matteo 28 e Luca 24: qui invece Pietro lascia indirettamente intendere che nessuno l’aveva più rivisto e che si era necessariamente dovuti ricorrere a un miracolo di guarigione per indurre di nuovo a credere in una sua prossima venuta (altri miracoli in At 9,32 ss.).
Pietro anzi è addirittura esplicito nel sostenere che mentre il pentimento dei carnefici del Cristo è conditio sine qua non per poter sperare nel ritorno del Cristo, la funzione antiromana di tale pentimento e quindi di tale parusia resta una prerogativa del solo messia. In tal senso il v. 21 è collaterale ai vv. 19-20 e serve come aggancio biblico strumentale nei riguardi degli scritti antico-testamentari.
Cosa intende Pietro per «restaurazione di tutte le cose»? Sostanzialmente tre cose: 1. che Gesù ritornerà solo quando lo riterrà opportuno (quindi non fa più testo l’esigenza oggettiva di liberazione nazionale); 2. che fino ad allora gli uomini dovranno credere nella sua resurrezione; 3. che se Gesù, che era messia, è morto e risorto, allora il suo messaggio non riguardava affatto il compito di realizzare il regno davidico, ma piuttosto quello di come ottenere la conversione di tutti gli uomini. Pietro, con questo discorso (vv. 25-26), mostra d’aver intuito, ovviamente a modo suo, la portata universalistica del messaggio del Cristo, cioè il fatto che con la conversione degli ebrei al cristianesimo potevano aprirsi porte ben più grandi di quelle del tempio di Gerusalemme.
Singolare tuttavia è il fatto, in questo capitolo, che mentre da un lato gli apostoli dimostrano d’esser capaci di compiere prodigiose guarigioni e di farle per un fine di bene, esattamente come il loro maestro, dall’altro mettono subito le mani avanti per dichiarare la loro indisponibilità a sostituire un leader politico come Gesù.
Invero la singolarità è alquanto relativa. Pietro infatti dà di Gesù l’immagine di un uomo esemplare, impolitico per eccellenza: il «santo», il «giusto», l’«autore della vita», il «servo Gesù». Lo stesso carnefice, il procuratore Pilato, non è più la personificazione dell’odiato impero romano, non è più l’«empio» di 2,23, ma anzi «colui che aveva deciso di liberarlo» (v. 13), proprio in quanto aveva capito, forse prima ancora degli stessi discepoli, che il Cristo era un uomo pacifico, un messia filosofo e moralista.
Politico rivoluzionario, anzi terrorista, era invece Barabba: costui sì giustamente incarcerato in quanto «assassino» (v. 14). Pietro in sostanza fa passare i giudei per autori di un orrendo delitto: avrebbero preferito un omicida senza scrupoli a un giusto timorato di Dio. Di lì a poco, cioè appena Paolo comincerà a predicare un’esplicita discendenza divina del Cristo, scatterà, a carico dei giudei, l’accusa gravissima d’essere un popolo «deicida».
Gli Atti degli Apostoli sono ormai lontanissimi dalla consapevolezza dei reali termini del processo politico contro Gesù, i quali in definitiva si riducevano a due: 1. il popolo scelse Barabba perché sembrava offrire maggiori garanzie di opposizione antiromana; 2. i capi preferirono lasciar condannare Cristo perché avevano capito che Barabba costituiva per i loro interessi di potere un pericolo minore.
A questo punto ci si può chiedere se risalga allo stesso Pietro la tesi della strumentalizzazione di Pilato da parte dei capi giudei (così evidente nei sinottici), o se il suddetto v. 13 non sia stato aggiunto in un secondo momento al suo discorso.
torna suCap. 4
[1]Stavano
ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il
capitano del tempio e i sadducei,
[2]irritati per il fatto che
essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la
risurrezione dai morti.
[3]Li arrestarono e li portarono in
prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera.
[4]Molti
però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero e
il numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila.
[5]Il giorno
dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli
scribi,
[6]il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e
quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti.
[7]Fattili
comparire davanti a loro, li interrogavano: «Con quale potere o
in nome di chi avete fatto questo?».
[8]Allora Pietro, pieno
di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e
anziani,
[9]visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la
salute,
[10]la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi
avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta
innanzi sano e salvo.
[11]Questo Gesù è la
pietra che, scartata da
voi, costruttori,
è diventata testata d’angolo.
[12]In
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro
nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che
possiamo essere salvati».
[13]Vedendo la franchezza di
Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e
popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano
stati con Gesù;
[14]quando poi videro in piedi vicino a
loro l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa
rispondere.
[15]Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a
consultarsi fra loro dicendo:
[16]«Che dobbiamo fare a
questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto per opera loro;
esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo.
[17]Ma perché la cosa
non si divulghi di più tra il popolo, diffidiamoli dal parlare
più ad alcuno in nome di lui».
[18]E, richiamatili,
ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare
nel nome di Gesù.
[19]Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se
sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui,
giudicatelo voi stessi;
[20]noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato».
[21]Quelli allora, dopo averli
ulteriormente minacciati, non trovando motivi per punirli, li
rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano
Dio per l’accaduto.
[22]L’uomo infatti sul quale era
avvenuto il miracolo della guarigione aveva più di
quarant’anni.
[23]Appena rimessi in libertà, andarono
dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto i sommi sacerdoti
e gli anziani.
[24]All’udire ciò, tutti insieme
levarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore, tu che hai
creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in
essi,
[25]tu
che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre,
il tuo servo Davide: Perché
si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane?
[26]Si
sollevarono i re della terra e i principi si radunarono insieme,
contro il Signore e contro il suo Cristo;
[27]davvero
in questa città si
radunarono insieme
contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo,
Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli d’Israele,
[28]per
compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano
preordinato che avvenisse.
[29]Ed ora, Signore, volgi lo sguardo
alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta
franchezza la tua parola.
[30]Stendi la mano perché si
compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo
Gesù».
[31]Quand’ebbero terminato la preghiera,
il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di
Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.
[32]La
moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che
gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.
[33]Con grande
forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di grande
simpatia.
[34]Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché
quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo
di ciò che era stato venduto
[35]e lo deponevano ai piedi
degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il
bisogno.
[36]Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli
Barnaba, che significa «figlio dell’esortazione»,
un levita originario di Cipro,
[37]che era padrone di un campo, lo
vendette e ne consegnò l’importo deponendolo ai piedi
degli apostoli.
*
Il fatto che Luca, ad un certo punto (qui nei vv. 32-35), abbia avvertito l’esigenza di sottolineare che la differenza maggiore tra comunità cristiana e comunità giudaica stava nello stile di vita e non tanto delle pratiche terapiche di questo o quell’apostolo, è indicativo della presenza di convertiti non disposti ad accettare descrizioni mitologiche della realtà.
Naturalmente gli autori degli Atti e se vogliamo di buona parte del Nuovo Testamento, guardando retrospettivamente la nascita del cristianesimo, non hanno potuto esimersi dal raffigurarla con scene se vogliamo «classiche» di guarigioni miracolose e prodigi di varia natura. Inutile meravigliarsi di questi abusi quando li ritroviamo, anche più inverosimili, nelle epopee di popoli a noi molto prossimi, come i romani e i greci.
Chiunque d’altra parte sarebbe in grado di capire che se il racconto narrato da Luca in merito alla guarigione dello storpio può aspirare a una qualche parvenza di storicità, è forse possibile concedergliela unicamente là dove si constata un passaggio di tipo esistenziale dalla disperazione di una vita marginale e sofferente alla speranza, anzi alla fede nella proposta evangelica degli apostoli, in contrasto con l’indifferenza giudaica, sempre che non si sia trattato di un caso da includere negli annali della psicopatologia.
La stranezza di questo presunto «miracolo» non sta tanto nel fatto che al cospetto della diffusione della sua notizia reagirono prontamente le autorità costituite, quanto soprattutto che queste lo fecero al gran completo. Luca infatti non si rende conto che parlando di sommi sacerdoti, sadducei, anziani e scribi e persino del capitano del tempio (un ufficiale di polizia reclutato tra i leviti), in una parola di tutti i rappresentanti del potere istituzionale giudaico, non fa un favore ma un torto alla credibilità di questa guarigione.
Qui è evidente che Luca vuol presentare Pietro come un imitatore perfetto del Cristo dei vangeli (il che, si badi e vogliamo continuamente ribadirlo, non sta affatto a significare che il Cristo storico fosse necessariamente un taumaturgo) e, per questa ragione, Pietro non poteva avere che nemici da combattere, soprattutto tra i giudei, eterni rivali dei galilei.
Noi ovviamente non possiamo escludere che le autorità giudaiche, temendo di perdere il loro ascendente sulle masse, da tempo vistosamente in calo, cercassero d’impedire con ogni mezzo che gli apostoli predicassero apertamente cose eterodosse o non esattamente in linea con quelle ufficiali. Ma è assai dubbio ch’esse abbiano iniziato a comportarsi così in seguito a eventi prodigiosi. Proprio l’ostentata importanza concessa alla guarigione dello storpio sta ad indicare che la controversia tra le due comunità non verteva più su cose sostanziali come ai tempi del Cristo.
Peraltro nel testo si ha a che fare con un paradosso di non poco conto: le autorità giudaiche, ch’erano filo-romane, temono la propaganda di un’idea politicamente regressiva, quella della resurrezione di Cristo dai morti, in virtù della quale nessuna rivoluzione sarebbe mai stata possibile. Cioè le autorità collaborazioniste si trovavano nella posizione di dover difendere, agli occhi del popolo, l’esigenza di una liberazione nazionale dal dominio di Roma, contro dei cristiani che rivendicavano posizioni culturali o etico-religiose più progressiste, meno etnocentriche, pur in un contesto di relativa indifferenza nei confronti delle sorti politiche del loro paese. I cristiani non stavano accettando l’idea di resurrezione come forma di ricompensa ultraterrena per aver lottato o per il fatto di dover lottare contro le ingiustizie terrene: al contrario, quell’idea serviva proprio come giustificazione teorica al disimpegno politico.
Il potere giudaico non stava a disquisire sull’idea di resurrezione, che non poteva non essere opinabile, e neppure si sentiva giudicato per aver mandato a morire un rivoluzionario ritenuto impostore: ciò che non poteva tollerare era l’equivalenza di Cristo e Messia, la cui progressiva diffusione avrebbe necessariamente comportato un risentimento popolare, in quanto assai difficilmente si sarebbe potuto accettare che il Cristo crocifisso (ancorché «risorto», secondo i cristiani) fosse il Messia tanto atteso, né, ancor meno, che questa tesi venisse sostenuta dal potere costituito, già alquanto compromesso coll’invasore pagano.
Peraltro Luca fa notare che Pietro non si limitava semplicemente ad affermare la resurrezione di Cristo, come «logica» conseguenza della scoperta della tomba vuota, ma addirittura «la resurrezione dei morti in Cristo» (v. 2), dando così per esclusa qualunque imminente parusia e invitando le masse a credere come inutile qualunque rivendicazione politico-nazionale. Lo storpio risanato, in tal senso, sarebbe stato nient’altro che una prefigurazione della beatitudine ultraterrena. È impossibile che Pietro, all'inizio del suo tradimento del vangelo di Gesù, abbia potuto parlare in questi termini. Pietro aveva bisogno di apparire credibile, e quando parlava di «resurrezione» intendeva imminente la parusia trionfale del Cristo.
Qualcuno potrà obiettare che una predicazione del genere sarebbe caduta come manna dal cielo per un potere corrotto come quello giudaico. Il fatto è che a livello di società, cioè negli strati più consapevoli della popolazione era ancora molto sentita l’esigenza di liberarsi del dominio romano. Persino i vangeli, che sono testi volti a spoliticizzare al massimo l’opera del Nazareno, furono costretti a ricordare l’attività dei battisti e degli esseni o qumranici prima di loro, l’origine zelota di alcuni apostoli, l’ala progressista dei farisei, la querelle sull’identità del messia, ecc.
Lo scambio di battute tra le autorità e Pietro è tutto preso dai racconti evangelici di guarigione, specie da quelli in cui il Cristo con le sue azioni viola il sabato. Il sospetto delle autorità si pone a un duplice livello: sulla persona e sull’intenzione, nel senso che più la persona è autorevole e più si sospetta ch’essa voglia approfittare del bene compiuto per rivendicare un potere personale, destabilizzante per quello costituito. Come condizione per poter accettare il benevolo intervento di Pietro, le autorità chiedono di sapere quale ne sia il vero fine politico. A loro non interessa tanto l’azione socio-umanitaria o l’idea etico-religiosa che l’ha mossa, quanto il fine recondito, eminentemente politico, che si vuol porre sul tavolo delle trattative. Per questo anzitutto la domanda è, testuale e perentoria: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?» (v. 7).
Nei vangeli tutto ciò è prassi consueta. Non si teme o non si fa mostra di temere l’in sé della guarigione o della personale conversione, ma il fatto di esibire pubblicamente delle azioni che potrebbero minare il già precario consenso popolare alle istituzioni di governo. Sono molte le pagine dei vangeli in cui gli scribi lasciano intendere di non temere tanto le guarigioni, quanto la loro contestualità nel sabato, giorno di riposo assoluto.
In questo capitolo degli Atti è probabile che il redattore voglia farci capire che nel momento stesso in cui gli apostoli ricominciarono a predicare, le autorità sinedrite si posero il problema di come comportarsi, perché se da un lato appariva chiaro che la predicazione apostolica non era la stessa del Cristo, in quanto i contenuti originari erano stati edulcorati, dall’altro essa costituiva comunque una sorta di eresia rispetto al giudaismo ufficiale.
È sintomatico che nel contesto della diatriba la dottrina della resurrezione in Cristo infastidisca sì le autorità, ma non fino al punto di decidere un processo a carico degli apostoli. Luca dice che si limitarono a minacciarli, o meglio, dopo un giorno di carcere preventivo e un’udienza interlocutoria «li rilasciarono a causa del popolo» (v. 21), non trovando motivi per punirli. Luca naturalmente l’ha scritto per evidenziare la correttezza della posizione apostolica, ma così facendo non s’è accorto di fare un torto alla predicazione di Gesù, la cui presunta «correttezza» non venne mai considerata «sufficiente» dalla maggioranza del Sinedrio.
La stranezza del racconto sta nel fatto che gli apostoli (nella fattispecie Pietro e Giovanni) riescono a ottenere con molta facilità un notevole consenso popolare, come mai a Cristo era riuscito nella capitale (se si esclude l’ingresso nella festa delle palme), tanto che i capi religiosi sono costretti a rilasciarli, mentre nei confronti del Cristo pendeva continuamente un mandato di cattura.
In realtà si tratta di una finzione di Luca, strettamente connessa all’altra finzione, quella per cui essi facevano «guarigioni, miracoli e prodigi» (v. 30). La comunità cristiana non aveva altro per rispondere alle attese messianiche delle folle giudaiche. Le quali ora, diversamente che ai tempi del Cristo, acconsentono a rinunciare all’idea di liberazione nazionale, ovvero a trasformare questa esigenza in una richiesta di personale redenzione morale e di organizzazione pseudo-comunistica delle proprietà.
Sotto questo aspetto appare un po’ patetica la contraddizione tra il redattore che al v. 2 afferma che Pietro e Giovanni furono arrestati perché predicavano pubblicamente, senza autorizzazione, l’idea della resurrezione dei morti in Cristo, e lo stesso Pietro che al v. 9 sostiene che il fermo era stato causato dalla guarigione dello storpio.
Luca può aver ragione, ma la Chiesa deve dimostrare concretamente (e qui forse si può pensare a un successivo intervento redazionale) che gli apostoli erano nel giusto al cospetto di chi chiedeva loro una liberazione politico-nazionale, e che la guarigione era servita allo scopo: lo storpio poteva credere nella tesi della resurrezione del Cristo (e quindi anche nella propria resurrezione) appunto perché era stato guarito da chi la predicava.
Insomma Pietro si serve esplicitamente e pubblicamente dell’idea di resurrezione per annunciare una salvezza che di politico non ha più nulla, se non gli aspetti più regressivi. Al v. 12 è evidente ch’egli intende per «salvezza» non quella politica dai romani e dal potere giudaico collaborazionista, ma quella meramente morale (e fisica, se vogliamo accettare la miticità di questo racconto) del singolo. Gli altri versetti gli fanno da cornice: nel 9 si distingue tra «beneficio fisico» e «salute psichica»; al 10 viene usata l’espressione «sano e salvo» riferendosi alla salute psico-somatica.
La salvezza è in sostanza diventata la liberazione dal peccato (p.es. la disperazione dello storpio sulla propria condizione), cui la Chiesa primitiva ha dovuto aggiungere, mitologicamente, onde far fronte alle richieste d’impegno politico rivoluzionario da parte dei ceti più oppressi, la miracolosa guarigione fisica. Allo storpio povero e disperato la Chiesa cristiana diede fiducia ed egli si convertì. Quando il numero dei benestanti cristiani supererà quello degli oppressi cristiani, non ci sarà più bisogno d’inventare questi accorgimenti didattici o psicopedagogici.
Ovviamente il pezzo forte di questo racconto non sta in tutto questo, ma nella descrizione del comunismo del cristianesimo primitivo, in quanto ai ceti oppressi, nella fase iniziale di questa esperienza, non si poteva unicamente proporre la conversione dal peccato (lo faceva anche il Battista, ma in previsione della liberazione nazionale): occorreva piuttosto una strategia di organizzazione sociale alternativa a quella dominante.
I versetti 32, 34 e 35 rappresentano il vertice dell’utopismo sociale degli Atti e in fondo di tutto il Nuovo Testamento. Luca afferma che la vera diversità fra giudei e cristiani stava nella cosiddetta «comunione dei beni», cioè nell’assenza di proprietà privata. Tuttavia, egli lascia intendere che detta comunione poteva realizzarsi solo con il denaro, non con l’uso comune di terre e altri mezzi produttivi. I poveri non si trovavano «padroni» della terra, ma solo beneficiari di una cassa comune organizzata e gestita dai ricchi della comunità. Quindi era una sorta di comunismo meramente distributivo.
I soldi venivano distribuiti, dice Luca, secondo il bisogno di ciascuno: il vero bisogno, quello di possedere i mezzi produttivi, quello di avere un lavoro indipendente, quello di superare il regime schiavistico, padronale, di sfruttamento dei lavoratori, era un bisogno destinato a rimanere tale, poiché la comunità cristiana si poneva il compito non tanto di come ribaltare il sistema, quanto semplicemente di come riuscire a sopravviverci conciliando aspetti etici di dignità ed economici di sicurezza.
L’assenza della proprietà privata all’interno della comunità fu probabilmente un aspetto di breve durata, che caratterizzò i più diretti seguaci del Cristo e forse fino a quando la comunità rimase piccola e con bisogni limitati. La regola generale che ben presto s’impose fu quella che la comunità cristiana aveva bisogno dei ceti benestanti per realizzare l’assistenza dei poveri. E anche se il numero di cinquemila di cui parla Luca al v. 4 ricorda troppo da vicino quello del racconto evangelico dei pani moltiplicati, si può tranquillamente pensare che in presenza di un numero del genere le pretese di comunismo avanzate da Luca rientravano in quella che si può definire «una pia intenzione».
torna suCap. 5
[1]Un uomo di
nome Ananìa con la moglie Saffìra vendette un suo
podere
[2]e, tenuta per sé una parte dell’importo
d’accordo con la moglie, consegnò l’altra parte
deponendola ai piedi degli apostoli.
[3]Ma Pietro gli disse:
«Ananìa, perché mai satana si è così
impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti
sei trattenuto parte del prezzo del terreno?
[4]Prima di venderlo,
non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non
era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo
a quest’azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a
Dio».
[5]All’udire queste parole, Ananìa cadde
a terra e spirò. E un timore grande prese tutti quelli che
ascoltavano.
[6]Si alzarono allora i più giovani e,
avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo
seppellirono.
[7]Avvenne poi che, circa tre ore più tardi,
entrò anche sua moglie, ignara dell’accaduto.
[8]Pietro
le chiese: «Dimmi: avete venduto il campo a tal prezzo?».
Ed essa: «Sì, a tanto».
[9]Allora Pietro le
disse: «Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito
del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno
seppellito tuo marito e porteranno via anche te».
[10]D’improvviso
cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono,
la trovarono morta e, portatala fuori, la seppellirono accanto a suo
marito.
[11]E un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in
quanti venivano a sapere queste cose.
[12]Molti miracoli e prodigi
avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti
stare insieme nel portico di Salomone;
[13]degli altri, nessuno
osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.
[14]Intanto
andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano
nel Signore
[15]fino al punto che portavano gli ammalati nelle
piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando
Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di
loro.
[16]Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme
accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e
tutti venivano guariti.
[17]Si alzò allora il sommo
sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei
sadducei, pieni di livore,
[18]e fatti arrestare gli apostoli li
fecero gettare nella prigione pubblica.
[19]Ma durante la notte un
angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse
fuori e disse:
[20]«Andate, e mettetevi a predicare al
popolo nel tempio tutte queste parole di vita».
[21]Udito
questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a
insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della
sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli
d’Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella
prigione.
[22]Ma gli incaricati, giunti sul posto, non li
trovarono nella prigione e tornarono a riferire:
[23]«Abbiamo
trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie ai loro
posti davanti alla porta, ma, dopo aver aperto, non abbiamo trovato
dentro nessuno».
[24]Udite queste parole, il capitano del
tempio e i sommi sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai
significasse tutto questo,
[25]quando arrivò un tale ad
annunziare: «Ecco, gli uomini che avete messo in prigione si
trovano nel tempio a insegnare al popolo».
[26]Allora il
capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza
violenza, per timore di esser presi a sassate dal popolo.
[27]Li
condussero e li presentarono nel Sinedrio; il sommo sacerdote
cominciò a interrogarli dicendo:
[28]«Vi avevamo
espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di
costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina
e volete far ricadere su di noi il sangue di quell’uomo».
[29]Rispose
allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini.
[30]Il Dio dei nostri padri ha
risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla
croce.
[31]Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e
salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il
perdono dei peccati.
[32]E di questi fatti siamo testimoni noi e
lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a
lui».
[33]All’udire queste cose essi si irritarono e
volevano metterli a morte.
[34]Si alzò allora nel Sinedrio
un fariseo, di nome Gamalièle, dottore della legge, stimato
presso tutto il popolo. Dato ordine di far uscire per un momento gli
accusati,
[35]disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò
che state per fare contro questi uomini.
[36]Qualche tempo fa
venne Tèuda, dicendo di essere qualcuno, e a lui si
aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quanti s’erano
lasciati persuadere da lui si dispersero e finirono nel
nulla.
[37]Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del
censimento, e indusse molta gente a seguirlo, ma anch’egli perì
e quanti s’erano lasciati persuadere da lui furono
dispersi.
[38]Per quanto riguarda il caso presente, ecco ciò
che vi dico: Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se
infatti questa teoria o questa attività è di origine
umana, verrà distrutta;
[39]ma se essa viene da Dio, non
riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere
contro Dio!».
[40]Seguirono il suo parere e, richiamati gli
apostoli, li fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a
parlare nel nome di Gesù; quindi li rimisero in
libertà.
[41]Ma essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di
essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù.
[42]E
ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di
portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo.
*
Il capitolo 5 inizia in modo emblematico: da un lato si mette in evidenza, con la frode dei due coniugi Anania e Saffira, l’involuzione della teoria comunitaria dei beni; dall’altro si fa seguire a tale involuzione la ricerca di un’intesa politico-diplomatica, se non proprio ideologica, con la setta dei farisei.
Stando al racconto di Luca, Anania e Saffira non erano entrati nella comunità cristiana per rivendicare qualche esigenza di libertà materiale, ma per salvaguardare quella che già possedevano dall’avidità sempre maggiore degli imperatori e dei loro eserciti. Probabilmente, ammesso e non concesso che questo racconto sia storicamente attendibile, ancorché deformato da descrizioni fantastiche, fra le tante sette religiose o filosofiche di quel tempo, l’ebraico-cristiana appariva probabilmente ai due coniugi la meno estremista sul piano politico, la più garantista sul piano sociale.
Qui non bisogna dimenticare che – come dice S. I. Kovaliov nella sua Storia di Roma – «nelle comunità cristiane della seconda metà del II secolo prevaleva già la popolazione cittadina media: mercanti, artigiani, proprietari di terra e altri elementi abbienti. L’afflusso di queste categorie nelle comunità cristiane si può spiegare con due ordini di cause. In primo luogo, la crisi ideologica investiva strati sempre più vasti della società romana. L’aumento dello scetticismo e dell’incredulità si accompagnava a uno sviluppo delle tendenze religiose, dell’attrazione della magia, dei culti orientali, della mistica ecc. In secondo luogo, nel II secolo l’appartenenza al cristianesimo era vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Le comunità erano disseminate in tutte le città più importanti dell’impero e mantenevano fra loro stretti collegamenti» (Editori Riuniti, Roma 1973, vol. II).
In tal senso è difficile credere che i due suddetti coniugi non sapessero quale regime sociale vigesse nell’ambito delle comunità cristiane. Qui infatti appare chiaro ch’essi erano consapevoli della presenza di un costume, che, seppur facoltativo, dava una sorta di imprinting a tutta la comunità: la comunione dei beni, in virtù della quale chi più dava più era stimato. Tant’è che per non apparire inferiori, essi si adeguarono alla consuetudine. Senonché l’abitudine a una relativa agiatezza, unita a una certa sfiducia nelle garanzie di benessere della comunità, vinsero i loro buoni propositi. Del ricavato ottenuto dalla vendita di un terreno preferirono consegnare solo una parte, affermando però che questa era tutto l’importo.
Parlando a nome dei Dodici, Pietro (o chi per lui), consapevole che il valore del campo doveva essere ben maggiore, s’accorge dell’inganno e senza remore di sorta li spubblica uno dopo l’altro: prima il più responsabile, Anania, poi, verificandone l’effettiva complicità, la moglie Saffira. «Il terreno era vostro e anche i soldi erano vostri: chi vi obbligava a dichiarare un guadagno minore di quello che avete realizzato?», pontifica Pietro.
Già avanzati negli anni (fingiamo che lo siano) i due non resistono alla vergogna e s’accasciano ai piedi dell’apostolo colpiti da collasso. Particolarmente forte la reazione della gente: «un gran timore si diffuse in tutta la chiesa». Qui per la prima volta la parola «ekklêsia» sostituisce il nome, troppo politicizzato, di «nazareni»: nell’Antico Testamento la «chiesa» veniva usata per indicare una convocazione sacra, con finalità di culto (cfr Es. 12,16; Lv 23,3; Nm 29,1).
È noto, agli addetti ai lavori, che spesso e volentieri gli esegeti degli Acta apostolorum interpretano questo brano, più o meno esplicitamente, in chiave anticomunista, in quanto vogliono far credere che nella primitiva comunità non solo non c’erano bisognosi, ma non c’era neppure l’obbligo di mettere in comunione i propri beni: i fedeli lo facevano spontaneamente. Anania e Saffira – per questi esegeti – altro non sarebbero stati che un’eccezione, che la comunità non volle passare sotto silenzio.
Sicché – mutatis mutandis – si può sostenere, e questi esegeti lo fanno, che il moderno comunismo sia crollato proprio perché anteponeva alla comunione spirituale quella materiale, obbligando gli uomini a essere onesti, giusti, eguali..., diversamente da quanto fa il cristianesimo, i cui credenti sanno bene che senza comunione spirituale, che è libera per definizione, non potrà mai esserci quella materiale.
Questa è davvero una cattiva esegesi. Se c’è una cosa che alla primissima comunità cristiana va riconosciuta è proprio la coincidenza di etica ed economia. Quando Luca scriveva che «nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At 4,32 s.), non aveva certo in mente di dire che per realizzare una perfetta comunione materiale bisognava «prima» realizzare quella spirituale. Luca vedeva entrambe in maniera contestuale, ben sapendo che fra esse esiste una reciproca dipendenza, anche nel valore ontologico.
Semmai i limiti del racconto di Luca stanno altrove. È vero che non esisteva, almeno agli inizi, la proprietà privata, ma è anche vero che il cristianesimo non è mai arrivato a concepire l’idea di espropriare la proprietà dei latifondisti, né l’idea di liberare gli schiavi dai loro padroni. La Chiesa non aveva la più pallida idea di cosa volesse dire una gestione sociale del lavoro mediante l’uso razionale dei mezzi produttivi. Ciò che predicava era, al massimo, l’equa ripartizione del denaro comunitario, ovvero l’uso etico dei beni mobili. Lo stesso Kovaliov parla di «un’originale società di mutuo soccorso e beneficenza. In ogni comunità esisteva una cassa che provvedeva a distribuire sussidi e a organizzare mense comuni. La cassa traeva i suoi mezzi da elemosine».
Le sostanze che i cristiani del II secolo possedevano venivano sì vendute e il ricavato distribuito secondo il bisogno, ma nessuno politicamente metteva in discussione il regime schiavistico come formazione economico-sociale: tutt’al più lo si rifiutava dal punto di vista morale. Gli apologisti cristiani del II secolo – chiarisce bene Ambrogio Donini – «attenuano il tono della polemica sociale, che allarmava le autorità; ma si mantengono entro limiti ancora accettabili ai fedeli più intransigenti» (Storia del cristianesimo, dalle origini a Giustiniano, ed. Teti, Milano 1977, p. 140).
In questo senso, gli Atti degli apostoli, come tutto il Nuovo Testamento, se si esclude la sola Apocalisse, più che esprimere l’esigenza degli schiavi di emanciparsi dai loro padroni o l’esigenza dei ceti proletari di vivere un’esistenza priva di conflitti sociali, si fanno portavoce delle esigenze dei ceti medi che, temendo di andare in rovina a causa della pressione fiscale romana, decidono di fare vita comune. Sono proprio questi commercianti, liberi artigiani, piccoli proprietari ecc. che, rinunciando a contrapporsi politicamente al sistema, favoriranno col tempo il sorgere d’interpretazioni appunto moralistiche sulla liberazione degli oppressi e sul senso della solidarietà umana.
Certo, se il cristianesimo, invece di mettersi a predicare la liberazione degli schiavi nell’aldilà (come ad un certo punto cominciò a fare), avesse lottato o continuato a lottare per realizzarla nell’aldiquà, persone come Anania e Saffira non avrebbero neppure chiesto di diventare cristiane o forse avrebbero smesso di essere avare.
Il loro ambiguo atteggiamento sta comunque a dimostrare che il cristianesimo aveva già perso – se mai l’avesse avuta dopo la parentesi del nazareno – la sua carica rivoluzionaria. In effetti, se è esistito un tempo nella vita della comunità primitiva in cui la comunione dei beni era prassi consolidata per poter diventare cristiani, è evidente che l’episodio di questa frode riflette un tempo diverso, in cui la consuetudine alla socializzazione dei beni era diventata facoltativa, ovvero l’obbligo era diventato meramente morale. F. Engels, nel suo Antidühring, sa bene che più di così il cristianesimo non avrebbe potuto: «Le tracce della comunione dei beni che si trovano agli inizi della nuova religione si possono ricondurre molto più alla solidarietà dei perseguitati che a vere idee di uguaglianza».
Ecco perché, allo scopo d’indurre i due coniugi a dire la verità, per invitarli cioè a «donare tutto» o a dare il più possibile (e risolvere così lo scrupolo di chi dà meno di quel che dovrebbe), Pietro è costretto ad appellarsi ad elementi esterni, estranei alla comunità, come lo «spirito santo» e la «giustizia di dio», che tutto vedono e ai quali nessuno può sfuggire. Per giustificare l’involuzione del comunismo cristiano verso una strada diremmo oggi «borghese», la Chiesa è stata costretta a inventarsi un’esemplare punizione.
Ma proprio la punizione della falsità attesta che chi si sottraeva esplicitamente all’obbligo morale non veniva punito o espulso dalla comunità, né gli venivano requisiti quei beni utili alla collettività: era soltanto considerato – almeno fino a quando la sua scelta non s’imporrà come regola – cristiano di seconda categoria. Pietro lo dice a chiare lettere, rivolgendosi ad Anania: «Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione?». Il che in sostanza voleva dire che la Chiesa poteva al massimo ammonire moralmente il ricco, avendo già perduto il coraggio di esigere quanto più era necessario per la liberazione effettiva degli schiavi e degli oppressi.
Se la paura d’impoverire portò quindi i due coniugi a farsi cristiani, la stessa paura li aveva convinti a non diventarlo sino in fondo. Abituati a un relativo benessere, essi temevano, e non a torto, che con la semplice comunione dei beni mobili, ovvero con la prassi delle libere donazioni o dell’assistenzialismo non si sarebbe potuto evitare, a lungo andare, il pericolo di finire (o di ricadere) nell’indigenza. Solo che invece di pretendere un maggiore rigore nella socializzazione dei beni, essi avevano prospettato una soluzione arbitraria, del tutto soggettivistica, offrendo facilmente il destro a una critica morale, travestita di teologia, da parte di una Chiesa che non era più in grado di mettere in discussione la proprietà privata.
Pietro dunque viene fatto vincere moralmente perché aveva già perso politicamente. Anania e Saffira devono morire proprio per permettere ai borghesi di poter accedere alla comunità restando borghesi. Cioè i ceti benestanti entrati in comunità si sarebbero limitati all’elemosina e alla carità, senza per questo smettere di essere benestanti, e di conseguenza l’eguaglianza socioeconomica avrebbe smesso d’essere un valore praticabile.
Gli attacchi contro la ricchezza, l’esaltazione della modestia, l’odio verso l’oppressore comune, cioè Roma, in una parola l’ideologia dominante della primitiva comunità cristiana si sarebbe progressivamente stemperata a vantaggio dell’ideologia della mera beneficenza, in cui i ricchi facilmente si riconosceranno, e della mera rassegnazione, in cui dovranno riconoscersi i poveri, nella certezza, per entrambi, della ricompensa ultraterrena: morale per gli uni, materiale per gli altri.
L’etica stoico-mistica, costruita per le classi popolari, farà appunto da contrappeso a quella, ben più opportunista, delle classi agiate. Anania e Saffira devono quindi morire, affinché tutta la Chiesa tremi di paura e si senta così indotta a non frodare o almeno a non mentire quando lo fa.
*
I versetti 12-16 di questo capitolo sono piuttosto contraddittori. Da un lato infatti Luca afferma che «nessuno osava associarsi a loro», dall’altro che «andava aumentando il numero degli uomini e delle donne» credenti nel vangelo. La difficoltà sta nel fatto che quando si parla di «miracoli e prodigi» compiuti dagli apostoli (v. 12), non si può poi sostenere ch’essi non avessero alcun effetto tra le folle. Non a caso Luca è costretto ad affermare che «portavano malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti» (v. 16). Questo naturalmente mentre i Dodici e gli altri discepoli trascorrevano gran parte delle loro giornate a discutere coi giudei «nel portico di Salomone» (v. 12 e cfr anche 3,11).
Com’erano cambiati i tempi! In occasione della cacciata dei mercanti, che gli esegeti cattolici chiamano con la definizione più soft di «purificazione del tempio», Gesù aveva reso pubblico il suo intendimento circa questa struttura politico-religiosa, profondamente corrotta. È vero che dopo di allora l’evangelista Giovanni ricorda in 10,23 che durante la festa invernale della Dedicazione, Gesù vi «passeggiava» discutendo coi giudei il problema della propria messianicità, cioè del proprio ruolo politico, ma è anche vero che in quell’occasione egli fece un’esplicita professione d’ateismo, sostenendo che tutti gli uomini sono virtualmente delle «divinità» (v. 34), per cui non vi è bisogno di credere in un dio superiore. A quel punto, sottolinea Giovanni, decisero di «lapidarlo» (v. 31), perché reo di bestemmia, ma egli «sfuggì loro di mano» (v. 39). In breve, il rapporto di Gesù col tempio non fu mai facile e neppure pacifico.
Qui, al contrario, pare che i Dodici abbiano scelto il tempio come luogo privilegiato della loro missione. L’esegesi cattolica motiva questa scelta sostenendo ch’essi si sentivano ancora «giudei». La realtà purtroppo è che avevano smesso di sentirsi dei giudei «rivoluzionari», «patriottici». E in tal senso è difficile immaginare che la loro predicazione incontrasse un consenso esplicito da parte delle masse più oppresse dall’imperialismo romano: se consenso vi era, da parte di questa gente, era sicuramente inconsapevole. L’idea stessa di resurrezione del messia Gesù aveva lo scopo di distogliere da qualunque lotta rivoluzionaria, sia che il nemico fosse esterno, come appunto quello romano, sia che fosse interno, come il potere politico collaborazionista.
Quando Luca scrive che «nessuno osava avvicinarsi a loro» sembra voglia riferirsi a quei gruppi che a livello sociale rappresentavano le istituzioni, in primo luogo scribi e farisei, ancora titubanti perché in attesa del placet delle autorità costituite. Quando invece aggiunge che «il popolo li esaltava» il riferimento a chi va? Nei vangeli i seguaci del Cristo sono di regola degli offsider che si muovono autonomamente, avversi al potere istituzionale e ben consapevoli dell’ipocrisia scribo-farisaica. Qui invece si ha a che fare con una popolazione desiderosa sì di emanciparsi, ma nei limiti della legalità. Una popolazione del genere, diremmo oggi, è più «piccolo-medio borghese» che «proletaria».
Dal canto loro, le autorità costituite si rendevano conto che la predicazione degli apostoli non rappresentava una minaccia politica così forte come quella del Cristo. Fatte salve però alcune precisazioni. Dai vangeli risulta che il Cristo venne ucciso non perché le autorità fossero contrarie a un’affermazione messianica in chiave antiromana, ma perché in quella del Cristo vedevano una minaccia esplicita al loro potere costituito.
Viceversa, i timori nei confronti della predicazione apostolica sono qui di tipo più ideologico che politico, in quanto gli apostoli non sembrano mettere direttamente in discussione il potere giudaico costituito. Ciò che Pietro chiede è esclusivamente di credere che il Cristo crocifisso era il messia tanto atteso e che era risorto: il che in sostanza significava, sul piano politico, rinunciare alla lotta antiromana e aprire le porte del giudaismo alla netta separazione tra politica e religione.
Per la mentalità ebraica tradizionale questa tesi avrebbe comportato, indubbiamente, una rivoluzione culturale, ma non necessariamente una politica, se non nel senso che concetti come «nazione santa» e «popolo eletto» avrebbero progressivamente perduto di peso ai fini della coesione sociale.
In ogni caso, il fatto che nei confronti della predicazione apostolica non vi fosse un rifiuto così categorico come nei confronti di quella del Cristo, è qui dimostrato dalla incredibile facilità con cui gli apostoli (Pietro e Giovanni anzitutto) riescono a evadere dalla prigione. Dietro la figura provvidenziale dell’angelo si nasconde ovviamente qualche importante membro del Sinedrio. Il quale addirittura invita gli apostoli a predicare direttamente nel tempio di Gerusalemme, ove i discorsi non avrebbero potuto avere un contenuto rivoluzionario non condiviso dalle autorità costituite.
Peraltro l’interlocutore presente nel tempio non poteva più essere quello delle piazze cittadine della Palestina, dei sobborghi abbandonati, dei ceti marginali, come spesso accade nei vangeli, ma necessariamente era quello che contestava il potere costituito più dal punto di vista morale che politico. Se questo popolo «non osava associarsi agli apostoli» era semplicemente a motivo del fatto che conosceva i legami politici di quelli col Cristo rivoluzionario, non per il timore ch’essi dicessero cose eversive.
Il fatto stesso che gli apostoli, una volta fatti uscire dal carcere, non siano fuggiti da Gerusalemme, ci induce a credere ch’essi fossero relativamente sicuri tra quella parte di popolo che frequentava ordinariamente il tempio e che si sentissero appoggiati persino da una certa parte del Sinedrio, disposta ad accettare la «nuova eresia» a condizione che se ne edulcorasse il contenuto politico.
Gli avversari più irriducibili erano in realtà i sadducei, che allora rappresentavano l’ala destra del Sinedrio. Erano loro a fornire i sommi sacerdoti, e sono sempre loro che, così tenacemente legati a interessi di poteri e a privilegi connessi all’uso del tempio, vorrebbero processare ed eventualmente eliminare gli apostoli, come prima fecero col loro leader. Al tempo del Cristo essi riuscirono ad avere la meglio dichiarando pubblicamente a Pilato di avere come re «solo Cesare» (Gv 19,15) e nel contempo evitarono di opporsi alla richiesta di scarcerare Barabba, che aveva come scopo quello di rabbonire le masse più estremiste. Ma non per questo la situazione dei sadducei era diventata più sicura. Il loro potere si andava progressivamente deteriorando proprio a motivo delle scarse prospettive che la loro ideologia, a differenza di quella farisaica, offriva agli strati sociali piccoli e medi della borghesia. Tant’è che negli anni 70 e soprattutto 135 essi verranno completamente travolti dagli avvenimenti.
Questo per dire che i sadducei temevano il rapporto tra cristiani e farisei non meno del rapporto tra nazareni e ceti sociali oppressi. Se ai tempi del Cristo s’andava profilando una certa spaccatura tra gli elementi più progressisti dei farisei (nei vangeli rappresentati da Nicodemo) e gli altri gruppi politici, ora la spaccatura sembra essere tra il gruppo farisaico in quanto tale e il gruppo avversario dei sadducei, con la differenza che mentre al tempo del Cristo era in gioco la possibilità di una rivoluzione nazionale, ora è semplicemente in gioco l’esigenza di modernizzare culturalmente l’ebraismo, venendo incontro p.es. alle esigenze degli ebrei ellenisti, come vedremo nei capitoli successivi. Paolo di Tarso rappresenterà, nell’ambito dei farisei, la consapevolezza della necessità di una modernizzazione culturale che non fosse però in contraddizione con l’esigenza della liberazione nazionale: quando rinuncerà a quest’ultimo obiettivo diventerà completamente «cristiano».
Durante l’interrogatorio davanti al Sinedrio, dopo che gli apostoli erano stati catturati dalle guardie, senza alcuna violenza, mentre predicavano presso il tempio, i sadducei fecero un’accusa molto precisa: «Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco che voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell’uomo»(v. 28). Il che non sta a significare, come si può facilmente notare, che i Dodici insegnassero le stesse cose di Gesù, anche perché se l’avessero fatto la reazione dei sadducei sarebbe stata ben diversa e, sicuramente, anche quella scribo-farisaica, sicché in sostanza si può supporre che l’inquirente intenda riferirsi solo a una determinata dottrina, quella della resurrezione del Cristo, che Pietro e, stando agli Atti, anche Giovanni iniziarono a predicare subito dopo la scoperta della tomba vuota (il ruolo effettivo di Giovanni resta però alquanto controverso).
La teoria della resurrezione dava fastidio ai sadducei non tanto per motivi politici quanto per motivi ideologici, e quindi solo indirettamente per motivi politici. Gli apostoli infatti sostenevano che i sadducei avevano eliminato il miglior messia che Israele avesse potuto desiderare. La versione ufficiale sadducea invece assegnava a Gesù il ruolo di «malfattore»: fu crocifisso insieme a «due ladroni» (Mc 15,27), nonché il ruolo di «impostore»: egli disse di essere «il re dei giudei» (Gv 19,21) contro la volontà popolare.
Tuttavia se il popolo avesse cominciato a credere che Gesù era davvero il messia tanto atteso e che dopo di lui non ve ne sarebbe stato un altro, i sadducei avrebbero dovuto fare pubblica ammenda e persino i farisei avrebbero dovuto rinunciare all’idea di una liberazione nazionale, ovvero avrebbero dovuto demandare la realizzazione di tale obiettivo al momento «mistico» della parusia. Ma questo avrebbe inevitabilmente comportato una diversa ripartizione dei seggi all’interno dello stesso Sinedrio. La corrente cristiana emergente, pur non volendo più essere connotata politicamente, non avrebbe certo rinunciato a una rappresentanza parlamentare che la tutelasse come movimento d’opinione.
In
tal senso la difesa di Pietro è molto interessante, poiché
da un lato ha l’apparenza di essere molto netta e categorica,
dall’altro invece offre non pochi appigli per realizzare una
sorta di compromesso tra cristiani e autorità giudaiche. Per
quattro ragioni il suo discorso non contiene neanche un aspetto
rivoluzionario:
1. si sostituisce il programma di Gesù con
la cosiddetta «volontà di Dio»(v. 29), cioè
invece di fare un discorso politico progressista ne fa uno
conservatore, anche se di matrice diversa rispetto a quelli sadducei;
egli in sostanza fa capire che i cristiani hanno il diritto
d’interpretare diversamente la «volontà del Dio
dei loro padri»;
2. conformemente alla sua premessa, Pietro
qualifica Gesù non come «politico rivoluzionario»
ma come «giudice morale»,
ovvero come un sacerdote che «perdona i peccati»,
un «redentore» in luogo del «liberatore»;
3.
Pietro non parla mai di liberazione nazionale ma unicamente di
«conversione personale»,
e quindi non chiama in causa la volontà delle masse, la
capacità organizzativa dei dirigenti politici, ma unicamente
la «grazia»
che Dio elargisce agli uomini che chiedono di ravvedersi;
4. come
sostituto del Cristo e quindi della stessa liberazione nazionale,
Pietro assicura il dono dello «Spirito santo»,
cioè la possibilità di vivere un’esistenza
sufficientemente dignitosa pur all’interno del regime di
oppressione romana: lo «Spirito santo»
è «democratico»
per natura, aperto a tutti, in grado di permettere un’organizzazione
sociale che vada oltre le differenze di classe o di casta o di
origine tribale.
Pietro in sostanza garantisce di essere disposto a realizzare con le autorità costituite qualunque compromesso se solo esse accetteranno queste essenziali condizioni. Da notare che i farisei già credevano nella teoria della resurrezione dei morti, per quanto la ritenessero fattibile solo per la fine dei tempi.
Il contrasto coi sadducei era netto ma non impossibilitato a risolversi. I sommi sacerdoti si rendevano conto che i cristiani non miravano più, come ai tempi del Cristo, a «rovesciarli dal trono» ma soltanto a ridimensionare il loro potere. Chiedendo una semplice riparazione morale, gli apostoli si dichiarano in realtà disponibili a un compromesso di tipo politico.
Tuttavia, i fatti si preoccuperanno di dimostrare che tale compromesso sarà possibile solo con i farisei, anzi solo con la parte più progressista di questa corrente, magistralmente rappresentata da Paolo di Tarso. Quindi il discorso di Pietro in realtà aveva aperto le porte a un confronto dialettico coi farisei, per i quali concetti come «grazia della conversione», «perdono dei peccati», «dono dello Spirito santo» e «resurrezione dei morti» potevano rientrare nella loro filosofia di vita. L’unico vero ostacolo era rappresentato dalla teoria della «resurrezione di Gesù»: se infatti essi l’avessero accettata, allora significava che si sarebbe dovuto credere nella sua messianicità (che in questo caso sarebbe apparsa come unica e straordinaria) e quindi rimettere in discussione l’idea di proseguire la lotta di liberazione nazionale, in cui ancora si credeva, o comunque accettare l’idea di posticipare la realizzazione di tale evento a tempi non definiti o umanamente non definibili. Un messia morto non serve a nessuno e un messia risorto serve solo se il suo ritorno è imminente e trionfale. Sarà Paolo a uscire da questo impasse dichiarando che il Cristo era molto di più di un «messia», era «il figlio di Dio».
Al
momento i cristiani possono soltanto ricevere il consenso di
Gamaliele, maestro di Paolo e rappresentante in vista dell’ala
più progressista dei farisei. La soluzione ch’egli
propone ai membri del Sinedrio è semplice ma convincente:
1.
se il Cristo predicato dagli apostoli è come i due messia
Giuda il Galileo e Teuda (che si ribellarono a Roma verso la fine del
regno di Erode il Grande)4,
allora non c’è da preoccuparsene, poiché come i
discepoli di quelli, alla morte dei loro leader, si sono dispersi,
così accadrà dei cristiani;
2. se invece Gesù
è più grande dei due leader, sarà il tempo a
deciderlo, e se il tempo sarà a lui favorevole, allora
significa che il suo messaggio meriterà d’essere preso
in considerazione, ma anche in questo caso Israele non avrà
nulla da temere, poiché il messaggio degli apostoli non è
contro le istituzioni del paese.
Con molta accortezza Gamaliele sconsiglia di usare le persecuzioni o i metodi coercitivi, sia perché ha capito che i cristiani non sono politicamente pericolosi, sia perché prevede che il martirio aumenterebbe il consenso, in quanto non poteva essere tenuto nascosto che una parte cospicua della popolazione già credeva nell’ideologia cristiana. Il suo consiglio in pratica è quello di temporeggiare, cioè di limitarsi a un parere interlocutorio sulla nuova «eresia», rimandando ogni decisione di merito a tempi più maturi.
In realtà, molto difficilmente le sue tesi, col passare del tempo, avrebbero potuto conservare l’appoggio dei sadducei. Il problema che quest’ultimi dovevano risolvere non era facile, specie per un partito abituato a vivere di privilegi. Posto infatti che i cristiani – si saranno chiesti – sono una corrente che può essere politicamente strumentalizzabile, in quanto non rivendicano una vera e propria alternativa al sistema dominante, cosa è preferibile fare: ostacolarne in tutti i modi l’operato prima che il tempo giochi a favore del consenso popolare di cui già ora godono, oppure scendere a compromessi rinunciando a una parte del potere?
La decisione di accettare la proposta di Gamaliele non fu, come si nota bene nel testo, unanime: seguirono sì il consiglio di liberarli, ma non senza prima averli fatti «fustigare» e non senza «ordinare loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù» (v. 40).
En passant si può qui far notare che dopo l’episodio di Anania e Saffira, la figura di Giovanni, che avrebbe dovuto sostituire Gesù alla guida dei Dodici secondo quanto dice lo stesso Giovanni nel suo vangelo, scompare quasi completamente dagli Atti (se si esclude il cenno insignificante in 8,14).
torna suCap. 6
[1]In quei
giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un
malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano
trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana.
[2]Allora
i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è
giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle
mense.
[3]Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di
buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali
affideremo quest’incarico.
[4]Noi, invece, ci dedicheremo
alla preghiera e al ministero della parola».
[5]Piacque
questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore,
Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di
Antiòchia.
[6]Li presentarono quindi agli apostoli i quali,
dopo aver pregato, imposero loro le mani.
[7]Intanto la parola di
Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei
discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva
alla fede.
[8]Stefano intanto, pieno di grazia e di fortezza,
faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo.
[9]Sorsero allora
alcuni della sinagoga detta dei «liberti» comprendente
anche i Cirenei, gli Alessandrini e altri della Cilicia e dell’Asia,
a disputare con Stefano,
[10]ma non riuscivano a resistere alla
sapienza ispirata con cui egli parlava.
[11]Perciò
sobillarono alcuni che dissero: «Lo abbiamo udito pronunziare
espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio».
[12]E
così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli
piombarono addosso, lo catturarono e lo trascinarono davanti al
Sinedrio.
[13]Presentarono quindi dei falsi testimoni, che
dissero: «Costui non cessa di proferire parole contro questo
luogo sacro e contro la legge.
[14]Lo abbiamo udito dichiarare che
Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà
i costumi tramandatici da Mosè».
[15]E tutti quelli
che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il
suo volto come quello di un angelo.
*
La goccia che fece traboccare il vaso di questa situazione precaria fu causata dalla conversione dei cosiddetti «ellenisti» (giudei della diaspora) al cristianesimo.
Come noto, durante l’edificazione del «secondo tempio», dopo la cattività babilonese, si erano sviluppate a Gerusalemme, sotto il dominio incontrastato della casta sacerdotale, due tendenze che si condizionavano a vicenda: un rigoroso monoteismo dottrinale (conseguente alla centralizzazione del culto nella capitale) e l’ideologia del popolo eletto, della nazione santa ecc.
Le radici di queste tendenze erano senz’altro anteriori a quel periodo, ma solo con le riforme di Neemia esse trovarono un certo riscontro. In particolare con esse si richiese la proibizione dei matrimoni misti e lo scioglimento di quelli già contratti, una rigida separazione dei giudei da tutti gli altri popoli limitrofi, e appunto una centralizzazione cultuale nel tempio: si favorì così una sorta di autoisolamento nazionale dei giudei, nella convinzione di poter avere con Jahvè un rapporto esclusivo, privilegiato.
Questa situazione, per molti versi paradossale, in quanto gli «eletti» giudei altro non erano che un popolo numericamente insignificante, per lo più oppresso da altri popoli, si trascinò per diversi secoli.
Le popolazioni di religione ebraica, che col passar del tempo cominciarono ad avvertire in maniera sempre più netta il contrasto fra l’ideologia dell’elezione e la realtà dell’oppressione, furono proprio quelle della diaspora. La dispersione degli ebrei oltre i confini della Palestina era iniziata negli anni della dominazione assiro-babilonese (secoli VII-VI a.C.), ma fu soprattutto nel periodo ellenistico (333-63 a.C.) ch’essa assunse vaste proporzioni, promuovendo altresì quel sincretismo culturale fra la religiosità giudaica e l’ideologia religiosa e filosofica dell’ellenismo che porterà alla nascita di un ebraismo fortemente ellenizzato e, se vogliamo, dello stesso cristianesimo, almeno nella forma che assunse sotto la predicazione paolina.
Ebrei ellenisti vivevano in Egitto, Siria, Asia Minore e in altri paesi del Mediterraneo. Essi organizzavano la loro vita religiosa sostanzialmente intorno alle sinagoghe, già presenti in tutta la Palestina ai tempi di Gesù. Parlavano il greco e in questa lingua tradussero tutta la Bibbia ebraica: il che poi farà sviluppare i sistemi sincretici filosofico-religiosi come quello di Filone Alessandrino o come quelli degli gnostici.
Rispetto agli ebrei residenti in Giudea, poco disposti a lasciarsi condizionare dai costumi della civiltà greco-romana, specie in considerazione del fatto che vi dovevano stare soggetti a motivo dell’oppressione politico-militare, molti ellenisti si rendevano conto che la centralizzazione del culto a Gerusalemme e lo stesso concetto di «popolo eletto» avrebbero potuto continuare ad avere un senso solo a condizione di ripristinare in tempi brevi l’indipendenza nazionale, altrimenti sarebbe stato meglio rinunciarvi definitivamente.
Di qui il conflitto latente, destinato a scoppiare, tra quei gruppi giudaici che ancora attendevano il messia trionfatore sui romani e quelli che credevano invece d’averlo trovato, in forme diverse da quelle sperate, nel Cristo morto e risorto. In mezzo stavano i cristiani residenti in Giudea (la terra più ortodossa di tutta la Palestina), che, dovendo convivere coi giudei locali, non se la sentivano di dover rinunciare, senza soluzione di continuità, alla specificità delle tradizioni classiche del giudaismo, nonostante fosse chiara la loro connotazione di «setta» sul piano sociale e di «eresia» su quello dottrinale.
Stefano capeggiava un gruppo estremista degli ellenisti: la sua opposizione netta al tempio poteva trovare facilmente seguaci tra i samaritani, gli esseni, la setta di Qumran, i battisti e anche tra gli stessi nazareni, ora divenuti «cristiani».
Il motivo che introduce il cap. 6: la discriminazione delle vedove elleniste nella distribuzione quotidiana delle offerte, non era una banalità. La condizione socioeconomica di questa categoria di persone era allora drammatica. Nel Nuovo Testamento vi sono due episodi in cui i redattori si sono sentiti in dovere d’introdurre degli elementi mitologici per poterne parlare: in Lc 7,11 ss., ove si narra della resurrezione del figlio della vedova di Nain, e At 9,36 ss., che riprende il racconto di Luca, sostituendo Pietro taumaturgo a Gesù.
Il fatto descritto in questo capitolo rispecchia quanto già detto sopra, e cioè che gli ebrei della Giudea, fossero essi ortodossi o, come appunto i cristiani, eretici, tendevano a considerare quelli della diaspora come credenti di secondo rango, proprio per il principio della «elezione» del popolo giudaico. Naturalmente gli ellenisti in oggetto non erano più residenti all’estero, altrimenti la distribuzione delle offerte non avrebbe potuto essere «quotidiana»: essi quasi sicuramente avevano a Gerusalemme delle sinagoghe ove leggevano la bibbia in greco.
In pratica era successo che con l’ampliarsi della comunità cristiana erano aumentati i problemi di carattere organizzativo, la cui mancata soluzione s’intersecava con aspetti di carattere soggettivo, quale appunto la discriminazione per motivi ideologici.
Se si considera che il regime economico della comunità primitiva era basato su offerte, lasciti e donazioni, diventa del tutto naturale che all’aumentare dei suoi seguaci aumentassero progressivamente anche i bisogni materiali. Inevitabilmente risultavano maggiori le persone disposte a ricevere che non quelle disposte a dare.
La decisione dei Dodici di separare le loro responsabilità materiali da quelle morali e ideali riflette appunto il limite strutturale della comunità, incapace di garantire l’effettiva uguaglianza economica ai suoi aderenti.
In realtà nel contesto dell’episodio sembra avvenga il contrario, e cioè che gli apostoli, già coinvolti nelle difficoltà emerse con l’episodio di Anania e Saffira, affidano l’incarico della gestione delle risorse economiche ai sette diaconi al fine di meglio garantire l’eguaglianza economica. E si tratta di un incarico di carattere generale, che va ben oltre l’assistenza alle vedove.
Il momento è significativo poiché viene sancita la separazione, all’interno della comunità, tra aspetti morali e aspetti materiali: cosa che prima d’allora non era mai avvenuta. Nella fattispecie gli apostoli evitano di nominare gli incaricati al servizio delle mense, temendo di apparire parziali, e preferiscono che sia la comunità a proporre i candidati. Tuttavia sono sempre i Dodici che stabiliscono il numero di «sette» e che decidono, in ultima istanza, di confermare ai diaconi la mansione.
Si ha qui l’impressione che gli apostoli costituiscano una sorta di «potere separato», in cui il numero stesso di dodici evochi una sorta di particolare privilegio. Cosa che, come noto, genererà, da qui a breve, delle tensioni con Paolo, che si autoproclamerà «tredicesimo apostolo». Questo poi senza considerare che i «Dodici» non esistevano più al tempo in cui gli Atti presumono di riferirsi, e forse non sono mai esistiti in quel numero così simbolico.
In sostanza è come se la predicazione e l’insegnamento fossero diventati, ope legis, patrimonio esclusivo della cerchia dei Dodici, tant’è che qui per la prima volta si usa l’espressione «ministero della parola» (v. 4). L’incapacità di risolvere le contraddizioni di fondo della sfera economica sembra abbia portato alla nascita di una particolare categoria di intellettuali della religione o della teologia: i cosiddetti «sacerdoti» (qui certamente più «laicizzati» di quelli giudeo-ortodossi), le cui idee, oltre a garantire la correttezza formale delle pratiche cultuali e la retta dottrina, tenderanno a diventare, inevitabilmente, sempre più astratte, moralistiche e apologetiche.
Che in questo capitolo nasca la figura del «sacerdote cristiano» è testimoniato anche dal fatto che al momento di ratificare la scelta comunitaria dei diaconi, i Dodici per la prima volta compiono un gesto tipicamente religioso: «l’imposizione delle mani» (v. 6). Questo conferma che è stato proprio nel momento in cui si sono separati gli aspetti morali da quelli materiali, dietro il pretesto che non si poteva trascurare «la parola di dio per il servizio delle mense» (v. 2), che i Dodici si sono specializzati nel ruolo alienato e alienante del «sacerdote». Nulla di strano quindi che Luca concluda questa prima parte sottolineando che «anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede» (v. 7).
Fra i sette diaconi scelti, uno, probabilmente il più importante, in quanto citato per primo e anche perché di tutti gli altri, a parte Filippo, non si saprà più nulla, si attirava coi suoi polemici discorsi l’inimicizia di altri ellenisti come lui, non seguaci però dei cristiani. Luca dice, esagerando, che mentre discutevano con lui «non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava» (v. 10), per cui si risolsero di denunciarlo.
Siccome Stefano era un cristiano agguerrito, per quanto assai poco diplomatico, gli autori degli Atti hanno ovviamente tutto l’interesse a mettere in buona luce l’intero suo operato e, a tale scopo, non risparmiano gli argomenti.
Già al v. 5, in un banale elenco di nomi, si era precisato, solo per lui, che si trattava di «un uomo pieno di fede e di spirito santo». Elogi del genere non si erano mai fatti neppure negli elenchi evangelici dei Dodici, dove anzi si era cercato di nascondere il più possibile le loro origini politicamente rivoluzionarie.
Si prosegue al v. 8 presentando di nuovo la personalità di Stefano come quella di un santo taumaturgo, alla stregua del Gesù evangelico più edulcorato, addirittura «pieno di grazia e di potere», poiché «faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo» (descrizione che in verità risente poco dello stile di Luca).
Si continua dicendo che, a motivo della sua irresistibile dialettica, furono costretti a «sobillare» dei «falsi testimoni» (vv. 11 e 13). E si conclude con una frase degna d’essere riportata per intero: «E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo» (v. 15).
Da notare che descrizioni analoghe si trovano solo in Es. 34,29-35, allorché si parla dello splendore del volto di Mosè, e nella trasfigurazione di Gesù, che riprende appunto il racconto veterotestamentario. Il che fa pensare a due cose: sia che negli ambienti ellenistici era relativamente facile idealizzare il messia e promuovere un culto della sua personalità debitamente trasformata in un’entità mitologica; sia che questa accentuata identificazione con l’immagine divinizzata del messia è inversamente proporzionale alla credibilità del messaggio di Stefano, per cui essa altro non è che un elemento apologetico usato in modo strumentale.
Un’ovazione così solenne in così poche righe non è riscontrabile in alcuna parte del Nuovo Testamento. Essa si spiega appunto con la necessità di mascherare un delitto che agli occhi dei contemporanei (ebrei e probabilmente anche cristiani) dovette risultare ampiamente giustificato.
A questi meccanismi redazionali di autodifesa la Chiesa si sentì costretta per motivi di opportunità, in quanto era nell’interesse di tutti accontentare i cristiani provenienti dall’ebraismo ellenistico di vedersi rappresentare in questo libro di memorie storiche da alcuni loro significativi esponenti. Questo peraltro spiega perché esista nei sinottici un doppione del racconto della moltiplicazione dei pani.
Ciò che c’è di vero nel racconto dell’arresto di Stefano è, probabilmente, solo l’accusa dei «falsi testimoni», che forse tanto «falsi» non erano, nel senso che è possibilissimo che Stefano abbia detto qualche parola di troppo contro il tempio e la legge, e che abbia altresì esagerato nel dichiarare che Gesù il Nazareno avrebbe distrutto il tempio e sovvertito i costumi tramandati da Mosè.
Forse Stefano può aver esagerato nel dire che il tempio sarebbe finito materialmente distrutto, forse questa era solo l’accusa dei suoi detrattori, mentr’egli in realtà intendeva riferirsi a una distruzione di tipo simbolico. Fatto sta che la decisione è quella di condannarlo a morte per un semplice «reato d’opinione».
A dir il vero però le sue filippiche contro i giudei ortodossi si trascinavano già da lungo tempo: dapprima l’avevano contestato i Liberti, i Cirenei e gli Alessandrini, in seguito i più agguerriti della Cilicia e dell’Asia: fra questi c’era il fariseo Saulo, futuro grande persecutore dei cristiani.
torna suCap. 7
[1]Gli
disse allora il sommo sacerdote: «Queste cose stanno proprio
così?».
[2]Ed egli rispose: «Fratelli e padri,
ascoltate: il Dio
della gloria apparve
al nostro padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, prima che
egli si stabilisse in Carran,
[3]e
gli disse: Esci dalla tua terra e dalla tua gente e va’ nella
terra che io ti indicherò.
[4]Allora,
uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran; di là,
dopo la morte del padre, Dio lo fece emigrare in questo paese dove
voi ora abitate,
[5]ma non gli diede alcuna proprietà in
esso, neppure
quanto l’orma di un piede,
ma gli promise di
darlo in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui,
sebbene non avesse ancora figli.
[6]Poi Dio parlò così:
La discendenza di
Abramo sarà pellegrina in terra straniera, tenuta in schiavitù
e oppressione per quattrocento anni.
[7]Ma
del popolo di cui saranno schiavi io farò giustizia,
disse Dio: dopo
potranno uscire emi adoreranno in
questo luogo.
[8]E gli diede l’alleanza della circoncisione.
E così Abramo generò Isacco e lo
circoncise l’ottavo giorno e
Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i dodici patriarchi.
[9]Ma
i patriarchi, gelosi
di Giuseppe, lo vendettero schiavo
in Egitto. Dio
però era con lui
[10]e
lo liberò da tutte le sue afflizioni e gli
diede grazia e
saggezza davanti
al faraone re d’Egitto, il quale lo nominò
amministratore dell’Egitto e di tutta la sua casa.
[11]Venne
una carestia su tutto l’Egitto e
in Canaan e
una grande miseria, e i nostri padri non trovavano da
mangiare.
[12]Avendo
udito Giacobbe che in Egitto c’era del grano,
vi inviò i nostri padri una prima volta;
[13]la seconda
volta Giuseppe si
fece riconoscere dai suoi fratelli
e fu nota al faraone
la sua origine.
[14]Giuseppe allora mandò a chiamare
Giacobbe suo padre e tutta la sua parentela, settantacinque
persone in tutto.
[15]E
Giacobbe si recò
in Egitto, e qui egli morì
come anche i nostri
padri;
[16]essi
furono poi trasportati in Sichem
e posti
nel sepolcro che
Abramo aveva acquistato e
pagato in denaro dai
figli di Emor, a Sichem.
[17]Mentre
si avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il
popolo crebbe e
si moltiplicò in
Egitto,
[18]finché salì
al trono d’Egitto un altro re, che non conosceva
Giuseppe.
[19]Questi,
adoperando
l’astuzia contro la nostra gente, perseguitò
i nostri padri fino
a costringerli a esporre i loro figli, perché non
sopravvivessero.
[20]In
quel tempo nacque Mosè e piacque a Dio; egli
fu allevato per tre mesi
nella casa paterna,
poi,
[21]essendo stato esposto,
lo raccolse la
figlia del faraone
e lo allevò
come
figlio.
[22]Così
Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli Egiziani ed era
potente nelle parole e nelle opere.
[23]Quando stava per compiere
i quarant’anni, gli venne l’idea di far visita ai
suoi fratelli, i
figli di Israele,
[24]e
vedendone uno trattato ingiustamente, ne prese le difese e vendicò
l’oppresso,
uccidendo
l’Egiziano.
[25]Egli
pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro
salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero.
[26]Il giorno dopo
si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e si
adoperò per metterli d’accordo, dicendo: Siete fratelli;
perché vi insultate l’un l’altro?
[27]Ma
quello che
maltrattava il vicino
lo respinse,
dicendo: Chi ti
ha nominato capo e giudice sopra di noi?
[28]Vuoi
forse uccidermi, come hai ucciso ieri l’Egiziano?
[29]Fuggì
via Mosè a queste parole, e andò ad abitare nella terra
di Madian, dove
ebbe due figli.
[30]Passati quarant’anni,
gli apparve nel
deserto del monte. Sinai un angelo, in mezzo alla fiamma di un roveto
ardente.
[31]Mosè
rimase stupito di questa visione; e mentre si avvicinava per veder
meglio, si udì la voce del Signore:
[32]Io
sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe.
Esterrefatto, Mosè non osava guardare.
[33]Allora
il Signore gli disse: Togliti dai piedi i calzari, perché il
luogo in cui stai è terra santa.
[34]Ho
visto l’afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito il loro
gemito e sono sceso a liberarli; ed ora vieni, che ti mando in
Egitto.
[35]Questo
Mosè che avevano rinnegato dicendo: Chi
ti ha nominato capo e giudice?,
proprio lui Dio aveva mandato per esser capo e liberatore, parlando
per mezzo dell’angelo che gli era apparso nel roveto.
[36]Egli
li fece uscire, compiendo
miracoli e
prodigi nella terra d’Egitto,
nel Mare Rosso, e nel
deserto per quarant’anni.
[37]Egli
è quel Mosè che disse ai figli d’Israele:
Dio vi farà
sorgere un profeta tra i vostri fratelli, al pari di me.
[38]Egli
è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore
tra l’angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri;
egli ricevette parole di vita da trasmettere a noi.
[39]Ma i
nostri padri non vollero dargli ascolto, lo respinsero e si
volsero in cuor
loro verso
l’Egitto,
[40]dicendo
ad Aronne: Fa’
per noi una divinità che ci vada innanzi, perché a
questo Mosè che ci condusse fuori dall’Egitto non
sappiamo che cosa sia accaduto.
[41]E
in quei giorni
fabbricarono un
vitello e offrirono sacrifici
all’idolo e si
rallegrarono per l’opera delle loro mani.
[42]Ma Dio si
ritrasse da loro e li abbandonò al culto dell’esercito
del cielo, come
è scritto nel libro dei Profeti:
[43]Mi
avete forse offerto vittime e sacrifici per quarant’anni nel
deserto, o casa d’Israele? Avete preso con voi la tenda di
Mòloch, e la stella del dio Refàn, simulacri che vi
siete fabbricati
per adorarli!
Perciò vi deporterò al di là di
Babilonia.
[44]I nostri padri avevano nel deserto la
tenda della testimonianza,
come aveva ordinato colui che disse
a Mosè di costruirla secondo il modello che aveva visto.
[45]E
dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè se la
portarono con sé nella conquista
dei popoli che
Dio scacciò davanti a loro, fino ai tempi di
Davide.
[46]Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò
di poter trovare
una dimora per il Dio di Giacobbe;
[47]Salomone
poi gli
edificò una casa.
[48]Ma
l’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo,
come dice il Profeta:
[49]Il
cielo è il mio trono e la terra sgabello per i miei piedi.
Quale casa potrete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà
il luogo del mio riposo?
[50]Non
forse la mia mano ha creato tutte queste cose?
[51]O
gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie,
voi sempre opponete
resistenza allo Spirito Santo;
come i vostri padri, così anche voi.
[52]Quale dei profeti
i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete
divenuti traditori e uccisori;
[53]voi che avete ricevuto la legge
per mano degli angeli e non l’avete osservata».
[54]All’udire
queste cose, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di
lui.
[55]Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al
cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua
destra
[56]e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il
Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio».
[57]Proruppero
allora in grida altissime turandosi gli orecchi; poi si scagliarono
tutti insieme contro di lui,
[58]lo trascinarono fuori della città
e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai
piedi di un giovane, chiamato Saulo.
[59]E così lapidavano
Stefano mentre pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli
il mio spirito».
[60]Poi piegò le ginocchia e gridò
forte: «Signore, non imputar loro questo peccato». Detto
questo, morì.
*
Il lungo discorso di Stefano, infarcito quanto mai di citazioni veterotestamentarie, è stato qui collocato dai redattori degli Atti per evidenziare il progressivo formarsi di un’ermeneutica cristiana sostanzialmente diversa da quella del giudaismo ortodosso.
Il diacono ellenista non rispetta i canoni esegetici della storiografia ufficiale allora dominante, per la semplice ragione che vuole incentrare tutto il suo discorso su una tesi per lui evidente: la fine del primato storico della nazione giudaica, ovvero della capitale Gerusalemme e in particolare del suo secondo tempio, coincidono con le vicende occorse al messia Gesù.
Riportando fonti e tradizioni extra-bibliche e fondendole con la nuova eresia cristiana, Stefano si fa portavoce di un modo alquanto discutibile d’interpretazione della storia, in quanto subordina il passato al presente, cioè la storia dell’ebraismo all’ideologia emergente del cristianesimo apostolico, al punto che la vantata superiorità del cristianesimo sull’ebraismo non è posta come questione pratica da dimostrare, ma semplicemente come confronto opinabile di idee, in cui le cristiane hanno il privilegio d’inverare le ebraiche.
E nel contesto degli Atti il tentativo di fare del cristianesimo una teologia più completa ed esaustiva dell’ebraismo appare riuscito, proprio perché ciò che qui viene manipolato (in questo caso da Stefano, ma prima di lui da Pietro) non era storia autentica ma storia romanzata, mitologica, sicché in realtà Stefano altro non ha fatto che sostituire a una storiografia religiosa e quindi fantastica una propria storiografia altrettanto irreale. Basta vedere, in tal senso, il rapporto che stabilisce tra Mosè e Gesù: parlando del primo Stefano pensa sempre al secondo, così come appare nell’attribuzione di riferimento che egli crede di ravvisare nella stessa profezia di Mosè (v. 37). Questo criterio ermeneutico applicato a molti passi veterotestamentari (specie a quelli profetici) s’imporrà come naturale nell’ambito del cristianesimo fino agli studi critici di Bauer e di Strauss della Sinistra hegeliana.
A giudizio di Stefano, il primato d’Israele, così come s’andò configurando a partire da Salomone, non avrebbe mai dovuto esistere. Abramo infatti – dice l’ellenista, smentendo la stessa Bibbia – non ebbe «alcuna proprietà» nella terra di Canaan, e neppure i suoi discendenti, che finirono schiavi nelle mani del faraone. Stefano, nel suo elenco di personaggi biblici, sostiene di condividere l’operato di Abramo, dei patriarchi, di Mosè, Giosuè, Davide, ma non quello di Salomone, proprio perché questi «edificò una casa» (il tempio) a Jahvè (v. 47). «L’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mani d’uomo» (v. 48), afferma un po’ enfaticamente.
Senza negare il valore della circoncisione, egli considera finita la centralizzazione del culto nel tempio della capitale giudaica e quindi il primato storico della stessa nazione; primato che è andato definitivamente perduto, secondo la sua analisi, nel momento stesso in cui, in nome della centralizzazione cultuale, s’è giustiziato il Cristo.
Le accuse di Stefano sono gravi: egli giudica «pagane» («nel cuore e nelle orecchie») le autorità sinedrite e sostiene che queste si oppongono «sempre» allo Spirito santo (concetto, questo dello «Spirito santo», del tutto estraneo agli ebrei, almeno per come lo formularono i cristiani, e che in quel momento possono al massimo aver interpretato come «sapienza divina»).
Stefano in sostanza, al cospetto delle autorità sinedrite, contrappone, come già Gesù con la samaritana al pozzo di Giacobbe, il tempio allo spirito, ma, a differenza del Cristo, usa invettive molto forti, che non offrono, in ultima istanza, alcuna possibilità di dialogo. Da un lato egli sembra dare per scontato che tali autorità, i cui interessi sono strettamente vincolati alla gestione del tempio, non possano in alcun modo cambiare mentalità; dall’altro fa comunque di tutto per indurle a rinunciare spontaneamente al loro potere.
Il v. 52, in tal senso, è particolarmente aspro: «Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato?». Stefano, in sostanza, mira a persuadere le autorità di una cosa che mai avrebbero ammesso, e cioè che di tutta la storia del popolo ebraico solo singole personalità (Abramo, Mosè ecc.) potevano essere accettate. In particolare egli afferma che i «loro padri», ovvero il potere del tempio costituitosi nell’arco di molti secoli, «uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori». Si badi che Stefano non arriva a dire, al v. 56, che Gesù sia «figlio di Dio», poiché questa acquisizione teologica sarà a lui posteriore, frutto della predicazione paolina.
Senza una vera preoccupazione storiografica, Stefano sostiene, con fare pretenzioso, che siccome i «padri» uccisero i «profeti», così le autorità del tempio non potevano che uccidere il «Giusto» preannunciato dagli stessi profeti. Un modo, questo, di leggere la storia del popolo ebraico, che verrà poi ereditato e sviluppato enormemente, in maniera non meno arbitraria, da uno dei carnefici dello stesso Stefano, e cioè Paolo di Tarso. Le leggi del typos e dell’antitypos, della figura e della realtà, relativamente ai rapporti tra Antico e Nuovo Testamento, qui vengono completamente stravolte se non del tutto inventate.
È incredibile che si sia avuto il coraggio di dire (ma è probabile che qui le mani redazionali degli Atti abbiano avuto la loro parte) che i profeti, quando venivano perseguitati, era a motivo del fatto che auspicavano la venuta del «Giusto» e che questi altro non era che il «Cristo». Stefano poteva avere tutte le ragioni a contestare il tempio in sé, in quanto istituzione conservatrice sin dalla fondazione, ma non era certo in diritto di attribuire a questa sola istituzione la causa di tutti i mali (passati e recenti) della società ebraica.
Colpevolizzando radicalmente il ruolo dei sacerdoti che si erano succeduti alla guida del tempio, Stefano in sostanza ne sopravvalutava il peso politico, mentre è noto che almeno sino alla cattività babilonese il clero dovette spartire il potere con la monarchia e l’aristocrazia laica, e anche dopo la liberazione ad opera del persiano Ciro, esso fu sempre vincolato a deliberazioni prese oltre i confini nazionali. Persino sul piano socioeconomico il clero ha sempre dovuto spartire il potere, in Giudea, coi ceti più facoltosi: notabili, latifondisti, funzionari, mercanti..., di religione ebraica e non. L’aristocrazia, sicuramente più laica dei sommi sacerdoti, non era forse rappresentata nel Sinedrio dagli «anziani»? Stefano ha forse dimenticato che procuratore della Giudea era Pilato? e che nemici dei cristiani non erano solo i preti corrotti ma anche gli oppressori romani e i collaborazionisti erodiani e i settari terroristi e gli ambigui farisei...?
Indubbiamente il discorso di Stefano ha una connotazione fondamentalista, che invece quelli pronunciati in precedenza da Pietro non avevano. Ciò è dipeso molto probabilmente dal fatto che, provenendo dalla diaspora, Stefano si sentiva meno influenzato dall’ideologia del tempio. Tuttavia, proprio l’asprezza dei toni deve indurci a credere che ancora molto forti dovevano essere i rapporti di dipendenza tra diaspora e giudaismo ortodosso. Non è da escludere che Stefano fosse giunto nella capitale proprio allo scopo di condannare i privilegi e l’autoritarismo dei sacerdoti o dei sinedriti. Nel suo discorso non sembrano esservi possibilità per una realistica mediazione.
Oltre a ciò va detto che Stefano ha imbastito un discorso radicale in un momento del tutto sbagliato, in quanto dominato dal riflusso apostolico dopo la spinta rivoluzionaria capeggiata dal Cristo. Portando alle estreme conseguenze l’interpretazione apostolica della tomba vuota, egli vuol fare della tesi petrina della resurrezione la leva fondamentale con cui scardinare il primato d’Israele e del suo tempio religioso.
Stefano non riconosce ad alcuna istituzione giudaica alcun potere, neppure quello relativo alla legge mosaica, poiché esplicitamente afferma che i giudei «hanno ricevuto la legge per mano degli angeli e non l’hanno osservata» (v. 53). Come si può notare, non era solo questione della critica alla centralizzazione del culto o alla corruzione del clero, ma addirittura di come rimettere in discussione, per superarla decisamente, l’interpretazione e l’applicazione della legge mosaica. Cosa che in effetti anche il Cristo aveva posto all’ordine del giorno, ma in un dibattito con le folle o al massimo coi farisei (cfr Gv 7,19).
Stefano non cerca alleanze politiche (neppure in via provvisoria) con nessuna componente del Sinedrio. E non sembra neppure comunicare con le masse, al fine di realizzare un movimento d’opinione che lo appoggi nella sua battaglia anti-istituzionale. Egli anzi sembra voler provocare esplicitamente un conflitto di tipo ideologico-politico, escludendo a priori qualunque forma di «coesistenza pacifica» con le autorità.
Stefano è un politico cristiano irriducibile ed estremista, coraggioso sì ma come può esserlo chiunque faccia della politica una forma di avventurismo. Esprimendo gli interessi e le esigenze di una ristretta minoranza: gli ellenisti della comunità cristiana, il suo destino sembra facilmente prevedibile. Tant’è che, a differenza delle tesi sostenute da Pietro, le sue trovano all’opposizione non solo le autorità costituite ma anche gli stessi farisei: tutti insomma lo volevano morto.
In effetti Stefano non proponeva alcuna vera alternativa politica compatibile con gli interessi del giudaismo; liquidando frettolosamente e irreversibilmente le pretese politico-nazionalistiche della Palestina, in nome di una generica e moralistica «vita nello spirito», nella consapevolezza di un messia redivivo ma invisibile, egli mostrava di voler abdicare definitivamente all’egemonia romana.
A dir il vero Luca (o l’autore di questo racconto) mira a collocare Stefano sulla stessa linea politica del Cristo, ma il tentativo è, come si può facilmente notare, malriuscito. Gli esempi sono molteplici: Stefano che si trasfigura come Mosè e Gesù (6,15), i falsi testimoni di 6,13, che si trovano anche nel processo contro Gesù, l’analoga accusa di «voler distruggere il tempio», la finale del processo (7,56 s.), che riecheggia quella di Gesù in Mt 26,62 ss., persino le parole dette in punto di morte (7,60), che rievocano quelle dette da Gesù in Lc 23,34 – tutto ciò ha davvero poco senso storico e molto senso apologetico.
Gesù non disse mai che avrebbe distrutto il tempio, ma solo che se l’avessero aiutato a farlo, sul piano etico, superandone cioè la corruzione, egli l’avrebbe riedificato, con l’aiuto del popolo, in poco tempo, offrendo un’opportunità di aggregazione intorno a un progetto rivoluzionario antiromano. La riedificazione in tre giorni era solo un modo di far capire l’urgenza della cosa e la sua pratica fattibilità.
Al pari di Stefano, il Cristo non considerava riformabile il tempio, ma diversamente da lui non legava la riuscita della propria strategia politica a una preliminare distruzione dell’edificio materiale. Gesù non s’era mai spinto a fare rivendicazioni così estreme, anche perché non sperava che le autorità potessero rinunciare spontaneamente al loro potere, per quanto non sottovalutasse la possibilità di trovare degli alleati tra gli stessi sinedriti (vedi il caso di Nicodemo o quello dell’Arimatea).
Quando Gesù cacciò i mercanti dal tempio, mostrando in questo più coraggio di quanto ne avesse il Battista, lo scopo non era stato certo quello d’indurre le masse a distruggere materialmente il tempio, ma semplicemente quello di reagire prontamente e in prima persona alla sua corruzione, senza aspettare improbabili cambiamenti dall’alto. Il tempio avrebbe perso la sua importanza progressivamente e si sarebbe trasformato in un rudere soltanto quando le masse avessero vinto dentro di loro ogni sorta di paura e di sfiducia. Il vero problema, per il movimento nazareno, non era quello di come conciliare delle posizioni religiose con l'istanza rivoluzionaria antiromana, ma come impedire che queste posizioni venissero gestite politicamente dalle autorità del tempio.
Stefano, insomma, compie una contestazione politico-religiosa da un punto di vista meramente ideologico, cioè si serve di un’ideologia, quella cristiana, per condannare en bloc tutto l’ebraismo. Egli sembra ripudiare le autorità non solo come fonte o come complici di un’oppressione politica delle masse, ma anche come controparte ideologica avversa al cristianesimo. Ecco perché il suo discorso, se può avere dei lati condivisibili sul piano teorico, politicamente è scorretto, privo di senso tattico e strategico, troppo schematico e unilaterale.
A suo giudizio le autorità del tempio avrebbero ucciso o fatto uccidere Gesù dai romani non solo perché legate a interessi di potere contrapposti, ma anche perché, essendo vincolate all’uso e abuso del tempio, non potevano che comportarsi così. Il che vuol dire che per Stefano il perno di tutte le contraddizioni era la centralizzazione del culto, ovvero l’autoritarismo di una fede decisa dall’alto. Egli non riusciva a cogliere questo limite come espressione di una contraddizione assai più vasta, quella di origine socioeconomica.
Stefano pensa di dover combattere il centralismo autoritario del tempio con la democrazia decentrata delle piccole comunità, ma non fa neanche un accenno al rapporto fra masse oppresse (ebraiche e non) e oppressori (romani e collaborazionisti). La sua unica vera alternativa al culto politico-religioso del tempio resta, eticamente, la «vita nello spirito», sul modello di quella proposta da un Gesù pacifista e pluriconfessionale alla samaritana presso il pozzo di Giacobbe. Un Gesù che, se mai disse quelle cose, le pensò nella prospettiva di una rivoluzione di popolo e non in quella della sua rinuncia.
Pertanto, tutta questa ricercata identificazione di Stefano con Gesù alla lunga non regge. Il fatto stesso che l’uno sia stato lapidato e l’altro crocifisso sarebbe sufficiente per escluderla. Se Gesù fosse stato un estremista semi-isolato come Stefano, se non avesse fruito di ampi appoggi popolari, probabilmente avrebbe fatto la sua stessa fine. Si può anzi forse azzardare che con Stefano inizia quella tradizione irrazionale che fa coincidere il martirio (a imitazione della morte violenta del Cristo) col supremo momento della verità di sé. Il perseguitato, nella pantomimica rivoluzionaria, è eo ipso un «giusto» le cui parole sono «vere» per definizione.
D’altro canto i discorsi pronunciati da Pietro, prima di questo tragico episodio, non costituivano certo un’alternativa convincente a quello di Stefano. Pietro cercava un compromesso col movimento farisaico non sul piano tattico ma su quello strategico, cioè un’intesa di lunga durata, con cui legittimare la rinuncia agli ideali rivoluzionari.
Sarebbe interessante poter verificare, con altri testi alla mano, se la posizione di Stefano e degli altri ellenisti non possa essere configurata come una sorta di «ala sinistra» radicaleggiante della posizione «centrista» rappresentata dagli apostoli. Forse si potrebbe sostenere che gli ellenisti avevano reagito negativamente all’atteggiamento troppo diplomatico assunto dai Dodici nei confronti delle autorità giudaiche e, in tal senso, essi rischiavano di creare un’insanabile frattura tra i cristiani orientati verso il riformismo e le autorità del tempio, di cui l’ala farisaica sembrava, dopo l’eliminazione di Gesù, maggiormente disponibile a un confronto paritetico.
Rebus sic stantibus, si può forse ipotizzare che la questione della discriminazione delle vedove elleniste, nella distribuzione delle offerte, può essere stata usata come pretesto per affermare una sorta di contropotere all’interno della neonata comunità cristiana, che si ponesse in maniera parallela a quello dei Dodici.
È significativo che gli ellenisti si siano serviti di una contraddizione economica per rivendicare alla fine un’autonomia politica e ideologica, addirittura il diritto di poter predicare come gli apostoli. Sebbene i Dodici si siano limitati ad assegnare loro una mera funzione amministrativa, Stefano (e dopo di lui Filippo) si spinsero fino a reclamare dei diritti anche sul piano ideologico e politico (Filippo sceglierà da solo la Samaria come terra di missione).
Da questo punto di vista non fa meraviglia che nella persecuzione che colpì la Chiesa subito dopo gli atti di Stefano, i Dodici venissero risparmiati (8,1).
torna suCap. 8
[1]Saulo
era fra coloro che approvarono la sua uccisione. In quel giorno
scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi
nelle regioni della Giudea e della Samarìa.
[2]Persone pie
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui.
[3]Saulo
intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva
uomini e donne e li faceva mettere in prigione.
[4]Quelli però
che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la
parola di Dio.
[5]Filippo, sceso in una città della
Samarìa, cominciò a predicare loro il Cristo.
[6]E
le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo
parlare e vedendo i miracoli che egli compiva.
[7]Da molti
indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti
paralitici e storpi furono risanati.
[8]E vi fu grande gioia in
quella città.
[9]V’era da tempo in città un
tale di nome Simone, dedito alla magia, il quale mandava in visibilio
la popolazione di Samarìa, spacciandosi per un gran
personaggio.
[10]A lui aderivano tutti, piccoli e grandi,
esclamando: «Questi è la potenza di Dio, quella che è
chiamata Grande».
[11]Gli davano ascolto, perché per
molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue magie.
[12]Ma
quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella
del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si
facevano battezzare.
[13]Anche Simone credette, fu battezzato e
non si staccava più da Filippo. Era fuori di sé nel
vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano.
[14]Frattanto
gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva
accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni.
[15]Essi
discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito
Santo;
[16]non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù.
[17]Allora
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito
Santo.
[18]Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con
l’imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del
denaro
[19]dicendo: «Date anche a me questo potere perché
a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo».
[20]Ma
Pietro gli rispose: «Il tuo denaro vada con te in perdizione,
perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di
Dio.
[21]Non v’è parte né sorte alcuna per te
in questa cosa, perché
il tuo cuore non
è retto davanti a Dio.
[22]Pèntiti
dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia
perdonato questo pensiero.
[23]Ti vedo infatti chiuso
in fiele amaro e
in lacci d’iniquità».
[24]Rispose
Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi
accada nulla di ciò che avete detto».
[25]Essi poi,
dopo aver testimoniato e annunziato la parola di Dio, ritornavano a
Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi della Samarìa.
[26]Un
angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e
va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da
Gerusalemme a Gaza; essa è deserta».
[27]Egli si alzò
e si mise in cammino, quand’ecco un Etìope, un eunuco,
funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a
tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme,
[28]se ne
ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta
Isaia.
[29]Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’
avanti, e raggiungi quel carro».
[30]Filippo corse innanzi
e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci
quello che stai leggendo?».
[31]Quegli rispose: «E
come lo potrei, se nessuno mi istruisce?». E invitò
Filippo a salire e a sedere accanto a lui.
[32]Il passo della
Scrittura che stava leggendo era questo:
Come una pecora
fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo
tosa, così egli non apre la sua bocca.
[33]Nella
sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua
posterità chi potrà mai descriverla? Poiché è
stata recisa dalla terra la sua vita.
[34]E
rivoltosi a Filippo l’eunuco disse: «Ti prego, di quale
persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun
altro?».
[35]Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel
passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di
Gesù.
[36]Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo
dove c’era acqua e l’eunuco disse: «Ecco qui c’è
acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?».
[37]Filippo
dice: «Se credi con tutto il cuore, è permesso».
Rispose allora l’eunuco: «Credo che Gesù Cristo è
il Figlio di Dio».
[38]Fece fermare il carro e discesero
tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo
battezzò.
[39]Quando furono usciti dall’acqua, lo
Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide
più e proseguì pieno di gioia il suo
cammino.
[40]Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e,
proseguendo, predicava il vangelo a tutte le città, finché
giunse a Cesarea.
*
Approfittando della diatriba violenta inaugurata dalle filippiche di Stefano, le autorità del tempio, in primis i sadducei, organizzano una repressione di massa contro i cristiani, in specie ovviamente gli ellenisti, cui aderirono anche i farisei, sebbene proprio questi permisero ai Dodici d’essere risparmiati.
«Quelli però che [a seguito delle retate] erano stati dispersi (nelle regioni della Giudea e della Samaria) – rassicura Luca – diffondevano la parola di Dio» (v. 4). Col che, beninteso, egli non pensa affatto a sostenere che, siccome la persecuzione favoriva indirettamente la diffusione del vangelo, allora l’operato di Stefano va visto con entusiastico apprezzamento. Luca è uno scrittore troppo equilibrato per poter cadere in simili ingenuità. In tempi e modi diversi i cristiani avrebbero compreso ugualmente l’esigenza di diffondere il loro messaggio anche agli ebrei non ortodossi, come appunto, p.es., i samaritani. Sappiamo tuttavia che gli Acta Apostolorum sono il frutto di un compromesso di varie tendenze.
È inevitabile supporre che anche in una situazione di relativa convivenza pacifica, i cristiani, soprattutto gli ellenisti, di fronte al rifiuto delle autorità del tempio di accettare un confronto con la teologia emergente del cristianesimo apostolico, avrebbero ad un certo punto optato per una diversificazione dei propri interlocutori, visto e considerato che difficilmente si sarebbero spinti verso un’esplicita azione politica destabilizzante. Già nel suo vangelo Luca l’aveva fatto dire a Gesù: «Quanto a coloro che non vi accolgono, nell’uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi, a testimonianza contro di essi» (9,5).
Dal punto di vista politico, la situazione dei cristiani era diventata così ambigua che probabilmente essi si sarebbero dati all’attività missionaria anche dopo aver realizzato con le autorità giudaiche un’intesa reciprocamente vantaggiosa.
Fra gli ellenisti che scelgono la predicazione itinerante in luogo del carcere nella capitale, va annoverato il diacono Filippo, il secondo citato nella lista di 6,5, il quale «sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo» (v. 5), riscuotendo uno strabiliante successo, al punto che un redattore assai più limitato di Luca non ha riserve nel descrivere fantastici miracoli e prodigi di varia natura (vv. 6-8), salvo tacere sull’identità del luogo in cui avvenivano.
Il successo fu così grande che anche il popolarissimo mago Simone – presumiamo di quella stessa anonima città – decise di aderire alla predicazione di Filippo. Simone – scrive Luca – «mandava in visibilio la popolazione di Samaria, spacciandosi per un gran personaggio» (v. 9). «Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche Simone credette, fu battezzato e non si staccava più da Filippo» (vv. 12-13).
Forse memori di quanto Cristo aveva loro promesso, negli anni passati, e della buona accoglienza che avevano tributato a un messia di origine giudaica che non aveva difficoltà a considerare gli «eretici» samaritani come partner politici a tutti gli effetti nella lotta antiromana, la popolazione di questa e forse di altre città decise di accettare la predicazione di Filippo in luogo di quella di Simone. A queste folle, con esigenze di tipo politico-sociale, l’imbonitore Simone, confrontato a Filippo, appariva troppo limitato e superficiale; ancora purtroppo esse non erano in grado di rendersi conto che il contenuto della predicazione di Filippo, non avendo nulla di politicamente significativo, non era meno illusorio del messaggio magico del suo avversario.
Probabilmente Simone credette e si fece battezzare perché il background culturale della predicazione di Filippo mostrava aspetti di maggiore concretezza e di maggiore socializzazione del bisogno, e quindi risultava più convincente.
Tuttavia la cosa singolare non è tanto questa improvvisa e sospetta conversione, quanto il fatto che Filippo era in grado di «battezzare». Proseguendo la linea autonomistica (rispetto al potere accentratore dei Dodici) inaugurata da Stefano con la sua battaglia contro le autorità del tempio, Filippo considera come naturale il diritto di battezzare quanti accettavano senza condizioni il suo messaggio evangelico. Non sono più soltanto i Dodici ad autorizzare l’ingresso in comunità, ma, a partire da questo momento, s’è fatta avanti una pretesa che, pur non avendo ancora trovato un consenso esplicito da parte del collegio apostolico, diverrà in certo qual modo irreversibile.
Da notare che Filippo condivise senza particolari problemi l’adesione di Simone alla sua comunità, forse nella speranza di poter svolgere più agevolmente la propria missione propagandistica. Ma proprio questo fatto incontrerà – come vedremo – ostacoli di non poco conto da parte dell’ufficialità cristiana.
I Dodici, rimasti a Gerusalemme in occasione della repressione antiellenistica, saputo «che la Samaria aveva accolto la parola di Dio vi inviarono Pietro e Giovanni» (v. 14). Significativo è qui il fatto che gli apostoli rivendicano il potere di stabilire, in ultima istanza, quanto la predicazione di Filippo, che evidentemente non era stato mandato in missione, fosse giusta o sbagliata. Luca dice chiaramente, smentendo le pretese degli ellenisti, che il battesimo amministrato da Filippo non aveva l’autorità e quindi l’efficacia di quello amministrato dagli apostoli. Solo i Dodici infatti potevano concedere lo «spirito santo» (vv. 15-17), cioè la verità interpretativa del messaggio cristico.
È evidente che si deve far risalire a questo episodio l’esigenza egemonica di controllo centralizzato della divulgazione del vangelo e del primo sacramento, il battesimo, che la Chiesa adottò sulla scia della obsoleta prassi essenica del Precursore. Il conflitto con gli ellenisti era divenuto così preoccupante che i Dodici furono costretti a inventarsi un nuovo sacramento col quale confermare l’operato di Filippo, e cioè la cresima.
Luca infatti è costretto ad affermare che il battesimo del cristiano Filippo, pur concesso «nel nome del Signore Gesù» (v. 16), era privo del dono dello Spirito santo. È sottile la distinzione tra «battesimo nel nome di Gesù» e «battesimo in nome dello Spirito»: essa è appunto servita ai Dodici per salvaguardare il loro potere specifico di depositari di una verità indiscutibile. Nelle loro mani lo Spirito era diventato una forma di proprietà specifica appartenente a una casta intoccabile, la cui autorità proveniva unicamente dal fatto d’essere stati diretti discepoli del Cristo e d’aver condiviso la tesi della resurrezione. Tutto ciò, o meglio, la prima parte di tutto ciò – come vedremo – verrà messa profondamente in discussione da Paolo di Tarso.
Che il dissenso nei confronti della tattica dirompente degli ellenisti avesse raggiunto il colmo, è qui testimoniato anche dal fatto che i Dodici non inviarono due apostoli qualsiasi ma addirittura i loro capi, Pietro e Giovanni (ma è dubbio che quest’ultimo fosse proprio l’apostolo), che avrebbero dovuto convincere Filippo e gli altri ellenisti, e al v. 17 pare vi siano riusciti, ad accettare l’idea, ridimensionando così la portata del sacrificio di Stefano, che il loro battesimo non poteva avere la stessa autorevolezza né poteva offrire le stesse garanzie di quello amministrato dagli apostoli.
È a questo punto che scoppia, com’era facile prevedere, un forte contrasto tra Simone e Pietro. Resosi conto che i poteri di Pietro e Giovanni erano maggiori di quelli di Filippo e che i due apostoli, a differenza del diacono ellenista, erano meno disposti a spartirli con altri, Simone, che non voleva perdere il proprio protagonismo, pensò di poter corrompere i due leader dietro un certo compenso in denaro. Abituato a trucchi ed espedienti di vario genere, egli ricorre, in maniera del tutto irresponsabile, ma in linea con l’arrivismo di chi vuole emergere a tutti i costi, a una prassi tipica delle società antagonistiche: vuole comprare col denaro l’autorità del potere (nella fattispecie la carica stessa di apostolo o di amministratore dei sacramenti). Di qui il termine spregiativo di «simonia», che la Chiesa cristiana applicherà al commercio delle cose sacre o delle cariche ecclesiastiche.
Gli apostoli tuttavia consideravano, almeno in questa fase, i loro poteri intrasmissibili e molto probabilmente non avrebbero mai accettato di condividerli in forme così meschine. Ma a parte questo, che fa comunque onore ai due leader cristiani, l’esplicito rifiuto di patteggiare stava anche ad indicare che nel complesso le condizioni che gli apostoli ponevano ai neoconvertiti restavano di livello superiore a quelle poste dagli ellenisti: il che non può non aver influito sui futuri rapporti dei due apostoli con Filippo.
Dunque Pietro, nella convinzione che l’autorità apostolica non possa essere ceduta a chicchessia, tanto meno barattata in cambio del vile denaro, rifiuta offeso e scandalizzato. Tuttavia egli non specifica che detta autorità possa essere acquistata «eticamente», cioè sulla base di virtù personali, in stretta aderenza alla vita e agli ideali della comunità d’origine (come invece si preoccuperà di sostenere Paolo), altrimenti non avrebbe potuto giustificare la propria ingerenza nella missione degli ellenisti.
Egli si limita semplicemente a far capire che la loro autorità è intangibile, voluta direttamente dal Cristo; lo stesso Spirito santo è un dono conferito, in uso esclusivo, agli apostoli, senza che ne abbiano la proprietà personale, cedibile a terzi. Lo Spirito resta proprietà di Dio e come tale può essere conferito solo attraverso la loro mediazione.
Simone ovviamente non poteva sapere che queste motivazioni traevano origine da complessi fattori politici, che andavano ben oltre le priorità concesse da Pietro all’etica sull’economia. Proprio nel momento stesso in cui gli apostoli avevano creduto di non potersi sostituire al Cristo proseguendone il messaggio rivoluzionario, essi avevano avuto bisogno di affermare una stretta dipendenza del loro operato direttamente da Dio e dai privilegi che questa astratta entità poteva elargire: in tal modo si premunivano dall’accusa di aver tradito gli ideali del loro leader.
È forse in grado Simone di accettare questi principi perentori, che sembrano non avere alcuna soluzione di continuità? Solo in parte. All’invito fattogli da Pietro di pentirsi e di pregare Dio che lo perdoni, Simone, troppo abituato a calcare le scene da protagonista, risponde ambiguamente, quasi temendo che i rimproveri di Pietro possano fargli perdere la poca credibilità rimastagli, l’ultima risicata ascendenza sulle folle: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto» (v. 24).
È da presumere che da allora Simone non abbia più continuato a partecipare alla vita della comunità, avvertendo come irrimediabilmente compromessa la sua posizione ufficiale. Proprio nel momento in cui aveva pensato, aderendo al messaggio di Filippo, di poter continuare una carriera ancora più gloriosa di quella di prima, si era praticamente ritrovato con un pugno di mosche.
Pietro e Giovanni tuttavia non rimasero in Samaria, ma – dice Luca – «dopo aver testimoniato e annunziato la parola di Dio [quasi volessero far concorrenza alla predicazione di Filippo], ritornarono a Gerusalemme» (v. 25).
La vittoria però fu di breve durata. Gli Atti di Filippo infatti si dividono in due parti: nella seconda, l’ultima, la medesima tradizione ellenistica confluita negli Atti di Luca cerca una rivalsa nei confronti dei Dodici.
Vediamo la chiusa del capitolo. Filippo torna di nuovo a predicare, inviato questa volta «da un angelo del Signore» (v. 26), che sostituisce lo «Spirito» del v. 29, di cui Filippo – avevano detto i due apostoli – non poteva essere titolare. Lo fa, questa volta, a sud della Palestina, ai confini tra la Giudea e l’Idumea; il v. 26 parla di una «strada deserta [nei pressi infatti esiste il deserto di Giuda] che discende da Gerusalemme a Gaza» (ex città filistea situata sulla costa mediterranea).
Qui Filippo incontra un etiope (del Sudan settentrionale) molto importante, in quanto amministratore generale di tutti i tesori di Candàce (che è titolo non nome di persona), regina d’Etiopia. Il funzionario, che stava tornando al suo paese, non era evidentemente un pagano, poiché aveva partecipato a un culto nella città di Gerusalemme (sebbene qui non precisato), inoltre nel testo viene detto che leggeva, per strada, il profeta Isaia (v. 28), e molto probabilmente non era neppure ebreo, in quanto eunuco (v. 27); gli esegeti pensano fosse di origine araba.
I versetti che in lingua greca stava leggendo sono, almeno per come li riporta Luca, una traduzione poco chiara d’un testo ebraico oscuro o alterato: sicché ancora una volta ci troviamo alle prese con le manipolazioni esegetiche dei redattori cristiani (in questo caso ellenisti) ai danni di quei passi veterotestamentari utilizzabili in maniera apologetica, a motivo della loro ambiguità o genericità o anche poeticità.
Isaia 53, in particolare, è stato sin dagli inizi della predicazione cristiana, abbondantemente travisato e strumentalizzato, al fine di dimostrare a quegli ebrei che attendevano la venuta del messia restauratore del regno davidico, che questi in realtà era già venuto nella persona del Cristo morto e risorto.
Il funzionario non riusciva a comprendere in maniera adeguata il senso del brano che stava leggendo, il cui motivo fondamentale era l’ingiusta sofferenza d’un uomo importante, una sofferenza – direbbe Kierkegaard – che porta alla morte.
Filippo, «partendo da quel passo della Scrittura, gli annunciò la buona novella di Gesù» (v. 35), cioè il fatto che pur nella sofferenza e persino nella morte di un grande uomo è possibile vedere l’occasione per iniziare un discorso che dia speranza ai viventi. Nulla infatti potrà impedire alle giuste idee di una persona di trovare dei seguaci dopo la sua morte.
L’etiope non attendeva il messia, né pensava a una liberazione sociale o politica degli oppressi dalla schiavitù, però si rendeva conto che il tema dell’ingiusta sofferenza (facilmente collegabile, peraltro, alla sua condizione di eunuco) non trovava nella letteratura del suo tempo una spiegazione convincente.
Filippo accetta di battezzarlo, mostrandogli che il sacrificio dell’evirazione per il bene della regina e del suo regno sarebbe stato umanamente ed eternamente riscattato nell’aldilà, ad immagine del Cristo risorto, il cui sacrificio era stato infinitamente più grande.
La cosa più importante però è che in questo battesimo, a differenza dei precedenti in Samaria, lo Spirito – viene detto nel racconto – scese sull’etiope: nella variante occidentale del v. 39 questo è chiarissimo. Alla domanda del funzionario: «che cosa m’impedisce d’essere battezzato?» (v. 36), l’antica glossa conservata nel testo occidentale riporta l’interessante risposta di Filippo: «Se credi con tutto il cuore, è permesso» (v. 37). Al che quello rispose: «Credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio» (v. 37).
Questo scambio di battute ha un significato evidente: gli ellenisti, ad un certo punto, si convinsero che per ottenere lo Spirito era sufficiente credere in coscienza nella divinità di Gesù. Una qualsiasi altra conferma da parte degli apostoli sarebbe stata inutile, anzi inopportuna, e Paolo, di lì a poco, lo dirà senza mezzi termini.
torna suCap. 9
[1]Saulo
frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del
Signore, si presentò al sommo sacerdote
[2]e gli chiese
lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a
condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della
dottrina di Cristo, che avesse trovati.
[3]E avvenne che, mentre
era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso
lo avvolse una luce dal cielo
[4]e cadendo a terra udì una
voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?».
[5]Rispose: «Chi sei, o Signore?».
E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti!
[6]Orsù,
alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò
che devi fare».
[7]Gli uomini che facevano il cammino con
lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo
nessuno.
[8]Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi,
non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a
Damasco,
[9]dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere
né cibo né bevanda.
[10]Ora c’era a Damasco un
discepolo di nome Ananìa e il Signore in una visione gli
disse: «Ananìa!». Rispose: «Eccomi,
Signore!».
[11]E il Signore a lui: «Su, va’
sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale
che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando,
[12]e ha visto in
visione un uomo, di nome Ananìa, venire e imporgli le mani
perché ricuperi la vista».
[13]Rispose Ananìa:
«Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto
il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme.
[14]Inoltre ha
l’autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli
che invocano il tuo nome».
[15]Ma il Signore disse: «Va’,
perché egli è per me uno strumento eletto per portare
il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele;
[16]e
io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio
nome».
[17]Allora Ananìa andò, entrò
nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio,
mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso
sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e
sia colmo di Spirito Santo».
[18]E improvvisamente gli
caddero dagli occhi come delle squame e ricuperò la vista; fu
subito battezzato,
[19]poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco,
[20]e
subito nelle sinagoghe proclamava Gesù Figlio di Dio.
[21]E
tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma
costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro
quelli che invocano questo nome ed era venuto qua precisamente per
condurli in catene dai sommi sacerdoti?».
[22]Saulo
frattanto si rinfrancava sempre più e confondeva i Giudei
residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il
Cristo.
[23]Trascorsero così parecchi giorni e i Giudei
fecero un complotto per ucciderlo;
[24]ma i loro piani vennero a
conoscenza di Saulo. Essi facevano la guardia anche alle porte della
città di giorno e di notte per sopprimerlo;
[25]ma i suoi
discepoli di notte lo presero e lo fecero discendere dalle mura,
calandolo in una cesta.
[26]Venuto a Gerusalemme, cercava di
unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo
ancora che fosse un discepolo.
[27]Allora Bàrnaba lo prese
con sé, lo presentò agli apostoli e raccontò
loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva
parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di
Gesù.
[28]Così egli poté stare con loro e
andava e veniva a Gerusalemme, parlando apertamente nel nome del
Signore
[29]e parlava e discuteva con gli Ebrei di lingua greca;
ma questi tentarono di ucciderlo.
[30]Venutolo però a
sapere i fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire
per Tarso.
[31]La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea,
la Galilea e la Samarìa; essa cresceva e camminava nel timore
del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.
[32]E avvenne
che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche
dai fedeli che dimoravano a Lidda.
[33]Qui trovò un uomo di
nome Enea, che da otto anni giaceva su un lettuccio ed era
paralitico.
[34]Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo
ti guarisce; alzati e rifatti il letto». E subito si
alzò.
[35]Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn
e si convertirono al Signore.
[36]A Giaffa c’era una
discepola chiamata Tabità, nome che significa «Gazzella»,
la quale abbondava in opere buone e faceva molte
elemosine.
[37]Proprio in quei giorni si ammalò e morì.
La lavarono e la deposero in una stanza al piano superiore.
[38]E
poiché Lidda era vicina a Giaffa i discepoli, udito che Pietro
si trovava là, mandarono due uomini ad invitarlo: «Vieni
subito da noi!».
[39]E Pietro subito andò con loro.
Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero
incontro tutte le vedove in pianto che gli mostravano le tuniche e i
mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro.
[40]Pietro
fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi rivolto alla
salma disse: «Tabità, alzati!». Ed essa aprì
gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere.
[41]Egli le diede la
mano e la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove, e la
presentò loro viva.
[42]La cosa si riseppe in tutta Giaffa,
e molti credettero nel Signore.
[43]Pietro rimase a Giaffa
parecchi giorni, presso un certo Simone conciatore.
*
La conversione dell’etiope era stata giustamente collocata da Luca dopo quella dei samaritani. Il funzionario della regina di Candace non era un ebreo «eretico», come i samaritani, ma probabilmente un uomo di origine araba, o comunque uno di origine più pagana che ebraica.
A questo punto diventa giocoforza, per i redattori degli Atti, introdurre il racconto, decisivo per gli sviluppi del futuro cristianesimo, della conversione di Saulo, cioè di colui che col nome di Paolo sarà chiamato dalla tradizione cristiana con l’appellativo univoco e altisonante di «apostolo dei gentili».
A causa della persecuzione contro gli ellenisti, il fariseo Saulo fruiva di una particolare considerazione da parte delle autorità del tempio. Il sommo sacerdote aveva l’autorità necessaria per costringere i capi-sinagoga di Damasco (in Siria) ad accettare ch’egli arrestasse «i seguaci della dottrina di Cristo» presenti in quella città. Le autorità romane riconoscevano al sommo sacerdote una certa giurisdizione su tutti i membri delle comunità giudaiche, residenti anche fuori della Palestina, compreso perfino, stando a 1 Mac 15,21, il diritto di estradizione.
Evidentemente Saulo, pur formatosi nella scuola democratica e tollerante di Gamaliele (22,3), doveva aver già compiuto altri arresti prima di questi: forse Damasco rappresenta qui una delle città più importanti, oppure viene semplicemente citata perché fu l’ultima in cui Saulo esercitò il ruolo di funzionario di polizia.
Nella Lettera ai Galati egli afferma che perseguitava «fieramente» la Chiesa cristiana, devastandola e «superando nel giudaismo la maggior parte (dei suoi) coetanei e connazionali, (accanito com’era) nel sostenere le tradizioni dei padri» (1,13 s.).
Il suo odio per i cristiani era dunque particolarmente forte: egli si rendeva conto che con la loro predicazione il primato d’Israele veniva a perdere ogni credibilità, ogni speranza di sopravvivenza e anzi di restaurazione davidica. I cristiani predicavano un messia morto (per una causa politica) e risorto (per una causa religiosa); gli ellenisti, in particolare, collegavano la cosiddetta «resurrezione di Gesù» alla fine della centralità cultuale del tempio. La morte del messia significava, per loro, la progressiva morte della concezione del «popolo eletto» e quindi il necessario superamento di molti aspetti della legislazione mosaica.
Per Saulo questo significava rinunciare all’esigenza di ripristinare l’antico regno d’Israele o quanto meno significava dover rinunciare all’esigenza di opporsi, in quanto giudei, al dominio romano, per quanto egli fosse del tutto consapevole che la resistenza antiromana non riusciva a dare i frutti sperati. Di fatto i romani dominavano incontrastati, non solo per la loro superiorità militare, ma anche e soprattutto grazie alle separazioni politico-ideali presenti fra i molti gruppi sociali della Palestina.
Saulo inoltre, in quanto fariseo tenacemente legato alla speranza di veder liberata la Giudea, era costretto a chiedere l’autorizzazione per perseguitare i cristiani proprio a quelle stesse autorità politico-religiose che, seppure sul piano ideologico restavano tenacemente legate alle tradizioni, spesso su quello politico facevano gli interessi di Roma.
Ora, che cosa gli accadde sulla strada che da Gerusalemme portava a Damasco, è difficile dirlo. Indubbiamente la coscienza politica di Saulo stava scontando degli acuti conflitti irrisolti, che ad un certo punto giunsero a un livello tale di tensione da determinare una drammatica svolta ideale e insieme esistenziale.
La
leggenda ha voluto attribuire a un’apparizione esplicita di
Gesù «avvolto in una luce dal cielo» (v. 3), la
causa di questa sua improvvisa conversione, ma qui non si deve
dimenticare:
1. che ci si trova in un contesto culturale dominato
dall’ideologia religiosa, la quale anche oggi, di fronte a
episodi del genere, non rinuncia a interpretazioni fantasiose o
comunque forzate;
2. che Paolo aveva bisogno di dimostrare la sua
affidabilità ai seguaci di una dottrina religiosa, che già
dicevano di credere in un messia «redivivo» e che per
questa ragione non avrebbero potuto tanto facilmente negare a un
neoconvertito la visione di questo fantomatico «risorto»;
va detto tuttavia che se per i discepoli più stretti di Gesù,
e cioè Pietro e Giovanni, il messia era risorto (per Giovanni,
in verità, era solo «misteriosamente scomparso»),
difficilmente qualcuno avrebbe potuto negare a Paolo una visione
«diretta» di questa idea mistica di «resurrezione»,
e quindi la pretesa di un apostolato di pari dignità, da
svolgersi in maniera autonoma da quello della «vecchia guardia»
giudeo- e galileo-cristiana;
3. che Paolo, ponendosi qui come
rappresentante degli ellenisti, aveva necessità di dimostrare
autonomamente la propria specificità cristiana (rispetto a
quella nota di matrice giudaica e galilaica); egli stesso si servirà
di questo racconto leggendario per rivendicare un potere analogo a
quello degli apostoli. Dirà infatti nella Lettera
al Galati: «il
vangelo da me annunciato... non l’ho ricevuto né l’ho
imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo»
(1,11 s.). Egli stesso quindi è alla fonte di questa leggenda:
una leggenda peraltro che gli ha permesso di poter predicare un
«proprio» vangelo, che difficilmente, in presenza di tale
presunta rivelazione,
qualcuno avrebbe potuto contestare;
4. che Paolo era stato un
fariseo persecutore di cristiani e a quel tempo difficilmente, senza
l’aiuto di versioni leggendarie, si sarebbe potuto credere
nella verità o nella genuinità di un cambiamento così
repentino di mentalità e di comportamento.
Che cosa sia veramente accaduto quel giorno, «verso mezzogiorno» (22,6), intorno all'anno 36 (stando al computo cristiano), su quella strada infuocata dal sole, chiamata «Diritta», si può soltanto immaginarlo. Le contraddizioni fra le tre versioni dell’episodio, riportate negli Atti (9,3 ss.; 22,6 ss.; 26,12 ss.), sono veramente molte.
Nelle prime due la luce avvolse solo Paolo, nella terza anche la scorta (probabilmente questo sta ad indicare o che la scorta seguì Paolo nella sua vocazione, oppure che venne eliminata in quanto scomodo testimone). Nelle prime due solo Paolo cadde da cavallo, nella terza anche la scorta. Nella prima versione la scorta sentì la voce (di Gesù) ma non lo vide; nella seconda e nella terza la scorta non sentì alcuna voce né vide nulla di particolare se non una luce non meglio precisata.
Ancora. Nelle prime due versioni Paolo rimase cieco, nella terza neppure se ne parla: e così via. È da escludere comunque – come invece risulta dalla terza versione – che Paolo avesse acquisito in quel momento la consapevolezza che la sua missione doveva rivolgersi ai pagani.
È probabile che Paolo soffrisse di ipertensione o che fosse particolarmente stressato a causa della sua frenetica attività poliziesca, e che quindi, in quelle particolari circostanze ambientali e climatiche, abbia avuto uno svenimento o un collasso nervoso, eventualmente accompagnato da allucinazioni di vario genere.
Il fatto ch’egli «cadde a terra» e rimase «cieco» va interpretato in maniera simbolica: a cadere in realtà è stata un’ideologia in cui Paolo e tanti come lui avevano profondamente creduto, ed è stata la voce della sua «coscienza» (che forse la scorta in quel momento può non aver «udito») a farlo piombare in una crisi psico-politica.
Paolo doveva essersi reso conto che se si rinunciava alla lotta di liberazione politica, l’idea di credere in un messia risorto poteva aiutare a superare lo sconforto di un’esistenza che altrimenti sarebbe stata votata alla disperazione. Così dunque «guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda» (vv. 8-9). La purificazione era necessaria.
Entrato in città, Paolo pernottò in casa di un certo Giuda: un ebreo non cristiano, dopodiché chiese di parlare con un cristiano di nome Anania. Qui gli Atti sono costretti a celare i veri rapporti che intercorrevano fra Paolo e Anania, in quanto quest’ultimo avrebbe rischiato l’accusa di tradimento o comunque non avrebbe evitato il sospetto di collaborazionismo, se si fosse saputo che aveva accettato, su richiesta di Paolo, di parlare con lui o che addirittura lo aveva avvicinato di sua iniziativa.
La leggenda impedisce che si possa dubitare della lealtà cristiana di Anania, in quanto fa risalire il motivo di questo rapporto col fariseo nemico a una visione (la seconda di questo capitolo!) che lo stesso Anania avrebbe avuto. Curioso peraltro il fatto che quest'ultimo interpreti la propria visione con molta circospezione e timore, mentre Paolo ne farà invece un motivo di revanche privata e pubblica.
È comunque certo che stando con Anania, Paolo riacquista fiducia in se stesso e si riabilita a livello psico-fisico: forse Anania era anche un medico o forse era una persona dotata di una certa autorevolezza e probabilmente anche di una intelligenza e sensibilità capaci di scongiurare a Paolo una crisi che avrebbe anche potuto portarlo alla pazzia o addirittura al suicidio.
Accettando il battesimo, l’imposizione delle mani, la trasmissione dello Spirito santo, Paolo in pratica si converte all’idea della resurrezione di Gesù. Anzi, a partire da questo momento egli inizia a predicare nelle sinagoghe di Damasco l’idea che Gesù è addirittura «figlio di Dio» (v. 20) e non solo il «messia» da tutti atteso (v. 22).
In particolare l’equazione «Gesù-figlio di Dio» vien fatta valere fra gli ellenisti, quella invece di «Gesù-messia» fra i giudei (il titolo di «figlio di Dio» appare di nuovo negli Atti, in maniera peraltro poco chiara, solo in 13,33).
Sin dall’inizio, in sostanza, Paolo associa al titolo ebraico di «messia» quello pagano di «figlio di Dio» e in una maniera così esplicita come mai nessuno prima di lui aveva fatto: al massimo Stefano aveva parlato di «figlio dell’uomo alla destra di Dio» (7,56), come p. es. poteva essere il Battista. Prima di lui Pietro aveva parlato di «Giusto» (anche Stefano in 7,52) e di «Santo» (3,14), di «Signore e Cristo» (2,36), di «Nazareno» (3,6), di «servo di Dio» (3,26).
«Figlio di Dio» era per gli ebrei un’espressione blasfema, perché con essa s’innalzava l’uomo al livello di Dio o si abbassava Dio al livello dell’uomo. Era in sostanza una definizione ateistica, per la quale si poteva rischiare anche la lapidazione e che si ritrova nei vangeli laddove il Cristo affermava d’essere figlio di Dio al pari di ogni uomo in grado di distinguere il bene dal male, quindi senza alcuna pretesa esclusivistica di tipo trascendentale. Al massimo gli ebrei la intendevano in senso simbolico-traslato: essendo stati Adamo ed Eva creati da Dio, tutti gli uomini gli sono «figli».
Viceversa la conclusione cui Paolo era giunto andava oltre quella cui erano giunti i cristiani prima di lui: se Gesù era veramente risorto, allora – secondo Paolo – egli era certamente il messia, ma evidentemente non come quello che ci si attendeva; egli dunque era più di un leader politico-militare, era addirittura l’unico vero figlio di Dio, non in senso metaforico e soprattutto in antitesi alla presunta divinità rivendicata dagli imperatori romani e da tutti gli altri sovrani preromani.
In pratica, anche quando predicava la messianicità di Gesù agli ebrei, Paolo già la intendeva in forma alquanto diversa da quella degli apostoli. Gesù per lui era messia in quanto anzitutto «figlio di Dio», cioè Gesù era stato «uomo» solo perché aveva accettato di abbassarsi a questo livello (di qui la teoria dell’incarnazione e della kenosis): Paolo in sostanza era disposto ad accettare la messianicità di Gesù solo a condizione di accettarne la divinità. E se Gesù che era Dio aveva accettato di morire – questa la conseguenza politica in senso stretto – allora l’esperienza della liberazione integrale dell’uomo non era possibile su questa terra, né nel presente né nel futuro. Paolo è il primo a credere che il ritorno di Cristo sulla terra avrebbe potuto coincidere solo con la fine della storia (di qui il concetto di «parusia escatologica»).
Per quale motivo egli non accettava più la definizione apostolica di messianicità di Gesù come «figlio dell’uomo risorto»? Perché con questa interpretazione, dal sapore simbolico, Israele – secondo Paolo – avrebbe potuto liberare se stessa solo a condizione che il messia fosse tornato a vivere da trionfatore. E difficilmente si sarebbe potuto dargli torto.
Il fatto che questo non fosse accaduto, obbligava – secondo Paolo – ad ampliare il senso dell’umana messianicità di Gesù a un livello di esplicita divino-umanità. Le alternative insomma non potevano che essere due: o un figlio dell’uomo risorto che in modo politico-militare restaura il regno nazionalistico di Davide e Salomone; oppure, in chiave spiritualistico-universale, un figlio di Dio accettabile da chiunque fosse oppresso da Roma, come forma di consolazione morale.
Paolo insomma non supera soltanto la convinzione apostolica del ritorno più o meno imminente del Cristo (un ritorno comunque vincolato, secondo Pietro, alla conversione degli ebrei), ma anche l’esigenza di questo ritorno nel breve periodo, mostrando che Gesù non ha bisogno di tornare per imporsi come messia, in quanto egli è già, per definizione, «figlio di Dio»: messianicità e divinità coincidono perfettamente dal punto di vista della divinità. Lo stesso concetto di «messia» non ha più senso e infatti, di lì a poco, verrà abbandonato. (Da notare che questo modo di ragionare è presente anche in tutte quelle parti manipolate del vangelo di Giovanni).
Il concetto di «figlio di Dio» non solo toglie a quello di «messia» (o di «figlio d’uomo risorto») ogni pretesa nazionalistica, ma toglie anche definitivamente dalla coscienza cristiana ogni aspirazione politica di liberazione. Con Paolo si effettua il passaggio irreversibile dall’immagine di Gesù come «liberatore» (la quale, a sua volta, aveva subìto varie modificazioni dai tempi di Gesù a quello degli apostoli) all’immagine di Gesù come «redentore» (Paolo parlerà addirittura di un Gesù cosmico, universale, ricapitolatore di tutte le cose).
Già Pietro aveva tentato, timidamente, di effettuare un passaggio del genere, ma si guardò bene dall’escludere in modo così netto e radicale il ritorno trionfale ed imminente del Cristo: ecco perché egli tardò ad applicare il concetto paolino di redenzione ai pagani.
Paolo invece si rende conto che se il Cristo non torna, l’immagine che necessariamente deve prevalere è quella del mero redentore e addirittura di un redentore universale, che superi i confini politico-nazionalistici dell’ebraismo.
Egli si mise a predicare queste cose – come dice la Lettera ai Galati (i quali lo accusavano di abuso di potere) – «senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano stati apostoli prima di lui» (1,16 s.). Questo perché egli si era convinto che con la resurrezione del messia e il suo mancato ritorno nell’immediato, fosse definitivamente concluso il primato d’Israele e che quindi la facoltà o il potere di confessare la divinità di Gesù fosse patrimonio di ogni uomo, in quanto acquisibile da ogni uomo «con la grazia» del Cristo (Gal 1,15). Gesù concede la sua grazia, cioè la facoltà di annunciarlo, a chi lo riconosce come dio.
Com’è dunque possibile che una dottrina così politicamente conservatrice e rinunciataria nei confronti delle contraddizioni sociali, potesse risultare progressista agli occhi degli oppressi? La ragione è relativamente semplice: considerando anzitutto che tutti i tentativi di emancipazione politica erano falliti per la disorganizzazione, lo spontaneismo delle masse, il settarismo e l’estremismo dei gruppi politici più in vista, gli oppressi potevano credere di continuare a lottare contro Roma accettando come figlio di Dio non l’imperatore bensì un figlio d’uomo, che pur avendo vissuto una vita povera e umile, fino ad essere ingiustamente crocifisso, aveva saputo dimostrare con la sua resurrezione d’essere più grande d’ogni uomo e quindi anche di ogni sovrano della terra. Proprio in virtù della sua resurrezione, interpretata col concetto di «figlio di Dio» (il quale escludeva l’imminente parusia del politico Gesù), gli oppressi potevano sperare di emanciparsi moralmente, nel presente, dalla loro condizione di schiavitù, e fisicamente nell’aldilà o nel regno dei cieli, sino a quando Gesù stesso non fosse ritornato, questa volta «alla fine dei tempi», per giudicare i vivi e i morti, cioè per la restaurazione finale e definitiva del suo regno di libertà e di giustizia, di verità e di pace.
L’imbarazzo dei discepoli cristiani fu all’inizio notevole: Luca però non lo mette in relazione a questa inedita predicazione, ma alla sola conversione di Saulo (v. 21). Coloro che invece hanno intenzione di ostacolarlo seriamente, perché contrari, nel merito, alla sua predicazione, sono i «giudei», i quali organizzano addirittura «un complotto per ucciderlo» (v. 23), che viene sventato grazie ad alcuni delatori, che, con una trovata geniale (lo calarono in una cesta di notte da un muro della città di Damasco), gli permisero di sfuggire dalle mani del procuratore del re Areta (2 Cor 11,32). Questi giudei ortodossi si erano subito accorti della pericolosa ideologia antinazionalista sottesa alla predicazione di Paolo, il quale, non dimentichiamolo, era vissuto nella città cosmopolita di Tarso, in Cilicia (Turchia meridionale), e che per questa ragione fruiva della cittadinanza romana.
Dopo questi fatti Paolo ricorda nella sua Lettera ai Galati d’essersi recato per tre anni in Arabia (1,17), proprio per sottrarsi ad Areta, dopodiché tornò a Damasco. «In seguito – scrive Paolo – andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui 15 giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, ma solo Giacomo, il fratello del Signore» (Gal 1,18 s.). Interessante il fatto che non citi Giovanni.
Qui, stando a Luca, egli ebbe bisogno della mediazione di Barnaba per essere accettato dai giudeo-cristiani della capitale, ma di questo non dice nulla Paolo nella sua lettera. Luca anzi precisa che Barnaba «lo presentò agli apostoli» (v. 27), mentre Paolo – come sopra sì è detto – si giustificò agli occhi dei Galati dicendo che quando andò a Gerusalemme per essere confermato nel suo apostolato dai Dodici non trovò che Pietro e Giacomo il minore (o il Giusto), lasciando così intendere che il collegio apostolico da tempo si era sciolto e non più ricostituito o che comunque esso non aveva più l’importanza di un tempo: le «colonne» per lui erano soltanto «Giacomo, Cefa e Giovanni» (Gal 2,9). Interessante anche l’ordine in cui cita queste autorità, lasciando chiaramente intendere che anche la figura di Pietro stava cedendo il passo a quella di Giacomo il Minore.5
Paolo afferma di essere rimasto con Pietro per circa «15 giorni» e di non aver visto nessun altro, ad eccezione di Giacomo. Invece qui Luca sostiene ch’egli, grazie all’intercessione di Barnaba prima e degli apostoli dopo, «poté stare con loro [cioè con i cristiani] e andava e veniva a Gerusalemme, parlando apertamente nel nome del Signore e parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca, benché questi, ad un certo punto, tentassero di ucciderlo. Venutolo però a sapere i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso» (vv. 28-30).
Anche di questo Paolo non dice nulla nella sua Lettera ai Galati: si limita soltanto a ricordare che dopo essere stato a Gerusalemme andò, a quanto pare spontaneamente, cioè non perché costretto dalle circostanze, «nelle regioni della Siria e della Cilicia» (1,21). Ma è probabile che qui sia Paolo a non voler ricordare il dissidio che si era creato, sin dagli inizi, fra lui e i cristiani di Gerusalemme guidati da Pietro e da Giacomo il minore (quest’ultimo poi sostituirà lo stesso Pietro nella guida della comunità). Egli infatti si limita a scrivere: «ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo; soltanto avevano sentito dire: – Colui che una volta ci perseguitava, va ora annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio a causa mia» (Gal 1,22-24).
Paolo insomma si lamenta che lo esaltassero di più per la sua inaspettata conversione che non per la novità del suo messaggio teologico. Alcune precise circostanze comunque lo indussero ad andarsene, anche se Paolo non le presenta in maniera drammatica.
Il fatto è che i giudeo-cristiani, avendo già dovuto sopportare una persecuzione a causa di quello che per loro era stato il «fanatismo» di Stefano, non volevano ora rischiarne un’altra a causa di un fanatismo per loro analogo. Paradossalmente i giudeo-cristiani, prima ancora d’integrarsi nella società romana, s’erano già integrati in quella ebraica. Paolo cercò di parlare soprattutto con gli ellenisti, perché pensava che avrebbero potuto meglio capirlo, essendo meno chiusi e provinciali dei giudeo-cristiani. Invece sono proprio questi che meno sopportano le sue novità.
Gli ellenisti avvertivano di più il peso delle contraddizioni fra mondo ebraico e mondo pagano: se non volevano rischiare di diventare troppo «pagani», come ad es. Filone di Alessandria, rischiavano comunque di trascendere nel fanatismo più bieco. Ecco, in questo senso, la posizione «cristiana» di Paolo esprime una sorta di compromesso tra la posizione fanatica ellenistica e la posizione moderata di Filone. (Anche nel vangelo di Giovanni, nelle parti manipolate, viene esplicitato che Gesù è l’unico figlio di Dio, ma per questi redattori gnostici il concetto va semplicemente contemplato, non propagandato. Il quarto vangelo è favorevole all’ascesi personale, alla riflessione metafisica, non alla predicazione vera e propria).
I giudeo-cristiani di Gerusalemme volevano convivere pacificamente con le autorità ebraiche. La Chiesa attendeva «in pace» il ritorno del figlio dell’uomo, nella speranza che i giudei ortodossi si convertissero spontaneamente all’idea del Cristo risorto. «La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo» (v. 31). La descrizione, indubbiamente idilliaca, in realtà lascia trapelare una situazione di completa rassegnazione e passività, una totale sfiducia negli strumenti e possibilità politiche di emancipazione umana.
Lo dimostrano i due racconti leggendari che ora vedremo. Nel primo Pietro guarisce un paralitico a Lidda. Il suo nome era Enea: un nome pagano. Il malato forse era un proselite. Lidda è in Giudea, nei pressi della costa mediterranea. Che il malato non fosse un cristiano o un giudeo lo si capisce anche dal fatto che Pietro non gli dice «Gesù Cristo il Nazareno», come in 3,6, ma solo «Gesù Cristo», titolo questo indicativo del fatto che per Pietro Gesù era anzitutto il messia e che come tale andava predicato a tutti coloro che fossero interessati al mondo ebraico.
Pietro cioè si era convinto che per credere in Gesù bastava sapere ch’egli era il messia, di ieri di oggi di sempre: il messia che ha trionfato non sui nemici ma sulla morte, e che se ha trionfato su questa – aggiunge la leggenda – può vincere anche le malattie. Ecco perché Pietro può guarire il paralitico in nome di Gesù: col che può appunto «dimostrare» che Gesù è «messia».
La liberazione umana sta in questa consolazione (la vittoria sulla morte) che la leggenda rende più accettabile riportando la guarigione miracolosa. Guarigione che, non essendo attribuita direttamente ai poteri di Pietro, non ha neppure quel carattere di segno progressista che, pur in una cornice di analoga mitologia, avevano quelle attribuite a Gesù nei vangeli. Essa infatti non è «segno» per qualcos’altro di diverso significato, ma è finalizzata alla rinuncia della liberazione sociale e politica.
Grazie peraltro a questo prodigio si può facilmente legittimare l’intervento di Pietro presso il mondo pagano o presso i proseliti di origine pagana, ché altrimenti sarebbe apparso equivoco. Qui infatti Pietro considera Enea meritevole del miracolo come fosse un cristiano. Non è da escludere che questi racconti siano stati messi da redattori giudeo-cristiani proprio allo scopo di dimostrare che anche nel loro ambiente, come in quello ellenistico o come in quello che emergerà dalla predicazione paolina, non vi erano riserve particolari ad accettare nelle file delle prime comunità cristiane persone provenienti da altre culture.
E ora il secondo racconto. A Giaffa, vicino a Lidda, la comunità cristiana chiama Pietro perché venga a sanare o addirittura resuscitare Tabità, una ricca vedova che dava molto lavoro ad altre vedove. Luca qui vuol fare capire che l’atteggiamento dei «fedeli» trovato da Pietro a Lidda non era molto diverso da quello dei «discepoli» trovato a Giaffa. Anche a Giaffa infatti i cristiani (ellenisti) chiedono miracoli: in particolare sembra che la richiesta d’intervenire sia mosso più da un interesse di ordine materiale che dall’affetto nei confronti della vedova. Tant’è che Pietro fa «uscire tutti» (come Gesù in occasione della resurrezione della figlia di Giairo, Mc 5,40).
Questa volta Pietro fa il miracolo in nome suo, cioè di sua propria volontà, ma anche qui esso è non meno regressivo, proprio perché gli viene richiesto da cristiani che già hanno la fede. Questa è forse la ragione per cui Pietro ad un certo punto si rende conto che il vangelo post-pasquale, per come era stato formulato dagli apostoli, poteva essere tranquillamente predicato anche ai pagani, o comunque si potevano considerare quest’ultimi, una volta convertiti, allo stesso livello degli ellenisti e persino dei giudeo-cristiani. Di qui il suo pernottamento presso «un certo Simone il conciatore» (v. 43), un ebreo dedito a una professione proibita dalla legge giudaica. (Da notare che il miracolo viene usato dalla leggenda anche per mascherare l’incapacità di affrontare in maniera diretta le contraddizioni economiche; nei vangeli invece vengono usati per mascherare contraddizioni di tipo politico).
torna su - Sulla figura di Giacomo il Minore vedi anche questo testoCap. 10
[1]C’era
in Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte
Italica,
[2]uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia;
faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio.
[3]Un
giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un
angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio!».
[4]Egli
lo guardò e preso da timore disse: «Che c’è,
Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue
elemosine sono salite, in tua memoria, innanzi a Dio.
[5]E ora
manda degli uomini a Giaffa e fa’ venire un certo Simone detto
anche Pietro.
[6]Egli è ospite presso un tal Simone
conciatore, la cui casa è sulla riva del mare».
[7]Quando
l’angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò
due dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti
e,
[8]spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa.
[9]Il
giorno dopo, mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città,
Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a
pregare.
[10]Gli venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre
glielo preparavano, fu rapito in estasi.
[11]Vide il cielo aperto
e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande, calata a terra
per i quattro capi.
[12]In essa c’era ogni sorta di
quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo.
[13]Allora
risuonò una voce che gli diceva: «Alzati, Pietro, uccidi
e mangia!».
[14]Ma Pietro rispose: «No davvero,
Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano e di
immondo».
[15]E la voce di nuovo a lui: «Ciò
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più
profano».
[16]Questo accadde per tre volte; poi d’un
tratto quell’oggetto fu risollevato al cielo.
[17]Mentre
Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa
significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da
Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono
all’ingresso.
[18]Chiamarono e chiesero se Simone, detto
anche Pietro, alloggiava colà.
[19]Pietro stava ancora
ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: «Ecco,
tre uomini ti cercano;
[20]alzati, scendi e va’ con loro
senza esitazione, perché io li ho mandati».
[21]Pietro
scese incontro agli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che
cercate. Qual è il motivo per cui siete
venuti?».
[22]Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo
giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei Giudei, è
stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa, per
ascoltare ciò che hai da dirgli».
[23]Pietro allora
li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente si mise in
viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo
accompagnarono.
[24]Il giorno dopo arrivò a Cesarèa.
Cornelio stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e gli
amici intimi.
[25]Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio
andandogli incontro si gettò ai suoi piedi per
adorarlo.
[26]Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati:
anch’io sono un uomo!».
[27]Poi, continuando a
conversare con lui, entrò e trovate riunite molte persone
disse loro:
[28]«Voi sapete che non è lecito per un
Giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza; ma Dio mi ha
mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo.
[29]Per
questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare.
Vorrei dunque chiedere: per quale ragione mi avete fatto
venire?».
[30]Cornelio allora rispose: «Quattro giorni
or sono, verso quest’ora, stavo recitando la preghiera delle
tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un
uomo in splendida veste
[31]e mi disse: Cornelio, sono state
esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a
Dio.
[32]Manda dunque a Giaffa e fa’ venire Simone chiamato
anche Pietro; egli è ospite nella casa di Simone il
conciatore, vicino al mare.
[33]Subito ho mandato a cercarti e tu
hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio,
siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è
stato ordinato».
[34]Pietro prese la parola e disse: «In
verità sto rendendomi conto che Dio
non fa preferenze di persone,
[35]ma
chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è
a lui accetto.
[36]Questa è la
parola che egli ha inviato ai
figli d’Israele, recando
la buona novella della
pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di
tutti.
[37]Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta
la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni;
[38]cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui.
[39]E noi siamo testimoni
di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce,
[40]ma Dio
lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse,
[41]non a
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
[42]E
ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è
il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio.
[43]Tutti i
profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui
ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome».
[44]Pietro
stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra
tutti coloro che ascoltavano il discorso.
[45]E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo;
[46]li
sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio.
[47]Allora
Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano
battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito
Santo al pari di noi?».
[48]E ordinò che fossero
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo
pregarono di fermarsi alcuni giorni.
*
L’incontro di Pietro con Cornelio viene giustamente messo dopo gli atti di Stefano e di Filippo e dopo la conversione di Paolo. La Chiesa di Gerusalemme, che dopo la fallita esperienza rivoluzionaria del Gesù messia, aveva ripreso a credere nelle tradizioni giudaiche, divenute obsolete rispetto all’evolversi dei tempi, non poteva accettare che l’idea dell’uguaglianza universale degli uomini fosse portata avanti solo dagli ellenisti: quell’idea che gli ellenisti avevano cercato di mettere in pratica sia predicando con Filippo in Samaria a quegli ebrei che i giudei ortodossi consideravano degli «eretici», sia convertendo il proselite etiope.
La Chiesa-madre doveva per forza disporre di un esempio autonomo, indipendente dall’ideologia e dall’attività propagandistica degli ellenisti, che mostrasse in modo chiaro e univoco come anche i giudeo-cristiani fossero capaci di considerare «loro fratelli» a pieno diritto i pagani proseliti e persino i «timorati di dio» (termine tecnico con cui gli ebrei indicavano i simpatizzanti non circoncisi: in questo caso Cornelio, v. 2). I proseliti avevano accettato la religione e i costumi d’Israele, passando attraverso una serie di riti di aggregazione che comprendevano anche la circoncisione. Essi erano numerosi nelle colonie giudaiche del Mediterraneo orientale, ed è probabile che Simone il conciatore fosse uno di loro.
Quando l’approccio al mondo pagano avrà posto, grazie agli ellenisti e qui a Pietro, basi sufficienti per un’autonoma evoluzione, nulla potrà più fermare lo spirito missionario di Paolo, il quale, essendo troppo avanti rispetto alla mentalità giudeo-cristiana, era costretto a vita privata nella sua città natìa. Il problema della predicazione del vangelo indirizzata a quei pagani privi di qualunque rapporto col giudaismo si porrà, con forza, solo quando Paolo e la comunità cristiana di Antiochia estenderanno sistematicamente la missione alle regioni pagane, il che costringerà la Chiesa-madre a convocare un Concilio a Gerusalemme.
Naturalmente non è stato un caso che i redattori degli Atti abbiano messo come protagonista principale di questo incontro col mondo pagano filocristiano il massimo rappresentante degli apostoli.
Ora, siccome non esistevano validi motivi politici per incontrarsi né altri di diversa natura (come quando Gesù esaudì la richiesta del funzionario di Erode a Cana, cfr Gv 4,46 ss.), la tradizione è stata costretta a giustificare tale incontro facendone risalire la causa all’iniziativa di Dio, che si servì di un angelo come mediatore e messaggero. In realtà l’iniziativa partì dall’apostolo Pietro, probabilmente in accordo con lo stesso Cornelio, mentre questi si trovava a Cesarea e quello a Giaffa, in casa di un certo Simone il conciatore, e l’angelo altri non è che un suo discepolo-ambasciatore, il cui nome si è preferito tacere per ovvie ragioni di opportunità.
Oltre all’angelo, diventato nel racconto di Cornelio «un uomo in splendida veste» (v. 30), la tradizione ha attribuito anche a un «sogno» di Pietro il motivo di questo incontro. È singolare come negli Atti si sia costretti a ricorrere a tali elementi mitologici, quando nel vangelo di Giovanni Gesù poté incontrarsi col mondo pagano in circostanze del tutto naturali. Il fatto è che mentre per Gesù l’incontro col funzionario di Erode poteva anche essere occasione di un’intesa politica antiromana; per gli apostoli invece, e per Pietro in particolare, tutto diventava molto più difficile, poiché la possibilità e anzi la necessità di un’intesa del genere, a causa del tradimento degli ideali originari, non esisteva più e inevitabile era diventata un’anacronistica ripresa delle tradizioni classiche del giudaismo.
I termini della questione si erano in un certo senso ribaltati: se prima il Cristo veniva accusato di tradire Israele mentre cercava di abbattere il dominio romano con l’aiuto delle forze pagane, ora gli apostoli possono essere accusati del medesimo tradimento nonostante non abbiano alcuna velleità sovversiva. Prima Israele temeva di perdere l’identità pur in presenza di un progetto rivoluzionario, ora teme di perderla in presenza di un progetto conservatore.
Infatti, che motivo avevano gli apostoli di cercare un rapporto politico con la parte progressista del paganesimo? Essi anzi avrebbero dovuto rifiutarlo per rassicurare i farisei (e anche le autorità del tempio) d’essere legati alle istituzioni dell’ebraismo, seppure in forme e modi non del tutto ortodossi. Luca invece vuole mostrare come il tentativo della comunità cristiana della capitale di cercare un rapporto col mondo pagano progressista, venisse considerato come del tutto legittimo per una Chiesa che aspirava a diffondersi nel mondo intero. I proseliti non venivano forse cercati anche dagli ebrei?
È bene tuttavia precisare che la Chiesa cristiana vuole qui incontrarsi col paganesimo progressista non tanto perché nutriva un qualche interesse per la liberazione dalla schiavitù e dallo sfruttamento romano (politicamente l’incontro serve anzi per riconfermare tale dominio), quanto perché la necessità di superare i confini nazionali per affermare una sorta di cosmopolitismo etico-religioso e culturale, che tanto più forte si poneva quanto meno s’intravedeva la possibilità concreta di una liberazione politico-nazionale, era sentita nell’ambito della comunità cristiana prima ancora che se ne impadronisse in maniera così totalizzante il tredicesimo apostolo.
Tutto ciò, pur non avendo niente di sconvolgente sul piano politico, non poteva essere condiviso dal gruppo dei farisei, il quale avrebbe continuato a resistere alle «contaminazioni culturali», restando tenacemente legato alle proprie superate tradizioni. Ecco, in questo senso si può affermare che i cristiani erano giunti alla consapevolezza che una resistenza farisaica all’oppressione romana era inesorabilmente votata a una sconfitta sui piani sia etico che politico, perché priva di sbocchi operativi.
Conclusasi tragicamente l’utopia rivoluzionaria del messia Gesù, gli apostoli, non potendo tornare indietro come se nulla fosse accaduto, cioè non potendo fingere che con la predicazione del Cristo s’erano poste le questioni su basi nuove, non avevano altra scelta che allargare i loro orizzonti ideali, le loro alleanze politiche con il mondo romano, all’interno di una prospettiva riformista ed etico-religiosa. Da questo punto di vista l’intesa che prima sembrava così difficile da realizzare a causa dei compromessi col gruppo farisaico, poteva diventare ora molto più facile: l’intesa morale e politico-conservatrice con i pagani sembra infatti essere una diretta conseguenze della rinuncia, ormai definitiva, alla rivendicazione dell’obiettivo più importante d’Israele: l’indipendenza della nazione. Che non sia ancora completamente conclusa, tale rinuncia, è dimostrato appunto dal fatto che per realizzare questo incontro si chiamano in causa elementi mitologici come l’angelo di Dio e il sogno di Pietro.
Pietro, in sostanza – stando al racconto – aveva sognato una tovaglia calata dal cielo piena di animali d’ogni genere, e aveva sentito una voce che gli diceva di mangiare quello che voleva. Al suo terzo rifiuto d’obbedire e di mangiare carne, che per lui era immonda, cioè vietata dalla legge, la voce, che era quella di Dio, gli aveva detto: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano» (v. 15).
Già nei Sinottici Gesù si era pronunciato sulla questione della purezza legale relativa ai cibi (cfr Mc 7,1 ss., Mt 15,1 ss., Lc 11,38 ss.). Egli non solo aveva dichiarato puri tutti i cibi previsti dalla legge, senza che vi fosse più alcun bisogno di compiere le preliminari abluzioni, ma aveva anche accusato scribi e farisei di essersi dati delle tradizioni formali semplicemente per eludere i problemi più importanti e addirittura per non rispettare la legge di Mosè: quindi l’accusa coinvolgeva direttamente il livello politico e non riguardava esclusivamente la questione morale. Il ritualismo delle abluzioni era stato portato all’eccesso, secondo Gesù, proprio per evitare il rispetto della legge o comunque per coprire trasgressioni socialmente più gravi. E di questo erano responsabili proprio i gruppi politici più legati alle istituzioni.
Qui Pietro estende l’insegnamento di Gesù anche ai cibi non previsti dalla legge, non tanto pensando di denunciare l’ipocrisia dei farisei, e neppure pensando di realizzare un’intesa politico-rivoluzionaria col mondo romano progressista. Pietro voleva semplicemente lanciare un sasso, senza per questo doversi assumere tutte le responsabilità, indubbiamente gravose, del gesto: è noto infatti l’incidente di Antiochia con Paolo, in cui viene rimproverato di doppiezza, in quanto mangiava insieme ai pagani solo in assenza degli ebrei.
Nei vangeli è scritto che dopo aver discusso sulle tradizioni ebraiche riguardanti il puro e l’impuro, Gesù emigrò in territori pagani, «nella regione di Tiro e Sidone» (Mc 7,24). Viceversa Pietro, invece di partire dal punto in cui Gesù era arrivato, sembra che debba ripercorrerne da capo il cammino. Questo però non deve apparire strano. Gesù aveva compreso l’uguaglianza degli uomini sulla base della comune oppressione e aveva compreso anche che il ritualismo farisaico costituiva un ostacolo insormontabile alla realizzazione dell’unità universale degli oppressi. Pietro invece giunge alla comprensione dell’unità degli uomini sulla base di un’oppressione da superare non tanto politicamente quanto moralmente: di qui la questione dei cibi puri e impuri.
Poiché ha già rinunciato, e con lui la Chiesa cristiana di Gerusalemme, a conseguire l’obiettivo della rivoluzione politico-nazionale, e poiché quindi ciò che, per lui, divide veramente i pagani dai giudei cristiani non sembrano più essere questioni politiche, bensì questioni etico-religiose, legali-ritualistiche, Pietro non può fare alcuna distinzione fra pagani oppressi e pagani oppressori. Queste distinzioni, essendo sconveniente sostenerle sul piano politico, hanno perduto il loro senso anche su quello etico-religioso.
La posizione di Pietro è quindi, rispetto a quella di Gesù, esattamente capovolta. Pietro accetta la virtù morale del centurione solo perché ha già rinunciato a credere che tale virtù possa essere messa al servizio della causa rivoluzionaria. La sua posizione è progressista rispetto a quella farisaica, che rimane chiusa dal punto di vista etico-culturale e senza prospettive realistiche sul piano politico, ma è regressiva rispetto a quella di Gesù manifestata nel dialogo col funzionario di Erode (Gv 4,43 ss.).
Nel testo di Luca è il centurione Cornelio che vuole incontrarsi con Pietro. Questo sta fra l’altro ad indicare che il rozzo politeismo pagano era giunto già al tempo degli apostoli a una forte crisi d’identità, che lo portava ad abbracciare religioni orientali più complesse e sofisticate. Pietro naturalmente nel contesto finge di non aspettarsi la visita dei messi inviati da Cornelio, ma con altrettanta disinvoltura accetta di ospitare in casa propria degli «incirconcisi», andando loro incontro «senza esitazione» (v. 20).
Ma sarebbe meglio dire che Pietro ebbe degli scrupoli non tanto perché temeva di compromettersi incontrando un avversario politico-militare, quanto perché temeva il giudizio moralistico dei suoi discepoli cristiani influenzati dall’ideologia farisaica. Quanto sia stato difficile alla Chiesa cristiana considerare i pagani convertiti come cristiani di pari dignità, lo si vede chiaramente, p. es., dalla Lettera di Paolo ai Galati e dagli incidenti avvenuti ad Antiochia a proposito del prendere i pasti con loro (Gal 2,12 ss.).
Su Pietro comunque non doveva pesare neppure l’ombra di un sospetto di collaborazionismo, poiché i suoi discepoli erano ancora legati all’idea, seppure con sempre meno convinzione, di un primato storico della nazione d’Israele, né si doveva assolutamente credere che fosse stata presa da lui l’iniziativa di questo incontro. Tant’è che quando va a Cesarea, Cornelio gli si prostra ai piedi adorandolo come una divinità (v. 25).
Di fronte a una devozione del genere (diremmo meglio: a un tale culto della personalità, tipico peraltro della mentalità pagana) Pietro poteva forse non reagire positivamente? Questa descrizione romanzata si spiega col fatto che quei cristiani che non credevano più nella restaurazione del regno davidico, dovevano compiere dei salti mortali per giustificare i loro rapporti amichevoli con i pagani oppressori. Nel caso di Cornelio l’oppressione in causa era naturalmente politica, non personale, dato che egli «era un uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei giudei» (v. 22), anche se qui si vuol far credere che essendo egli un uomo onesto, non aveva senso per un ebreo pensare a un rapporto oggettivo di dominio. Diventa addirittura patetica, a questo punto, la scena di un oppressore che, inginocchiatosi davanti a Pietro, si sente dire da quest’ultimo: «Alzati: anch’io sono un uomo!» (v. 26). Si è così voluto costringere il centurione Cornelio a compiere una vergognosa umiliazione, pur di giustificare l’operato di Pietro (qui addirittura identificato col messia Gesù), il cui atteggiamento e le cui idee politiche, peraltro, erano già tali da non averne alcun bisogno.
Pietro dunque, dopo aver premesso che, a suo giudizio, non possono esistere uomini migliori di altri solo perché appartenenti a etnie o culture diverse (v. 28), solo perché quindi praticano usi e costumi differenti, in quanto la bontà o la virtù di ogni uomo dipende dai suoi retti principi e dal suo comportamento etico-religioso, e che quindi il cosiddetto «primato d’Israele» per lui non ha più senso – si accinge a proferire un discorso che, anche questa volta, presenta degli aspetti di un certo interesse.
Anzitutto egli non si rivolge a Cornelio come se questi fosse un pagano (gli Atti danno un’impostazione diversa ai discorsi missionari pro-pagani), bensì esegue in parte lo schema dei discorsi rivolti ai giudei, tralasciando tuttavia un esplicito riferimento all’Antico Testamento e omettendo naturalmente di pronunciare l’atto di accusa per l’uccisione di Gesù (invece di dire: «voi lo uccideste», come in 2,23; 3,15; 5,30; 4,10, dice, al v. 39: «essi l’hanno ucciso»), lasciando così intendere che i principali responsabili della morte di Gesù furono gli ebrei legati al potere del tempio e non tanto i romani, che, stando alla falsata versione evangelica, parteciparono all’esecuzione solo perché costretti dalle circostanze.
Nel suo discorso Pietro ha di Gesù un'opinione che, stando agli Atti, era condivisa da tutto il collegio apostolico, e cioè che Gesù era «Signore di tutti» (v. 36), non in modo politico, ma in quanto «giudice dei vivi e dei morti» (v. 42), in senso cioè ontoteologico o metafisico o semplicemente etico-religioso (che poi nella Chiesa romana diverrà essenzialmente in senso gius-canonico). Per i «vivi» però non è «giudice» terreno, mondano, stricto sensu, poiché ciò presuppone un potere politico (suo personale o dei suoi successori, gli apostoli, che ancora non ne dispongono nei confronti del dominio romano), o comunque un potere normativo riconosciuto da quello politico, come la magistratura viene riconosciuta dal governo. Egli dunque è, al momento, solo signore «etico-religioso», in forza dell'idea di «resurrezione», in quanto redentore dei peccati universali, in attesa che diventi «signore di tutti» in senso pieno e riconosciuto, qui sulla terra in chiave «etica» o al massimo «giuridica», e nei cieli in senso «globale generale universale».
Pietro inoltre spiega che se Gesù avesse voluto realizzare un regno politico una volta risorto, avrebbe scelto di apparire a tutto il popolo e non solo a pochi eletti. Le apparizioni di Gesù risorto ai Dodici escludono quindi, a suo giudizio, ch’egli volesse realizzare un regno politico anche quando era in vita. Il vangelo di Gesù è anzitutto «vangelo della pace» (v. 36).
Un discorso del genere doveva particolarmente rassicurare il centurione Cornelio sulle intenzioni dei cristiani nei confronti dell’imperialismo romano. Esso infatti venne accettato all’unanimità, nonostante le riserve manifestate da alcuni «fedeli circoncisi» giunti con Pietro a Cesarea (v. 45).
Pietro in sostanza arriva a credere nell’uguaglianza universale degli uomini non attraverso la consapevolezza di una comune oppressione sociale e politica, ma attraverso la necessità di una comune fede religiosa. La politica di Pietro è dunque una politica conservatrice. Egli infatti parla soltanto di «buona novella della pace» (v. 37), in antitesi all’esigenza politica di liberazione. Quand’egli afferma che Dio non fa preferenze nei confronti di chi «pratica la giustizia» (v. 35), non intende riferirsi alla lotta politica, ma solo all’esempio morale: «timore di Dio» e «pratica della giustizia» vengono posti sullo stesso piano (a detrimento non del «timore di Dio», naturalmente, bensì della «pratica della giustizia»). Al v. 34 egli fa coincidere la pratica della giustizia con la «vita buona» esente da peccato. Ossia chi ha fede (pagano e ebreo che sia) può ottenere la «remissione dei peccati» (v. 43), il che comporta una liberazione personale. La «liberazione sociopolitica» è tutta racchiusa nel concetto di «redenzione morale».
L’esempio più importante di «pratica della giustizia» che qui viene offerto è appunto quello di Cornelio, il centurione romano che, essendo «pio e timorato di dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio» (v. 2). La pratica della giustizia coincide dunque col «timore di Dio», e al massimo, dal punto di vista sociale, con le «elemosine per i poveri».
Già si è detto che quando Pietro afferma che Gesù è «Signore di tutti» (v. 36) non intende riferirsi a un messianismo politico (poiché questa signoria-basileia non è affatto riconosciuta da tutti), ma solo al fatto che per lui Gesù è «giudice dei vivi e dei morti» (v. 42). Ebbene, è proprio togliendo a Gesù ogni qualificazione politica che Pietro si sente poi costretto a conferirgli un’esistenza divina particolare, propria a lui solo, e solo mediante la quale si può valorizzare adeguatamente l’identità etico-religiosa del messia, o meglio del «giusto», in quanto anche il concetto di «messia» va superato perché troppo politicamente caratterizzato. Infatti Pietro, decontestualizzando nettamente l’operato del Gesù storico, si sente in diritto di affermare che già «tutti i profeti gli rendono questa testimonianza» (v. 43) e anche che «Dio consacrò in Spirito santo e potenza Gesù di Nazareth» (v. 38). Anche da queste espressioni si capisce facilmente come, essendo morti da un pezzo tutti i protagonisti degli Atti, i redattori non hanno avuto scrupoli nell’attribuire loro le frasi più impensate.
Tuttavia Pietro, lasciando intendere che questo Gesù voluto da dio è apparso dopo morto «non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi» (vv. 40-41), rischia di contraddirsi. Il Cristo voluto da Dio sembra essere in realtà voluto dagli apostoli. Un privilegio, questo dell’apparizione del Gesù risorto ai Dodici, che potrebbe permettere a quest’ultimi di giustificare qualunque cosa, anche il nuovo rapporto con i pagani ch’essi intendono stabilire.
Dicendo che Gesù si è manifestato dopo morto solo ai Dodici, Pietro lascia capire che all’uguaglianza universale degli uomini i Dodici erano arrivati soltanto dopo la morte di Gesù (di qui la sua doppia funzione di «giudice dei vivi e dei morti»). Quindi la volontà di Gesù risorto, per Pietro, corrisponde a quella di Dio. Pietro attribuisce ai Dodici e quindi a se stesso, l’acquisizione dell’uguaglianza umana universale, ma ufficialmente la fa risalire a Gesù risorto e quindi, in ultima istanza, a Dio stesso. La Chiesa cristiana diventa l’unica interprete della volontà divina, in netto contrasto con la Chiesa ebraica, e può fare di questo privilegio un’arma con cui zittire gli avversari.
Pietro può comportarsi in una maniera così equivoca e nel contempo unilaterale, perché per lui più importante di Gesù è Dio, cioè in luogo di un uomo preferisce un concetto astratto (che in questo testo scriviamo sempre con la maiuscola solo per rispetto dei credenti). È anzitutto Dio che «non fa preferenze» (v. 34), è sempre Dio che «ha recato la buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo (v. 36). Il vangelo è dunque di Dio: «la parola ch’egli ha inviato ai figli d’Israele» (v. 36). Il vangelo non è, propriamente parlando, di Gesù Cristo, poiché il Cristo è stato crocifisso. È Dio che lo ha «consacrato in Spinto santo e potenza» (v. 38) e che lo ha «resuscitato» e ha voluto che apparisse solo agli apostoli (vv. 39-40): è Dio che lo ha costituito «giudice dei vivi e dei morti» (v. 42). I profeti, ispirati da Dio, rendono testimonianza a lui.
Questa accentuazione metafisica del concetto di Dio è direttamente proporzionale alla deformazione della politicità del messia Gesù. Conseguentemente al fatto che da messia politico Gesù viene trasformato dagli apostoli in un puro e semplice redentore spirituale, è il fatto che nel contempo Gesù viene trasformato da essere umano in una semidivinità (ancora Pietro non parla di Gesù come di «unigenito figlio di Dio», alla maniera di Paolo, però il passo sarà breve. Paolo renderà il Cristo, al pari dei manipolatori del vangelo di Giovanni, un essere completamente astratto, facendo della redenzione spirituale del messia un aspetto riguardante non semplicemente i credenti, di origine ebraica o pagana, ma addirittura tutta la storia degli uomini e dell’universo. Cristo diventa un essere cosmico, apocalittico, ricapitolatore universale).
Il discorso teologico di Pietro resta equivoco perché si serve di categorie ebraiche all’interno di una semantica filo- o cripto-pagana. Questo lo si nota nei concetti di «Signore di tutti» e nel contempo di «giudice dei vivi e dei morti», di «pratica della giustizia» e insieme di «remissione dei peccati»... Tuttavia l’aspetto più interessante del suo discorso, diciamo più innovativo rispetto alla cultura farisaica, è che egli non pone alcuna limitazione di principio all’accettazione dei pagani convertiti nella Chiesa cristiana.
Pietro però giunge a relativizzare non solo il primato d’Israele ma anche l’originalità e la peculiarità del vangelo di Gesù. Per la prima volta infatti, ammettendo l’uguaglianza degli uomini di fronte a Dio (e non di fronte a loro stessi), cioè l’uguaglianza degli oppressi con gli oppressori, ammette anche la pari dignità delle diverse ideologie e religioni, cioè un certo cosmopolitismo etico-religioso. L’unica condizione che egli pone perché queste ideologie e religioni possano essere accettate dal cristianesimo come partner a pari titolo, è che riconoscano il «timor di Dio» e che «pratichino la giustizia», intesa in senso moralistico di elemosine per i poveri e onestà personale (umanesimo personale e democrazia sociale nei limiti dell’ordine costituito).
È su questo terreno moralistico e di politica conservatrice che, d’ora in poi, si devono confrontare tutte le ideologie del mondo col cristianesimo. Cornelio, che aveva chiesto a Pietro di riferirgli «tutto ciò che dal Signore gli era stato ordinato» (v. 33), sapeva bene che Pietro gli avrebbe in realtà riferito solo il proprio vangelo e non quello di Gesù. Pietro infatti dà per scontato che a Cornelio sia già nota tutta la predicazione di Gesù.
Una cosa veramente singolare in questo racconto è che lo Spirito santo viene fatto scendere sui pagani prima ancora che vengano battezzati. In questo senso sembra che gli apostoli non abbiano più il compito di confermare la vocazione altrui con la cresima: essi devono soltanto prenderne atto (la conferma, se c’è, è puramente formale). La lezione degli ellenisti non sembra essere passata invano.
In effetti se Gesù non è il Cristo politico che ci si attendeva, ma solo un redentore spirituale, chi lo riconosce come tale è già un credente ortodosso. Le condizioni per poter appartenere alla comunità cristiana sono ora meno onerose: non si chiede più partecipazione attiva, lotta, organizzazione, propaganda politica, ecc., ma solo «timore di dio» e «pratica della giustizia» (cioè carità ed elemosine), non-violenza, rettitudine morale, pace interiore ecc. Ora è più facile diventare cristiani. Ecco perché lo Spirito santo può scendere ancor prima d’essere battezzati. Non occorre neanche un’esplicita confessione dei peccati, come veniva richiesta da Pietro all’inizio degli Atti: basta la fede nel Cristo risorto. I pagani anzi qui ricevono lo Spirito prima ancora che abbiano espresso una qualche manifestazione di fede.
Estendendo il messaggio ai pagani Pietro lo ha ulteriormente snaturato sul piano politico: naturalmente non perché lo abbia aperto ai pagani, ma perché lo ha aperto senza far valere le esigenze politiche di trasformazione. Estendendolo senza fare riferimento a tali esigenze, Pietro dovrà poi per forza rivolgersi ai ceti sociali abbienti, più elevati di quelli a cui p. es. apparteneva un centurione. Qui il battesimo viene conferito perché il centurione resti centurione.
La situazione è completamente diversa da quella descritta da Giovanni, in cui Gesù esaudì la richiesta del funzionario reale perché sperava in realtà che smettesse di fare il funzionario e diventasse un suo discepolo.
torna suCap. 11
[1]Gli
apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che
anche i pagani avevano accolto la parola di Dio.
[2]E quando
Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano
dicendo:
[3]«Sei
entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con
loro!».
[4]Allora Pietro raccontò per ordine come
erano andate le cose, dicendo:
[5]«Io mi
trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi
una visione: un oggetto, simile a una grande tovaglia, scendeva come
calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me.
[6]Fissandolo
con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere e rettili della terra
e uccelli del cielo.
[7]E sentii una
voce che mi diceva: Pietro, alzati, uccidi e mangia!
[8]Risposi:
Non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è
entrato mai nella mia bocca.
[9]Ribatté
nuovamente la voce dal cielo: Quello che Dio ha purificato, tu non
considerarlo profano.
[10]Questo
avvenne per tre volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo.
[11]Ed ecco, in
quell’istante, tre uomini giunsero alla casa dove eravamo,
mandati da Cesarèa a cercarmi.
[12]Lo Spirito
mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche
questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell’uomo.
[13]Egli ci
raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e
dirgli: Manda a Giaffa e fa’ venire Simone detto anche Pietro;
[14]egli ti dirà
parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua
famiglia.
[15]Avevo
appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro,
come in principio era sceso su di noi.
[16]Mi ricordai
allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni
battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito
Santo.
[17]Se dunque
Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a
Dio?».
[18]All’udir questo si calmarono e cominciarono
a glorificare Dio dicendo: «Dunque anche ai pagani Dio ha
concesso che si convertano perché abbiano la
vita!».
[19]Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la
persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati fin nella
Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno
fuorché ai Giudei.
[20]Ma alcuni
fra loro, cittadini di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiochia,
cominciarono a parlare anche ai Greci, predicando la buona novella
del Signore Gesù.
[21]E la mano
del Signore era con loro e così un gran numero credette e si
convertì al Signore.
[22]La notizia
giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò
Barnaba ad Antiochia.
[23]Quando questi giunse e vide la grazia
del Signore, si rallegrò e,
[24]da uomo
virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti
a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla
considerevole fu condotta al Signore.
[25]Barnaba poi
partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo
condusse ad Antiochia.
[26]Rimasero
insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta
gente; ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati
Cristiani.
[27]In questo tempo alcuni profeti scesero ad Antiochia
da Gerusalemme.
[28]E uno di
loro, di nome Àgabo, alzatosi in piedi, annunziò per
impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su
tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l’impero
di Claudio.
[29]Allora i
discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di
mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea;
[30]questo
fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo.
*
L’obiezione fondamentale che i giudeo-cristiani di Gerusalemme muovono a Pietro è quella d’essersi contaminato legalmente e moralmente «entrando in casa di uomini non circoncisi», cioè pagani, non proseliti, «mangiando insieme con loro» (v. 3).
In particolare i «fratelli» che lo rimproverano sono quelli che ancora credevano nella circoncisione come segno di distinzione dai pagani. I «circoncisi» sono quegli ebrei-cristiani che, volendo restare legati a questa e ad altre tradizioni ebraiche, credevano di poter affermare meglio il primato d’Israele contro Roma. Avendo inoltre accettato l’idea apostolica di una parusia imminente del Cristo per la restaurazione del regno davidico, vedevano il comportamento di Pietro come una forma liquidatoria non solo delle tradizioni d’Israele, ma anche delle nuove speranze politiche emancipative espresse dal messianismo di Gesù.
Si badi: la protesta non era volta contro l’ingresso dei pagani nella comunità cristiana, ma contro un rapporto che mettesse l’ebreo sullo stesso piano del pagano non circonciso. Ciò che non si riusciva ad accettare, da parte di questo gruppo di seguaci, in quel momento maggioritario, era l’idea che la diversità principale fra un pagano e un ebreo passasse non tanto per la circoncisione (e le altre tradizioni ebraiche) quanto per l’oppressione.
Gli ebrei si sentivano oppressi anzitutto in quanto ebrei e non prendevano particolarmente in considerazione l’idea che l’oppressione di cui soffrivano caratterizzasse anche popolazioni non circoncise, con le quali si sarebbe anche potuto stabilire alleanze in funzione antiromana. Essi erano convinti che il primo modo di affermare un’opposizione contro Roma fosse quello di far valere la propria diversità (circoncisione, sabato, tempio, legge mosaica ecc.) e non si rendevano conto che proprio questa diversità, in ultima istanza, faceva gli interessi di Roma, in quanto contribuiva a tenere divisi gli oppressi ebraici da quelli pagani di tutto l’impero.
Dunque, discriminando il pagano in quanto pagano, i giudeo-cristiani non facevano distinzioni fra pagani oppressi e pagani oppressori. Il pagano, se voleva, poteva chiedere di diventare proselite, ma questo avveniva solo s’egli rinunciava alla propria identità e assumeva quella dell’ebreo: non esisteva un rapporto alla pari. Il senso di appartenenza nazionale a un popolo che si considerava «eletto» impediva di fatto ai circoncisi di realizzare delle intese politiche progressiste in nome della comune privazione dei diritti: non esistevano neppure degli scambi di natura culturale, se non nelle zone di emigrazione dell’ebraismo (l’esempio più eloquente è quello di Filone Alessandrino).
Evidentemente per questi giudeo-cristiani la lezione degli ellenisti non aveva avuto alcuna conseguenza. Essi anzi si sentono così liberi nei confronti degli ellenisti, così sicuri della loro ideologia che non hanno scrupoli nel muovere critiche e accuse a uno dei massimi dirigenti della comunità cristiana, cioè a Pietro, il quale è costretto a rendere conto del suo operato, chiarendo «per ordine» (v. 4) gli avvenimenti davanti a tutta l’assemblea.
Pietro riuscirà a «calmare» (v. 18) i circoncisi solo facendo ricorso a spiegazioni del tutto fantastiche, per cui è qui difficile stabilire quanta finzione sia a lui propria e quanta invece sia stata aggiunta dalla tradizione o dallo stesso autore degli Atti. Come si può facilmente notare, la versione di Pietro, sulla scia del racconto di Luca nel capitolo precedente, fa ampio uso di espressioni e vocaboli mitologici come estasi, visione, voce, spirito, angelo...
Oltre a ciò vengono aggiunte una considerazione personale e una palese falsità. Quest’ultima laddove Pietro sostiene che si trovava a Giaffa non in casa di Simone il conciatore ma «in preghiera» (v. 5). La prima invece al v. 16: «Mi ricordai della parola del Signore che diceva: – Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo». Tale riflessione teologica è chiaramente una mistificazione, poiché successiva, e di molto, alla predicazione politica del Cristo. Giovanni Zebedeo, nel suo vangelo, l’attribuisce allo stesso Battista, ma pure questa attribuzione è inverosimile, in quanto il Precursore non poteva avere alcuna concezione dello «Spirito santo», per cui essa si può spiegare solo alla luce del fatto che anche il vangelo di Giovanni ha subìto molteplici manipolazioni.
Il fatto che qui Pietro l’attribuisca a Gesù fa ancora una volta pensare che del messaggio autentico del Gesù storico la comunità primitiva non avesse ritenuto quasi nulla. Pietro infatti interpreta alla lettera un’espressione che se anche fosse stata davvero pronunciata da Giovanni Battista, essa avrebbe dovuto essere colta, al massimo, nella sua valenza simbolica. Viceversa, interpretandola alla lettera, egli è costretto ad attribuirla non a colui che al massimo avrebbe potuto pensarla in maniera metaforica, ma a colui che avrebbe dovuto superarla praticamente.
Quella frase, che forse sul piano simbolico avrebbe potuto far pensare a qualcosa di vagamente costruttivo, era diventata per Pietro non la figura ma la realtà, non un simbolo che attendeva d’essere realizzato, ma una realtà in se stessa, volta, nonostante le apparenze, verso la conservazione dei rapporti sociali esistenti. La figura, come spesso succede nei documenti neotestamentari, viene usata proprio per impedire che si realizzi la svolta rivoluzionaria che altri ancora vorrebbero, anche se in nome di essa si chiede di superare un passato troppo remoto per poter essere riattualizzato.
La posizione di Pietro è politicamente conservatrice proprio quando si sostiene che lo Spirito santo viene dato da Dio «per aver creduto nel Signore Gesù Cristo» (v. 17). Il che in sostanza voleva dire che la novità del messianismo cristico non stava tanto nell’invito a credere in un messaggio politico che poteva essere realizzato a prescindere dalla propria appartenenza etnica o tribale, ma nell’aver ricevuto da Dio una sorta di premio consolatorio (lo Spirito santo o Paraclito), in ragione del fatto che si era accettato di non abbandonare il movimento nazareno, pur in presenza di una svolta politica involutiva inaugurata dallo stesso Pietro.
Pietro non ha mai chiesto ai pagani di lottare insieme ai cristiani per affermare la signoria di Gesù, ma ha semplicemente chiesto di riconoscere questa signoria come già realizzata nell’aldilà, in virtù dell’idea di resurrezione (il Cristo postpasquale è sempre meno «messia politico» e sempre più «giudice dei vivi e dei morti»), e in cambio ha promesso una maggiore libertà di coscienza, cioè il premio dello Spirito, che Dio elargisce a chiunque creda in questa vittoria ultraterrena sulla morte. Nell’ideologia petrina l’idea di combattere attivamente contro le ingiustizie va considerata superata non meno di quella di ritenere l’ebreo giusto per definizione.
Pietro è progressista solo sul piano culturale (ma il sincretismo culturale di cui si fa carico era già oggetto d’interesse di molti ebrei che vivevano all’estero: vedi p. es. il giudaismo alessandrino). Egli ritiene che, se si accetta l’idea di una sconfitta irreversibile del progetto rivoluzionario di Gesù, non vi sia più alcuna ragione di continuare a credere nel primato d’Israele, e che pertanto l’esigenza di allacciare un rapporto paritetico con tutti gli uomini dell’impero debba quanto prima trovare soddisfazione. Pietro giunge a questa conclusione progressista (pur già presente in alcuni testi evangelici attribuiti al Cristo) quando politicamente s’era già schierato a favore della conservazione dei rapporti schiavistici romani.
Il sillogismo di Pietro era abbastanza semplice: se tutti gli uomini sono uguali (come i cibi) dal punto di vista morale (davanti a Dio, che è unico per tutti), la distinzione fra oppressi e oppressori non ha più senso: l’unica distinzione possibile è quella fra chi crede in questa uguaglianza universale e chi no, e chi non vi crede è destinato a restare prigioniero entro i confini del mero nazionalismo.
Sotto questo aspetto, che i cristiani siano stati oggetto di persecuzioni da parte dei romani per ben tre secoli, può essere spiegato unicamente col fatto che i romani ritenevano che il rifiuto di prestare giuramento alla divinità dell’imperatore o di prestare culto alle divinità fondamentali dell’impero, potesse facilmente portare a una contrapposizione politica: la qual cosa appariva troppo rischiosa a un impero caratterizzato, a partire dalla svolta cesarea, dal primato del militarismo, sia per motivi di ordine interno che di salvaguardia dei confini.
Il paganesimo romano era fondamentalmente integralistico e solo parzialmente tollerante. Non c’è mai stato un momento nella storia di Roma in cui sia stata messa in discussione l’esigenza che la religione dovesse restare funzionale agli interessi della politica: quando Roma capirà, con Costantino, che anche il cristianesimo poteva essere usato in questo senso, non si rinuncerà all’intolleranza ideologica, ma anzi si farà dello stesso cristianesimo una religione di stato, perseguitando duramente le confessioni non cristiane.
Pietro arrivò alla conclusione che l’uguaglianza morale degli uomini andava affermata non a partire dalla lotta per la liberazione d’Israele, ma piuttosto a partire da questioni di ordine legale-rituale. Se al pari dei cibi anche tutti gli uomini sono «puri», a prescindere dalla loro appartenenza etnica, tribale o geografica, allora il messaggio della resurrezione può essere esteso a tutto l’impero. La riscoperta «purezza interumana» si pone qui come una sorta di leit-motiv revisionista, in quanto finalizzata alla legittimazione dei rapporti di potere esistenti. Tutti i pagani possono essere giusti se obbediscono alle leggi, se compiono il bene conforme alla legge e se temono Dio, esattamente come per gli ebrei.
Di che cosa dunque i circoncisi che lo accusavano si convincono? Che anche i pagani possono credere nell’idea (petrina) del messia risorto, ma non per questo la comunità cristiana rinuncerà a desiderare la restaurazione del regno davidico. La conversione dei pagani viene accettata come un’eccezione alla regola, nel senso che l’interesse di taluni pagani per l’ideologia cristiana può non contraddire il fatto che la comunità continui a rivendicare il primato d’Israele.
Questi pagani possono non condividere alcune leggi fondamentali degli ebrei, come la circoncisione, il sabato, i cibi puri e impuri ecc., ma la loro accettazione di tutto il resto (l’idea di Gesù risorto, la remissione dei peccati, il battesimo nello Spirito, il rito dell’eucarestia, lo Spirito consolatore ecc.) non può implicare la rinuncia, da parte dei giudeo-cristiani, alla convinzione di una propria indiscussa superiorità etica, culturale e politica.
Questo problema scoppierà di nuovo in tutta la sua drammaticità quando la conversione dei pagani sarà di proporzioni tali da superare il numero dei credenti giudei. Paolo ricorderà nella Lettera ai Galati il dissenso sulla necessità di consumare pasti insieme ai pagani convertiti (2,13) e quindi di avere con loro dei rapporti paritetici.
Peraltro in questo stesso capitolo non è affatto chiaro che i giudeo-cristiani abbiano accettato l’idea che gli uomini pagani non siano tenuti a circoncidersi. L’incertezza nell’interpretazione del brano dipende dal fatto che l’episodio di Cornelio non si pone con molto rigore sul piano dei principi: esso stabilisce solo un importante precedente su cui si avrà poi modo di tornare in occasione del Concilio di Gerusalemme.
Naturalmente a questo punto la corrente ellenistica non poteva non bilanciare il successo di Pietro descrivendo, con compiacimento, i propri successi. Ed ecco che l’autore degli Atti afferma che «quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati sin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona novella del Signore Gesù» (vv. 19-20).
La città in cui la predicazione ai pagani diventa massiccia è appunto Antiochia, la terza dell’impero, dopo Roma ed Alessandria. Negli Atti Luca ha voluto giustificare l’operato degli ellenisti a partire da quello di Pietro, al quale ha voluto far risalire, per ovvi motivi, il primo incontro col mondo pagano, ma nella realtà post-pasquale avvenne esattamente il contrario. I versetti 19-20 di questo capitolo si riallacciano direttamente al capitolo 8,1.4, e questo, ovviamente, a prescindere dal fatto che già nei vangeli esistono brani in cui è evidente l’apertura universalistica del messaggio di Cristo.
La stessa vocazione di Saulo è strettamente legata alla consapevolezza dell’uguaglianza di pagani ed ebrei. In questo senso è da escludere ch’egli sia rimasto a Tarso per molto tempo, dopo esservi giunto da Gerusalemme, per quanto solo nella terza versione della sua conversione (26,17-18) viene esplicitata l’idea dell’uguaglianza tra ebrei e pagani (una consapevolezza maturata indipendentemente dalle considerazioni di Pietro, anche se forse non da quelle di Stefano e degli ellenisti).
Il fatto stesso che qui la Chiesa-madre, guidata da Giacomo fratello di Gesù, decida di inviare Barnaba ad Antiochia, fa pensare ad almeno due cose: che gli apostoli non fossero più presenti a Gerusalemme (infatti la persecuzione di Erode Agrippa I li costrinse a fuggire), e che gli ellenisti da tempo conducevano la predicazione ai pagani (Barnaba non conferisce la cresima e non muove alcuna obiezione).
Da sottolineare che in questo rapporto col mondo pagano si sottolinea sempre meno la messianicità di Gesù. Già Pietro aveva parlato di «giudice dei vivi e dei morti». Ora gli ellenisti parlano di «Signore Gesù», alla maniera greca (v. 20). Gli ellenisti sentivano di non aver bisogno di un mandato speciale per poter predicare a chiunque l’idea di resurrezione del messia. Barnaba non può fare altro che prendere atto della situazione (anche perché dopo la persecuzione di Erode Agrippa la Chiesa-madre si renderà conto di aver meno potere di controllo, soprattutto sulle zone periferiche del cristianesimo, che ormai, dal punto di vista numerico, tanto periferiche non erano).
Ad Antiochia infatti la predicazione ai pagani assumerà un carattere pubblico e di massa («una folla considerevole» venne convertita, dice Luca al v. 24), e sarà proprio qui che nascerà la prima comunità di credenti composta prevalentemente di pagani, i quali per la prima volta assumeranno il nome di «cristiani» (usato forse dalla controparte in senso spregiativo di «unti», v. 26).
Barnaba, oriundo di Cipro, viene chiamato «apostolo» due volte negli Atti (14,4.14), eppure non faceva parte dei Dodici: questo sarebbe stato impossibile se prima non ci fosse stata la predicazione di Paolo. E sarà proprio lui che andrà a Tarso per indurre Paolo a trasferirsi ad Antiochia (v. 25).
Il successo tra i pagani sarà clamoroso, e solo perché si era prospettata una soluzione esauriente di tutti i loro problemi nell’aldilà. Chi si converte appartiene per forza a ceti relativamente benestanti, oppure non ha sufficiente consapevolezza della propria condizione marginale. È la convinzione dell’impossibilità di cambiare le cose a favore della giustizia sociale che induce gli uomini a convertirsi al cristianesimo.
Una volta realizzata la conversione dei pagani si può anche inserire, a livello redazionale, una testimonianza relativa ad alcuni profeti ebreo-cristiani provenienti da Gerusalemme e diretti ad Antiochia, allo scopo di chiedere sovvenzioni per far fronte alla carestia che aveva colpito la città. La Chiesa madre stava vivendo molti disagi materiali, accentuati dalla crisi economica che di lì a poco avrebbe colpito tutto l’impero. La colletta, raccolta secondo le possibilità di ciascuno, viene affidata non ai profeti, ma a Barnaba e Paolo (vv. 29-30), di cui a quanto pare i cristiani di origine pagana si fidavano maggiormente, e questi dovranno portarla a Gerusalemme, non ai Dodici, scomparsi a causa della persecuzione di Erode Agrippa, ma agli anziani, che li avevano sostituiti (v. 30).
Questa colletta è il risvolto sociale della parabola involutiva del cristianesimo primitivo.
torna suCap. 12
[1]In
quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri
della Chiesa [2]e
fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni.
[3]Vedendo che
questo era gradito ai Giudei, decise di arrestare anche Pietro. Erano
quelli i giorni degli Azzimi.
[4]Fattolo
catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a
quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo
comparire davanti al popolo dopo la Pasqua.
[5]Pietro dunque
era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a
Dio dalla Chiesa per lui.
[6]E in quella
notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo,
Pietro piantonato da due soldati e legato con due catene stava
dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il
carcere.
[7]Ed
ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò
nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e
disse: «Alzati, in fretta!». E le catene gli caddero
dalle mani.
[8]E
l’angelo a lui: «Mettiti la cintura e legati i sandali».
E così fece. L’angelo disse: «Avvolgiti il
mantello, e seguimi!».
[9]Pietro uscì
e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà
ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva
infatti di avere una visione.
[10]Essi oltrepassarono la prima
guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in
città: la porta si aprì da sé davanti a loro.
Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l’angelo si
dileguò da lui.
[11]Pietro
allora, rientrato in sé, disse: «Ora sono veramente
certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla
mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei
Giudei».
[12]Dopo aver
riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni
detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte
in preghiera.
[13]Appena ebbe
bussato alla porta esterna, una fanciulla di nome Rode si avvicinò
per sentire chi era.
[14]Riconosciuta
la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad
annunziare che fuori c’era Pietro.
[15]«Tu
vaneggi!» le dissero. Ma essa insisteva che la cosa stava così.
E quelli dicevano: «È l’angelo di
Pietro».
[16]Questi intanto continuava a bussare e quando
aprirono la porta e lo videro, rimasero stupefatti.
[17]Egli allora,
fatto segno con la mano di tacere, narrò come il Signore lo
aveva tratto fuori del carcere, e aggiunse: «Riferite questo a
Giacomo e ai fratelli». Poi uscì e s’incamminò
verso un altro luogo.
[18]Fattosi giorno, c’era non poco
scompiglio tra i soldati: che cosa mai era accaduto di Pietro?
[19]Erode lo
fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece
processare i soldati e ordinò che fossero messi a morte; poi
scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarèa.
[20]Egli
era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però
si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro
causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il
loro paese riceveva i viveri dal paese del re.
[21]Nel giorno
fissato Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne
loro un discorso.
[22]Il popolo
acclamava: «Parola di un dio e non di un uomo!».
[23]Ma
improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché
non aveva dato gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò.
[24]Intanto
la parola di Dio cresceva e si diffondeva.
[25]Barnaba e
Saulo poi, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme
prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco.
*
L’Erode di cui si parla in questo capitolo è Agrippa I, nipote di Erode il Grande, re della Giudea e Samaria dal 41 al 44 e che, come spiega il testo, si limitò a perseguitare solo «alcuni membri» della comunità cristiana, quelli più in vista, e certo non per le aperture ellenistiche viste nel capitolo precedente.
Sappiamo che nel 40 l’imperatore Claudio, abolita la provincia di Giudea, l’aveva concessa ad Agrippa, dotandolo della potestà consolare e che questi, pur essendo stato educato nell’ambito della cultura romana, si diede alla pratica scrupolosa e zelante della religione giudaica, cercando di rendersi gradito alla corrente farisaica.
La persona più importante che Agrippa, in questo frangente, fa uccidere, e senza processo, è Giacomo Zebedeo, fratello dell’evangelista Giovanni, che non si era certo rassegnato, come Pietro, all’idea di non poter ricostruire in patria il regno davidico in funzione antiromana, specie dopo l’infausto quinquennio dell’imperatore Caligola (37-41).
Poiché grazie alle ambiguità di Pietro, gli apostoli avevano potuto convivere, più o meno pacificamente, coi carnefici del Cristo, Luca è costretto ad affermare che Agrippa, prima di procedere anche contro Pietro, volle vedere se il suo delitto era stato gradito agli ebrei e, avendone ottenuto il consenso, decise di arrestarlo.
Nonostante che gli apostoli fossero stati rispettati proprio perché considerati politicamente inoffensivi dalle autorità sinedrite e romane, Agrippa ha comunque bisogno di scaricare su qualcuno le responsabilità dei disordini presenti in Giudea-Samaria, dimostrando così a Roma che la situazione era sotto controllo: il rischio era quello d’essere sostituito da qualche governatore di origine latina. Non dimentichiamo che Agrippa s’era guadagnato i favori di Caligola e di Claudio al punto che gradualmente aveva ottenuto il governo di tutta la Palestina.
Pietro tuttavia, essendo più popolare di Giacomo, non poteva essere eliminato senza salvare le apparenze della legalità, per quanto qui i redattori degli Atti non abbiano fatto nulla per evitare un remake del processo a carico di Gesù. Nonostante l’appoggio di molti ebrei, Agrippa non se la sente di procedere con un’esecuzione sommaria, tanto più che quelli «erano i giorni degli azzimi», cioè della Pasqua, festa in cui molti si riunivano a Gerusalemme e dove le possibilità di disordini e sommosse non erano remote.
La somiglianza rispetto ai racconti della passione di Cristo sta anche in questo, che i capi-giudei si servono di un re filo-romano per risolvere i loro contrasti coi cristiani. Pietro infatti è sì rispettato ma fino a un certo punto, poiché l’idea propagandata di un messia morto e risorto ai capi-giudei non piaceva affatto; con essa infatti la teologia petrina chiedeva di rinunciare alla speranza di un ritorno del regno davidico, almeno nell’immediato. Non a caso l’esperienza della tomba vuota venne sfruttata da Pietro per rinunciare definitivamente alla lotta politica: in un primo momento nella convinzione di una parusia imminente, poi nella convinzione opposta, di una parusia da rimandare sine die.
Agrippa qui rappresenta l’incapacità del potere costituito (romano) di scorgere nel cristianesimo apostolico una fonte di stabilità politica più sicura dell’ebraismo ufficiale.
Che Pietro fosse un personaggio di spicco è testimoniato anche dal numero di sentinelle che lo devono sorvegliare: sedici (sei ore per ogni picchetto di quattro guardie di cui due addirittura incatenate con lui tutto il giorno). Agrippa probabilmente aveva intenzione di processarlo dopo pasqua per condannarlo a morte.
Questa volta però i cristiani non si lasciano prendere di sorpresa e forti dei loro legami con l’ebraismo di potere fanno di tutto per liberarlo. Scrivendo che «pregavano» per lui, Luca vuol farci capire, indirettamente, che cercarono qualunque strada, legale e illegale, per ottenere la scarcerazione. Il misticismo correlato alla descrizione di questa evasione è servito, a livello redazionale, per metterne in luce il carattere miracoloso, ma anche per nascondere le ambigue trame che occorsero allo scopo.
La fuga avviene il giorno prima del processo, quando non c’era più nulla da fare: quasi certamente si era convinti che, pur in presenza di un regolare processo, Pietro sarebbe stato fatalmente condannato.
Dormendo legato alle due guardie, sarebbe stato impossibile liberare Pietro senza ucciderle o corrompere chi le comandava. L’angelo in questione sarà stato un capo ebreo o un militare romano di alto grado, simpatizzante dei cristiani: una figura molto importante di cui si è sempre taciuto il nome. Già nei vangeli tuttavia si vedono personaggi di spicco simpatizzare per i nazareni: Giuseppe di Arimatea, Nicodemo, Zaccheo, Giairo, il funzionario di Erode... C’è anche un precedente in At 5,19, che fa pensare si tratti della stessa persona.
La dinamica dell’evasione è abbastanza realistica. Tutto ovviamente avviene di notte, qualcuno entra nella cella con una torcia accesa, trova Pietro addormentato, che evidentemente non si aspettava questa fortuna, lo libera dalle catene, non prima d’aver drogato o stordito le guardie, e lo fa uscire in tutta fretta, temendo l’arrivo di altri militari.
Luca rasenta la comicità quando scrive che «la porta si aprì da sé» e che «le catene gli caddero dalle mani». Il motivo di ciò resta forse legato alla sorte delle due guardie legate a Pietro, che non potevano essere state corrotte, poiché la regola voleva che, essendo Pietro destinato a morire, in caso di evasione, esse sarebbero state uccise al suo posto. Nessuno quindi poteva garantire la loro incolumità fino al punto da doversi rivelarsi come autore della fuga dell’apostolo. Il loro destino era segnato.
Pietro ovviamente si rese subito conto che si trattava di un’evasione, tuttavia qui appare molto strano che si faccia ordinare delle cose («Mettiti la cintura e legati i sandali», «Avvolgiti il mantello, e seguimi!») che avrebbe dovuto capire da solo; forse si era già rassegnato all’idea di dover morire come Gesù, oppure temeva di compiere qualcosa di cui poi non avrebbe saputo come rendere conto: p.es. che le guardie sarebbero state giustiziate o che era stato liberato non da un cristiano ma da un ebreo o, peggio ancora, da un romano.
Luca dice, fingendo, che Pietro non si rendeva conto della realtà, proprio per evitare, a sé e allo stesso Pietro, di dare ulteriori spiegazioni sull’identità del liberatore. Pietro infatti è stato l’unico testimone del fatto, oltre ovviamente alle persone che si sono lasciate corrompere. E Luca può tranquillamente insistere su questa finzione perché a quell’epoca poteva apparire del tutto naturale che un inaspettato «salvatore» venisse considerato come un angelo mandato da Dio...
È notte fonda, Pietro cerca rifugio presso una certa Maria, ove i cristiani erano soliti riunirsi. Maria era madre di Giovanni Marco, autore del primo vangelo, cugino di Barnaba e discepolo dello stesso Pietro.
Di nuovo (come al momento del primo processo a carico di Gesù) Pietro s’imbatte, prima d’incontrare Maria, in una serva. Bussa alla «porta esterna», che dava sul giardino antistante alla casa, e gli si presenta Rode, che stava dormendo in una dimora separata dalla casa, non lontana dall’ingresso principale.
Pur riconoscendolo dalla voce, non gli apre: sapeva infatti che era in prigione, inoltre è buio, lei non è che una «fanciulla» al servizio della padrona di casa... Luca, cercando di sdrammatizzare, dice che «per la gioia non aprì» e «che corse ad annunziare che fuori c’era Pietro»: una descrizione straordinariamente somigliante a quella dei vangeli, là dove si descrive l’atteggiamento delle donne al cospetto della tomba vuota.
La ragazza viene trattata come una stupida domestica. Evidentemente non sapevano che qualcuno aveva avuto intenzione di organizzare l’evasione: d’altra parte in quei casi la segretezza era ingrediente fondamentale del piano di fuga.
Rode ha una personalità semplice: è obbediente ma non servile, proprio perché insiste, si preoccupa, non è indifferente alla situazione, e non si lascia smontare dall’incredulità e dall’ironia dei padroni, che la prendono in giro evocando il «fantasma» di Pietro. Qui è significativo che una popolana non abbia creduto alla finzione del fantasma o dell’angelo (di Pietro) quando la storia redazionale di questo racconto ha indotto milioni di lettori a credere in una finzione maggiore: quella dell’angelo liberatore.
I padroni di casa o comunque i suoi ospiti si rendono conto che diceva la verità, sentendo bussare insistentemente alla porta e quindi andando a vedere di persona.
Pietro fu tassativo nel raccomandare loro di tacere sul modo come era stato liberato, per non compromettere il destino del suo anonimo «salvatore». E dispose che venisse sostituito alla guida della comunità da Giacomo, uno dei Dodici, fratello di Gesù, legato forse ancor più di lui alle tradizioni giudaiche. Dopodiché emigra verso Antiochia o comunque fuori della Giudea-Samaria.
Grande, il mattino seguente, fu lo «scompiglio tra i soldati», che ovviamente si saranno accusati a vicenda. Il tentativo di ritrovarlo e risparmiarsi così da morte sicura andò a vuoto e Agrippa li fece giustiziare.
Da notare che mentre Pietro accettò di fuggire sapendo che le guardie sarebbero state uccise, Paolo, quando verrà il suo turno, non lo farà (16,28). Pietro sapeva di questa legge, eppure qui non se ne preoccupa. Sa che se vuole fuggire, questo è il prezzo che dovrà far pagare. (è probabile però che Paolo si sia comportato diversamente perché su di lui non pesava un sicuro verdetto di condanna).
Ma perché Pietro non accettò di affrontare il processo? Perché aveva capito che la sua morte non sarebbe servita a niente. Gesù si lasciò uccidere per evitare un male peggiore: la distruzione del movimento, e sperava di essere liberato da una sommossa popolare, ma ai tempi di Pietro i cristiani e lo stesso Pietro non avvertivano più la necessità di una lotta rivoluzionaria contro Roma e le autorità del tempio. Il fatto stesso che qui Pietro sia stato liberato grazie non alle pressioni popolari, ma a un funzionario romano (o comunque legato ad Antipa) la dice lunga sul carattere inoffensivo del cristianesimo apostolico.
Quanto al resto forse si può ipotizzare che dopo il 44 Pietro sia tornato a Gerusalemme (e non solo in occasione del Concilio), senza però togliere a Giacomo la guida della comunità, e che in questo suo soggiorno Paolo l’abbia incontrato.
La chiusura sull’Antipa è del tutto indecifrabile. Sappiamo che fuori della Giudea Agrippa non si fece scrupolo di erigere statue, istituire ludi gladiatorii, edificare un anfiteatro a Beyrouth, battere moneta con effigie umana... Egli probabilmente voleva che anche Tiro e Sidone diventassero sue colonie o che gli permettessero di fruire di qualche particolare privilegio. Le due città sembrano qui voler barattare la pace e una maggiore libertà commerciale in cambio di riconoscerlo come loro dio. Ma Luca fa notare come Agrippa ebbe la peggio proprio nel momento culminante del suo potere, molto probabilmente restando vittima di un complotto (si pensa a un avvelenamento da parte dei Romani). Alla sua morte la Galilea e la Giudea passarono sotto la diretta giurisdizione dei procuratori romani.
torna suCap. 13
[1]C’erano
nella comunità di Antiòchia profeti e dottori: Bàrnaba,
Simeone soprannominato Niger, Lucio di Cirène, Manaèn,
compagno d’infanzia di Erode tetrarca, e Saulo.
[2]Mentre essi
stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito
Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per
l’opera alla quale li ho chiamati».
[3]Allora, dopo
aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li
accomiatarono.
[4]Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo,
discesero a Selèucia e di qui salparono verso Cipro.
[5]Giunti a
Salamina cominciarono ad annunziare la parola di Dio nelle sinagoghe
dei Giudei, avendo con loro anche Giovanni come aiutante.
[6]Attraversata
tutta l’isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso
profeta giudeo, di nome Bar-Iesus,
[7]al seguito
del proconsole Sergio Paolo, persona di senno, che aveva fatto
chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la
parola di Dio.
[8]Ma Elimas, il
mago, – ciò infatti significa il suo nome – faceva
loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla
fede.
[9]Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo,
fissò gli occhi su di lui e disse:
[10]«O
uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo,
nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie
diritte del Signore?
[11]Ecco la mano
del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo
non vedrai il sole». Di colpo piombò su di lui oscurità
e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano.
[12]Quando vide
l’accaduto, il proconsole credette, colpito dalla dottrina del
Signore.
[13]Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a
Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò
a Gerusalemme.
[14]Essi invece proseguendo da Perge, arrivarono ad
Antiòchia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di
sabato, si sedettero.
[15]Dopo la
lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a
dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione
per il popolo, parlate!».
[16]Si alzò Paolo e fatto
cenno con la mano disse: «Uomini di Israele e voi timorati di
Dio, ascoltate.
[17]Il Dio di
questo popolo d’Israele scelse i nostri padri ed esaltò
il popolo durante il suo esilio in terra d’Egitto,
e con braccio
potente li condusse via di là.
[18]Quindi,
dopo essersi
preso cura di loro per circa quarant’anni nel deserto,
[19]distrusse
sette popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità
quelle terre,
[20]per circa
quattrocentocinquanta anni. Dopo questo diede loro dei Giudici, fino
al profeta Samuele.
[21]Allora essi
chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù
di Beniamino, per quaranta anni.
[22]E, dopo
averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al
quale rese questa testimonianza:
Ho trovato
Davide, figlio
di Iesse, uomo
secondo il mio cuore;
egli adempirà tutti i miei voleri.
[23]Dalla discendenza di
lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù.
[24]Giovanni
aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a
tutto il popolo d’Israele.
[25]Diceva
Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono ciò che
voi pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non
sono degno di sciogliere i sandali.
[26]Fratelli, figli della
stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è
stata mandata questa parola di salvezza.
[27]Gli abitanti
di Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno riconosciuto e
condannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono
ogni sabato;
[28]e,
pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte,
chiesero a Pilato che fosse ucciso.
[29]Dopo aver
compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla
croce e lo misero nel sepolcro.
[30]Ma Dio lo ha
risuscitato dai morti
[31]ed egli è
apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla
Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al
popolo.
[32]E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa
fatta ai padri si è compiuta,
[33]poiché
Dio l’ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù,
come anche sta scritto nel salmo secondo:
Mio figlio sei
tu, oggi ti ho generato.
[34]E
che Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più
a tornare alla corruzione, è quanto ha dichiarato:
Darò a voi
le cose sante promesse a Davide, quelle sicure.
[35]Per
questo anche in un altro luogo dice:
Non permetterai
che il tuo santo subisca la corruzione.
[36]Ora
Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione,
morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione.
[37]Ma colui che
Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione.
[38]Vi sia
dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la
remissione dei peccati
[39]e che per
lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui
non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè.
[40]Guardate
dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto nei
Profeti:
[41]Mirate,
beffardi, stupite e nascondetevi, poiché un’opera io
compio ai vostri giorni, un’opera che non credereste, se vi
fosse raccontata!».
[42]E,
mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste cose nel
prossimo sabato.
[43]Sciolta poi
l’assemblea, molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono
Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li
esortavano a perseverare nella grazia di Dio.
[44]Il sabato
seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare
la parola di Dio.
[45]Quando
videro quella moltitudine, i Giudei furono pieni di gelosia e
contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando.
[46]Allora
Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era
necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma
poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita
eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai pagani.
[47]Così
infatti ci ha ordinato il Signore:
Io ti ho posto
come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino
all’estremità della terra».
[48]Nell’udir
ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio
e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita
eterna.
[49]La
parola di Dio si diffondeva per tutta la regione.
[50]Ma i Giudei
sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città
e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li
scacciarono dal loro territorio.
[51]Allora essi,
scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio,
[52]mentre i
discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
*
Con il cap. 13 inizia praticamente la seconda parte degli Atti, quella concernente l’apostolato degli ellenisti e soprattutto di Paolo di Tarso. La città promotrice di questa notevole azione missionaria in terra pagana è Antiochia di Siria, che era la residenza del proconsole romano e contava circa mezzo milione di abitanti. Punto di convergenza di strade molto importanti, era la terza città dell’impero, posta a 20-30 km dal mare Mediterraneo.
I primi fedeli cristiani di cui si ha notizia provenivano da Gerusalemme, da dove erano fuggiti a causa della persecuzione sorta dopo la morte di Stefano. Alcuni si limitarono a predicare ai giudei; altri, nativi di Cipro e di Cirene, si rivolsero anche ai pagani: il che dovette indurre la Chiesa di Gerusalemme ad inviare Barnaba per un controllo in loco. Barnaba però – stando almeno a questo capitolo – non sembra comportarsi come un ispettore (non si dice che sia tornato a riferire), ma piuttosto come un vero e proprio dirigente, coadiuvato da altre quattro persone, tra cui Paolo (Luca naturalmente, per indicare la continuità con la tradizione della comunità di Gerusalemme, mette Barnaba al primo posto, ma nel corso di questo capitolo risulterà Paolo il vero e unico protagonista. Barnaba può essere qui considerato come un valente diplomatico che ha cercato di mediare gli interessi degli ellenisti – lui stesso lo era – con quelli dei giudeocristiani).
Proprio ad Antiochia i discepoli cominciarono ad essere chiamati dagli avversari del cristianesimo, col termine spregiativo di «cristiani» (cioè untuosi, in riferimento anche alla loro ambigua posizione politica).
I «profeti e dottori» presenti in questa comunità, cioè i pedagogisti e i politici, gli educatori, i maestri di vita, gli intellettuali più in vista, provenivano geograficamente sia dal mondo ebraico che dal mondo pagano, ma di cultura erano tutti ellenisti e di religione ebraica. Celebrano il «culto del Signore» (eucarestia, desunta in parte dalla comunità di Qumran e mai istituita in realtà da Gesù Cristo) alla maniera cristiana e «digiunano» alla maniera ebraica, ma decidono alla maniera ellenistica di mandare Barnaba e Saulo in missione. Il narratore attribuisce allo «Spirito santo» la decisione di farli partire: così facendo non indica solo una decisione presa collegialmente, ma giustifica anche il distacco di Antiochia da Gerusalemme, ovvero la rivendicazione di un’ampia autonomia politico-amministrativa. Agli inviati speciali, i profeti e dottori «impongono le mani», non solo in segno di augurio o di benedizione, ma anche come conferma di una stretta comunione ideologica, la ratifica di un mandato. Essi cioè hanno ricevuto piena facoltà di poter trasmettere le verità di fede in cui tutta l’intellighenzia e la comunità stessa di Antiochia da tempo credono. La differenza tra questi missionari e gli apostoli è praticamente inesistente. Il titolo di «apostolo» poteva essere guadagnato semplicemente dimostrando un particolare impegno missionario.
Il distacco degli ellenisti dai giudeocristiani viene ribadito al v. 4, ove si afferma che fu lo stesso «Spirito santo» (e non quindi la comunità di Gerusalemme) che li inviò «verso Cipro» (meta proposta probabilmente dallo stesso Barnaba, originario di quell’isola). Con Giovanni Marco, autore del vangelo sinottico più antico, Barnaba e Paolo (quest’ultimo scelto dallo stesso Barnaba) intraprendono verso il 47-49 (secondo il computo cattolico) il loro primo viaggio missionario, partendo dal porto di Seleucia.
Dopo una navigazione di almeno 220 km essi giungono a Salamina, nell’isola di Cipro, cominciando a predicare nelle sinagoghe. Toccano vari villaggi percorrendo per circa 250 km la costa meridionale dell’isola fino a Pafo, dove Paolo si scontra con il mago e profeta giudeo Bar-Jesus (figlio di Gesù), al seguito del proconsole romano Sergio Paolo.
Cipro, ricca di rame, era la patria di Barnaba, come s’è detto, e questi vi si recherà di nuovo dopo essersi staccato da Paolo. Era pure la patria di un gruppo di fedeli che molto contribuì alla formazione della cristianità di Antiochia e alla conversione di Mnasone, «discepolo della prima ora», in casa del quale Paolo sarà ospitato durante l’ultima sua permanenza a Gerusalemme. Moltissimi erano gli ebrei residenti nell’isola: essi avevano diverse sinagoghe nell’antica capitale Salamina, l’odierno Porto Costanzo. Erano così tanti che una settantina d’anni dopo l’arrivo di Paolo e Barnaba, distrussero, in una rivolta contro Traiano, la città stessa di Salamina, operando stragi in tutta l’isola. Pafo, a una quindicina di chilometri dal tempio di Afrodite, essendo il primo porto dell’isola per chi viene dall’Italia, era la sede del proconsole (Cipro era provincia senatoriale e fu governata a suo tempo anche da Cicerone).
Dunque il proconsole Sergio Paolo, «persona di senno» – dice Luca – aveva fatto chiamare Barnaba e Saulo per ascoltare personalmente il contenuto della loro dottrina, la quale evidentemente aveva riscosso un certo successo nell’isola. Forse Sergio teneva al suo servizio Bar-Jesus, detto anche Elimas, non tanto o non solo perché «giudeo», quanto piuttosto perché si atteggiava a «mago e profeta». Quel che interessava al proconsole era, più che la religione ebraica, la personalità imbonitrice di questo mago, i cui poteri da prestigiatore e da parolaio potevano senz’altro tornargli utili per distogliere le masse dell’isola (quindi non solo quelle di origine ebraica) dall’affronto dei problemi reali.
Naturalmente Luca sostiene che il proconsole voleva ascoltare Paolo e Barnaba perché mosso da sane intenzioni religiose, ma al massimo si può pensare a una semplice curiosità intellettuale: egli sapeva benissimo che la predicazione dei due apostoli non era politicamente pericolosa. Il suo interesse è quello di verificare se esiste la possibilità di strumentalizzare anche questa nuova religione, che appare più sofisticata dei trucchi di Elimas.
Lo stesso scontro fra Paolo ed Elimas pare essere dettato unicamente dalla preoccupazione di ottenere favori o privilegi dal proconsole, in tutto il territorio dell’isola, e Paolo mostra di saper già perfettamente come comportarsi con le autorità romane. Il mago giudeo reagisce negativamente perché teme di essere sostituito dagli ultimi due arrivati.
Forse Paolo all’inizio avrà cercato di convincere Bar-Jesus con le buone maniere, con la persuasione ragionata, assicurandogli che non aveva intenzione di spodestarlo, in quanto la sua presenza nell’isola sarebbe stata solo temporanea; forse può esserci stato il tentativo di dividersi le zone geografiche di competenza, o forse Elimas può aver chiesto a Paolo del denaro per permettergli di predicare indisturbato per un certo periodo di tempo... In ogni caso qui, da quel poco che si riesce a intuire, non si ha l’impressione di trovarsi in presenza di un semplice scontro verbale. Paolo deve aver senz’altro compiuto qualcosa agli occhi di Elimas, cioè al mezzo col quale egli incantava il suo pubblico. «La mano del Signore sopra di lui» – come dice Luca – è un eufemismo per dire che Paolo lo colpì fisicamente. L’espressione «lo guardò fisso negli occhi» forse sta proprio ad indicare che Paolo non si lasciò impressionare dalla sua personalità.
Paolo non era tenero di carattere ed è anzi molto probabile che sia stato proprio questo episodio ad indurre Marco ad abbandonare la missione. Cosa gli abbia fatto è difficile dirlo: forse lo ha reso cieco per tutta la vita e la frase «per un certo tempo non vedrai il sole» è stata messa per coprire l’eccessiva disinvoltura con cui Paolo usava taluni mezzi coercitivi (non dimentichiamo che apparteneva, quand’era fariseo, a un corpo di polizia). Egli comunque deve aver approfittato del fatto che la popolarità di Elimas presso taluni ambienti giudaici dell’isola non era così elevata, in quanto si sapeva che la magia (peraltro vietata dalla legge mosaica) veniva da lui usata anzitutto per gli interessi del proconsole e quindi di Roma.
Paolo inoltre poté dimostrare che la magia di Elimas, ora che era stato da lui accecato, era solo una menzogna; e lui che l’aveva vinto andava inevitabilmente considerato come un individuo superiore. Il proconsole credette appunto in questo e non tanto nella «dottrina del Signore», come invece dice Luca. Ciò che lo colpì fu la sicurezza con cui Paolo agì: egli in pratica credette, da realista politico qual era, alle ragioni dell’ebreo più forte (che peraltro, guarda caso, era anche «cittadino romano»), sempre nella convinzione di poterlo strumentalizzare politicamente. Luca vuol farci credere che il proconsole «pieno di senno» era stato tratto in inganno dal mago «pieno di frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia», ma la posizione di Luca è puramente apologetica.
Paolo in realtà era ancora un novizio del cristianesimo e in quell’occasione si era comportato in maniera molto impulsiva. Lo si capisce anche dal fatto ch’egli, pur avendo ottenuta la pseudo-conversione di un importante funzionario romano, non tornerà più a Cipro. Infatti, verso la fine degli Atti Luca noterà che nel viaggio da Mileto a Gerusalemme la nave che trasportava Paolo, passando a sud di Cipro, permetterà di rivedere Pafo solo di lontano; e anche quando, nel viaggio da Gerusalemme a Roma, Paolo navigò a nord dell’isola, decise di non sostarvi. Quanto a Giovanni Marco, la ripresa dei rapporti avverrà solo dopo qualche anno.
Dal porto di Pafo, «Paolo e i suoi compagni» (Paolo è già diventato il capo-comitiva, avendo compiuto a Pafo un’azione di cui si è assunto tutta la pesante responsabilità, ed è forse lui che prende l’iniziativa di compiere questo viaggio in Asia minore) giungono sulle coste della Panfilia (una regione costiera larga al massimo 40 km sul golfo di Adalia), dopo circa 300 km di mare; e mentre Marco torna a Gerusalemme, scandalizzato al massimo di quel che aveva visto, Barnaba e Paolo puntano da Perge verso nord, attraversando coraggiosamente la catena del Tauro per circa 160 km in linea d’aria, fino ad Antiochia di Pisidia, centro commerciale posto su un altopiano a 1200 m di altezza, presso la grande via che da Efeso si inoltra nell’Asia.
Nella sinagoga di Antiochia Paolo fa un discorso molto importante, che Luca ha ritenuto opportuno sintetizzare. La prima parte è un riassunto della storia d’Israele fino a Davide, in cui Paolo sottolinea la particolare grandezza della nazione ebraica. Nella seconda parte Paolo lascia intendere che Israele aveva avuto una buona opportunità per tornare ad essere quella che era stata ai tempi di Davide (ove raggiunse la massima espansione territoriale), ma gli «abitanti di Gerusalemme e i loro capi» l’avevano sprecata – dice Paolo – lasciando che il Cristo fosse crocifisso.
Col che Paolo evidenzia un distacco dalla comunità di Gerusalemme molto forte, superiore addirittura a quello di Stefano, il quale sperava ancora di poter cambiare la situazione politica della capitale, ovvero i rapporti di intesa tra giudaismo e cristianesimo. Da notare che ai tempi di Stefano, Pietro si limitava a incolpare moralmente i capi religiosi, pur sapendo che una buona parte della popolazione era stata complice passiva della crocifissione. Paolo afferma che i giudei gerosolimitani hanno rifiutato la grande opportunità offerta dal Cristo chiedendo a Pilato di ucciderlo, il che poté avvenire – secondo lui (e qui vedremo ora la differenza tra lui e Pietro) – perché era già stato previsto dai profeti.
Paolo in sostanza compie, sulla scia di Pietro, un ragionamento a posteriori e molto artificioso, andando a ricercare negli scritti profetici quei passi che potevano essere utilizzati per giustificare il comportamento dei rivali del messia e lo stesso comportamento ambiguo o non sufficientemente determinato dei nazareni. In sostanza egli ribadisce, portando alle estreme conseguenze le tesi petrine, che se il Cristo fosse stato semplicemente un messia politico non avrebbe dovuto morire.
Se invece così avvenne è stato non perché non fosse il messia, ma perché la restaurazione del regno davidico non andava più considerata come un obiettivo perseguibile o politicamente realizzabile, o comunque utile alla salvezza umana. Cristo è stato molto di più di un liberatore nazionale, è stato un liberatore metafisico, la cui morte violenta trova ampia giustificazione in una teologia ad hoc, come già avevano previsto i profeti. Da qui a dire che i pagani, in sostanza, possono essere dei seguaci di Cristo meglio degli ebrei, che restano legati a un passato che pesa come un macigno, non ci vuol molto, anche se Pietro, come noto, riuscirà a compiere questo passo solo dopo i successi della predicazione paolina, non prima.
Paolo ricorda anche la funzione e l’operato del Battista, che preannunciò la venuta del messia ed anzi personalmente lo indicò nella figura del Cristo. Il Battista viene ricordato per due ragioni: le masse pensavano che fosse proprio lui il messia, mentre Giovanni stesso disse di non esserlo e disse anche chi sarebbe potuto diventarlo, cioè il Cristo, per la qual cosa si deve considerare Gesù, a giusto titolo, il messia da tutti atteso. Paolo insomma vuol dimostrare non che Gesù non era il messia perché morì in croce, ma che la sua messianicità non andava interpretata in modo politico.
La prova più convincente ch’egli fu il messia atteso da tutti la diede Gesù stesso – dice Paolo – quando decise di risorgere dalla tomba. La sua morte o meglio la sua resurrezione stava proprio ad indicare, negativamente, che per Israele non c’era più la possibilità di tornare ad essere quella di un tempo, ma anche, positivamente, la nascita di una nuova speranza: quella di poter vivere un regno di giustizia nell’aldilà.
Per cercare di sostenere una tesi che un qualunque soggetto rivoluzionario non avrebbe mai potuto condividere (e infatti nemmeno lui lo faceva quando perseguitava i cristiani), Paolo è costretto ad affermare, sapendo di mentire, che il Cristo risorto «è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo».
Naturalmente egli può dire questo perché nessuno può smentirlo: infatti a Gerusalemme gli apostoli non risiedevano più da tempo. Se infatti la tesi mitologica delle apparizioni del Cristo risorto non fosse stata diffusa come verità storica, Paolo non avrebbe potuto concludere dicendo che la «buona novella» (cioè in realtà la sua «buona novella») consisteva unicamente nella resurrezione di Gesù e non nella possibilità concreta, storica, da adempiersi politicamente, di liberarsi dall’oppressione dell’imperialismo romano.
Un Cristo risorto e riapparso è certamente per Paolo un Cristo che ha parlato ed ha sicuramente parlato in un senso politicamente conservatore. «Noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, perché Dio l’ha attuata per noi, loro figli, resuscitando Gesù...». Cioè Paolo considerava la resurrezione di Gesù un milione di volte superiore alla promessa di una terra libera dall’oppressione. Anzi, è addirittura pronto ad affermare, falsificando volutamente l’interpretazione tradizionale dei testi biblici, che la «vera» promessa fatta ai «padri» si è adempiuta soltanto nella resurrezione di Gesù. Paolo insomma, non ritenendo più possibile, o praticabile, una lotta di liberazione antiromana, riconduce l’esigenza di una nazione libera e giusta alla semplice fede del Cristo redivivo (figlio di Dio): il che, secondo lui, spostava ovviamente nell’aldilà la soluzione del problema politico di una felicità terrena.
In questo senso, conclude Paolo, Gesù è superiore allo stesso Davide, pur non avendo realizzato alcun regno di pace e di giustizia. Gli è superiore come lo è la resurrezione alla morte. La vittoria messianica del Cristo è anzitutto la vittoria umana sulla morte. E la consapevolezza di fede del cristiano riposa su questa certezza: se Cristo ha vinto la morte, tutto può essere sopportato in attesa della sua parusia. «Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione». Cristo non ha subìto alcuna corruzione e se lui, che poteva farlo, non ha voluto costruire sulla terra un regno di giustizia, significa che questo non è un obiettivo storicamente realizzabile. Non è dunque la storia il luogo in cui si possono esprimere tutte le potenzialità positive dell’uomo: la storia è un luogo di attesa, un luogo di speranza e di fede, soprattutto di certezza della sua fine e del ritorno glorioso del Cristo.
Paolo è un politico conservatore perché è un filosofo pessimista, rassegnato: il fatto che Cristo non sia riuscito a costruire un’alternativa ai romani è per lui motivo sufficiente per rinunciare a questa speranza e non occasione per riflettere sugli errori compiuti e per rettificare tattica e strategia, sempre in direzione della liberazione nazionale. L’incapacità politica di edificare un regno terreno di giustizia viene interpretata come impossibilità pratica, materiale, definitiva di realizzare questo regno; le esigenze di partecipazione democratica ai fini della ricerca di un’alternativa antiromana vengono colte come forme di debolezza, di ingenuità, di utopia: se con la forza che si sarebbe potuta usare non si è riusciti a prevalere, significa che il destino era quello di rinunciare a emanciparsi politicamente e di cercare altre forme di realizzazione umana. La fiducia assoluta nel Cristo risorto è in Paolo inversamente proporzionale alla sfiducia nelle masse oppresse.
L’unica liberazione possibile per lui è quella della «remissione dei peccati», l’unica cui l’uomo possa aspirare (in questo senso anche la missione del Battista va recuperata). L’uomo cioè è talmente peccatore (e lo dimostra il fatto che non si è fatto scrupolo di uccidere un messia come Gesù) che nessun’altra liberazione gli è possibile. Ottenuta tale remissione, qualunque azione può essere giustificata dalla fede nella resurrezione, oggi di Gesù e domani personale, di ogni essere umano, in quanto liberazione universale.
Se l’uomo riconosce d’essere peccatore, strutturalmente limitato, assolutamente incapace di bene, niente e nessuno potrà giudicarlo: «per opera di lui vi viene annunciata la remissione dei peccati e per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè». La legge di Mosè infatti può essere fedelmente adempiuta, in tutto e per tutto, solo se esiste una nazione libera in cui poterla mettere in atto. Mancando tale nazione o tale libertà, la legge mosaica diventa un fardello insopportabile, un inutile peso. Anche da questo si capisce come il capitolo 13 sia un preciso spartiacque rispetto ai capitoli in cui Pietro ne fu il protagonista indiscusso.
La vera novità, nel discorso di Paolo, sta appunto in questo, che per potersi salvare di fronte a Dio l’uomo non ha più bisogno di compiere tutte le opere previste dalla legge di Mosè, basta che creda nella resurrezione di Gesù, la quale riassume o include, superandoli, tutti gli elementi migliori della stessa legge di Mosè.
Questa predicazione ebbe un buon effetto su coloro che già avevano rinunciato a lottare per la giustizia o su coloro che non avevano molto da guadagnare in tale lotta. Per cui «molti giudei e proseliti» della sinagoga «seguirono Paolo e Barnaba». La massiccia presenza di questi pagani proseliti (o «timorati di dio») indusse Paolo ad affrontare con molta sicurezza l’ostilità giudaica che si manifestò il sabato successivo: «poiché respingete la nostra predicazione e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo a pagani». Paolo sapeva già che avrebbe dovuto farlo: gli mancava solo l’occasione propizia.
Luca calca la mano dicendo che i giudei si opposero ai due apostoli perché erano «pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando». Lo scontro sarà stato senz’altro molto duro, non solo sul piano delle interpretazioni religiose circa il ruolo della Torah e dei Profeti, ma anche e soprattutto per la visione politica del futuro di Israele. Mentre infatti i giudei popolani si saranno chiesti che senso avesse rinunciare definitivamente all’esigenza di restaurare il regno davidico, quelli benestanti invece che senso avesse rinunciare a tradizioni usi e costumi da secoli in vigore.
Nel contesto del racconto appare che la seconda categoria di giudei sia riuscita a far combutta con «le donne pie di alto rango [simpatizzanti del giudaismo] e i notabili della città [legati a questi ebrei per motivi economici]», cioè con i pagani più in vista, per «suscitare una persecuzione contro Paolo e Barnaba», la quale poi risulterà vincente, anche se all’udire che Paolo poneva sullo stesso piano di uguaglianza morale i giudei con i pagani, quest’ultimi (specie se di condizione sociale povera) esulteranno di gioia: «i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio», scrive Luca. Essi cioè avevano compreso che il cristianesimo, nonostante la sua limitatezza sul piano politico, permetteva di affermare una sorta di uguaglianza morale di tutti gli uomini e le donne di fronte a Dio: cosa che nessuna religione allora prevedeva, neppure quella ebraica.
Ora finalmente la superiorità materiale di quei giudei ricchi presso cui quelli di basso rango, ebrei e pagani che fossero, andavano elemosinando qualcosa, doveva per forza ridimensionarsi, almeno a livello morale, visto che la fede in Cristo risorto era comune e non richiedeva appartenenze di censo o di casta. Anche per questo motivo la predicazione di Paolo, rivolta a certi ambienti agiati del giudaismo della diaspora, faceva poco piacere.
torna suCap. 14
[1]Anche
ad Icònio essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e vi
parlarono in modo tale che un gran numero di Giudei e di Greci
divennero credenti.
[2]Ma i Giudei
rimasti increduli eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani
contro i fratelli.
[3]Rimasero
tuttavia colà per un certo tempo e parlavano fiduciosi nel
Signore, che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia
e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi.
[4]E la
popolazione della città si divise, schierandosi gli uni dalla
parte dei Giudei, gli altri dalla parte degli apostoli.
[5]Ma quando ci
fu un tentativo dei pagani e dei Giudei con i loro capi per
maltrattarli e lapidarli,
[6]essi se ne
accorsero e fuggirono nelle città della Licaònia,
Listra e Derbe e nei dintorni,
[7]e là
continuavano a predicare il vangelo.
[8]C’era a Listra un
uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva
mai camminato.
[9]Egli
ascoltava il discorso di Paolo e questi, fissandolo con lo sguardo e
notando che aveva fede di esser risanato,
[10]disse a gran
voce: «Alzati diritto in piedi!». Egli fece un balzo e si
mise a camminare.
[11]La gente
allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in
dialetto licaonio e disse: «Gli dèi sono scesi tra di
noi in figura umana!».
[12]E chiamavano
Bàrnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui il più
eloquente.
[13]Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era
all’ingresso della città, recando alle porte tori e
corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla.
[14]Sentendo
ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le
vesti e si precipitarono tra la folla, gridando:
[15]«Cittadini,
perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come
voi, e vi predichiamo di convertirvi da queste vanità al Dio
vivente che
ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si
trovano.
[16]Egli, nelle
generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua
strada;
[17]ma
non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi
dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e
riempiendo di letizia i vostri cuori».
[18]E così
dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire
loro un sacrificio.
[19]Ma giunsero da Antiòchia e da
Icònio alcuni Giudei, i quali trassero dalla loro parte la
folla; essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono fuori
della città, credendolo morto.
[20]Allora gli
si fecero attorno i discepoli ed egli, alzatosi, entrò in
città. Il giorno dopo partì con Bàrnaba alla
volta di Derbe.
[21]Dopo aver predicato il vangelo in quella città
e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra,
Icònio e Antiòchia,
[22]rianimando i
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché,
dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per
entrare nel regno di Dio.
[23]Costituirono
quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo avere
pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano
creduto.
[24]Attraversata
poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia
[25]e dopo avere
predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attalìa;
[26]di qui
fecero vela per Antiòchia là dove erano stati affidati
alla grazia del Signore per l’impresa che avevano
compiuto.
[27]Non appena furono arrivati, riunirono la comunità
e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e
come aveva aperto ai pagani la porta della fede.
[28]E si
fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.
*
Scoppiata una persecuzione che li costrinse a lasciare Antiochia di Pisidia, la comitiva (Luca li chiama già esplicitamente col termine di «apostoli»), per circa 100 km, andò verso sud-est, a Iconio (l’odierna Konia, in Turchia), dove però l’opposizione anticristiana si ripeté.
Nonostante «un gran numero di giudei e di greci» si convertisse, «i giudei rimasti increduli», quelli cioè che avevano più da perderci con i discorsi di uguaglianza morale davanti a Dio, quelli che parteggiavano per l’aristocrazia sacerdotale del tempio, ma anche quelli che non avevano rinunciato all’idea politica di restaurare il regno davidico e attendevano quindi un messia adatto allo scopo: insomma tutti questi giudei divisi tra loro ma uniti nei confronti dell’ambigua posizione cristiana «eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli» (cristiani).
Quali «pagani»? Quelli più ricchi, che mal sopportavano ogni idea di uguaglianza, foss’anche solo di tipo etico-religioso di fronte a Dio; ma anche quei pagani che desideravano realizzare i loro sogni emancipativi qui sulla terra e non nel regno dei cieli.
La differenza fra la situazione di Antiochia e quella di Iconio sta soltanto nel fatto che qui «per un certo tempo» essi furono liberi di predicare, determinando una forte spaccatura nella città fra il partito dei «giudei» e quello degli «apostoli». Luca spiega questo successo usando una formula convenzionale o tecnica: «operavano segni e prodigi». Il che sta certo ad indicare che ad Iconio la situazione sociale era più drammatica, per cui gli apostoli poterono fruire di un seguito popolare più consistente.
Luca afferma ch’essi fecero «segni e prodigi» per dimostrare che gli apostoli in qualche modo venivano incontro alle esigenze degli strati più poveri. In realtà gli «apostoli», di cui parla l'evangelista, erano solo in grado di organizzare delle comunità di mutuo soccorso, in cui vigeva la pratica dell’elemosina, della carità reciproca, della comunione dei beni liberamente offerti. Più che predicare un’uguaglianza morale davanti a un unico Dio, i cristiani di allora non potevano e non sapevano fare. Ovviamente questo, dati i tempi, era sufficiente per ottenere vasti consensi.
Tutto ciò però non poté impedire il tentativo di «lapidazione» organizzato dal partito anticristiano. Ad Antiochia si limitarono a «scacciarli» – aveva detto Luca – ma solo perché la borghesia e l’aristocrazia giudaica e pagana si sentivano molto forti e non avevano quindi bisogno di ricorrere ai mezzi estremi.
Ad Iconio invece la situazione era diversa. Da qui essi si dirigeranno verso «le città della Licaonia, Listra e Derbe e nei dintorni». Ormai appare chiaro che negli Atti la differenza non passa più tra pagano e giudeo, ma tra cristiano e anticristiano: una differenza che però nella vita reale e concreta non riassumeva certo le principali contraddizioni dell’epoca.
Scesero allora verso sud per circa 40 km giungendo a Listra, patria di Timoteo, futuro importante discepolo di Paolo e manipolatore delle lettere di quest'ultimo. Essa si trovava su un altopiano dall’altezza media superiore ai mille metri, a nord della catena montuosa del Tauro. Era una colonia militare romana, stabilita per sorvegliare le popolazioni locali piuttosto turbolente. Lo si capisce anche dal fatto che il narratore si è sentito autorizzato ad inventare un miracolo vero e proprio.
Il racconto della guarigione dello storpio non è che una ripetizione malriuscita del racconto di quella compiuta da Pietro a Gerusalemme (3,1 ss.), il quale, a sua volta, era una ripetizione svilita di altri due racconti di guarigioni compiute da Gesù ai paralitici di Cafarnao e di Gerusalemme, a loro volta mistificazioni di situazioni che si sono volute rendere ambigue.
Luca però, anche per gli atti che riguardano Paolo, che si presentano in maniera autonoma rispetto a quelli di Pietro, ha bisogno di dimostrare che l’ideologia religiosa del movimento cristiano era popolare, conforme al messaggio originario di Gesù, e siccome si rivolgeva (almeno qui) a un popolo ignorante e credulone, nulla risultava più indicato del racconto di un miracolo. Il popolo ha bisogno di credere in fatti concreti e l’autore degli Atti sa bene cosa si deve propagandare affinché il messaggio prima di Pietro, poi di Paolo sia ascoltato e seguito.
Come saranno andati i fatti? Probabilmente la predicazione degli apostoli ebbe un certo successo fra gli strati più poveri ed emarginati. Potrà anche esserci stata una guarigione, ma sicuramente non miracolosa (o forse tale sarà sembrata a una popolazione deprivata e superstiziosa).
L’arretratezza culturale e lo spontaneismo dei licaoni sono documentati dal fatto che Paolo e Barnaba vengono immediatamente scambiati per Giove ed Apollo (Zeus ed Hermes, oppure soltanto due divinità locali, visto che per timore di sbagliarsi sull’identità «divina» da attribuire ai due apostoli, essi parlarono in dialetto licaonio, evitando quindi di farsi capire).
Le aspettative popolari si notano proprio nella scelta delle due divinità: il padre degli dèi e quello più eloquente (Paolo era un retore affermato, Barnaba era più anziano di lui). Da queste poche battute si può indirettamente capire quanto fossero maturi i tempi per una transizione dal politeismo ingenuo del paganesimo al monoteismo teologizzato della nuova religione cristiana.
Se una guarigione c’è stata, essa venne recepita positivamente dai Licaoni in quanto accompagnata da parole di speranza, tant’è che dei due apostoli risulta più importante per loro non, come sarebbe stato naturale, Barnaba-Giove, bensì Paolo-Apollo. Lo dimostra inoltre il fatto che una tradizione riporta, in luogo della parola «risanato», la parola «salvato»: il che sta a significare che si era compreso (e il racconto mitizzato serve appunto a testimoniarlo) come il paralitico rappresentasse una fede non solo o non tanto nella guarigione fisica, ma anche e soprattutto in una integrale liberazione di tutti i mali, fisici e sociali.
Proprio l’aver suscitato questa speranza di liberazione deve aver determinato il clamoroso successo cristiano fra quella popolazione povera ed oppressa. In questo senso lo storpio di Paolo sembra avere più vivacità politica di quello di Pietro, ed è forse proprio per questo motivo che Paolo è costretto a disilludere lui e i suoi compaesani con un discorso più demagogico. Pietro infatti sostenne la possibilità di un ritorno glorioso del messia a condizione che i capi giudei si fossero pentiti del loro delitto (3,19 s.). Il discorso di Paolo invece va in tutt’altra direzione.
Quando essi s’accorsero che la popolazione locale aveva intenzione di considerarli alla stregua di due somme divinità, concedendo loro ampi poteri per qualunque iniziativa volessero intraprendere, furono costretti a «strapparsi le vesti» e a «precipitarsi tra la folla», «gridando» d’essere dei semplici «uomini». La situazione insomma era sfuggita loro di mano.
Sono costretti a questo non solo perché erano contrari a qualsiasi culto della personalità (sotto questo aspetto l’ebraismo soffriva di meno illusioni e di meno complessi rispetto al paganesimo), ma anche perché hanno il terrore di veder utilizzato il loro messaggio religioso in chiave politica. Gli apostoli infatti non possedevano né cercavano di possedere alcun progetto politico rivoluzionario.
«Anche noi siamo esseri mortali, umani come voi», si affrettano a dire, come volessero metterli sull’avviso ch’essi non si sentivano assolutamente capaci di modificare, neppur minimamente, la realtà d’oppressione in cui i licaoni e non solo loro vivevano (è questo il senso recondito della frase; quello esplicito indica invece la generale uguaglianza e limitatezza degli uomini).
«Vi predichiamo quindi di convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano». Il Dio «vivente» viene contrapposto agli «uomini mortali», incapaci di compiere un bene reale, destinato a durare nel tempo.
Paolo insomma considera «vanità» non solo il culto della personalità (il quale peraltro avrebbe dovuto essere considerato inevitabile al cospetto di un miracolo), ma anche l’esigenza di liberazione che aveva mosso tale culto. È sintomatico che in questa occasione Paolo non faccia alcun accenno al Cristo.
Paolo vuol dare al suo messaggio un puro e semplice contenuto religioso. Ciò è dimostrato anche dal fatto ch’egli, di fronte all’esigenza di protagonismo politico avanzata dai pagani di Listra, non può garantire altro che un «miracolo individuale». Secondo l’autore degli Atti, in effetti, Paolo può far qualcosa di concreto solo al singolo individuo sofferente (come in genere fa qualunque religione), proprio perché al messaggio cristiano di liberazione è già stata tolta qualsiasi prospettiva politica. Questa guarigione quindi, anche se fosse realmente accaduta (pur non avendo alcunché di miracoloso), poteva apparire come un segno della forza della Chiesa, e non della sua debolezza, soltanto a una mentalità rozza e primitiva.
La liberazione, per Paolo, e la sua guarigione lo dimostra, è soltanto una conquista personale, una conversione interiore alla misericordia di Dio. La guarigione è «segno» solo di questo. In altri termini, essa doveva servire (anche secondo l’autore degli Atti) non ad alimentare l’esigenza di altri eventi ben più importanti (come avviene nei vangeli di Marco e Giovanni), ma doveva invece servire a svilire, a mortificare tale esigenza, indirizzandola verso un nuovo culto religioso. Paolo voleva servirsi della guarigione per strappare consensi alla sua dottrina: non fu forse naturale che quando gli oppressi s’accorsero che la sua dottrina era politicamente un bluff, essi reagissero in modo proporzionato all’illusione che avevano subìto?
L’idolatria dei licaoni non venne ricondotta da Paolo alle sottese esigenze umane di liberazione, ma piuttosto ad esigenze religiose monoteistiche ch’essi dovevano maturare, cioè ad una religiosità monoteistica non meno alienata ed alienante di quella politeistica che già avevano.
Il discorso di Paolo infatti è tipicamente conservatore: «Dio, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada; ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori».
Con fare e intenzioni molto demagogiche, Paolo sostiene che le contraddizioni dei licaoni sono strettamente legate all’ignoranza del vero Dio. Egli tuttavia offre una consolazione: Dio non ha abbandonato nessun popolo della terra, anche se ha permesso a ognuno di seguire la propria strada. Con questo Paolo non solo pone tutti i popoli sullo stesso piano di giusta uguaglianza, ma evita anche di distinguere all’interno di ogni popolo le classi o gli strati sociali oppressi da quelli che invece opprimono.
Egli considera uguali tutte le civiltà e le culture e le ideologie politiche, affermando ch’esse si differenziano solo per quanto riguarda il culto all’unico dio o ai molti dèi.
Ora che i licaoni conoscono il vero e unico Dio – sembra dica Paolo – essi possono essere pienamente soddisfatti, e sotto tutti i punti di vista, e lo saranno anzi per sempre, poiché quanto più lo conosceranno tanto più saranno da questo (nuovo) Dio beneficati. Il Dio cristiano concederà loro con maggiore convinzione ciò che nel passato dava lo stesso, ma con minore entusiasmo, a causa del loro politeismo: piogge, frutti, cibo...
E naturalmente per ottenere questo – Paolo lo fa capire molto chiaramente – non c’è alcun bisogno di lottare contro Roma, basta pregare e vivere in comunità.
In definitiva, l’unica soluzione che Paolo offre agli abitanti di Listra è quella di passare dal desiderio politico di liberazione (espresso in forme politeistiche molto ingenue) alla sua rinuncia (che devono esprimere in forme monoteistiche più raffinate).
Paolo insomma dopo aver offerto parole di speranza e aver così promosso l’entusiasmo popolare, si vede costretto a fare marcia indietro, offrendo parole di rassegnazione e di rinuncia a livello politico, ovvero parole di fiducia religiosa, illusoria, nell’onnipotenza dell’unico Dio ebraico-cristiano.
Vedendo che le folle, «offerto un sacrificio», volevano costringerli a dare alle loro parole una realizzazione pratico-operativa di tipo politico, essi «riuscirono a fatica a farle desistere».
La prima missione finì però in modo drammatico. «Giunsero infatti da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla; essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono fuori della città, credendolo morto».
Questi giudei riescono a convincere facilmente gli abitanti di Listra: dovevano essere degli intellettuali abbastanza stimati. Forse sono giudei convinti della necessità di lottare contro Roma (giudei che facilmente trovano l’appoggio interessato dei correligionari più facoltosi, che non lottano contro Roma, ma che restano legati al «primato d’Israele» e ai suoi privilegi sacerdotali).
Il linciaggio è immediato. Paolo non fa nemmeno in tempo ad appellarsi a un tribunale romano. Salvò la sua vita unicamente perché gli oppositori lo credettero morto (probabilmente uno dei primi sassi lanciati lo colpì alla testa facendolo svenire).
Passati a Derbe (80 km circa da Listra) continuarono a predicare e a fare discepoli. Nel viaggio di ritorno a Listra, Iconio e Antiochia eleggono dei capi («anziani») per le singole comunità, rendendole in tal modo completamente indipendenti dalle sinagoghe locali.
Questi «anziani», con funzioni sacerdotali, non vengono scelti dalla comunità locale. Tuttavia con l’espressione usata da Luca: «li affidarono al Signore», si indica ch’essi non dovevano render conto a chi li aveva istituiti, ma solo alla comunità che rappresentavano. Questo naturalmente non impediva il reciproco confronto sulle posizioni comuni.
Le tribolazioni sofferte ebbero un ottimo effetto sui primi discepoli. Di questo gli apostoli e soprattutto l’ex grande persecutore Paolo si rendevano perfettamente conto. Le persecuzioni fisiche e l’intolleranza verbale per motivi politico-ideologici hanno sempre sortito l’effetto contrario a quello sperato da parte di chi se ne faceva attivo promotore.
Si fermarono a predicare a Perge (città a una decina di chilometri dal mare) e s’imbarcarono ad Attalia per Antiochia di Siria: comunità a cui Paolo e Barnaba si sentivano ancora legati. Qui infatti ritornano non solo per difendere la comunità cristiana da coloro che giungendo da Gerusalemme (15,1 ss.) misero in questione la validità della legge mosaica per i convertiti dal paganesimo, ma anche per dimostrare che le loro convinzioni erano giuste, e cioè che i pagani accettavano la predicazione cristiana meglio dei giudei.
D’altra parte non poteva essere diversamente. I giudei, più abituati a lottare contro l’impero romano anche in quanto «giudei» e non solo in quanto «oppressi» (essi infatti continuavano a credere nella possibilità di ottenere una nazione libera dallo straniero e dallo sfruttamento), erano meno disposti a rinunciare alle loro caratteristiche etnico-nazionalistiche per vivere come i pagani divenuti cristiani.
Sotto questo aspetto il cristianesimo era veramente più progressista del giudaismo: esso aveva compreso che nell’ambito dell’imperialismo romano le distinzioni cultuali, rituali, etniche, linguistiche... non potevano servire per costituire un’alternativa al dominio di Roma.
Roma vedeva le cose da un punto di vista universale, ed appunto così andavano superate le contraddizioni che il suo sistema politico oppressivo generava. La lotta poteva essere svolta anche su un terreno nazionale, si poteva cominciare là dove la situazione era più esplosiva, ma a condizione di tenersi aperti al contatto col mondo intero, a un rapporto paritetico, internazionale, con le popolazioni oppresse di tutto l’impero.
All’ebraismo invece mancò proprio il senso universalistico dell’oppressione: il giudeo voleva liberarsi anzitutto come «giudeo». Esso – come molte altre religioni e culture – non seppe o non volle rinunciare alle sue peculiarità nazionali per cercare di realizzare un nuovo e più ampio fronte popolare.
Qui però si evidenziano i grandissimi limiti non solo dell’ebraismo ma anche del cristianesimo. Tale fronte popolare infatti non doveva avere, per l’ideologia cristiana, alcuna connotazione politica, ma solo religiosa. Cosa che neppure l’ideologia ebraica progressista avrebbe mai accettato.
torna suCap. 15
[1]Ora
alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina:
«Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè,
non potete esser salvi».
[2]Poiché Paolo e Barnaba si
opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro,
fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
[3]Essi dunque,
scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la
Fenicia e la Samarìa raccontando la conversione dei pagani e
suscitando grande gioia in tutti i fratelli.
[4]Giunti poi a
Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli
anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per
mezzo loro.
[5]Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che
erano diventati credenti, affermando: è necessario
circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè.
[6]Allora
si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo
problema.
[7]Dopo
lunga discussione, Pietro si alzò e disse: «Fratelli,
voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra
voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del
vangelo e venissero alla fede.
[8]E Dio, che
conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo
anche a loro lo Spirito Santo, come a noi;
[9]e non ha
fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori
con la fede.
[10]Or
dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo
dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi
siamo stati in grado di portare?
[11]Noi crediamo che per la
grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo
anche loro».
[12]Tutta l’assemblea tacque e stettero
ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi
Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro.
[13]Quand’essi
ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse:
[14]«Fratelli,
ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto
scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome.
[15]Con questo
si accordano le parole dei profeti, come sta scritto:
[16]Dopo
queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide
che era caduta; ne riparerò le rovine e la
rialzerò,
[17]perché
anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle
quali è stato invocato il mio nome,
[18]dice
il Signore che fa queste cose da lui conosciute
dall’eternità.
[19]Per
questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si
convertono a Dio tra i pagani,
[20]ma solo si
ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla
impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue.
[21]Mosè
infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città,
poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe».
[22]Allora
gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere
alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba:
Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande
considerazione tra i fratelli.
[23]E consegnarono loro la seguente
lettera: «Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia,
di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute!
[24]Abbiamo
saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun
incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i
vostri animi.
[25]Abbiamo
perciò deciso tutti d’accordo di eleggere alcune persone
e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e
Paolo,
[26]uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro
Signore Gesù Cristo.
[27]Abbiamo
mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi
queste stesse cose a voce.
[28]Abbiamo
deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo
al di fuori di queste cose necessarie:
[29]astenervi
dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e
dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da
queste cose. State bene».
[30]Essi allora, congedatisi,
discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la
lettera.
[31]Quando
l’ebbero letta, si rallegrarono per l’incoraggiamento che
infondeva.
[32]Giuda e
Sila, essendo anch’essi profeti, parlarono molto per
incoraggiare i fratelli e li fortificarono.
[33]Dopo un
certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per
tornare da quelli che li avevano inviati.
[34*]. [35]Paolo
invece e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando e annunziando,
insieme a molti altri, la parola del Signore.
[36]Dopo alcuni
giorni Paolo disse a Barnaba: «Ritorniamo a far visita ai
fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la
parola del Signore, per vedere come stanno».
[37]Barnaba
voleva prendere insieme anche Giovanni, detto Marco,
[38]ma Paolo
riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da
loro nella Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera.
[39]Il dissenso
fu tale che si separarono l’uno dall’altro; Barnaba,
prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro.
[40]Paolo invece
scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del
Signore.
[41]E attraversando la Siria e la Cilicia, dava nuova
forza alle comunità.
* Il testo occ. aggiunge il v. 34: «Ma Sila decise di restare là». Altri manoscritti aggiungono: «Giuda partì da solo».
*
Il Concilio di Gerusalemme
Se ci si attiene al computo cattolico, su cui, come noto, le interpretazioni sono diversissime, in quanto la Chiesa ha tutto l’interesse a dare la massima credibilità possibile agli avvenimenti narrati nel Nuovo Testamento, il Concilio di Gerusalemme si sarebbe svolto non più tardi dell’anno 50. Gli antefatti della controversia sarebbero scoppiati ad Antiochia.
Chi sono questi «alcuni» di cui parla il v. 1? Stando alla Lettera ai Galati 2,12, si tratterebbe della corrente giudeo-cristiana capeggiata da Giacomo il Minore (Mt 10,3), «fratello del Signore» (Gal 1,18 ss.) o comunque parente stretto di Gesù, di cui conosciamo la Lettera neotestamentaria che porta il suo nome e il linciaggio subìto ad opera dei giudei della capitale verso il 62. Tale corrente considerava la circoncisione indispensabile ai fini della salvezza personale (ovviamente non solo la circoncisione ma anche il rispetto di tutta la legge mosaica, come si evince dal v. 5 di questo capitolo).
Erano politicamente nazionalisti, ma attendisti, non rivoluzionari, come invece i nazareni al tempo del Cristo, poiché nutrivano atteggiamenti di sfiducia nei confronti della maturità politica delle masse giudaiche, resesi indirettamente complici dell’esecuzione romana del Cristo. Dalla Lettera di Giacomo, assai dura contro i ricchi giudei e romani, risulta comunque che questa corrente s'era messa dalla parte dei ceti marginali, per quanto temesse enormemente le influenze culturali straniere.
Contro questo nazionalismo politico e culturale, Antiochia, gli ellenisti, i cristiani di origine pagana vogliono opporre l’universalismo spiritualistico di Paolo, Barnaba e degli altri ellenisti, anche della prima ora come p. es. Stefano e Filippo. Questo universalismo era politicamente conservatore, nel senso che, pur non avendo più alcun interesse a salvaguardare le tradizioni giudaiche, politicamente non metteva affatto in discussione l'imperialismo romano. Solo sul piano culturale il paolinismo era alquanto eversivo nei confronti del giudaismo ortodosso e persino di quello cristiano facente capo a Giacomo il Minore, e poteva apparire tale (e infatti lo sarà per almeno tre secoli) anche agli occhi del paganesimo romano, in quanto di fatto esso andava a negare ogni forma di politeismo e di riconoscimento all’imperatore di qualsivoglia caratteristica divina.
Probabilmente gli «alcuni», di cui sopra, erano stati influenzati dall’ideologia di quei farisei, appena entrati nella comunità cristiana, che, pur avendo manifestato, sin dai tempi di Gesù, idee prevalentemente moderate, in contrasto col loro passato rivoluzionario dei tempi di Erode il Grande, non erano alieni all’idea di ripensarsi culturalmente in maniera propositiva – sulla scia di Paolo –, pur temendo che la predicazione paolina avrebbe potuto snaturare politicamente l’esigenza di una patria libera e indipendente.
Era naturale questa involuzione all’interno della comunità? Sì, perché non solo gli obiettivi fondamentali del vangelo di Gesù non erano stati realizzati, ma anche perché col passare del tempo quegli stessi obiettivi erano stati sostanzialmente modificati, per cui la posizione vetero-giudaica di Giacomo veniva a porsi come una inevitabile conseguenza. Si ricordi che Giacomo il Minore aveva sostituito Pietro dopo la fortunosa evasione di quest’ultimo dal carcere della capitale.
Paolo, nella sua Lettera ai Galati, parla di una polemica scoppiata fra lui e Pietro a causa appunto di questa corrente revisionista, le cui posizioni erano più retrive di quelle petrine. Egli sostiene che prima che i filo-giacomiti giungessero ad Antiochia, Pietro condivideva il concetto, che Paolo aveva iniziato a predicare 14 anni prima (Gal 2,1), dell’uguaglianza morale, nell’ambito dell’ideologia cristiana, di pagani e giudei.
Ma dopo la venuta dei giudeo-cristiani, Pietro aveva cambiato atteggiamento, mostrando così le sue preferenze per il giudaismo e rendendo per così dire eccezionale, rispetto alla regola, la cosiddetta conversione di Cornelio, la quale in effetti, almeno fino alla predicazione paolina, non aveva comportato particolari conseguenze nell’impianto ideologico della comunità primitiva di Gerusalemme, in quanto Pietro non dimostrò mai un vero interesse a portare alle più logiche e inevitabili conseguenze le considerazioni di Paolo sui rapporti tra giudaismo ed ellenismo, o comunque non riuscì mai a trasformare l’interesse personale che nutriva nei confronti dell’ideologia paolina in una vera e propria proposta politica e culturale rivolta a tutta la comunità.
Paolo, nei confronti di Pietro, appariva sicuramente un progressista, ma questo lato della sua predicazione Pietro era disposto ad accettarlo sul piano più culturale che politico. Questo, a noi che siamo abituati a considerare Paolo un politico conservatore, non deve apparirci strano: il carattere regressivo dell’ideologia politica di Paolo va messo in relazione con quello progressivo della predicazione del Cristo, ma è evidente che se lo si mette in relazione con l’ideologia degli strati politici giudaico-cristiani, l’analisi assume sfumature diverse, come più sopra abbiamo visto.
Più strano è il fatto che mentre nell’atteggiamento ambiguo di Pietro ci si erano ritrovati molti altri giudeo-cristiani, fra cui lo stesso Barnaba, qui invece appare che Paolo e Barnaba si oppongano «risolutamente», cioè entrambi alla stessa maniera, alla corrente di Giacomo. È quindi evidente che il diplomatico Barnaba, mentre all’inizio (vedi il primo viaggio di Paolo) aveva assunto un atteggiamento più vicino alla predicazione paolina, in seguito, per amore di pace, l’aveva data vinta all’ostinazione e alla chiusura settaria dei giudeo-cristiani, definiti da Paolo, in Gal 2,4, con l’appellativo inequivoco di «falsi fratelli».
La comunità di Antiochia inviò a Gerusalemme Paolo, Barnaba e altri (in Gal 2,1 si cita Tito). Paolo afferma che accettò di andare non perché si sentiva costretto ma «in seguito ad una rivelazione» (Gal 2,2), senza specificarne la natura. Paolo si serve sempre, al momento opportuno, della tesi della resurrezione di Cristo per affermare i propri punti di vista (cioè se Cristo è risorto, la verità non è patrimonio di nessuno in particolare, ma di chiunque al quale il Cristo, di volta in volta, la voglia rivelare. Ricordiamo che quando Paolo iniziò a predicare la teoria della figliolanza divina del Cristo, lo fece asserendo d’aver ottenuto una rivelazione personale sulla strada di Damasco; col che in pratica egli rivendicava un pari diritto all’apostolato).
Egli insomma avvertiva di non avere più alcun legame ideologico o politico, ma solo formale ed esteriore (tradizione, origine, provenienza, ecc.) con la città di Gerusalemme. Non a caso mise piede in questa città dopo ben «14 anni» (Gal 2,1) di predicazione, dal giorno in cui vi incontrò per la prima volta Pietro e Giacomo il Minore, o comunque dal giorno della sua conversione.
Essi lasciarono Antiochia «scortati per un tratto dalla comunità». Evidentemente temevano rappresaglie da parte dei giudei ortodossi, che odiavano a morte quello che per loro era stato il fariseo persecutore dei cristiani, il quale, incurante dei pericoli cui andava incontro, continuava a predicare il suo nuovo vangelo; infatti, mentre erano in Fenicia e Samaria essi cercavano appoggi per il loro vangelo e li ottennero abbastanza facilmente.
L’accoglienza nella città santa sembra avere avuto una veste ufficiale, ma Paolo in Gal 2,4 dirà il contrario, a testimonianza ch’egli era malvisto non solo tra i vetero-giudei ma anche tra quei giudeo-cristiani che non volevano rinunciare a molti loro usi e costumi.
A Gerusalemme egli espose il suo vangelo «privatamente alle persone più ragguardevoli», cioè più fidate, temendo di provocare rotture traumatiche in seno alla comunità della Chiesa madre. Paolo non vuole scandalizzare nessuno, non vuole passare per un provocatore, per un seminatore di discordie. Egli vuole sentirsi libero, ma anche bene intenzionato nei confronti dei giudeo-cristiani, a condizione naturalmente che essi se ne restino a Gerusalemme e che non si «intromettano a spiare la libertà che abbiamo in Gesù Cristo, allo scopo di renderci schiavi» (Gal 2,4).
Più chiaro di così non poteva essere: Paolo chiedeva non ingerenza nella sua predicazione e dei suoi seguaci, non intromissione negli affari interni di Antiochia, confronto libero e aperto. A Gerusalemme essi non «furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani» – come dice Luca, sempre preoccupato di smorzare i contrasti –, ma, più genericamente, solo dalle persone più influenti e ragguardevoli (cioè da quelle persone importanti, disposte ad ascoltare le loro ragioni). Fra queste persone Paolo cita, nel seguente ordine: «Giacomo, Cefa e Giovanni» (Gal 2,9). Fra l’altro il collegio dei Dodici (ammesso e non concesso che sia mai esistito) da tempo non esisteva più a Gerusalemme.
Al Concilio (vv. 5-6-7) appare comunque chiaro che la corrente di Giacomo era spalleggiata dai farisei «diventati credenti». Probabilmente proprio l’appoggio esplicito di questi farisei ha fatto sì che negli Atti di Luca confluissero due tradizioni: una, risalente alla posizione di Giacomo, l’altra risalente alla posizione di Pietro. Pietro infatti nel suo discorso appare più comprensivo e tollerante di Giacomo.
Invece Paolo non fa distinzioni fra le tre «colonne» (Gal 2,9) e afferma che Giacomo, Cefa e Giovanni scelsero di limitare la loro missione ai circoncisi (Pietro dunque rinunciò alle aperture acquisite ad Antiochia stando con Paolo e con gli ellenisti. L’apologetica cattolica invece afferma che l’incidente di Antiochia avvenne dopo il Concilio). Paolo anzi afferma, contraddicendo apertamente Luca, che Pietro si sentiva apostolo solo dei circoncisi: «colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani» (Gal 2,8).
Evidentemente la conversione del centurione Cornelio era stata nella vita di Pietro un puro e semplice caso, o forse l’episodio non è mai avvenuto in quanto troppo simile a quello dei vangeli, in cui il centurione ai piedi della croce si converte, o forse Cornelio fu lo stesso che fece evadere Pietro dalla prigione di Gerusalemme e che per questa ragione ha ottenuto dai redattori degli Atti un trattamento di riguardo, a prescindere dalla sua conversione, che probabilmente non c’è mai stata.
Il fatto è che Paolo rivendica esclusivamente a se stesso l’iniziativa d’aver predicato per primo il Cristo risorto ai pagani o comunque d’averlo fatto nel modo migliore e più convincente e coerente (prima di lui si ricordino gli ellenisti fuggiti da Gerusalemme al tempo della cospirazione contro Stefano).
Discorso di Pietro
Questo discorso (vv. 7-11) è completamente inventato, se lo si considera attribuito a Pietro; non lo è invece se lo si attribuisce a Paolo. Se Pietro avesse veramente detto queste cose, non ci sarebbe stato l’incidente di Antiochia (né prima né, come vuole l’apologetica cattolica, dopo il Concilio).
Luca ha voluto differenziare Pietro dalla linea e dalla condotta etico-politica di Giacomo, ma in realtà le cose procedettero diversamente. Si può anzi dire che proprio in occasione di questo Concilio (termine peraltro esagerato stando a quanto dice Paolo in Galati), Pietro decise definitivamente di optare per le tesi di Giacomo, appoggiato in questo da Giovanni. Viceversa, dalla sua evasione sino all’incidente di Antiochia, Pietro aveva manifestato una certa simpatia per le tesi di Paolo. Pietro e Giovanni si avvicineranno di nuovo alle tesi di Paolo solo dopo il 70, cioè solo dopo che la possibilità di costruire un regno politico-nazionale indipendente da Roma era definitivamente sfumata, ma forse Pietro era già morto e il Giovanni manipolato del quarto vangelo non può essere quello dell’Apocalisse (anzi è certo che il Giovanni evangelista non è lo stesso degli Atti degli apostoli, proprio perché sul concetto di «resurrezione» vi fu rottura tra i due). Se qui, al v. 7, al posto di Pietro mettessimo Paolo, la coerenza del testo resterebbe salva. Questo discorso infatti avrebbe potuto benissimo farlo non Pietro ma Paolo.
Il contenuto fondamentale del discorso è l’uguaglianza delle etnie, dei popoli e quindi degli uomini che, con le loro diverse culture e lingue, credono nel Cristo risorto in virtù della fede interiore e della grazia (la grazia è un tipico concetto paolino). Il v. 10 inoltre è troppo duro per pensare che l’espressione ivi contenuta sia stata pronunciata da Pietro. Con essa praticamente si fa capire che il primato di Israele è storicamente finito, in quanto non è possibile rispettare pienamente la legge mosaica in mancanza di un potere politico effettivo e di una patria libera. Si noti infine che Pietro non si riferisce esplicitamente (come avrebbe dovuto) alla conversione di Cornelio.
Il v. 12 è chiaramente apologetico. Gli Atti, paragonati alle lettere di Paolo, sembrano fatti apposta per sdrammatizzare le situazioni. Luca si serve di una testimonianza attribuita a Pietro e di alcuni miracoli attribuiti a Paolo per avvalorare la tesi dell’inutilità della circoncisione. Questo a riprova che la resistenza politica dei giudeo-cristiani era molto forte.
Viceversa, il discorso di Giacomo (v. 13) appare più verosimile. Giacomo sostiene che le parole di Pietro (cioè di Paolo) sono giuste in quanto già dette dai profeti (in particolare da Amos 9,11 s.). è caratteristico dell’integrismo accettare determinate affermazioni solo se già contenute o implicite in altre appartenenti alle fonti classiche. Solo che Giacomo le accetta con una riserva fondamentale: quando la «tenda di Davide» sarà riedificata, allora il Dio d’Israele potrà essere comunicato ai pagani, senza che vi siano differenze di sorta.
Per aprirsi ai pagani e considerarli a pari titolo dei giudei, Giacomo vuole prima che si realizzi il trionfo politico-nazionalistico della Giudea. Amos addirittura dice che dopo che sarà ricostruita la «capanna di Davide», tutte le nazioni che erano state vassalle di Davide dovranno essere riconquistate (da Israele). La citazione riportata da Luca si basa su varianti della traduzione greca dei LXX, che però non conosceva queste sfumature politico-nazionalistiche. I Settanta infatti non parlano di «nazioni vassalle», ma del «mondo intero», in una prospettiva più universalistica e meno politicizzata, meno militaristica e più etica. Forse Giacomo si riferiva alla versione originale del testo ebraico di Amos, ma qui i circoli ellenistico-cristiani hanno preferito mettergli in bocca la versione a loro più vicina.
Giacomo dunque non esclude che fra i pagani si possa formare un popolo che accetti il monoteismo ebraico, ma esclude categoricamente che questo popolo, finché la tenda6 di Davide non sarà riedificata, possa essere considerato uguale a quello giudaico. La conversione dei pagani dipenderà dalla grandezza dei giudei. E la parola di Giacomo, leader indiscusso della comunità, viene qui riportata perché dovette risultare come decisiva o definitiva. Paolo in Gal 2,9 lo cita per primo, anche se sembra preferirgli Pietro.
Giacomo in sostanza ha fatto un discorso politicamente irrealistico, in quanto ha ribadito l’importanza storica d’Israele come nazione e come civiltà giudaica in un contesto storico e geopolitico che contraddiceva tutto ciò abbastanza nettamente (in quanto l’opposizione a Roma, essendo condotta in maniera spontaneistica e frammentaria, non produceva risultati significativi) e anche in contrasto con la stessa predicazione del Cristo, secondo cui una liberazione politica di Israele avrebbe dovuto necessariamente comportare una sostanziale revisione dei tradizionali principi culturali e religiosi e avrebbe dovuto essere di «popolo» e non di «fazioni» in lotta tra loro.
La speranza di Giacomo resta sempre quella di un ritorno glorioso del messia politico, visto in chiave veterotestamentaria. E tuttavia appare interessante ch’egli abbia voluto ribadire che le questioni politiche (la liberazione di Israele) dovevano rimanere prioritarie su quelle culturali di Paolo e che questo primato concesso da Paolo alla cultura (l’universalismo della fede nel Cristo risorto) sulla politica poteva essere tollerato solo a condizione che fosse rivolto esclusivamente ai pagani.
Ai vv. 19-20-21 il Concilio pone le condizioni perché ai pagani sia permesso di non circoncidersi e di essere considerati quasi come gli ebrei: no al politeismo (inclusi tutti i sacrifici rituali), no al malcostume (specie a livello sessuale), no al sangue bevuto, no agli animali non macellati alla maniera ebraica, sì alla possibilità di ascoltare i commenti rabbinici sulla legge mosaica nelle sinagoghe durante il sabato. Sono precetti – come si può vedere – di tipo legale-rituale.
In pratica Giacomo accetta soltanto la non ingerenza invocata da Paolo, ma da parte sua continua a ribadire che se i pagani convertiti vogliono essere accettati dai giudeo-cristiani devono per forza sottoporsi a delle precise condizioni. Fra queste l’unica su cui Giacomo transige è la circoncisione. Quanto al sabato, in questo giorno – ci tiene a ricordarlo – la legge e la tradizione mosaica viene letta e predicata e commentata in tutte le sinagoghe del mondo.
Tuttavia Paolo nella Lettera ai Galati dice che non gli «fu imposto nulla di più» (2,6). Di più rispetto a cosa? Di più della richiesta di non scandalizzare i giudeo-cristiani con il suo vangelo, ovvero con la libertà acquisita stando coi pagani.
Il Concilio per Paolo fu una soluzione di compromesso in questo senso, che ognuno avrebbe continuato a fare le stesse cose di prima, senza però che i giudei di Gerusalemme ficcassero il naso nelle faccende di Antiochia e delle altre città di competenza degli ellenisti. In altre parole, Paolo avrebbe fatto meglio, se non voleva avere noie, a limitare il suo apostolato, la sua predicazione ai non-circoncisi, lasciando definitivamente a Pietro, Giovanni e Giacomo il compito di fare proseliti tra i circoncisi.
Era una grossa concessione che Paolo avrebbe dovuto fare, ma vedremo che non la farà, in quanto voleva sentirsi libero di predicare a chi gli pareva. E comunque in Galati 2,10 l’unica richiesta che venne rivolta a Paolo fu quella di «ricordarsi dei poveri». Ciò che appunto egli fece organizzando in seguito una colletta (1 Cor 16,1), o forse anche questa colletta deve essere messa in relazione al suo arrivo a Gerusalemme.
Che senso hanno le indicazioni poste da Giacomo nella sua lettera (vv. 22-29)? Esse non sembrano essere precisate allo scopo di permettere ai pagani di metterle in pratica, nel caso in cui la richiesta, da parte di quest’ultimi, sia di abbracciare il cristianesimo predicato nelle sinagoghe ebraiche. Esse piuttosto sembrano voler ribadire a quei pagani filo-ebraici ancora incerti se restare in sinagoga o seguire Paolo, le condizioni fondamentali per poter operare una scelta definitiva.
A questi pagani «timorati di Dio», cioè proseliti, Giacomo non chiede più la circoncisione, poiché teme di perderli, però chiede di rispettare gli obblighi più importanti sul piano rituale-legale. Insomma queste clausole si riferiscono a quei pagani che volevano diventare cristiani, frequentando le sinagoghe ebraiche locali, cioè accettando di avere coi giudei un rapporto abbastanza stretto. Questi pagani proseliti esistevano da tempo nella società ebraica, ma ora la Chiesa di Gerusalemme li dispensa definitivamente dall’obbligo della circoncisione, che in età adulta poteva essere adempiuta con non poca riluttanza. Forse però questi pagani, a giudizio di Giacomo, potevano aspirare a restare «timorati di Dio», senza mai poter diventare veri e propri «proseliti» (i quali erano tali proprio per aver accettato la circoncisione).
Si può però anche pensare che Giacomo volesse far accettare da parte dei giudei delle sinagoghe locali i «timorati di Dio» allo stesso titolo dei proseliti, anche se i primi non volevano circoncidersi. La circoncisione diventava insomma una libera scelta, non un’imposizione.
Dunque con la lettera apostolica si ribadiscono – come si è visto – le condizioni da rispettare. Essa venne scritta non per i pagani divenuti cristiani, estranei alla sinagoga, ma per non perdere quei pagani «timorati di Dio» che invece frequentavano la sinagoga e che erano tentati, sentendo la predicazione di Paolo, di abbandonarla.
Ecco perché Paolo non ricorda in alcun luogo questa lettera, essa non lo riguardava. Luca non afferma che Paolo abbia diffuso o pubblicato il decreto mentre attraversava la Siria e la Cilicia. Ne parla solo a proposito delle città di Derbe, Listra e Iconio (At 16,4) e solo perché in realtà Paolo voleva continuare a rivolgersi anche ai giudei.
Al v. 24 di questo capitolo ci si scusa del comportamento dei farisei che non avevano ricevuto alcun mandato. Ma questa è solo una finzione, poiché le tesi dei farisei erano sostanzialmente condivise da Giacomo.
Come venne accolto il decreto? Luca dice al v. 31 che «si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva», ma al v. 32 è costretto a dire il contrario: Giuda e Sila, inviati da Giacomo, «parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificavano». Solo «dopo un certo tempo» se ne tornarono a Gerusalemme, anzi, paradossalmente, dei due solo Giuda partì, poiché Sila (o Silvano), venendo a contatto con gli ellenisti, decise di abbracciare la causa di Paolo.
E lo stesso evangelista Marco dovette convenire, dopo il Concilio, che le tesi di Paolo erano più praticabili di quelle di Giacomo, ma Paolo rifiutò di averlo al suo seguito dopo l’incidente della Panfilia. Barnaba, ancora una volta, si offrì come paciere e mediatore. Ma tutto fu vano: Paolo non era intenzionato a perdonare chi non solo aveva mostrato dubbi e perplessità, ma che addirittura li aveva abbandonati nel corso del primo viaggio missionario.
Barnaba cercò d’insistere perché gli sembrava assurdo che per questa ragione Paolo fosse così duro e risoluto: in fondo la rinuncia di Marco non pregiudicò gli esiti di quella missione; per di più ora Marco era disposto a rivedere il suo giudizio negativo sull’operato di Paolo.
Ma Paolo ne fa una questione di principio: la sua missione è troppo delicata, e Marco è inaffidabile. Questa ostinata fermezza indurrà lo stesso Barnaba a non seguirlo nel suo secondo viaggio, per cui mentre Barnaba e Marco si diressero nuovamente verso l’isola di Cipro, Paolo sceglierà invece Sila e partirà alla volta della Siria e della Cilicia.
torna suCap. 16
[1]Paolo
si recò a Derbe e a Listra. C’era qui un discepolo
chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre
greco;
[2]egli era assai stimato dai fratelli di Listra e di
Iconio.
[3]Paolo
volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere per
riguardo ai Giudei che si trovavano in quelle regioni; tutti infatti
sapevano che suo padre era greco.
[4]Percorrendo
le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli
e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero.
[5]Le
comunità intanto si andavano fortificando nella fede e
crescevano di numero ogni giorno.
[6]Attraversarono quindi la
Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato
loro di predicare la parola nella provincia di Asia.
[7]Raggiunta la
Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù
non lo permise loro;
[8]così,
attraversata la Misia, discesero a Troade.
[9]Durante la
notte apparve a Paolo una visione: gli stava davanti un Macedone e lo
supplicava: «Passa in Macedonia e aiutaci!».
[10]Dopo
che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la
Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la
parola del Signore.
[11]Salpati da Troade, facemmo vela verso
Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e
[12]di qui a
Filippi, colonia romana e città del primo distretto della
Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni;
[13]il sabato
uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si
facesse la preghiera, e sedutici rivolgevamo la parola alle donne
colà riunite.
[14]C’era
ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora,
della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le
aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo.
[15]Dopo esser
stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: «Se
avete giudicato ch’io sia fedele al Signore, venite ad abitare
nella mia casa». E ci costrinse ad accettare.
[16]Mentre
andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi
padroni facendo l’indovina.
[17]Essa seguiva
Paolo e noi gridando: «Questi uomini sono servi del Dio
Altissimo e vi annunziano la via della salvezza».
[18]Questo fece
per molti giorni finché Paolo, mal sopportando la cosa, si
volse e disse allo spirito: «In nome di Gesù Cristo ti
ordino di partire da lei». E lo spirito partì
all’istante.
[19]Ma vedendo i
padroni che era partita anche la speranza del loro guadagno, presero
Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai
capi della città;
[20]presentandoli ai magistrati dissero:
«Questi uomini gettano il disordine nella nostra città;
sono Giudei
[21]e
predicano usanze che a noi Romani non è lecito accogliere né
praticare».
[22]La folla
allora insorse contro di loro, mentre i magistrati, fatti strappare
loro i vestiti, ordinarono di bastonarli
[23] e dopo
averli caricati di colpi, li gettarono in prigione e ordinarono al
carceriere di far buona guardia.
[24]Egli,
ricevuto quest’ordine, li gettò nella cella più
interna della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi.
[25]Verso
mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i
carcerati stavano ad ascoltarli.
[26]D’improvviso
venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta
della prigione; subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le
catene di tutti.
[27]Il
carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte della
prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i
prigionieri fossero fuggiti.
[28]Ma Paolo gli
gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui».
[29]Quegli
allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò
ai piedi di Paolo e Sila;
[30]poi li
condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per esser
salvato?».
[31]Risposero:
«Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua
famiglia».
[32]E
annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua
casa. [33]Egli
li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne
lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i
suoi;
[34]poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola
e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in
Dio.
[35]Fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire:
«Libera quegli uomini!».
[36]Il
carceriere annunziò a Paolo questo messaggio: «I
magistrati hanno ordinato di lasciarvi andare! Potete dunque uscire e
andarvene in pace».
[37]Ma Paolo
disse alle guardie: «Ci hanno percosso in pubblico e senza
processo, sebbene siamo cittadini romani, e ci hanno gettati in
prigione; e ora ci fanno uscire di nascosto? No davvero! Vengano di
persona a condurci fuori!».
[38]E le guardie
riferirono ai magistrati queste parole. All’udire che erano
cittadini romani, si spaventarono;
[39]vennero e si
scusarono con loro; poi li fecero uscire e li pregarono di partire
dalla città.
[40]Usciti dalla
prigione, si recarono a casa di Lidia dove, incontrati i fratelli, li
esortarono e poi partirono.
*
In questo capitolo si descrive il secondo viaggio missionario, cioè propagandistico, di Paolo, accompagnato da Sila (Silvano) che resterà con lui fino a Corinto. Da qui verranno spedite le due Lettere ai Tessalonicesi. Di Sila, dopo la partenza di Paolo da Corinto, gli Atti non parleranno più. Pare che Sila sia stato il redattore della prima Lettera di Pietro (1 Pt 5,12).
Lo scopo del secondo viaggio è di visitare le comunità già fondate (da almeno un anno), ma anche ovviamente di costituirne di nuove. La tattica è cambiata, è diventata più prudente.
Raggiunte, dopo circa 350 km, Derbe e Listra, Paolo e Sila incontrano Timoteo, che vive a Listra ed è persona colta (2 Tim 3,15): era stato loro raccomandato dalle stesse comunità cristiane delle due cittadine.
Timoteo, pur avendo la madre ebrea (cosa molto importante per l’appartenenza etnico-religiosa) non era stato circonciso, perché il padre, essendo di origine e di cultura greca, non lo riteneva indispensabile per il futuro del proprio figlio.
La madre evidentemente, pur essendo una credente del giudaismo, non aveva interferito in questa scelta. A Paolo invece non sembra vero di poter avere come collaboratore un intellettuale di cultura ellenistica che, avendo una madre ebrea, avrebbe potuto rivolgersi tranquillamente anche ai giudei della diaspora. Ecco perché, pur non credendo più nel valore etico-tribale della circoncisione, gli impone questo rito, evidentemente nella ferma intenzione di continuare a rivolgersi non solo ai pagani ma anche agli ebrei, eludendo così le decisioni conciliari a suo carico.
Timoteo diventerà un grande collaboratore di Paolo (solo le Lettere ai Galati e a Tito non parlano di lui).
Per poter predicare anche agli ebrei Paolo non solo fece circoncidere Timoteo, ma pubblicizzò anche, in quella zona dell’odierna Turchia, il decreto conciliare. Evidentemente non considerava ancora chiusa la sua sfida col mondo giudaico o comunque sperava di trovare in questo ambiente, soggetto qui ad influenze elleniche, quegli appoggi di cui ancora aveva bisogno prima di avventurarsi decisamente verso un’altra capitale, ben più importante di Gerusalemme: Roma.
Fu costretto a questa tattica anche perché le prime comunità create a Listra, Iconio e Derbe, nel corso del primo viaggio, erano composte prevalentemente di giudei, i quali erano sicuramente a conoscenza di quanto disposto in occasione del Concilio.
Timoteo era un discepolo ideale per Paolo, una sorta di alter ego, sicuramente migliore di Barnaba, che in definitiva restava troppo legato alle tradizioni ebraiche. Timoteo poteva predicare agli ebrei come ebreo al 100%, perché sicuramente la madre aveva svolto il suo ruolo di educatrice domestica, e poteva farlo anche coi pagani come pagano al 100%, in quanto cittadino romano, conoscitore della lingua greca e sensibile alla «grecità», essendo stato educato ai principi e ai valori di questa cultura dal padre pagano.
Paolo vuole sentirsi libero di fare quello che vuole, o meglio, non vuole sentirsi legato a cose in cui non crede più. Paolo è spregiudicato, ma non è immorale o senza principi. Egli infatti, come aveva già fatto ad Antiochia di Pisidia (13,14-43) e ad Iconio (14,1) continua a rivolgersi, nella fase iniziale di ogni viaggio missionario, anzitutto agli israeliti. Lo farà anche a Filippi (16,13-16), a Tessalonica (17,1-4), a Berea (17,10-12), ad Atene (17,17), a Corinto (18,1-5), a Efeso (18,19-21; 19,8) e persino a Roma (28,17-23).
Questo per togliere agli ebrei qualunque pretesto, qualunque occasione di polemica sulla questione della precedenza. Ma anche perché s’era accorto, già nel corso del primo viaggio, che tra i pagani di estrazione più povera facilmente il suo messaggio veniva interpretato in chiave rivoluzionaria, come una forma di protesta contro il culto divino della personalità imperiale, contro i limiti istituzionali del politeismo pagano, contro l’abbandono e la discriminazione in cui venivano tenute le province dell’impero.
In realtà Paolo voleva soltanto limitarsi a un discorso culturale, cioè di religione e di comportamento morale. Nel secondo viaggio infatti egli si rende conto ch’era meglio predicare non ai ceti più poveri e marginali, ma a quelli di una certa cultura e soprattutto di una certa estrazione sociale (commercianti, artigiani...), i quali non gli avrebbero chiesto di tradurre immediatamente in maniera eversiva il contenuto del suo vangelo.
Paolo voleva fare del cristianesimo una questione religiosa che servisse a porre un’alternativa soprattutto al dilagante politeismo pagano e al relativismo etico che gli era connesso, ma che servisse anche a porre un freno, in virtù della tesi sulla figliolanza divina del Cristo, alla personalizzazione della politica incentrata sulla figura carismatica dell’imperatore; pertanto la necessità di frequentare le sinagoghe era solo in relazione al fatto che qui avrebbe potuto incontrare dei pagani proseliti che già avevano accettano il monoteismo e che gli avrebbero permesso di introdursi in ambienti più direttamente greco-romani.
Luca dice che pubblicizzarono il decreto conciliare, ma è evidente che la parte che a Paolo premeva di più di quel documento era il fatto che gli ebrei della diaspora non dovevano più chiedere la circoncisione ai pagani neo-convertiti.
Nei vv. 6-7 viene detto che non riuscirono ad andare in Asia e in Bitinia. Il motivo ci è ignoto. È probabile che sapessero che in quelle regioni la situazione dei poveri era disastrosa e carica di tensioni sociali e fermenti politici, in virtù dei quali il loro messaggio poteva essere più facilmente frainteso o strumentalizzato. Paolo vuole evitare d’illudere i suoi interlocutori con promesse che poi non sarebbe stato in grado di mantenere. Si pensi solo al fatto che un predicatore intenzionato a mettere in piedi comunità di seguaci in tutte le città visitate, facilmente offriva l’impressione d’essere un agitatore politico, con un messaggio alternativo da proporre alle masse.
Dopo aver raggiunto Derbe, Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia si diressero nella regione della Galazia, a nord, ove Paolo fu trattenuto da una malattia, ma grazie alla quale poté annunciare il suo vangelo ai Galati (Gal 4,13 s.). La Galazia era diventata provincia romana nel 25 a.C. La Lettera ai Galati venne scritta a Efeso.
Poi andarono verso ovest, fino alle coste della Misia. Forse Paolo dalla Frigia voleva dirigersi verso Efeso, ma quando arrivò a Troade si convinse che sarebbe stato meglio toccare le città principali della Macedonia e in particolare la capitale della Grecia, Atene.
Al v. 9 viene indicata una persona che, rimasta anonima, gli avrebbe suggerito di passare in Macedonia, ch’era stata conquistata dai romani nel 146 a.C. Si è pensato a Luca, cioè allo stesso redattore degli Atti, per il motivo che al v. seguente l’espressione «cercammo di partire» è la cosiddetta «prima sezione noi» degli Atti. Si tratta forse della firma di Luca?
Originario di Antiochia, Luca non era certamente un ebreo, neppure di tipo ellenista. Paolo può aver accettato la sua sequela perché avrà visto ch’era un intellettuale moderato, che non lo avrebbe messo in difficoltà chiedendogli chissà quale impegno politico. Probabilmente si sarà più sentita imbarazzata quest’anonima persona, che, essendo di origine pagana, era andata a cercare un rapporto costruttivo con gli ebrei.
Tuttavia queste son solo congetture. Quel che è certo è che sempre più la comitiva si rendeva conto della necessità di indirizzare il vangelo sia agli ebrei della diaspora sia ai pagani interessati alla religione, indifferentemente, facendo bene attenzione a non lasciarsi coinvolgere in questioni politiche.
Giungono quindi alla città di Troade (a 20 km dall’antica Troia), importante nodo di comunicazione nelle traversate tra l’Asia proconsolare e la Macedonia.
Fanno poi vela verso l’isola di Samotracia e raggiungono per la prima volta le coste europee a Neapolis. La comitiva ha già percorso in linea d’aria oltre 1500 km via terra e più di 200 km via mare. Da Neapolis, dopo circa 15 km, giungono a Filippi, teatro della famosa battaglia del 42 a.C. tra Antonio, Ottaviano, Bruto e Cassio.
Filippi era città completamente pagana, latina; gli ebrei non avevano neppure una sinagoga, forse erano pochissimi. La comitiva ritiene che durante il sabato gli ebrei facciano le loro abluzioni presso il fiume che scorre fuori città e s’intrattiene a parlare con alcune donne, più facilmente abbordabili.
A quanto pare la missione non stava avendo un grande successo. Dopo 1700 km la comitiva sembra non abbia fatto alcunché di significativo e il viaggio voleva essere «missionario», non semplicemente «esplorativo». Luca non ci racconta quasi nulla. Probabilmente Paolo aveva mutato il tono dei discorsi, rendendolo meno aggressivo, più diplomatico, o forse era mutata la tattica, in quanto qui Paolo sembra più disposto a incontrare la gente privatamente.
Lidia era una pagana proselite, «credente nel Dio ebraico», commerciante di porpora. Il fatto che gli apostoli accettino di rivolgersi di preferenza ai ceti benestanti e che qui l’evangelizzazione della città avvenga per opera della conversione di una donna pagana non intellettuale, è indicativo del mutamento di rotta avvenuto in Paolo tra il primo e il secondo viaggio.
Fu questo il primo centro europeo evangelizzato. Forse Paolo s’era anche accorto che quanto più penetravano nelle zone occidentali dell’impero, tanto più aumentava il rischio di non poter predicare il vangelo. Si badi: non solo perché il loro esplicito monoteismo rischiava di apparire ai politeisti pagani come una sorta di ateismo volgare, ma anche perché la figura dell’ebreo era mal vista, e non solo a causa della propaganda del potere istituzionale, ma anche perché gli ebrei, legati a una patria oppressa, tendevano a rimarcare la loro diversità.
Lidia accetta d’essere battezzata alla maniera cristiana, benché fosse proselite degli ebrei, e la sua conversione trascina quella di tutta la sua famiglia. Gli ebrei lì presenti sembrano non fare alcuna obiezione, alcuna opposizione al vangelo di Paolo, come se neppure si siano accorti del rito, o forse proprio perché il rito era analogo a quello che loro avevano già visto fare ai tempi del Precursore, che certo cristiano non era, e la diversità, in sostanza, stava solo nelle parole. Il quadro ha un che d’idilliaco, a testimonianza del fatto che quando Paolo si limitava a questioni puramente religiose, trattate con circospezione e privatezza, tutto sembrava filare liscio come l’olio.
Le comunità della Macedonia e in particolare quella di Filippi saranno sempre molto generose con lui (Fil 4,10-19; 2 Cor 8,1-5).
Tuttavia, proprio a Filippi la comitiva ebbe un problema molto difficile da risolvere, perché qui Paolo intimorì una giovane schiava che «procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l’indovina». La schiava, messasi a fare la maga per migliorare il suo status sociale, aveva riconosciuto il valore del vangelo di Paolo e li seguiva, sicché «per molti giorni» Paolo l’aveva lasciata fare, pensando che questo avrebbe potuto agevolare la sua missione o comunque non ostacolarla.
Poi quando s’accorse che la schiava non aveva il coraggio o l’intenzione di diventare cristiana (i romani di questa città erano piuttosto ostili ai giudei), e che la sua predicazione aveva solo un fine d’interesse personale e rischiava per di più di ridicolizzare il vangelo o comunque di sminuirne la portata, Paolo, che certamente non amava che qualcuno, non autorizzato, affiancasse gli apostoli nella predicazione, o che il proprio vangelo rischiasse di confondersi con qualcuna delle molte religioni misteriche o esoteriche d’oriente, interviene con decisione, affermando di predicare il vangelo di Gesù Cristo e di non essere semplicemente, come lei aveva detto, un «servo di Dio». E la minacciò gravemente.
Al che lei si impaurì. Subì uno choc. E smise di andare in giro a fare la maga e l’indovina. Ovviamente non possiamo sapere se le capitò ben di peggio, ma conoscendo la rudezza di Paolo non sarebbe strano pensarlo.
In ogni caso i suoi padroni reagiscono immediatamente e giustificano i mancati introiti con pretesti di ordine politico, giuridico, culturale e religioso; accusano insomma i predicatori d’aver violato l’ordine pubblico. Questi pagani manifestano chiari umori razzisti. Infatti li accusano anzitutto d’essere giudei e in particolare d’essere dei propagandisti del giudaismo.
Il che fa pensare che le autorità romane tollerassero il giudaismo solo a condizione che questo venisse praticato e predicato in ambiti strettamente privati, senza far proseliti di sorta. L’integralismo pagano, che univa la politica alla religione, facendo di questa uno strumento di quella, non impediva tanto di avere culti diversi da quelli ufficiali, quanto di considerarli in alternativa a quest’ultimi e soprattutto di mostrarlo pubblicamente. Chi seguiva un culto diverso era tenuto a seguire anche quelli ufficiali, almeno quelli che potevano evitargli il sospetto di insubordinazione, di slealtà istituzionale, quindi in primis tutti i culti connessi alla figura dell’imperatore, di Roma o dell’Impero in generale.
I padroni riescono ad attirare dalla loro parte molta folla non perché rivendicano un diritto violato (sfruttare una schiava indovina non poteva essere considerato un diritto particolarmente significativo), ma perché riescono a convincere la folla che questi ebrei sono una causa del malcontento sociale, una minaccia alla sicurezza economica della città.
Paolo e Sila vengono usati come capri espiatori e la folla ignorante abbocca facilmente. L’odio nei loro confronti è forte perché lo è quello nei confronti degli ebrei, e lo è al punto che i due apostoli rischiano un linciaggio in piena regola: infatti vengono flagellati o bastonati senza processo, senza alcuna possibilità di difesa, e la dimostrazione di forza si conclude con un duro incarceramento. Forze dell’ordine e magistrati non hanno alcun problema a difendere gli interessi della collettività pagana contro quella ebraica e la folla si aspetta una sentenza di condanna definitiva.
Senonché questi «pericolosi malfattori» – si diverte Luca a ironizzare, poiché sa bene che per Paolo questo arresto, lui che è cittadino romano, è come una manna caduta dal cielo – cantano dei salmi nel profondo della prigione, suscitando lo stupore degli altri carcerati.
Paolo il giorno dopo avrebbe sicuramente dichiarato, nel corso del processo, d’essere cittadino romano e avrebbe fatto scatenare il finimondo, ma in quell’occasione la fortuna lo baciò due volte e venne incontro alla sua causa persino un fortuito terremoto (abbastanza frequenti in Turchia).
Ovviamente è da considerarsi inverosimile l’apertura di tutte le porte e lo scioglimento di tutte le catene. Luca vuol semplicemente farci capire che c’era la possibilità concreta di fuggire, e non solo per Paolo e Sila.
Forse qualcuno tra i prigionieri avrà cercato di liberare gli altri e Paolo, che certamente non voleva apparire come un sobillatore delle masse e quindi come un liberatore di detenuti ingiustamente perseguitati, non prese parte all’evasione, sapendo bene di non aver nulla da rischiare, essendo appunto cittadino romano. Oppure sarà addirittura riuscito a convincere i prigionieri a non fuggire, nella speranza che le autorità attenuassero per tutti la pena.
Questa d’altra parte è una caratteristica del suo vangelo, che non vuole essere politico ma solo morale (a questo però si deve aggiungere che Paolo sapeva sfruttare benissimo le questioni giuridiche, essendo un grande conoscitore delle leggi e del diritto in generale).
Paolo non chiede ai detenuti di approfittare dell’occasione e di fuggire per tornare a combattere da clandestini il potere, ma chiede di aver timore del fatto che se li avessero ripresi, durante la fuga, li avrebbero sicuramente uccisi senza processo e che se fossero rimasti avrebbero potuto beneficiare di un atteggiamento più benevolo da parte delle autorità o dei carcerieri.
Mentre stavano ancora decidendo sul da farsi, il carceriere, non sentendo le voci nel buio, era convinto che fossero tutti evasi, per cui voleva uccidersi, poiché questa era la prassi romana (anche di fronte all’eccezione del terremoto?).
Sentendo solo la voce di Paolo che lo rassicura, rimane un po’ inebetito e chiede una torcia per andare a verificare di persona se davvero nessuno sia evaso e scende nelle prigioni tremante, poiché teme che possano fargli del male, che il richiamo di Paolo possa essere una trappola. D’altra parte non ha più nulla da perdere: in un modo o nell’altro deve rischiare.
Lo stesso carceriere ci fa poi capire che la situazione a Filippi non era così tranquilla come all’inizio era sembrato. Già la schiava aveva parlato di «salvezza» (v. 17). Ora è lui stesso a chiederla (v. 30).
Al v. 33 li fa uscire momentaneamente dal carcere, sotto la sua diretta responsabilità, per lenire le loro piaghe e, prima di portarli a casa sua per rifocillarli, si fa battezzare nel fiume. Incredibilmente tutto avviene di notte, nella più generale confusione, nell’arco di poche ore. Poi li riporta in carcere.
Accetta di convertirsi perché Paolo gli ha praticamente salvato la vita, ma è evidente che sapeva bene cosa i due apostoli stessero predicando, e la loro umanità, la loro avvedutezza e disponibilità al dialogo devono averlo positivamente impressionato. Cioè doveva aver capito che non aveva a che fare con due rivoluzionari o terroristi, ma con due persone che avrebbero rispettato le leggi vigenti. E Paolo, che se vogliamo è una sorta di Ulisse con la fede cristiana, è sufficientemente smaliziato per capire che quella è una situazione di cui possono ampiamente approfittare.
Dopo essere stati debitamente informati dell’accaduto, i magistrati hanno capito che non ha più senso trattenerli e decidono di liberarli come se nulla fosse.
Senonché Paolo si oppone alla grazia e pretende delle scuse ufficiali, un esplicito riconoscimento della loro innocenza, in quanto, pur essendo cittadini romani, avevano subito oltraggi pubblici, senza processo (la legge Porcia proibiva di sottoporre un cittadino romano alla flagellazione) ed erano stati gettati in prigione senza aver commesso alcun crimine, senza aver violato un articolo specifico della legge romana. Col passar del tempo Paolo saprà sfruttare magnificamente questo suo privilegio giuridico.
Ottengono soddisfazione proprio perché legalmente romani, non perché i magistrati si convincono delle loro ragioni cristiane. Quest’ultimi temevano d’essere denunciati e, ciononostante, li pregano di andarsene, per il bene di tutti.
Paolo accetta, ma a condizione di poter incontrare di nuovo i fratelli in casa di Lidia, esortandoli a predicare il vangelo.
Quanto agli altri carcerati, Paolo non chiese che venissero liberati e nessuno pensò di farlo.
torna suCap. 17
[1]Seguendo
la via di Anfìpoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove
c’era una sinagoga dei Giudei.
[2]Come era sua
consuetudine Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro
sulla base delle Scritture,
[3]spiegandole e
dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti; il
Cristo, diceva, è quel Gesù che io vi
annunzio.
[4]Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e
a Sila, come anche un buon numero di Greci credenti in Dio e non
poche donne della nobiltà.
[5]Ma i Giudei,
ingelositi, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di
piazza e, radunata gente, mettevano in subbuglio la città.
Presentatisi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per
condurli davanti al popolo.
[6]Ma non
avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi
della città gridando: «Quei tali che mettono il mondo in
agitazione sono anche qui e Giasone li ha ospitati.
[7]Tutti costoro
vanno contro i decreti dell’imperatore, affermando che c’è
un altro re, Gesù».
[8]Così
misero in agitazione la popolazione e i capi della città che
udivano queste cose;
[9]tuttavia,
dopo avere ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li
rilasciarono.
[10]Ma i fratelli subito, durante la notte, fecero
partire Paolo e Sila verso Berea. Giunti colà entrarono nella
sinagoga dei Giudei.
[11]Questi erano di sentimenti più
nobili di quelli di Tessalonica ed accolsero la parola con grande
entusiasmo, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se le cose
stavano davvero così.
[12]Molti di
loro credettero e anche alcune donne greche della nobiltà e
non pochi uomini.
[13]Ma quando i
Giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata
annunziata da Paolo la parola di Dio, andarono anche colà ad
agitare e sobillare il popolo.
[14]Allora i
fratelli fecero partire subito Paolo per la strada verso il mare,
mentre Sila e Timoteo rimasero in città.
[15]Quelli che
scortavano Paolo lo accompagnarono fino ad Atene e se ne ripartirono
con l’ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più
presto.
[16]Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo
spirito al vedere la città piena di idoli.
[17]Discuteva
frattanto nella sinagoga con i Giudei e i pagani credenti in Dio e
ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava.
[18]Anche certi
filosofi epicurei e stoici discutevano con lui e alcuni dicevano:
«Che cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano?».
E altri: «Sembra essere un annunziatore di divinità
straniere»; poiché annunziava Gesù e la
risurrezione.
[19]Presolo con
sé, lo condussero sull’Areopago e dissero: «Possiamo
dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te?
[20]Cose strane
per vero ci metti negli orecchi; desideriamo dunque conoscere di che
cosa si tratta».
[21]Tutti gli
Ateniesi infatti e gli stranieri colà residenti non avevano
passatempo più gradito che parlare e sentir
parlare.
[22]Allora Paolo, alzatosi in mezzo all’Areopago,
disse: «Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto
timorati degli dèi.
[23]Passando
infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche
un’ara con l’iscrizione: Al Dio ignoto. Quello che voi
adorate senza conoscere, io ve lo annunzio.
[24]Il
Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene,
che è signore del cielo e della terra, non dimora in templi
costruiti dalle mani dell’uomo
[25]né dalle mani
dell’uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche
cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni
cosa.
[26]Egli
creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché
abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito
l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio,
[27]perché
cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni,
benché non sia lontano da ciascuno di noi.
[28]In lui
infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei
vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi
siamo.
[29]Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare
che la divinità sia simile all’oro, all’argento e
alla pietra, che porti l’impronta dell’arte e
dell’immaginazione umana.
[30]Dopo esser
passato sopra ai tempi dell’ignoranza, ora Dio ordina a tutti
gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi,
[31]poiché
egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra
con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a
tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti».
[32]Quando
sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano,
altri dissero: «Ti sentiremo su questo un’altra
volta».
[33]Così Paolo uscì da quella
riunione.
[34]Ma
alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi
membro dell’Areopago, una donna di nome Damaris e altri con
loro.
*
Liberati con le dovute scuse, Paolo e Sila giunsero a Tessalonica, attraverso Anfipoli (capitale della Macedonia in seguito all’occupazione romana) e Apollonia, lungo un percorso di circa 200 km.
A Tessalonica, città piena di ebrei e di proseliti, non poteva mancare la sinagoga. Luca sottolinea che «era consuetudine» di Paolo iniziare la predicazione partendo proprio dalla sinagoga. Questa scelta non era strategica ma tattica: essi infatti erano originari del giudaismo e all’interno di queste sedi religiose era facile incontrare pagani credenti nel monoteismo ebraico, oppure ellenisti che avrebbero anche potuto diventare cristiani.
Inoltre c’è da dire che Paolo, dopo il primo viaggio missionario, aveva smesso di frequentare i ceti sociali più poveri dell’impero, preferendo a questi quelli piccolo-medio borghesi, anche se ad Atene – come vedremo – farà un tentativo coi ceti intellettuali.
La tesi ch’egli sostiene si pone a quattro livelli:
1. Gesù è il Cristo, cioè il messia che gli ebrei attendevano. Paolo si convince di questo quando secondo lui non esisteva più la possibilità di vincere il dominio romano, sicché la messianicità viene affermata con un intento opposto a quello che avevano avuto i primi seguaci del Cristo. Paolo in sostanza parte dalla tesi di Pietro secondo cui il Cristo ha dato conferma d’essere il messia in quanto appunto risorto, ma mentre Pietro non escludeva a priori una liberazione nazionale d’Israele, attraverso la parusia d'un Cristo glorioso, Paolo invece ad un certo punto si convince che quella tesi è illusoria e che se la parusia ha un senso, lo ha soltanto per la fine dei tempi.
2. Poiché il Cristo è morto significa che doveva morire (qui tutti i riferimenti, più o meno manipolati, alle Scritture). Cioè se la liberazione d’Israele non è stata possibile in virtù del messia, allora significa ch’essa non è più un obiettivo che il cristiano deve porsi. Il Cristo non è morto perché sconfitto politicamente, ma perché suo compito era quello di liberare gli uomini dalla schiavitù della morte e del peccato d’origine, dando a tutti una certezza di riconciliazione nell’aldilà. Il Cristo s’è sacrificato per colmare il distacco dell’uomo dalla divinità, per riportarlo alla sua condizione d’origine (Cristo come nuovo Adamo).
3. Il Cristo doveva resuscitare (anche qui i riferimenti manipolati alle Scritture, e soprattutto la testimonianza falsata, post-pasquale, degli apostoli). L’unico modo che il Cristo aveva di dimostrare che l’esperienza più significativa gli uomini la vivranno non sulla terra ma nei cieli, era appunto quello di risorgere. Egli ha potuto far questo perché, pur essendo uomo, aveva la stessa natura di Dio, in quanto figlio di Dio.
4. Il vangelo del Cristo, cioè dell’unico figlio di Dio morto e risorto, è un vangelo che può essere annunciato a chiunque, in quanto per salvarsi è sufficiente aver fede in questa verità. Non c’è più distinzione tra giudeo e pagano, tra libero e schiavo, tra uomo e donna.
L’erroneità di questa tesi non sta soltanto nell’interpretazione arbitraria dei testi veterotestamentari (che Paolo utilizzava in ambienti giudaici), ma anche e soprattutto nel fatto che si ritiene la morte di Cristo necessaria ai fini della tesi mitologica della resurrezione (col che la Chiesa vorrebbe dimostrare la divinità di Gesù). La falsità di questo sillogismo sta appunto nel voler far credere che la morte sia stata funzionale alla resurrezione: in tal modo si è interpretata la vita del Cristo (il suo vangelo) non in base a se stessa, ma a ciò che la negava: la morte violenta, per quanto mitologicamente reinterpretata. La tomba vuota è stata trasformata in un significato metafisico, esoterico, di un vangelo che invece voleva essere chiaramente terreno. Tale mistificazione dura da duemila anni.
Paolo considera necessaria la morte di Cristo anche perché egli è convinto che in questa maniera i pagani possano convertirsi meglio all’ebraismo cristianizzato (che dell’ebraismo classico conservava il rigore etico, il monoteismo assoluto ecc.): cosa che secondo lui non sarebbe mai potuta avvenire nell’ambito dell’ebraismo politico-nazionalistico. Eppure nei vangeli è più volte documentato il tentativo di avvicinare i gentili alla causa di liberazione nazionale dei giudei, prescindendo del tutto dalle questioni religiose (cfr Gv 12,20 s.).
A suo parere (che diverrà dopo il 70 il parere dominante della comunità primitiva) la possibilità di far avvicinare i gentili alla causa ebraica non riguarda affatto l’obiettivo della liberazione politico-nazionale, nel senso cioè che non riguarda tanto l’idea che se i giudei fossero riusciti a liberarsi dei romani avrebbero potuto costituire un esempio e un incentivo anche per tutte le altre popolazioni oppresse dell’impero, quanto piuttosto l’idea inversa, e cioè che i gentili potrebbero più facilmente avvicinarsi all’ebraismo (cristianizzato) se questo rinunciasse all’obiettivo politico della liberazione nazionale, e con esso a tutte quelle caratteristiche specifiche che rendono l’ebraismo una religione meramente nazionale o comunque etnica.
Alla luce del fatto che il messia Gesù è stato ucciso proprio dagli ebrei che cercavano una liberazione nazionale, è legittimo aspettarsi – secondo Paolo – una maggiore disponibilità del mondo pagano alla causa ebraica, a condizione ovviamente che questa si trasformi in una causa semplicemente «umana», il che per Paolo voleva dire una «causa religiosa» sensu lato, capace di sincretismo culturale tra monoteismo giudaico e politeismo pagano. E poiché gli ebrei nazionalisti continuano a cercare un nuovo messia, nella speranza, vana, di liberarsi dei romani, i gentili possono avere una fede cristiana superiore alla loro.
In tutto questo ragionamento ci sono almeno due aporie che Paolo non ha mai affrontato, semplicemente perché nell’economia del suo discorso sarebbero state irrisolvibili:
1. Cristo, se davvero era il figlio di Dio, avrebbe potuto risorgere anche da una morte naturale (dovuta all’anzianità o alla malattia), non necessariamente violenta (la crocifissione era la tipica esecuzione da infliggersi agli schiavi ribelli);
2. i pagani avrebbero potuto accettare il vangelo di Cristo anche se questi avesse trionfato come capo politico (il suo vangelo era universale di per sé, non lo divenne grazie agli apostoli, ed era per la liberazione di tutti gli oppressi, e sarebbe rimasto aperto a tutti anche dopo il trionfo messianico della Palestina contro i romani).
Il fatto è che Paolo considerava irrealizzabile il progetto politico di liberazione d’Israele, in quanto – secondo lui – se non vi era riuscito Cristo, che aveva dimostrato – stando alla tesi petrina della resurrezione – d’essere un Dio, nessun altro avrebbe potuto farlo. E il discorso, in questo senso, era chiuso per sempre.
Paolo aveva grande sfiducia nelle capacità emancipative delle masse giudaiche. Le riteneva troppo chiuse e malate di nazionalismo. A questo nazionalismo politico egli opponeva l’universalismo spiritualistico, etico-religioso, metafisico (sfruttando da un lato l’universalismo dell’ideologia nazarena e negandole dall’altro ogni istanza di tipo politico).
È del tutto naturale che Paolo, agli inizi, non ottenesse ampi consensi. Chi si poteva convertire alla sua teologia? Non certo il povero che sperava nella venuta imminente di qualche messia; semmai la persona relativamente agiata, che non aveva bisogno di sperare in una rivoluzione per migliorare la propria condizione e che si sarebbe accontentata di conservare il proprio patrimonio, limitandosi a cercare un’alternativa semplicemente morale alla crisi di valori della romanità.
Da notare però che i «greci credenti in Dio» (v. 4) si convertono più facilmente dei giudei (questi sono soltanto «alcuni», quelli «un buon numero»). Significativo anche il fatto che fra i convertiti vi siano «non poche donne della nobiltà» (anch’esse pagane). Luca non parla di «uomini nobili pagani», perché questi in genere non frequentavano le sinagoghe. Tra i pagani convertiti vi è un certo Aristarco.
Che il messaggio di Paolo fosse destinato ai ceti benestanti non è indicato dal fatto che «pessimi individui di piazza» (v. 5) gli si opposero, ma dal fatto che Paolo non trovò un aiuto popolare che gli permettesse di fronteggiare quell'ostilità.
Con un certo disprezzo Luca parla di questi estremisti, che si erano lasciati strumentalizzare dalle provocazioni dei giudei: altro non erano che individui di ceti marginali che vivevano della carità pubblica e che forse temevano conseguenze negative in seguito alla predicazione di Paolo.
La regia è dei giudei benestanti che vogliono salvaguardare le differenze di classe e non vogliono perdere i rapporti d’affari con la nobiltà pagana che, attraverso le donne, stava iniziando ad accostarsi al cristianesimo.
L’idea che viene diffusa è relativa all’imminente venuta di un «re» chiamato Gesù, che ovviamente avrebbe potuto costituire una nuova minaccia per la stabilità dei confini imperiali. Con le menzogne e i raggiri ottengono facilmente quello che vogliono, sfruttando il malcontento popolare per le diffuse ingiustizie.
Il tumulto della folla avvenne in breve tempo. I capi si impauriscono. Invece di prendere provvedimenti a carico di Giasone e di altri che avevano ospitato la «sovversiva» comitiva, si limitano a chieder loro una cauzione, rilasciandoli sulla parola. Questo perché fino a quel momento Giasone aveva goduto di una buona reputazione; ed è quindi possibile ch’egli abbia saputo convincere le autorità sul carattere assolutamente inoffensivo della dottrina di Paolo e sulle gelosie degli altri giudei, i quali rimasero senz’altro delusi del provvedimento delle autorità, che sarà parso troppo sbrigativo, anche in considerazione delle tensioni politiche presenti in città.
Visto dunque il fallimento del primo tentativo, i giudei ostili pensano di adottare un’altra soluzione, non meno sbrigativa: uccidere di nascosto Paolo e Sila. Il piano tuttavia fu svelato, per cui i «fratelli, durante la notte, li fecero partire verso Berea» (circa 100 km a ovest di Tessalonica). Qui i due apostoli usano la tattica già collaudata: dapprima entrano nella sinagoga dei giudei, poi passano a predicare ai pagani. È notevole il coraggio, la costanza, la fiducia in se stesso che Paolo dimostra.
I sentimenti più «nobili» riconosciuti da Luca a questi giudei di Berea (città dell’entroterra greco, molto meno importante della ricca e corrotta Tessalonica), dipendevano probabilmente dal fatto che qui essi avevano interessi minori da far valere o da difendere. Questa volta Luca dice che «molti di loro» credettero, però non ripete, parlando delle donne greche nobili, l’espressione del v. 4: infatti sono poche. Forse erano meno curiose sul piano intellettuale o con meno problemi esistenziali e filosofici da risolvere, in quanto di tradizioni più rurali che urbane.
Tuttavia, anche a Berea le contraddizioni non mancano, se è vero che i giudei di Tessalonica riescono facilmente a sobillare queste popolazioni rurali. L’odio dei giudei si è concentrato soprattutto su Paolo, il quale viene subito fatto partire «per la strada verso il mare» (v. 14), diretto ad Atene.
È possibile che Paolo sia arrivato ad Atene da solo e che Sila e Timoteo siano rimasti a Tessalonica per non far capire ai giudei che i discepoli intendevano trasferire Paolo altrove. In ogni caso Timoteo lo raggiunse poco dopo, per ripartire poi per la Macedonia e ritrovare nuovamente Paolo, insieme a Sila, a Corinto. Può darsi che Luca abbia semplificato tutto ciò.
Atene venne conquistata dai romani nel 146 a.C. Ai tempi di Paolo era una delle poche città libere e alleate di Roma e nel contempo il più famoso centro culturale dell’impero.
Della permanenza di Paolo in questa città non sappiamo nulla. In At 17 le informazioni sono scarsissime; lo stesso Paolo nelle sue lettere non ama parlarne, a motivo della sconfitta ch’egli aveva subito e che ora vedremo. In ogni caso il soggiorno ha come elemento essenziale il suo discorso tenuto all’Areopago. La data è forse il 50 d.C. Pare che la Lettera ai Tessalonicesi sia stata scritta da qui, ma non è sicuro.
Questo discorso è soltanto il secondo esempio di predicazione ai pagani riportato negli Atti. Ciò è alquanto strano, in quanto Paolo amava definirsi apostolo degli incirconcisi. Ma non va dimenticato che per molti pagani di allora (appartenenti ai ceti piccolo-borghesi) le religioni costituivano una sorta di passatempo o di curiosità intellettuale o uno sbocco alle proprie angosce esistenziali, senza che ciò implicasse l’impegno di una vera e propria conversione personale. Ecco perché Paolo preferiva rivolgersi a quei pagani che già frequentavano le sinagoghe o che simpatizzavano per il monoteismo giudaico.
È anche l’unico caso in cui vediamo Paolo servirsi della sapienza profana per combattere il paganesimo. D’altra parte la cultura prodotta dalla civiltà ellenica era sterminata e di grandissimo livello: non avrebbe potuto farne a meno.
La vasta proliferazione di idoli culti religioni era un segno eloquente del pluralismo culturale della città e insieme della sua estrema ecletticità. Paolo in realtà sapeva bene quale enorme abisso separasse il monoteismo giudaico, più sobrio ed essenziale, più sofferto e partecipato, dal politeismo pagano, più superficiale e individualistico, più estetico e intellettuale. Qui poteva confrontarsi direttamente col vertice della sapienza mondiale, da posizioni, le sue, che nel contempo erano di modesta filosofia e di buona teologia.
Paolo si rendeva conto che i tempi erano maturi per una convergenza idealistica di teorie filosofico-religiose: lo vedeva dalla rappresentanza pagana nelle varie sinagoghe. Egli non frequentava i ceti marginali ed oppressi che rivendicavano una liberazione politico-economica, ma quelli relativamente agiati: qui, p.es., gli intellettuali che passavano gran tempo della loro giornata a discutere in piazza o nelle sinagoghe (mentre i loro schiavi lavoravano la terra) e che non gli avrebbero mai posto domande cui non avrebbe saputo rispondere.
Le due correnti filosofiche principali che Paolo incontra sono l’epicureismo (scetticismo, materialismo) e lo stoicismo (dogmatismo, idealismo).
Considerano subito Paolo un ciarlatano perché i suoi discorsi non seguivano le leggi della retorica, non erano stilisticamente raffinati. Di tutti i suoi discorsi quello che più li aveva colpiti era relativo agli aspetti misterici o esoterici della nuova religione, in particolare il fatto che un Dio chiamato Gesù fosse risorto (la resurrezione pare venisse qui ritenuta come una sorta di divinità a fianco di Gesù).
L’Areopago era una collina posta a sud dell’agorà: lo portarono non davanti alla corte dell’Areopago (dove un tempo si tenevano le sedute del supremo tribunale) ma semplicemente sulla collina, in un luogo appartato per ascoltarlo con più comodo. L’incontro era senz’altro meno ufficiale di quel che appare.
L’interesse degli ascoltatori sembra essere in buona fede, ma Luca mette subito il lettore sull’avviso: si trattava di una pura e semplice curiosità intellettuale, senza l’intenzione di un vero ascolto, implicante la possibilità di un coinvolgimento personale. Per loro una dottrina non escludeva l’altra. Ovviamente queste cose Luca le dice con senno del poi, cioè consapevole del risultato ottenuto da Paolo. Infatti se Paolo fosse stato convinto di questo atteggiamento sin dall’inizio, forse non avrebbe accettato il confronto (non era poi così ingenuo), anche se in realtà egli non scartava mai a priori la possibilità di propagandare il proprio verbo a chicchessia, ovunque si trovasse. È però probabile che Paolo, considerando che Atene si trovava sottoposta a Roma, si aspettasse un dibattito e non indifferenza e disprezzo.
Luca però esagera nel dire che «tutti» gli ateniesi e gli stranieri là residenti «non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare» (v. 21). Egli dimentica di mettere in luce le drammatiche condizioni degli schiavi. Gli ateniesi e gli stranieri per lui erano solo i cittadini liberi. Ma questo suo atteggiamento è naturale: aveva bisogno di giustificare in qualche modo lo smacco dell’apostolo.
L’esordio di Paolo è di circostanza. Egli non dice subito quello che pensa, perché spera di essere ascoltato sino in fondo. Qualcuno poteva pensare ch’egli volesse fare dell’ironia con quella sua frase un po’ pretestuosa: «Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio» (v. 23), sia perché un filosofo greco difficilmente si sarebbe lasciato convincere di qualcosa da un teologo giudeo, sia perché i filosofi greci credevano sempre meno negli dèi della mitologia classica. In ogni caso la religiosità poteva non essere in contrasto – nella concezione di Paolo – con l’idolatria pagana. Qui infatti, avendo spogliato l’ebraismo di ogni connotazione politica, Paolo non faceva altro che contrapporre, a sua stessa insaputa, una superstizione a un’altra, chiedendo un confronto su quale delle due avesse fosse più conforme alle esigenze dei tempi e quindi avesse più speranze di successo per il futuro.
Agli occhi di Paolo l’indizio che fa meglio capire quanto gli ateniesi fossero religiosi è la presenza di un altare dedicato «al Dio ignoto». In verità i pagani dedicavano altari «agli dèi ignoti» nel timore di attirarsi i risentimenti di qualche popolazione e quindi di qualche divinità di cui si fosse ignorata l’esistenza. Paolo però dà un senso diverso alla dedica, non «pluralista» ma «esclusivista» (modifica le cose così come faceva quando rileggeva i passi dell’Antico Testamento che potevano essere scelti, a motivo della loro ambiguità, per giustificare la fine ingloriosa del messia). Da bravo opportunista qual è, egli mette subito le mani avanti per difendersi da un’eventuale critica di incoerenza, in quanto non avrebbe potuto confermare l’idea che esistono molti dèi e poi pretendere che si apprezzasse il suo come il migliore perché unico vero Dio.
Paolo vuole sfruttare un limite intellettuale del paganesimo: l’incapacità di conoscere tutti gli dèi e quindi in modo particolare l’unico vero Dio. Il suo discorso si pone a un livello puramente religioso (influenzato dall'orfismo); non prende in alcuna considerazione né le contraddizioni sociali, per le quali non avrebbe avuto risposte politiche da dare, né le teorie filosofiche, per le quali non aveva sufficienti competenze.
Il concetto di Dio che Paolo propone è completamente diverso da quello che hanno gli ateniesi: non esistono molti dèi più o meno equivalenti tra loro, ma un unico Dio che esclude ogni altro. Dio è «creatore» di tutto, quindi onnipotente e autosufficiente, libero dalla necessità di avere un culto e quindi assolutamente oltre le molteplici rappresentazioni (materiali o culturali) che gli uomini possono farsi di lui.
Questo Dio è rimasto ignoto appunto perché onnipotente: non poteva per questo essere rappresentato né circoscritto dagli uomini. Tutte le statue, i templi e gli altari sono inutili appunto perché esiste un unico Dio che non si vede e che va al di là di tutto questo.
Paolo dunque condanna ogni concezione antropomorfica di Dio (per quanto già nell'area cristiana si pensasse a Dio come a un «padre» e al messia come a un «figlio»), e condanna anche ogni culto fondato su un sistema di «dare e avere», sacrifici e premi. Il suo ragionamento non è molto diverso da quello di Stefano.
Nella tipologia di questo Dio già da molto tempo gli ebrei, che si sentivano «popolo», seppur divisi in «tribù», credevano: ciò dimostra la superiorità culturale della religione ebraica rispetto a quella greca, che non basandosi su una concezione di «popolo» ma al massimo di «stirpe» e avendo come punto costante di riferimento le lotte politiche delle poleis in competizione tra loro, non poteva fare altro che considerare il politeismo come un dato di fatto.
E comunque qui Paolo parla come un ebreo della diaspora, abbondantemente ellenizzato, in quanto gli ebrei nazionalistici consideravano il tempio di Gerusalemme come luogo privilegiato della manifestazione di Jahvè.
Le ironie di Paolo (ai vv. 24-25) sono troppo sottili per essere capite: per lui la religione pagana non sembra essere affatto un gradino che porta al monoteismo, in quanto non ha la forza da sola per arrivare a questa coerenza, a questa essenzialità e semplicità profonda. Egli in sostanza fa capire che se Dio è rimasto ignoto sino adesso, ciò è dipeso dal fatto che è onnipotente (cioè troppo grande per essere compreso con facilità); la sua onnipotenza è talmente grande che non ha bisogno della fede dell’uomo per sussistere. Qui per la prima volta Paolo introduce un concetto di oggettività nell’idea di divinità che sicuramente avrebbe potuto essere discusso, visto che già Platone e Aristotele, sul piano filosofico, ne avevano parlato e che certamente non si era tradotto sul piano della religiosità quotidiana.
Paolo non fa altro che interpretare in maniera più convincente le esigenze dell’epoca, ovviamente sempre nei limiti delle concezioni religiose: le contraddizioni erano talmente grandi che l’uomo aveva un maggior bisogno di credere in un Dio oggettivo, superiore a ogni cosa.
Paradossalmente però Paolo fa anche capire che la necessità del monoteismo assoluto non riesce ad essere teorizzata dal dibattito filosofico di questi ateniesi. Essa è diventata un’esigenza delle masse popolari più oppresse e piccolo borghesi, nei cui confronti però gli intellettuali si trovano spiazzati, con poca iniziativa. È evidente infatti che la sostituzione del politeismo col monoteismo doveva necessariamente implicare due cose: 1. una maggiore attenzione per le questioni materiali della vita; 2. il desiderio di costruire un’unità di popolo, che superasse idealmente ogni barriera (geografica, linguistica, etnica ecc.).
Ai vv. 26-27 troviamo l’universalismo astratto di Paolo, il suo cosmopolitismo spirituale. Egli professa il principio dell’uguaglianza degli uomini e di tutte le popolazioni o etnie davanti a Dio, tacendo naturalmente sulle loro differenze di classe e sorvolando sulle questioni politiche del dominio imperiale di Roma. Infatti sostiene che «i confini del loro spazio», cioè i confini territoriali delle regioni, sono stabiliti da Dio: col che in pratica egli giustifica ogni sorta di oppressione.
Paolo sostiene che le differenze di classe si dissolvono al cospetto dell’uguaglianza davanti a Dio. Al massimo egli sostiene che se tali differenze possono sembrare assolutamente ingiustificate, gli uomini si debbono consolare ricordando che esse non sono eterne, in quanto i tempi e i confini delle nazioni o regioni sono stabiliti da Dio, per cui non ci è dato di sapere quando e come essi muteranno. Le differenze di classe o quelle tra metropoli romana e colonie provinciali vanno considerate come una prova da sopportare in attesa che la provvidenza di Dio faccia il suo corso. Ecco la sua strategia geopolitica.
Ciò che conta per Paolo in ultima istanza è «cercare Dio», la risposta a tutti i problemi. L’esigenza di trovare questa risposta – dice Paolo – appartiene ad ogni uomo, anche se non tutti la trovano nello stesso momento e allo stesso modo.
Il compito è difficile ma alla portata di tutti, in quanto, secondo la predicazione monoteistica giudaica, l’uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, per cui il culto riservato agli idoli è assurdo.
La teologia paolina apparentemente è democratica, poiché non pone più alcuna differenza fra schiavo e libero, cittadino e straniero, giudeo e pagano, uomo e donna. Per Paolo è l’oggettività di Dio che rende tutti gli uomini uguali fra loro (nel senso che tutti possono considerarsi, a pari titolo, «figli di Dio»). Sicuramente sul piano astratto dei principi era stato fatto un passo avanti, rispetto alle concezioni razziste, classiste e sessiste dell’epoca.
Eppure, proprio perché nella realtà la situazione era ben diversa, questa teologia, nella sostanza, era tutto meno che democratica. Predicava una liberazione illusoria nella sfera del pensiero, sostenuta al massimo da una dimensione sociale di mutuo soccorso.
Il sillogismo di Paolo era molto semplice ed efficace sul piano teologico: se l’uomo è figlio di Dio, e l’uomo non è un oggetto materiale, allora neppure Dio è qualcosa di materiale, anzi Dio è infinitamente superiore alla materia, per cui non è attraverso la materia che ci si può mettere in contatto con lui. Gli idoli dunque sono un prodotto della fantasia umana e come tali vanno aboliti.
Paolo aveva una concezione di Dio più spiritualistica di quella ateniese, una teologia dialettica di gran lunga superiore alle filosofie religiose della Grecia di quel tempo.
Con molto savoir-faire egli praticamente dà dell’ignorante al pubblico colto che l’ascolta, attenuando questa sottile critica con un’osservazione che avrebbe dovuto rincuorare gli astanti, e cioè che gran parte del mondo allora conosciuto viveva in questa ignoranza. L’idolatria è stata generata dall’ignoranza e l’ignoranza va superata con la conoscenza. Ma la vera conoscenza è possibile solo se è Dio stesso a fornirla. Ciò che appunto è avvenuto designando un uomo, Gesù, a giudicare la terra con giustizia il giorno del giudizio. Sulla base della fede-accettazione di tale conoscenza, cioè della fede in quest’uomo, tutti saranno giudicati. La storia dunque ha un limite di tempo.
La scoperta dell’esistenza di un Dio oggettivo, di una conoscenza oggettiva, di una verità oggettiva va di pari passo – secondo Paolo – con la convinzione che il mondo ha un’esistenza limitata nel tempo. Gesù è giudice di tutti gli uomini, morti e viventi, passati, presenti e futuri, perché è mediatore fra uomo e Dio.
A questo punto Paolo non ha scelta: avendo circoscritto la missione di Gesù al solo compito del giudizio, avendola cioè espropriata di tutto il suo contenuto politico-rivoluzionario, non gli resta altro che proporre a quei filosofi di credere nell’aspetto meno politico, meno rivoluzionario del vangelo di Gesù: la sua resurrezione. Paolo fa indebitamente coincidere il vangelo di Gesù con l’idea di resurrezione. Egli non si pone come mediatore seguace di Gesù, ma continua a porre Gesù come mediatore tra l’umano e il divino, trasformando così lo stesso Gesù in un’idea astratta, valida per ogni tempo. Il mediatore è morto e risorto e risorgendo si è allontanato dalla terra, promettendo di ritornare nell’ultimo giorno, quello del giudizio. Così Paolo evita di proporre se stesso come mediatore, evita cioè di rispondere all’esigenza di risolvere le contraddizioni sociali del suo tempo.
Parlando del Cristo risorto sposta questa soluzione verso un futuro indeterminato. Ecco cosa significa usare in modo conservatore il concetto di resurrezione. Da notare che Paolo – qui come a Listra – non fa alcun riferimento alle profezie dell’Antico Testamento o all’attività di Dio nell’ambito della tradizione culturale ebraica. Entrambi i discorsi hanno per contenuto fondamentale la natura di Dio; l’idea stessa di Gesù-mediatore a Listra fu assente, mentre ad Atene è stata nel complesso abbastanza marginale; ma forse Paolo avrebbe voluto concludere diversamente il suo discorso e purtroppo non gliene diedero il tempo.
Di nuovo, nel finale, gli epicurei lo deridono, mentre gli stoici, più diplomatici, gli fanno capire che la conversazione è terminata. Lo interrompono prima ancora che finisca il discorso (avrebbe probabilmente dovuto parlare dell’esigenza dei sacramenti, della comunità...). Perché lo deridono? Ufficialmente perché un uomo morto per loro non può risorgere. In realtà il problema era un altro: la resurrezione di Cristo può forse contribuire a risolvere le contraddizioni sociali? Evidentemente no.
Il concetto di resurrezione, in senso simbolico non fisico, avrebbe avuto un valore costruttivo solo se il vangelo di Gesù avesse continuato a esistere sulla terra, contribuendo a modificare qualitativamente la situazione della società; ciò che però non avvenne, perché quand’egli morì i discepoli di lui (gli apostoli), pur essendo in grado di proseguire fedelmente il suo messaggio, non riuscirono a farlo. La resurrezione non è stata interpretata come una garanzia che il vangelo di Gesù era importante per il presente, ma come una garanzia di successo per il futuro (per il presente ci si doveva limitare a predicare appunto la resurrezione dalla tomba, con la quale si doveva credere nella divinità di Gesù).
Ecco, in questo senso, gli areopagiti lo deridono anche perché non credono in un futuro diverso, secondo una prospettiva finalistica, escatologica della storia. Lo avrebbero fatto anche se non avesse parlato di resurrezione fisica o di figliolanza divina.
Lo scacco di Paolo fu quasi totale. D’ora in poi egli rifiuterà di parlare in pubblico con gli intellettuali dell’epoca (1 Cor 2,1-5). I convertiti ad Atene furono molto pochi: tra questi Dionigi, che la Chiesa poi identificò col teologo mistico Dionigi Areopagita, e Damaris.
torna suCap. 18
[1]Dopo
questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto.
[2]Qui trovò
un Giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima
dall’Italia con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine
di Claudio che allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò
da loro
[3]e
poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella
loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di
tende.
[4]Ogni
sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e
Greci.
[5]Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, Paolo si
dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai Giudei
che Gesù era il Cristo.
[6]Ma poiché essi gli si
opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: «Il
vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora in
poi io andrò dai pagani».
[7]E andatosene di là,
entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava
Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga.
[8]Crispo, capo
della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia;
e anche molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano
battezzare.
[9]E una notte in visione il Signore disse a Paolo:
«Non aver paura, ma continua a parlare e non tacere,
[10]perché
io sono con te e
nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un
popolo numeroso in questa città».
[11]Così
Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnando fra loro la parola
di Dio.
[12]Mentre era proconsole dell’Acaia Gallione, i
Giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale
dicendo:
[13]«Costui persuade la gente a rendere un culto a
Dio in modo contrario alla legge».
[14]Paolo stava
per rispondere, ma Gallione disse ai Giudei: «Se si trattasse
di un delitto o di un’azione malvagia, o Giudei, io vi
ascolterei, come di ragione.
[15]Ma se sono questioni di parole o
di nomi o della vostra legge, vedetevela voi; io non voglio essere
giudice di queste faccende».
[16]E li fece
cacciare dal tribunale.
[17]Allora tutti
afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al
tribunale ma Gallione non si curava affatto di tutto ciò.
[18]Paolo
si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli e
s’imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e
Aquila. A Cencre si era fatto tagliare i capelli a causa di un voto
che aveva fatto.
[19]Giunsero a
Efeso, dove lasciò i due coniugi, ed entrato nella sinagoga si
mise a discutere con i Giudei.
[20]Questi lo
pregavano di fermarsi più a lungo, ma non
acconsentì.
[21]Tuttavia prese congedo dicendo: «Ritornerò
di nuovo da voi, se Dio lo vorrà», quindi partì
da Efeso.
[22]Giunto a
Cesarea, si recò a salutare la Chiesa di Gerusalemme e poi
scese ad Antiochia.
[23]Trascorso colà un po’ di
tempo, partì di nuovo percorrendo di seguito le regioni della
Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i
discepoli.
[24]Arrivò a Efeso un Giudeo, chiamato Apollo,
nativo di Alessandria, uomo colto, versato nelle Scritture.
[25]Questi era
stato ammaestrato nella via del Signore e pieno di fervore parlava e
insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù,
sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni.
[26]Egli intanto
cominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e
Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero
con maggiore accuratezza la via di Dio.
[27]Poiché
egli desiderava passare nell’Acaia, i fratelli lo
incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza.
Giunto colà, fu molto utile a quelli che per opera della
grazia erano divenuti credenti;
[28]confutava infatti
vigorosamente i Giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le
Scritture che Gesù è il Cristo.
*
A Corinto, capitale della provincia romana dell’Acaia, Paolo ebbe più fortuna che ad Atene. C’era una colonia ebraica molto importante; i commerci, molto floridi, si avvalevano di due porti; famoso era il tempio di Afrodite.
Paolo si ferma in casa di Aquila e Priscilla, che, insieme ad altri ebrei, erano stati allontanati da Roma in forza dell’editto imperiale di Claudio, nel 49-50, a motivo dei disordini provocati dalle discussioni su Cristo. I suoi effetti risultarono però effimeri.
Paolo aveva conosciuto questa famiglia nella sinagoga e grazie alla sua predicazione, che si rivolgeva prevalentemente ai ceti piccolo- borghesi (artigiani, commercianti, piccoli proprietari), essa era diventata cristiana. Paolo, che conosceva il mestiere di fabbricante di tende, colse l’occasione per mettersi a lavorare presso di loro.
Per poter frequentare queste persone Paolo ha bisogno di mezzi finanziari, non ha intenzione di fare il parassita predicando nelle sinagoghe (cfr le accuse mossegli in 1 Cor 9,4 ss.). Sebbene riconoscesse il diritto dei predicatori al sostentamento, Paolo, per quanto possibile, non rinunciava mai a lavorare con le sue mani, per non essere di peso a nessuno, ma anche per dar prova del suo disinteresse, specie quando aveva a che fare con comunità agiate, abituate a fargli i conti in tasca, come quella di Corinto.
Da notare che per poter predicare in questa città, senza lavorare, era costretto a elemosinare contributi alle chiese della Galazia e di altre zone (filippesi). Egli comunque raccomandava sempre ai fedeli di lavorare per provvedere alle loro necessità e a quelle dei bisognosi. Occorre però fare attenzione a non considerare questo atteggiamento una sorta di socialismo ante-litteram, poiché in realtà Paolo «benediva» tanto il lavoro del cittadino libero quanto quello dello schiavo, affermando, senza ambiguità, che lo schiavo doveva limitarsi a cercare la sola liberazione dal peccato e non (anche) quella dal padrone.
Dopo la venuta di Sila e Timoteo, Paolo scrisse le due Lettere ai Tessalonicesi. Essi erano arrivati con aiuti finanziari per permettere a Paolo di predicare senza dover lavorare.
Gli ebrei della sinagoga solo a questo punto si ribellano. Evidentemente Paolo, non avendo più bisogno di lavorare, aveva radicalizzato i suoi discorsi. Sembra che a partire dalla rottura con gli ebrei di Corinto, Paolo avesse per la prima volta deciso di frequentare solo i pagani, ma non sarà così. Forse qui Luca vuole farci capire che per Paolo i pagani convertiti erano migliori degli ebrei.
In effetti è del tutto possibile che Paolo si fosse convinto che a Corinto gli era più facile avvicinare i pagani che non ad Atene (lo dimostra p. es. la conversione di Tizio o Tito Giusto, pagano proselite, che diventerà un suo attivo discepolo). L’atteggiamento che lui teneva con i giudei era relativo a quello che poteva tenere con i pagani. Ormai il suo distacco dal giudaismo sta diventando sempre più netto, per quanto le circostanze lo costringano a comportarsi come non vorrebbe. E comunque in questa sinagoga egli non metterà più piede.
La conversione dell’archisinagogo Crispo rappresenta un’eccezione. Ed è abbastanza strana, in quanto Paolo, al v. 6, mostra di voler rompere ufficialmente e definitivamente con la sinagoga e persino con l’ebraismo. Un altro capo è Sostene (v. 17), che però gli è contrario.
L’ostilità degli ebrei doveva essere così forte che Paolo ad un certo punto pensò, dopo la clamorosa rottura, che se non avesse lasciato la città l’avrebbero sicuramente ucciso. Poi qualcuno deve averlo rassicurato (probabilmente gli stessi pagani convertiti) e convinto a restare, promettendogli un’adeguata protezione. Luca omette di riportare i nomi per esigenze di sicurezza. È probabile che tra la comunità ebraica e quella pagana ci fossero già forti tensioni.
Il Gallione citato al v. 12 è stato proconsole d’Acaia nel 51-52. Paolo viene deferito al suo tribunale dagli ebrei di Corinto, dopo un anno e mezzo di predicazione: questo dimostra ch'egli godeva di appoggi politici non indifferenti.
L’accusa che gli muovono è quella di essere un sovversivo, cioè è politica: Paolo «persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge» (v. 13). Perché «in modo contrario alla lex romana»? Semplicemente perché il Dio dei cristiani era esclusivo di tutti gli altri e non ammetteva il culto dell’imperatore.
A dir il vero questo anche i giudei lo pensavano: dunque dove stava la differenza? La differenza stava nel fatto che gli ebrei della diaspora, pur di essere lasciati in pace, avevano rinunciato a fare proseliti: essi non predicavano mai in pubblico le ragioni dell’ebraismo, la superiorità di questa religione rispetto al politeismo pagano. I proseliti pagani, frequentanti la sinagoga, erano frutto di una predicazione del tutto privata. Inoltre gli ebrei si consideravano tali per nascita, ovvero per discendenza materna; un qualunque pagano convertito sarebbe sempre rimasto un ebreo di seconda categoria.
Gli ebrei sapevano bene che se avessero tenuto un atteggiamento analogo a quello di Paolo, avrebbero dovuto subire pesanti ritorsioni da parte delle autorità romane. Quindi in pratica, denunciando Paolo, essi sperano di ottenere una delle due cose: o una ferma condanna del suo operato, oppure la possibilità di potersi comportare come lui. In entrambi i casi sarebbe aumentato il loro prestigio.
Tuttavia Gallione rifiuta di giudicare Paolo, poiché sa bene che la sua predicazione e il suo operato non sono politicamente pericolosi per gli interessi di Roma. Ha avuto modo di verificarlo molto tempo prima che scattasse la denuncia da parte degli ebrei rivali.
In realtà Gallione non aveva capito che indirettamente il messaggio di Paolo era «pericoloso» proprio in rapporto alla tendenza in atto, nelle sedi governative dell’impero, di trasformare l’imperatore in una sorta di «dio in terra». Cioè non aveva capito che Paolo, indirettamente, contestava la politica sempre più confessionale e integralista dell’impero.
Il fatto è che il culto dell’imperatore non era ancora una necessità di Stato come di lì a poco sarebbe diventato. Lo stesso politeismo, in virtù del quale Roma poteva autorizzare la diffusione di una nuova religione come quella cristiana, era visto negli ambienti governativi come una forma di credenza insufficiente per le esigenze accentratrici e sempre più autoritarie dello Stato: questo significava che per una qualunque religione sarebbe diventato sempre più difficile diffondersi senza un preventivo assenso da parte delle istituzioni o, quanto meno, senza che i seguaci di quella religione non avessero ammesso la loro subordinazione alle ragioni dell’impero.
Gallione non può ovviamente immaginare che nei secoli a venire le persecuzioni contro i cristiani sarebbero state ben più dure di quelle contro gli ebrei. Egli qui si limita semplicemente a costatare che Paolo non ha usato violenza fisica nella predicazione, non ha turbato in alcun modo l’ordine pubblico, e che la sua predicazione non ha un fine politicamente eversivo. Egli non s’interessa del contenuto del vangelo di Paolo. Per lui la questione sollevata dagli ebrei rivali era solo di natura religiosa, non politica, quindi irrilevante sul piano giuridico.
Il comportamento di Gallione ai vv. 14-17 è molto significativo: sin dalle prime battute egli aveva capito che gli ebrei volevano coinvolgerlo in una diatriba di tipo teologico-politico, inducendolo a prendere posizione contro i cristiani. Il suo fare sbrigativo sta forse a testimoniare che già altre volte aveva dovuto affrontare questioni del genere. Si comporta come se sapesse già che le accuse degli ebrei erano prive di fondamento. E non solo non ascolta alcuna argomentazione, né dell’accusa né della difesa, ma si guarda anche bene dall’intervenire quando i pagani, presenti in tribunale, malmenano Sostene, il principale accusatore, dimostrando così che la presenza della comunità ebraica nella città era malvista. Ovviamente evita anche con cura di prendere pubblicamente le difese di Paolo.
I pagani (qui bisogna intendere soprattutto la piccola-media borghesia) evidentemente s’erano resi conto che la predicazione paolina era più democratica della posizione settaria e aristocratica degli ebrei.
Paolo, dopo «parecchi giorni», decise di tornare ad Antiochia in compagnia di Priscilla e Aquila (la donna, citata per prima, sembra essere diventata più importante del marito: rischieranno entrambi la morte per lui ad Efeso).
Circa il voto, di cui al v. 18, non si sa nulla: durava in media trenta giorni, nel corso dei quali non ci si doveva tagliare i capelli e bisognava fare altre cose rituali. Dopo averlo sciolto, Paolo parte dal porto di Cencre (patria di Febe, latrice della Lettera ai Romani).
A Efeso lascia Aquila e Priscilla e da solo si mette a discutere coi giudei della sinagoga locale, che per fortuna non gli sono ostili; anzi vorrebbero trattenerlo, ma lui ha fretta di tornare ad Antiochia (forse per chiedere altri finanziamenti). Promette che sarebbe tornato e manterrà la promessa.
Approda a Cesarea, poi va a Gerusalemme, infine scende ad Antiochia di Siria e da qui praticamente inizia il suo terzo viaggio (54-57). Da Antiochia, dopo essere salito in Galazia e aver attraversata la Frigia, torna finalmente ad Efeso, dove aveva lasciato Aquila e Priscilla.
Ad Efeso era giunto Apollo, ebreo ellenista, oriundo di Alessandria d’Egitto: forse proveniva dalla scuola di Filone. Andò ad Efeso per predicare il vangelo del Battista; conosceva anche il vangelo di Gesù, ma dal punto di vista dei discepoli del Battista, che ovviamente vedevano nel Cristo un profeta inferiore al loro maestro.
Ignorava la tesi petrina della resurrezione, ripresa e sviluppata da Paolo, o forse non ci credeva, per quanto Luca sostenga che predicasse «esattamente ciò che si riferiva a Gesù» (v. 25). È dunque probabile che Apollo esponesse con più o meno correttezza quanto riguardava la vita e le opere del «Gesù storico», ma non sapesse nulla del «Cristo della fede».
Considera Gesù un profeta equivalente a Giovanni e forse accusava gli ebrei d’averlo ingiustamente ucciso e d’aver così perduto, come con Giovanni, un’altra delle speranze più significative di quel tempo. Si rivolgeva esclusivamente agli ebrei. È un uomo molto colto, ma qui viene istruito da due ex tessitori cristiani.
Solo dopo essere stato «istruito», Luca dice che Apollo cominciò a «dimostrare pubblicamente attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo» (v. 28), e fece questo cambiando territorio di missione, cioè trasferendosi da Efeso alle località dell’Acaia. Aveva finalmente appreso la lezione paolina per quanto concerne la reinterpretazione delle Scritture, volta a dimostrare la tesi della necessità della morte in croce del messia, ma non risulta chiaro che avesse altresì compreso l’universalismo di Paolo, cioè il fatto che la morte di Gesù apriva le porte alla predicazione spiritualistica, etico-religiosa, ai pagani.
Infatti durante la sua permanenza a Corinto – verrà detto altrove – Apollo indurrà alcuni a provocare delle separazioni. Forse era rimasto troppo legato al giudaismo della diaspora. Si pensa comunque che abbia scritto la Lettera agli Ebrei.
Probabilmente Apollo rappresenta la soluzione di compromesso tra il movimento battista e quello cristiano post-pasquale: entrambi i movimenti trovarono infatti un’intesa sul versante etico-religioso, a discapito di quello politico-nazionalistico. La soluzione più evidente di questo compromesso fu, nei sinottici, il racconto del battesimo di Gesù ad opera del Battista, che in realtà, secondo il quarto vangelo, non è mai avvenuto.
torna suCap. 19
[1]Mentre
Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell’altopiano,
giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli
[2]e disse loro:
«Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla
fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire
che ci sia uno Spirito Santo».
[3]Ed egli
disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il
battesimo di Giovanni», risposero.
[4]Disse allora
Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza,
dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui,
cioè in Gesù».
[5]Dopo aver udito questo, si
fecero battezzare nel nome del Signore Gesù
[6]e, non appena
Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e
parlavano in lingue e profetavano.
[7]Erano in
tutto circa dodici uomini.
[8]Entrato poi nella sinagoga, vi poté
parlare liberamente per tre mesi, discutendo e cercando di persuadere
gli ascoltatori circa il regno di Dio.
[9]Ma poiché
alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere dicendo male in
pubblico di questa nuova dottrina, si staccò da loro separando
i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di
un certo Tiranno.
[10]Questo durò
due anni, col risultato che tutti gli abitanti della provincia
d’Asia, Giudei e Greci, poterono ascoltare la parola del
Signore.
[11]Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di
Paolo,
[12]al
punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che
erano stati a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti
cattivi fuggivano.
[13]Alcuni esorcisti ambulanti giudei si
provarono a invocare anch’essi il nome del Signore Gesù
sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: «Vi scongiuro
per quel Gesù che Paolo predica».
[14]Facevano
questo sette figli di un certo Sceva, un sommo sacerdote giudeo.
[15]Ma lo
spirito cattivo rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è
Paolo, ma voi chi siete?».
[16]E l’uomo
che aveva lo spirito cattivo, slanciatosi su di loro, li afferrò
e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella
casa nudi e coperti di ferite.
[17]Il fatto fu
risaputo da tutti i Giudei e dai Greci che abitavano a Efeso e tutti
furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù.
[18]Molti di
quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in
pubblico le loro pratiche magiche
[19]e un numero considerevole di
persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri
libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore
complessivo e trovarono che era di cinquantamila dramme d’argento.
[20]Così
la parola del Signore cresceva e si rafforzava.
[21]Dopo questi
fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l’Acaia
e di recarsi a Gerusalemme dicendo: «Dopo essere stato là
devo vedere anche Roma».
[22]Inviati
allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si
trattenne ancora un po’ di tempo nella provincia di
Asia.
[23]Verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo
alla nuova dottrina.
[24]Un tale,
chiamato Demetrio, argentiere, che fabbricava tempietti di Artemide
in argento e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani,
[25]li radunò
insieme agli altri che si occupavano di cose del genere e disse:
«Cittadini, voi sapete che da questa industria proviene il
nostro benessere;
[26]ora potete
osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa
di gente, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l’Asia,
affermando che non sono dèi quelli fabbricati da mani d’uomo.
[27]Non soltanto
c’è il pericolo che la nostra categoria cada in
discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non
venga stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di
colei che l’Asia e il mondo intero adorano».
[28]All’udire
ciò s’infiammarono d’ira e si misero a gridare:
«Grande è l’Artemide degli Efesini!».
[29]Tutta la
città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel
teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco macèdoni,
compagni di viaggio di Paolo.
[30]Paolo voleva
presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero.
[31]Anche alcuni
dei capi della provincia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo
di non avventurarsi nel teatro.
[32]Intanto, chi
gridava una cosa, chi un’altra; l’assemblea era confusa e
i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi.
[33]Alcuni
della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i Giudei
avevano spinto avanti, ed egli, fatto cenno con la mano, voleva
tenere un discorso di difesa davanti al popolo.
[34]Appena
s’accorsero che era Giudeo, si misero tutti a gridare in coro
per quasi due ore: «Grande è l’Artemide degli
Efesini!».
[35]Alla fine il
cancelliere riuscì a calmare la folla e disse: «Cittadini
di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è
custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta
dal cielo?
[36]Poiché
questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate
calmi e non compiate gesti inconsulti.
[37]Voi avete condotto qui
questi uomini che non hanno profanato il tempio, né hanno
bestemmiato la nostra dea.
[38]Perciò
se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da
far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono
i proconsoli: si citino in giudizio l’un l’altro.
[39]Se poi
desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell’assemblea
ordinaria.
[40]C’è
il rischio di essere accusati di sedizione per l’accaduto di
oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo
assembramento».
[41]E con queste
parole sciolse l’assemblea.
*
Questo capitolo è molto importante perché per la prima volta ad opporsi alla predicazione di Paolo non sono soltanto gli ebrei ma anche i pagani. E mentre i primi lo facevano per questioni eminentemente politiche e ideologiche, i secondi lo fanno – come vedremo – per questioni sostanzialmente economiche.
Il racconto del tumulto di Efeso, qui riportato, è stato inserito artificialmente nel contesto del cosiddetto «terzo viaggio missionario» di Paolo, in quanto proveniente da una fonte particolare. È uno dei brani meno commentati dall’apologetica cattolica.
I primi quattro versetti del capitolo riprendono la situazione descritta in quello precedente, ovvero il rapporto tra battisti e cristiani. Mentre Paolo predicava a Corinto, Apollo era già ad Efeso, e quando Paolo giunge ad Efeso, Apollo era tornato a Corinto, sicché non riescono a incontrarsi.
Paolo però s’accorge subito ad Efeso, nonostante quanto detto nel cap. 18 sulla correttezza della predicazione di Apollo, che i discepoli di quest’ultimo avevano ricevuto solo il «battesimo di Giovanni»: dunque l’insegnamento di Aquila e Priscilla era servito a poco.
L’espressione «battesimo di Giovanni» è convenzionale, oltre che indicativa di una prassi simbolico-rituale, e sta semplicemente ad indicare che la predicazione di Apollo s’era limitata a considerare Gesù come un profeta etico-religioso al pari del Battista o al massimo come il messia (naturalmente impolitico) preannunciato dai profeti, che nel Precursore avevano trovato il loro compimento. (Inutile qui stare a ribadire il fatto che il messia preannunciato dai profeti veterotestamentari non aveva alcunché di «impolitico» e che l’esegesi cristiana dei passi veterotestamentari è sempre stata a dir poco tendenziosa).
Il linguaggio usato in tutta la prima parte di questo capitolo si spreca in formule sibilline di tipo religioso, che vanno sicuramente interpretate, e descrive situazioni a dir poco incredibili, come p. es. quella dei vv. 11-12, allorché si fa passare Paolo per un Cristo redivivo.
Paolo comunque s’accorge subito che i discepoli di Apollo non avevano ricevuto lo «Spirito santo». La concezione pneumatica dello «Spirito santo» era del tutto estranea al mondo ebraico, che al massimo parlava di «Spirito di Dio», paragonandolo alla «sapienza divina» (come viene fatto p. es. nel racconto della creazione della Genesi), e comunque non disgiungendolo mai dalla figura di Jahvè. Il Battista, checché ne dicano i vangeli, non costituiva un’eccezione a questo.
Sono stati i cristiani che, seguendo correnti gnostiche, hanno per primi separato lo «Spirito» da «Dio», facendone un’entità autonoma. Il concetto di «spirito», che è di tipo metafisico, venne elaborato per supplire al fallimento del messianismo politico, ma anche per non ricadere nella filosofia rassegnata di certe posizioni attendiste, come appunto quella battista o essenica.
È evidente, da questo punto di vista, che la predicazione di Apollo, avendo rinunciato a qualunque istanza politico-nazionalistica, non costituiva per i cristiani un concorrente temibile: sarebbe stato sufficiente, per surclassarla, dimostrare che la corrente battista era meno motivante sul piano spiritualistico, sicuramente priva di prospettive per il mondo pagano.
Da notare che Luca, parlando dei battisti, usa l’appellativo «discepoli», evitando quello di «fratelli». I battisti infatti venivano accettati solo in quanto il loro leader aveva visto nel Cristo un possibile messia per Israele, ma ai tempi di Gesù la polemica tra i due movimenti era abbastanza forte ed era tutta «politica», in quanto i battisti erano convinti che per liberarsi di Roma occorreva una preliminare rigenerazione morale: di qui il loro rifiuto di partecipare alla cacciata dei mercanti dal tempio, considerata un’iniziativa troppo categorica.
Viceversa, ai tempi degli apostoli la polemica si sposta sul terreno pre-politico (soteriologico), e qui inevitabilmente si ridimensiona, tant’è che i discepoli di Apollo non oppongono a Paolo alcuna resistenza e si fanno nuovamente battezzare. Solo dopo essersi sottoposti a questo sacramento diventeranno «fratelli» a tutti gli effetti.
In sostanza Paolo non negava un valore etico-religioso alla predicazione di Apollo, però fa chiaramente capire che mentre il battesimo di Giovanni era semplicemente di «penitenza», in attesa dell’arrivo del messia, quello cristiano è pneumatico, è positivo, in quanto viene effuso lo spirito o la grazia di credere possibile un’esistenza dignitosa anche senza rivoluzione politico-nazionalistica; lo spirito è la forza che viene concessa per credere, ovunque si viva, a qualunque ceto sesso etnia tradizione si appartenga, che il ritorno del Cristo avverrà solo alla fine della storia, per il giudizio universale.
Il fatto che i neo-battezzati ad un certo punto si siano messi a parlare in lingue e a profetare è stato aggiunto, a livello redazionale, per giustificare in qualche modo la diversità della posizione cristiana da quella battista. Come si può notare, si resta entro limiti rigorosamente mitologici. Dire poi che «erano circa dodici uomini» ha troppo il sapore di una mimesi delle vicende legate al personaggio Gesù, per poter pensare che qui vi sia qualcosa di minimamente credibile.
Interessante comunque resta la puntualizzazione fatta da Luca secondo cui Paolo riuscì a rimanere ben tre anni a Efeso, evidentemente pago dei successi ottenuti. Efeso era praticamente diventata il centro del suo apostolato, e questo stranamente, poiché all’inizio sembrava impossibile per lui predicare nella provincia d’Asia.
Durante questo periodo egli scrive sicuramente la prima Lettera ai Corinti e forse anche altre lettere. Nella sinagoga della città predica solo per tre mesi: se ne separa quando gli ebrei rivali cominciano a manifestare pubblicamente (ai pagani) le discordie tra giudaismo e cristianesimo. Con l’aiuto di Timoteo, Tito, Aristarco, Aquila, Priscilla ecc. si mette a predicare presso la scuola pagana di un certo Tiranno, dal nome curioso.
Il successo di Paolo, negli ambienti pagani di Efeso, fu comunque considerevole, altrimenti non si spiega il tentativo di screditare così pesantemente degli esorcisti di origine giudaica, là residenti, come riportato ai vv. 11-20.
L’episodio di questi esorcisti non val la pena prenderlo in esame, in quanto chiaramente inventato e aggiunto in maniera posticcia per far sembrare Paolo un novello Cristo. Va però sottolineata una differenza: mentre in Mc 10,38 ss. gli ebrei che non seguivano Gesù potevano comunque fare esorcismi nel suo nome in quanto non venivano considerati suoi nemici, qui invece la rivalità è netta, e questo nonostante che Paolo venga presentato come una sorta di Cristo spiritualizzato, lontanissimo dalla politica. Vien quasi da pensare ch’egli non sia stato del tutto estraneo alla situazione descritta nel v. 16: «E l’uomo che aveva lo spirito cattivo, lanciatosi su di loro, li afferrò e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite».
L’unica nota sicura a livello storico è che ad Efeso c’era molta superstizione e il racconto del tumulto – che ora vedremo – lo dimostra ampiamente. È però probabile ch’esso sia stato messo da redattori cristiani di origine ebraica per fare da contrappeso a quello sugli esorcisti, scritto da redattori cristiani di origine pagana.
Che il racconto sia stato aggiunto successivamente è dimostrato anche dalla stranezza del v. 21: «Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l’Acaia e di recarsi a Gerusalemme dicendo: – Dopo essere stato là devo vedere anche Roma», che indica chiaramente la volontà di andarsene da Efeso e che sul piano redazionale sarebbe stato meglio mettere alla fine del racconto sul tumulto.
Ad Efeso, città greca di cultura, colonizzata dai romani sin dal 190 a.C., viveva un certo Demetrio, piccolo imprenditore-appaltatore di un’officina ove si costruivano tempietti argentei per gli adoratori della statua di Artemide, antichissima dea della caccia (la Diana dei romani).
Egli aveva persuaso i suoi dipendenti artigiani e gli altri commercianti e bottegai, i cui profitti derivavano dalla popolarità della dea, a ribellarsi contro l’opera missionaria di Paolo, il quale – stando all’accusa di Demetrio – affermava che «non sono dèi quelli fabbricati da mani d’uomo» (v. 26). Demetrio doveva dimostrare che il danno subito come «lavoratori specializzati» era un danno per l’intera città.
Artemide non era una divinità da poco ma una delle più venerate. Il suo tempio era il più sontuoso di tutti, una delle meraviglie del Mediterraneo, tanto che attirava schiere di pellegrini da ogni parte del mondo. Allorché gli orefici decisero di opporsi alla dottrina cristiana, Paolo aveva già «convinto e sviato una massa di gente non solo di Efeso ma si può dire di tutta l’Asia [regione dell’odierna Turchia, sede appunto di Efeso]» (v. 26).
Essi reagiscono non anzitutto in quanto «pagani» – benché questa sia una motivazione presente nelle loro rivendicazioni – ma piuttosto in quanto «artigiani», proprietari dei loro mezzi produttivi. Ciò che li muove a lottare «sindacalmente» contro la comunità di Paolo è anzitutto la paura di cadere in discredito come categoria sociale.
Ovviamente – considerando che il culto di Artemide, divinità protettrice della polis, era in un certo senso obbligato, almeno sul piano del rito, per beneficiare dello status di cittadino – la protesta veniva condotta usando una terminologia di tipo religioso. Demetrio e gli altri colleghi, infatti, ribadiscono il valore del feticismo politeistico.
La singolare fama della predicazione monoteistica di Paolo stava però a indicare una simpatia non esclusiva per il culto di Artemide da parte della popolazione urbana. Il peggioramento della situazione economica, che comincerà ad essere acuto nel corso del II secolo, aveva decentrato l’interesse della gente verso le religioni più disparate, soprattutto quelle misteriche e messianiche, che più servivano per evadere dall’insopportabile fardello delle contraddizioni sociali. Le sollevazioni antiromane erano all’ordine del giorno.
Fu proprio nella provincia d’Asia che venne scritto dall’apostolo Giovanni il testo più antico e più radicale di tutto il cristianesimo primitivo: l’Apocalisse.
Efeso, ricco centro commerciale e artigianale, che a causa del dispotismo romano (tributi, allargamento della proprietà privata e sviluppo intensivo della schiavitù) vedeva le condizioni della sua popolazione peggiorare progressivamente, aveva sempre più bisogno di credere nell’imminente venuta di un liberatore che ripristinasse i fasti di un tempo. O quanto meno aveva bisogno che personaggi come Paolo evitassero, con le loro «eresie», di mettere a repentaglio la poca stabilità economica rimasta.
La progressiva tendenza alla precarietà sociale spiega il consenso generale (politico) che i cittadini di Efeso manifestarono per la causa di Demetrio. Il che la dice lunga sull’effettivo successo della missione di Paolo. «Tutta la città fu in subbuglio – scrive Luca – e tutti si precipitarono in massa nel teatro» (v. 29) – un teatro che poteva contenere fino a 25.000 persone!
Lo slogan che urlavano era soprattutto questo, certamente riassuntivo di un grande disagio sociale: «Grande è l’Artemide degli efesini!» (v. 28). Ovviamente non tutti erano interessati alla perdita dei guadagni degli argentieri, però il pretesto era più che sufficiente per far sentire la propria voce. La popolazione si batteva per il prestigio della propria città contro i soprusi e le angherie di Roma ed è difficile credere che in mezzo ad essa non vi fossero anche dei pagani neo-convertiti al cristianesimo.
Gli strali comunque vengono lanciati proprio contro i cristiani, visti come coloro che, in definitiva, non facevano che peggiorare, con le loro rigidità monoteistiche, le sofferenze quotidiane.
«Intanto – ironizza Luca – chi gridava una cosa, chi un’altra; l’assemblea era confusa e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi» (v. 32). La rivolta procedeva all’insegna del consueto spontaneismo di massa, nella più totale disorganizzazione e assenza di fini strategici.
Paolo voleva presentarsi alla folla per cercare di chiarire, presumibilmente, che coi due principi del monoteismo cristiano e dell’egualitarismo morale (nel peccato e nel perdono divino) di tutti gli uomini davanti a Dio, i cittadini di Efeso avrebbero potuto ottenere molto di più rispetto a quanto invece avrebbero conservato restando legati sia al politeismo pagano (che impediva, a causa della diversità dei culti e dei riti, un’azione comune), sia all’idea di sentirsi irrimediabilmente inferiori verso chi deteneva il potere (non dimentichiamo che diversamente da quella ebraica, la filosofia pagana aveva una concezione fatalista dell’esistenza, in cui il destino appariva superiore agli stessi dèi).
Paolo avrebbe voluto invitarli a sperare ancora in quella salvezza etico-religiosa che già per un triennio aveva loro annunciato in alternativa a tutti i culti pagani. Non si rendeva conto che era proprio contro i limiti (politici) di questa predicazione ch’era sorto il tumulto. Che senso aveva infatti togliere agli efesini uno dei pochi sostegni economici rimasti senza promettere loro un riscatto sociale vero e proprio?
A Paolo fu impedito di parlare da alcuni capi romani della provincia, suoi amici, nonché dai suoi stessi discepoli. Essi sapevano bene che l’esasperazione della folla non gli avrebbe permesso di parlare e forse – se con altre «belle parole» si fosse nuovamente saggiata la pazienza della città – neppure di vivere.
L’ideologia di Paolo era senz’altro più progressista di quella ingenua e primitiva degli efesini, ma fino a che punto efficace sul piano politico? Parte della cittadinanza si era dimostrata anche disposta a modificare la propria dedizione esclusiva alla dea Artemide, ma ciò sarebbe servito a ribaltare i rapporti con le classi dominanti? La rivolta di Efeso non stava forse ad indicare che, messo di fronte a problemi oggettivi, il cristianesimo si rivelava in tutta la sua pochezza e illusorietà, al pari dei culti idolatrici che pur voleva debellare?
Paolo comunque non venne catturato dalla folla: in suo luogo presero la parola i discepoli Gaio e Aristarco. Si sapeva ch’egli era cittadino romano e che, per questo, fruiva di determinati privilegi, nonché di protezioni da parte di taluni funzionari politico-amministrativi.
Non dimentichiamo inoltre che per gli imperatori romani (pur essendo essi lontanissimi dall’idea di sostenere una qualsivoglia forma di uguaglianza sociale: al massimo si concedeva quella giuridica della cittadinanza) l’esigenza politica del monoteismo religioso (o meglio di una «monolatria»7) stava diventando non meno forte della necessità di salvaguardare il politeismo al fine di non scontentare le popolazioni oppresse delle varie etnie e nazionalità. Solo che per gli imperatori «monoteismo» significava semplicemente «autodivinizzazione»: il contrasto col cristianesimo, le cui origini ebraiche in questo senso pesavano come non mai, sarebbe diventato prima o poi inevitabile.
Nel frattempo, all’interno del teatro, intervenne il giudeo Alessandro, col proposito d’impedire che gli ebrei venissero coinvolti nelle accuse indirizzate ai cristiani (che evidentemente passavano per una setta giudaica). Ma, prima che riuscisse a spiegare la differenza tra i due monoteismi e che potesse far loro capire come la comunità ebraica si tenesse del tutto separata dalle tradizioni religiose del resto della città, evitando di fare pubblici proselitismi, e come fosse anch’essa desiderosa di emarginare il pericoloso concorrente cristiano, «si misero tutti a gridare in coro per quasi due ore: Grande è l’Artemide degli efesini!» (v. 34).
Evidentemente la folla riunitasi presso l’arena, e forse la grande maggioranza dei cittadini non vedeva di buon occhio la presenza degli ebrei ad Efeso. Incapace di ascoltare le ragioni di una comunità settaria, che non sa condividere il disagio sociale dei non-ebrei, la folla, trovandosi improvvisamente unanime, urla e protesta più di prima, senza neppure prendere in considerazione le differenze «religiose».
È a questo punto che il cancelliere, cioè il primo segretario delle pubbliche assemblee (una sorta di sindaco), si sente costretto a intervenire. Il suo discorso è un piccolo capolavoro di abilità politico-diplomatica: da un lato infatti deve evitare che la protesta si trasformi in una sommossa, cui sarebbero seguite le inevitabili ritorsioni da parte romana; dall’altro deve evitare i pogrom antiebraici, che getterebbero discredito sulla città, notoriamente tollerante e aperta a tutti gli stranieri.
Egli esordisce dicendo: «Cittadini di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo?» (v. 35).
Come facilmente si nota, il cancelliere, col suo preambolo, riconferma subito il prestigio universale della divinità e quindi della città che ne conservava il tempio più bello e, allo stesso tempo, per togliere ogni equivoco, valorizza il carattere autenticamente divino della statua ricordando la leggenda della discesa dal cielo8.
In pratica il cancelliere si stava servendo della religione per due scopi contrapposti solo apparentemente: da un lato finge di parteggiare per il «municipalismo» antiromano dei convenuti, dall’altro soffoca sul nascere la protesta sociale illudendo gli esagitati di potersi emancipare socialmente proprio in virtù del culto di Artemide. Cioè nello stesso momento egli afferma il prestigio della dea per gli orefici e artigiani e la sua divinità per tutti gli altri.
Assicura poi che Gaio e Aristarco non hanno profanato il tempio né oltraggiato il nome della dea, avendo soltanto predicato una religione diversa, non alternativa a quella ufficiale, il che dalla legge romana non era proibito. Quasi volesse far capire – di là dalle vere intenzioni della predicazione paolina – che fra i due culti non v’era alcuna vera contraddizione. D’altra parte allo Stato romano non interessavano le differenze di principio fra un culto e l’altro: l’importante era che ogni fede fosse un docile strumento nelle mani del potere politico.
Qui appare evidente che non sono ancora in atto le persecuzioni imperiali ai danni del cristianesimo. Nella posizione del cancelliere non troviamo né la preoccupazione di scaricare sul cristianesimo le cause dei mali sociali (come a partire da Nerone si comincerà a fare e come soprattutto avverrà nel III secolo), né quella di servirsi di questa nuova religione per rafforzare le basi stesse dell’impero (come poi si farà con Costantino e soprattutto Teodosio).
«Perciò – prosegue il conciliatore della rivolta – se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli: si citino in giudizio l’un l’altro» (v. 38). Ovvero se la questione non è politica o ideologica ma semplicemente giuridica, se c’è un diritto violato o un legittimo interesse posto in discussione o minacciato, allora la sede più opportuna per risolverla non è la piazza ma il tribunale, ove la competenza specifica dei magistrati – eletti dai cittadini – saprà far debita giustizia.
Il riferimento qui alla prassi giudiziaria è ovviamente fuorviante, in quanto evita di affrontare dei problemi la cui natura era tutt’altro che giuridica, ma se guardiamo le cose più da vicino ci accorgeremo che nel contesto era obbligato, almeno come primo tentativo di mediare pacificamente la controversia.
Tuttavia, la corporazione degli argentieri, se anche avesse voluto risolvere la questione in sede contenziosa, quale soddisfazione avrebbe potuto ottenere? Non era forse stata la certezza dell’inutilità pratica di una vertenza giudiziaria ai danni di una fede già abbondantemente diffusa nella provincia, ovvero la certezza dell’improponibilità di un qualsiasi appello in tribunale, volto a dimostrare che il pluralismo delle confessioni andava bandito dalla città, a far maturare negli argentieri l’idea che sarebbe stato meglio organizzare una sommossa che vedesse coinvolta l’intera cittadinanza?
Il cancelliere, che evidentemente ricopriva quel ruolo a buon diritto, s’era già reso conto dei limiti della sua stessa proposta e, con molto fair-play, ne aggiunse un’altra di tipo più politico-istituzionale: «Se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell’assemblea ordinaria» (v. 39). Quella cioè dove solo «alcuni» potevano partecipare, votare, fare petizioni ecc. Quell’assemblea che, nonostante queste forti limitazioni rappresentative, tipiche della democrazia delegata e censuale, apparirà ugualmente pericolosa al potere romano, che verso la fine del II secolo, deciderà di sostituirla col senato municipale dei più ricchi possidenti.
Dopo aver presentato l’ultima ipotesi legale di mediazione, al cancelliere non restava che concludere in tono drammatico, prospettando un intervento armato di Roma per il reato di «sedizione». «Non vedo alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento» (v. 40) – disse ai partecipanti. Davanti al rischio di una repressione militare, in cui sicuramente i romani avrebbero fatto poca differenza di persone o di religioni, la piattaforma economicistica degli argentieri gli appariva del tutto sproporzionata.
Il cancelliere non era lì per trovare altre motivazioni, più convincenti, che legittimassero una sommossa potenziale come quella; anzi le sue parole lasciavano chiaramente intendere che la situazione socioeconomica della città non era così esplosiva da rendere plausibile una rivolta popolare così eclatante.
Il suo discorso quindi di fatto evita l’affronto circostanziato delle accuse contro gli imputati cristiani, evita cioè di considerare le cause sociali ad esse sottese. E i rivoltosi, non sufficientemente organizzati, non sanno approfittare della situazione, non riescono, in quell’occasione, a trovare valide ragioni da contrapporre al cancelliere, il quale scioglie la spontanea assemblea senza incidenti di sorta.
Paolo, dal canto suo, non proferì parola, ma dall’epistola che scrisse agli efesini è facile immaginarsi quale taglio conservatore, sul piano politico, avrebbe dato al suo intervento. Basta leggersi ciò che scrive all’inizio del cap. 6, riguardo all’atteggiamento che gli schiavi devono tenere verso i loro padroni. Anzitutto raccomanda loro di obbedire con «timore e tremore e semplicità di spirito», come se il padrone fosse un sosia del Cristo; poi, pur vietando, giustamente, di ricercare una qualsiasi forma di affrancamento ostentando il proprio servilismo, pretende addirittura che gli schiavi non si ribellino alle necessità dei padroni lavorando controvoglia. La conclusione è addirittura patetica: chiede ai padroni di non usare lo strumento della «minaccia» per indurre quelli all’obbedienza. Insomma, fra padroni e schiavi avrebbe dovuto regnare, in nome di Cristo, la più perfetta armonia.
Paolo smise di credere nella possibilità di realizzare una giustizia effettiva sulla terra il giorno stesso in cui pensò che per ottenerla sarebbe stato sufficiente credere nella divinità di Gesù, cioè in quella realtà che – secondo lui – si sarebbe imposta da sola all’attenzione di tutti gli uomini nel momento magico della «parusia» o della seconda venuta messianica. Fino a quel giorno il cristiano avrebbe dovuto dar battaglia non alle creature «fatte di carne e di sangue» ma agli «spiriti del male che abitano nelle regioni celesti» (Ef. 6,12).
torna suCap. 20
[1]Appena
cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo
averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la
Macedonia.
[2]Dopo
aver attraversato quelle regioni, esortando con molti discorsi i
fedeli, arrivò in Grecia.
[3]Trascorsi tre mesi, poiché
ci fu un complotto dei Giudei contro di lui, mentre si apprestava a
salpare per la Siria, decise di far ritorno attraverso la Macedonia.
[4]Lo
accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo
di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asiatici Tichico e
Trofimo.
[5]Questi
però, partiti prima di noi ci attendevano a Troade;
[6]noi invece
salpammo da Filippi dopo i giorni degli Azzimi e li raggiungemmo in
capo a cinque giorni a Troade dove ci trattenemmo una
settimana.
[7]Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a
spezzare il pane e Paolo conversava con loro; e poiché doveva
partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a
mezzanotte.
[8]C’era
un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove
eravamo riuniti;
[9]un ragazzo
chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un
sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare e, sopraffatto
dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto.
[10]Paolo allora
scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e
disse: «Non vi turbate; è ancora in vita!».
[11]Poi risalì,
spezzò il pane e ne mangiò e dopo aver parlato ancora
molto fino all’alba, partì.
[12]Intanto
avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto
consolati.
[13]Noi poi, che eravamo partiti per nave, facemmo vela
per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo; così infatti
egli aveva deciso, intendendo di fare il viaggio a piedi.
[14]Quando ci
ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene.
[15]Salpati da
qui il giorno dopo, ci trovammo di fronte a Chio; l’indomani
toccammo Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto.
[16]Paolo aveva
deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi
nella provincia d’Asia: gli premeva di essere a Gerusalemme, se
possibile, per il giorno della Pentecoste.
[17]Da Mileto mandò
a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa.
[18]Quando essi
giunsero disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con
voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo
tempo:
[19]ho
servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le
prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei.
[20]Sapete come
non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al
fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre
case,
[21]scongiurando
Giudei e Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro
Gesù.
[22]Ed
ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere
ciò che là mi accadrà.
[23]So soltanto
che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono
catene e tribolazioni.
[24]Non ritengo
tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a
termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore
Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di
Dio.
[25]Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi
tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio.
[26]Per questo
dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa
riguardo a coloro che si perdessero,
[27]perché
non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà
di Dio.
[28]Vegliate su
voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo
vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è
acquistata con il suo sangue.
[29]Io so che
dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non
risparmieranno il gregge;
[30]perfino di
mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per
attirare discepoli dietro di sé.
[31]Per questo
vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho
cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi.
[32]Ed ora vi
affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di
edificare e di concedere l’eredità con tutti i
santificati.
[33]Non ho
desiderato né argento, né oro, né la veste di
nessuno.
[34]Voi
sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me
hanno provveduto queste mie mani.
[35]In tutte le
maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono
soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù,
che disse: Vi è più gioia nel dare che nel
ricevere!».
[36]Detto questo, si inginocchiò con
tutti loro e pregò.
[37]Tutti
scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di Paolo lo
baciavano,
[38]addolorati
soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più
rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.
*
Desiderando visitare le comunità della Grecia per raccogliere fondi da portare a Gerusalemme, Paolo, da Efeso (Turchia) si reca in Grecia, passando per la Macedonia, cioè scegliendo un itinerario volutamente più lungo.
Luca si sofferma a descrivere un percorso dove, come al solito, non mancano imprevisti: il più importante dei quali, qui, è l’ennesimo complotto giudaico. È però inspiegabile il motivo di una descrizione così particolareggiata del percorso geografico e della reticenza su questo complotto.
Dal v. 4 si comprende bene come quasi tutti i discepoli di Paolo siano di origine pagana, a testimonianza che le vicende connesse alla sommossa degli orefici di Efeso avevano sortito il loro effetto. Ed è altresì probabile che tra questi vi sia lo stesso Luca, che indirettamente vuol far capire la propria presenza dettagliando al massimo la successione delle tappe di questo terzo viaggio.
Dopo aver raccolto i fondi in Acaia, Paolo voleva raggiungere la Siria via mare, ma il suddetto complotto lo convinse a tornare in Macedonia, praticamente rifacendo il percorso dell’andata.
Luca sarebbe partito con Paolo da Filippi e insieme avrebbero raggiunto altri discepoli, preventivamente mandati a Troade, dove Paolo aveva già avuto un incontro con un macedone (16,9) e dove rimasero una settimana. Che non tutti i discepoli fossero di origine pagana è evidente laddove Luca precisa che partirono da Filippi «dopo i giorni degli Azzimi» (v. 6).
Il sabato sera («il primo giorno della settimana») si riuniscono per celebrare l’eucarestia («spezzare il pane»), cioè per celebrare un sacramento inventato dai cristiani (ma le vere origini vanno cercate a Qumran) continuando a usare il computo ebraico di contare giorni e ore. La descrizione di questa prassi non ha negli Atti altro precedente riferimento che 2,42: «Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere». Che è frase, questa, indicativa di una certa istituzionalizzazione del sacramento, mentre qui pare trattarsi di un semplice rito che simboleggia dei rapporti amichevoli, confidenziali.
È probabile che Paolo agli inizi abbia continuato a usare il rito giudaico, spogliandolo però dei suoi contenuti strettamente mosaici (anche a motivo della forte presenza pagana tra i suoi seguaci), e che solo successivamente si sia voluto dare a questo rito una valenza teologica vera e propria. È infatti tassativamente da escludere che l’eucarestia possa esser fatta risalire a un Cristo che, entrando a Gerusalemme nell’ultima pasqua, aveva intenzione di vincere non di essere giustiziato (e quindi commemorato in un rito simbolico).
Si può inoltre supporre che agli inizi l’eucarestia fosse un semplice pasto in comune, dove si chiacchierava e che si concludeva con un canto corale. Luca deve essere stato testimone del fatto che ora prende a narrare.
«Un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto». Così viene scritto al v. 9. Era notte inoltrata, poiché Paolo doveva partire il giorno dopo.
Qui ovviamente gli autori del brano hanno avuto buon gioco nel cercare di dimostrare che Paolo aveva capacità soprannaturali: è stato facile approfittare del fatto che esiste un filo molto sottile tra «l’essere proprio morto» e «l’essere soltanto svenuto».
Paolo corse per primo, forse sentendosi responsabile dell’accaduto, e appena vide il ragazzo per terra «lo abbracciò» (v. 10) e disse ch’era ancora vivo. Cioè fu lui a costatare per primo che ancora respirava. Se fosse stato soltanto svenuto sarebbe stato importante riportare l’episodio? Evidentemente no. Qui non è detto in modo esplicito che Paolo lo fece risorgere, ma questo episodio ha lo scopo di preparare il terreno a una progressiva beatificazione dell’apostolo. E anche da questo si capisce bene il motivo per cui la maggior parte dei seguaci di Paolo cominciò ad essere, ad un certo punto, di origine pagana.
Il v. 11 è, sotto tale aspetto, emblematico: Paolo di nuovo ripete l’eucarestia, come se volesse mostrare che la provvidenza di Dio, grazie all’episodio fortunoso di Eutico, era decisamente dalla loro parte, e, pur in presenza di quell’incidente, egli continua a parlare sino a notte fonda, anzi «fino all’alba», e di tutto questo fiume di parole Luca non ha ritenuto opportuno riportare alcunché.
Poi da Troade Paolo si dirige a piedi, per altri 40 km, verso Asso, mentre alcuni discepoli lo precedono via mare. Ad Asso sale sulla loro nave, che tocca Mitilene e Samo e infine sbarca a Mileto. Paolo evita accuratamente di avvicinarsi ad Efeso, anzi da Mileto manda a chiamare gli «anziani della Chiesa» (v. 17) che si trovavano appunto in quella città, per poterli salutare prima di ripartire per Gerusalemme.
Il termine «anziani della Chiesa» o «presbiteri» qui è sicuramente eccessivo o comunque convenzionale. Si tratta semplicemente dei primi discepoli che avevano preso a seguirlo non molto tempo prima e che gli avevano dato fiducia, aiutandolo ad affrontare al meglio il pericoloso tumulto efesino. Ma non è da escludere la presenza di seguaci della prima ora, cioè del primo viaggio missionario.
L’incontro di Mileto è ufficiale: i capicomunità ci sono tutti, ma probabilmente è clandestino. Questo discorso di Paolo viene considerato dagli esegeti come una sorta di «testamento spirituale», ed è praticamente il suo terzo grande discorso.
A parte le note di commiato e le direttive pastorali, cioè i conferimenti di incarichi e responsabilità, qui si ha netta l’impressione che Paolo preferisca affrontare, piuttosto che l’ostilità giudaica di Efeso, tutte le tribolazioni possibili nella capitale Gerusalemme, come coronamento della sua missione.
Il discorso da un lato ha il sapore di un «bilancio personale» sul piano professionale: con grande perseveranza egli ha saputo predicare e istruire, in pubblico e in privato, mettendo giudei e pagani sullo stesso piano. Dall’altro però è come se l’occasione della colletta sia stata il pretesto per affermare una nuova teoria, quella secondo cui il martirio può rendere ancora più credibile la verità della sua nuova ideologia.
Sicuramente la fama di Paolo doveva essere nella capitale molto grande: forse per questa ragione egli pretendeva un confronto con le autorità giudaiche, nella speranza di ottenere un successo pieno anche sul terreno più difficile. La sua strategia in fondo è abbastanza chiara: se lui, in quanto ebreo, riesce a convincere le autorità giudaiche, forte dei successi ottenuti nei suoi viaggi missionari, allora c’è ancora un futuro per il giudaismo; in caso contrario il successo della predicazione è assicurato sul versante pagano, specie se la conclusione di questo viaggio sarà tragica.
Considerando infatti ch’egli rischiava d’essere ucciso in qualunque città vi fossero ebrei della diaspora, gli sarà parso politicamente più conveniente esserlo direttamente nella capitale. Qui non si deve dimenticare che avendo egli rifiutata la necessità di una rivoluzione politica antiromana, e non avendo nel contempo rinunciato all’esigenza di restare sulla cresta dell’onda, l’idea di un martirio personale finiva inevitabilmente coll’apparirgli una soluzione ottimale per la diffusione della sua nuova ideologia.
Per un incarico amministrativo come quello di consegnare i fondi raccolti, Paolo avrebbe potuto mandare un discepolo di fiducia, e continuare la predicazione in nuovi territori; invece qui le sue parole tradiscono un certo egocentrismo, poiché è come s’egli si fosse reso conto che, potendo ora la sua ideologia essere portata avanti da altri, che l’avevano ben assimilata, a lui non restava altra alternativa che quella di compiere l’ultimo gesto eclatante, in modo da lasciare un segno indelebile, all’altezza della sua grande personalità, che certo non avrebbe accettato di ritirarsi a vita privata.
Curiosamente, proprio a Gerusalemme egli penserà che sarebbe stato meglio morire a Roma, o comunque andare a predicare a Roma e poi eventualmente in Spagna (Rm 15,24 s.). Il che fa pensare che una frase altisonante come questa: «Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio» (v. 25), se non è interpolata, sia stata detta probabilmente soltanto per tenere unita la comunità dopo la sua partenza.
Dal v. 25 al 31 il discorso non è più di commiato ma pastorale. D’ora in poi – egli afferma – la responsabilità della missione, con le sue vittorie e le sue sconfitte, spetterà agli anziani, qui chiamati col termine di «vescovi», e alle comunità d’Asia, evangelizzate sin dal primo viaggio.
È come se affidasse loro un nuovo compito (politico): quello di autogovernarsi, non, beninteso, per costruire un «regno di Davide» (alla maniera ebraica), ma semplicemente per edificare la «Chiesa di Dio». Gli anziani sono tra loro tutti uguali, in quanto la direzione dovrà essere collegiale (da notare l’espressione democratica: «in mezzo al gregge»). Paolo rifiutava qualunque privilegio o favoritismo, qualunque primato d’onore o giurisdizionale; qui non usa l’espressione «io vi ho posti», ma «lo Spirito santo vi ha posti», lasciando così credere che la sua missione andava oltre la sua persona.
Dall’alto della sua grandissima esperienza di predicatore, egli può anche facilmente prevedere che le sue comunità dovranno affrontare seri problemi di coerenza ideologica, che potranno comportare anche traumatiche divisioni, nei confronti delle quali però egli precisa che non esistono altri strumenti che la vigilanza, su di sé e sugli altri, e l’esortazione, orale e gestuale («fra le lacrime»).
Gli ultimi versetti riguardano le questioni socioeconomiche. «Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno» (v. 33), dice con una punta d’orgoglio, mostrando di non aver mai approfittato dei successi della propria attività per ottenere vantaggi materiali personali.
Il benessere delle comunità dipenderà dalla diffusione del vangelo, ma dovrà essere un benessere nella modestia, nella sobrietà, nella essenzialità: quindi no ai privilegi di casta, alle differenziazioni sociali, alle discriminazioni di classe.
Sembra di sentir parlare un comunista ante litteram. Qui vi sono straordinarie anticipazioni dell’importanza del lavoro personale e quotidiano, del rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui (almeno all’interno della comunità), del parassitismo e della rendita.
Sappiamo tuttavia che Paolo non vedeva nel rapporto padrone/schiavo un rapporto oggettivo di sfruttamento, ma solo una prova da superare per lo schiavo, che in questo modo veniva ad assomigliare al Cristo.
D’altra parte egli non ha mai avuto un progetto politico di liberazione: qui la richiesta di praticare l’assistenza sociale, la carità pubblica, il soccorso dei poveri non è altro che un’esortazione morale alla comunione dei beni, quindi in sostanza alla comunione dei beni superflui o non strettamente necessari.
Il temine «deboli», usato al v. 35, indica astrattamente i «poveri», senza alcuna precisazione sociologica. Paolo non individua negli schiavi o nei liberi rovinati dai debiti o nelle categorie sociali più a rischio di pauperizzazione i soggetti del cristianesimo, quanto piuttosto l’oggetto di attenzioni, che avrebbero dovuto essere benevoli, da parte di ceti che marginali non erano.
I versetti 36-38 sono molto toccanti e commoventi, sicuramente molto in contrasto con la figura di Saulo ex persecutore dei cristiani.
torna suCap. 21
[1]Appena
ci fummo separati da loro, salpammo e per la via diretta giungemmo a
Cos, il giorno seguente a Rodi e di qui a Patara.
[2]Trovata qui
una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo e
prendemmo il largo.
[3]Giunti in
vista di Cipro, ce la lasciammo a sinistra e, continuando a navigare
verso la Siria, giungemmo a Tiro, dove la nave doveva scaricare.
[4]Avendo
ritrovati i discepoli, rimanemmo colà una settimana, ed essi,
mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme.
[5]Ma quando
furon passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio,
accompagnati da tutti loro con le mogli e i figli sin fuori della
città. Inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo
a vicenda;
[6]noi
salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case.
[7]Terminata la
navigazione, da Tiro approdammo a Tolemaide, dove andammo a salutare
i fratelli e restammo un giorno con loro.
[8]Ripartiti il giorno
seguente, giungemmo a Cesarea; ed entrati nella casa dell’evangelista
Filippo, che era uno dei Sette, sostammo presso di lui.
[9]Egli aveva
quattro figlie nubili, che avevano il dono della profezia.
[10]Eravamo qui
da alcuni giorni, quando giunse dalla Giudea un profeta di nome
Agabo.
[11]Egli
venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e
le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo: l’uomo a
cui appartiene questa cintura sarà legato così dai
Giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei
pagani».
[12]All’udir
queste cose, noi e quelli del luogo pregammo Paolo di non andare più
a Gerusalemme.
[13]Ma Paolo
rispose: «Perché fate così, continuando a
piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a esser
legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù».
[14]E poiché
non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: «Sia
fatta la volontà del Signore!».
[15]Dopo questi
giorni, fatti i preparativi, salimmo verso Gerusalemme.
[16]Vennero con
noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero da un
certo Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora, dal quale
ricevemmo ospitalità.
[17]Arrivati a Gerusalemme, i
fratelli ci accolsero festosamente.
[18]L’indomani
Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi: c’erano anche
tutti gli anziani.
[19]Dopo aver
rivolto loro il saluto, egli cominciò a esporre nei
particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo
suo.
[20]Quand’ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio;
quindi dissero a Paolo: «Tu vedi, o fratello, quante migliaia
di Giudei sono venuti alla fede e tutti sono gelosamente attaccati
alla legge.
[21]Ora
hanno sentito dire di te che vai insegnando a tutti i Giudei sparsi
tra i pagani che abbandonino Mosè, dicendo di non circoncidere
più i loro figli e di non seguire più le nostre
consuetudini.
[22]Che
facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato.
[23]Fa’
dunque quanto ti diciamo: vi sono fra noi quattro uomini che hanno un
voto da sciogliere.
[24]Prendili con
te, compi la purificazione insieme con loro e paga tu la spesa per
loro perché possano radersi il capo. Così tutti
verranno a sapere che non c’è nulla di vero in ciò
di cui sono stati informati, ma che invece anche tu ti comporti bene
osservando la legge.
[25]Quanto ai pagani che sono venuti alla
fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo loro scritto che si astengano
dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato
e dalla impudicizia».
[26]Allora Paolo prese con sé
quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con loro la
purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento
dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata
l’offerta per ciascuno di loro.
[27]Stavano ormai per finire
i sette giorni, quando i Giudei della provincia d’Asia, vistolo
nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui
gridando:
[28]«Uomini
d’Israele, aiuto! Questo è l’uomo che va
insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e
contro questo luogo; ora ha introdotto perfino dei Greci nel tempio e
ha profanato il luogo santo!».
[29]Avevano
infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la
città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel
tempio.
[30]Allora
tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse da ogni
parte. Impadronitisi di Paolo, lo trascinarono fuori del tempio e
subito furono chiuse le porte.
[31]Stavano già
cercando di ucciderlo, quando fu riferito al tribuno della coorte che
tutta Gerusalemme era in rivolta.
[32]Immediatamente egli prese
con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò
verso i rivoltosi. Alla vista del tribuno e dei soldati, cessarono di
percuotere Paolo.
[33]Allora il tribuno si avvicinò, lo
arrestò e ordinò che fosse legato con due catene;
intanto s’informava chi fosse e che cosa avesse fatto.
[34]Tra la folla
però chi diceva una cosa, chi un’altra.
Nell’impossibilità di accertare la realtà dei
fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella
fortezza.
[35]Quando fu
alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati a causa
della violenza della folla.
[36]La massa
della gente infatti veniva dietro, urlando: «A morte!».
[37]Sul
punto di esser condotto nella fortezza, Paolo disse al tribuno:
«Posso dirti una parola?». «Conosci il greco?,
disse quello,
[38]Allora non
sei quell’Egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e
condotto nel deserto i quattromila ribelli?».
[39]Rispose
Paolo: «Io sono un Giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una
città non certo senza importanza. Ma ti prego, lascia che
rivolga la parola a questa gente».
[40]Avendo egli
acconsentito, Paolo, stando in piedi sui gradini, fece cenno con la
mano al popolo e, fattosi un grande silenzio, rivolse loro la parola
in ebraico dicendo:
*
Paolo e gli altri discepoli, tra cui Luca, lasciata Mileto, riprendono la via del mare, toccando Cos, Rodi, Patara: qui trovano una nave per la Siria. A Cipro, una delle mete del primo viaggio, non si fermano.
Approdati a Tiro, ove la nave doveva scaricare, vi restano una settimana e alcuni discepoli, della cui comunità s’ignora l’origine, consigliano Paolo di non andare a Gerusalemme, perché avrebbe rischiato di morire. Che non siano gli stessi discepoli della partenza è chiaro laddove si parla di «mogli e figli» (v. 5); sappiamo però che già ai tempi della persecuzione contro Stefano si erano rifugiati in Fenicia (l’odierno Libano) alcuni ellenisti che sicuramente conoscevano Paolo, visto che quando si chiamava Saulo era stato l’artefice di quella persecuzione (cfr 11,19).
Qui Luca cerca di essere un po’ ambiguo proprio a motivo dei trascorsi di Paolo, per cui si limita a dire, molto genericamente, che avevano «ritrovato i discepoli» (v. 4).
Il consiglio dato a Paolo era stato «mosso dallo Spirito» (v. 4) – scrive Luca – cioè era stato dato in buona fede e non per misurare il suo livello di coraggio, anche se non è da escludere che su Paolo già pendesse un mandato di cattura da parte del Sinedrio, forse non ancora formalizzato ufficialmente; qui comunque Luca, avendo prima sostenuto la tesi che Paolo cercava il martirio, «in nome dello Spirito», non può ora sostenere il contrario, e cioè che il consiglio di non recarsi a Gerusalemme era mosso da uno spirito diverso. Lo «Spirito» è uno solo, solo che mentre a Paolo consiglia di cercare il martirio, ai discepoli, che ignorano le motivazioni recondite dell’apostolo, consiglia la prudenza. Paolo in realtà aveva già preso la sua decisione e non avrebbero potuto far nulla per trattenerlo: la loro convinzione era che lui sarebbe sicuramente morto.
Ripresa la navigazione, arrivano a Tolemaide, poi a Cesarea, ove incontrano un personaggio autorevole, Filippo, uno dei sette diaconi, qui chiamato con l’appellativo di «evangelista», cioè di «predicatore del vangelo», il che forse riflette una certa rivalità tra «apostoli» ed «ellenisti», essendo quest’ultimi culturalmente più ebrei di quello che l’appellativo lasci pensare.
Il termine «apostolo» indicava semplicemente un predicatore mandato in missione in un determinato luogo, per un tempo circoscritto, e a tale compito Paolo assegnava chiunque meritasse la sua fiducia, indipendentemente dall’origine etnica, tribale o religiosa.
L’uso di questo termine era in palese contrasto con quello voluto dai Dodici, i quali si ritenevano «apostoli» (loro che un tempo erano stati dei «nazareni») in quanto seguaci diretti del Cristo e nel contempo ideatori della tesi della resurrezione o della «morte necessaria», mentre tutti gli altri erano discepoli per così dire di seconda mano, fossero essi giudei, galilei o ellenisti, dunque discepoli che svolgevano funzioni di evangelizzazione o di servizio amministrativo, come p. es. i diaconi, e che, in ogni caso, dovevano rendere conto del loro operato ai Dodici, almeno finché anche questa struttura rimase in piedi. Paolo rivendicò per sé il titolo di «tredicesimo apostolo» e non avrebbe certo accettato un ruolo subordinato a quello dei Dodici.
Qui, nonostante Filippo sia una persona di rilievo, non è presente alcun dialogo tra i due, probabilmente a motivo del fatto che Filippo, già seguace di Stefano, difficilmente avrebbe accettato di diventare un «apostolo» di Paolo, anche se le loro ideologie avevano molti aspetti in comune.
Luca si limita a precisare che Filippo era sposato, padre di quattro figlie, e che queste «avevano il dono della profezia» (v. 9): una notizia che sembra buttata lì, senza apparenti conseguenze sull’economia della narrazione. In realtà se da un lato è molto probabile che la comunità locale, di origine appunto ellenistica, riconoscesse a queste ragazze una qualche capacità sacerdotale, dall’altro è molto difficile credere che un giudeo ortodosso, soggetto, per tradizione, a un certo maschilismo, avrebbe potuto accettare una funzione del genere, e noi sappiamo che su questo anche Paolo non la pensava diversamente (1Cor 14,34).
La cosa più curiosa di questo dissidio, qui molto velato, tra i seguaci di Paolo e quelli di Filippo, è testimoniata dall’arrivo a Cesarea «di un profeta di nome Agabo», proveniente dalla Giudea (v. 10), il quale dice a Paolo una cosa che avrebbero potuto dire le figlie di Filippo e sicuramente anche quest’ultimo, il quale, per poterla dire, non aveva certo bisogno d’uno «spirito di profezia» analogo a quello di Agabo.
Peraltro la suddetta profezia non rispecchierà affatto l’andamento delle cose nella capitale, in quanto non saranno i giudei a consegnare Paolo ai romani, ma saranno questi a impedire ai giudei di linciarlo. La profezia di Agabo assomiglia troppo da vicino a quanto accaduto al Cristo, per essere minimamente credibile. Qui è evidente che i redattori ambiscono a porre Cristo e Paolo sullo stesso piano.
Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra i due leader: Cristo non voleva morire. Il suo autosacrificio sul Getsemani ebbe come scopo quello di salvare la vita ai suoi seguaci, nella speranza che costoro avrebbero potuto successivamente liberarlo. Paolo invece cerca il martirio come una forma di testimonianza della verità e forse anche per riscattarsi dai molti delitti compiuti in gioventù.
Poco prima di arrivare a Gerusalemme, pernottano da un certo «Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora» (v. 16), di cui non sappiamo nulla se non che era di origine ellenica. Forse qui Luca, testimone oculare, ha voluto citarlo per far notare le diverse forme d’accoglienza che caratterizzarono il viaggio di Paolo: p. es. quella di Gerusalemme, da parte dei cristiani, fu sicuramente più «festosa» (v. 17) di quella di Giasone.
Tra i «fratelli» che li accolgono festosamente non pare ci fossero anche i capi della comunità cristiana, il principale dei quali è Giacomo il Minore (sostituto di Pietro), se è vero che Luca scrive che solo il giorno dopo Paolo e i suoi seguaci fecero loro visita (v. 18). Si può infatti pensare che i vertici della comunità, per ragioni diplomatiche, non amassero mettere in mostra relazioni di fiducia o di stretta collaborazione con Paolo. L’incontro è comunque ufficiale, poiché vi sono anche tutti gli «anziani», anche se pare avere un carattere clandestino, stando a quanto detto al v. 22: «senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato».
Paolo espone le vicende più significative dei suoi viaggi, in particolare racconta quello che «Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo suo» (v. 19), cioè da un lato sta attento a non prendersi dei meriti personali, dall’altro a non mostrare che aveva disobbedito alla direttiva conciliare di non predicare tra gli ebrei della diaspora.
Curiosamente, invece di esaltarsi dei successi ottenuti nel mondo pagano, i capi della comunità gli fanno capire che anche loro hanno ottenuto molti successi tra i giudei, i quali restano «gelosamente attaccati alla legge» (v. 20), quella legge a cui Paolo nega qualunque valore ai fini della salvezza. Non dev’essere stato molto piacevole, da parte di Paolo, che aveva rischiato di morire più volte in nome del vangelo, ascoltare un’accusa come questa: «vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani che abbandonino Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le nostre consuetudini» (v. 21).
È insomma evidente che la sua presenza nella città santa non era molto gradita alle autorità cristiane, e anche se i giudizi espressi su di lui, da parte dei partiti avversari, potevano essere volutamente esagerati, restava a suo carico l’onere di dimostrare che si trattava soltanto di calunnie. Di qui la proposta di eseguire, insieme ad altri quattro fedeli, sostenendone tutte le spese, un rito giudaico (il nazireato), cui lo stesso Paolo s’era già sottoposto anni prima (18,18). In questo modo avrebbe dimostrato di essere ancora fedele alla legge.
In pratica Giacomo lo mette sull’avviso: o smetteva di predicare qualsivoglia cosa contro le tradizioni ebraiche o veniva espulso dalla comunità cristiana. Paolo, obtorto collo, accetta, intenzionato com’era a concludere a Gerusalemme la sua esistenza, ma è probabile che abbia cominciato a pentirsi dell’idea di morire martire, visto che i leader cristiani non riuscivano ad apprezzare minimamente i suoi successi ottenuti tra i pagani, i quali peraltro avevano contribuito, non meno degli ebrei della diaspora, a fornirgli la colletta per le esigenze della stessa comunità di Gerusalemme.
Da notare che Giacomo ribadisce anche, recisamente, tutte le decisioni conciliari prese nei confronti della richiesta paolina di predicare ai gentili: «Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo loro scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalla impudicizia» (v. 25). Come si può notare, nei confronti di queste riserve morali e rituali l’atteggiamento dei giudeo-cristiani non era mutato d’una virgola, per cui se da un lato si permetteva a Paolo di continuare a predicare tra i pagani, dall’altro gli si vietava di considerare i pagani uguali agli ebrei. Paolo non è altro che un apostolo scomodo, che nell’ambito della comunità cristiana di Gerusalemme non avrebbe mai potuto avere un ruolo di prestigio. Non solo, ma se avesse continuato a diffondere le proprie idee nella capitale, la comunità non avrebbe fatto nulla per aiutarlo.
Qui però bisogna fare una precisazione, altrimenti rischiamo di assumere un atteggiamento di difesa ad oltranza delle posizioni paoline. Gli ebrei cristiani di Gerusalemme, finché questa non venne distrutta dalle legioni di Vespasiano e poi di Tito, si comportarono da un lato come dei nazionalisti, mentre Paolo, dopo la sua conversione, aveva smesso di esserlo, e dall’altro come dei moderati, tanto quanto Paolo, solo che mentre questi lo era più nei confronti di Roma che non nei confronti dei giudei, per quelli invece era il contrario, poiché non davano per scontato che la liberazione politico-nazionale della Palestina non sarebbe mai avvenuta e che anzi fosse un obiettivo del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione dell’ideologia cristiana.
Si badi, qui non si è in presenza di uno scontro tra un’ideologia rivoluzionaria e una riformista, ma tra due ideologie politicamente riformiste, di cui però quella paolina, situandosi sulla scia degli ellenisti, di Stefano e di altri ebrei della diaspora, giungeva a posizioni radicali nei confronti del giudaismo, che gli stessi ellenisti non avrebbero facilmente condiviso, per cui, a conti fatti, Paolo rappresenta qui una posizione culturalmente più avanzata, anche se politicamente rinunciataria.
L’idea petrina della «morte necessaria», ovvero della resurrezione del Cristo, era stata interpretata in due modi opposti: per Paolo si trattava di rinunciare a qualunque rivendicazione di tipo politico; per i giudeo-cristiani si trattava di attendere tempi migliori.
Il caso ha voluto che proprio la proposta di Giacomo abbia messo Paolo in una situazione molto pericolosa. Infatti «stavano ormai per finire i sette giorni, quando i giudei della provincia d’Asia, vistolo nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando: Questo è l’uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo; ora ha introdotto perfino dei greci nel tempio e ha profanato il luogo santo!» (vv. 27-28).
Questi giudei, arrivati a Gerusalemme per festeggiare la Pentecoste, risultano anche qui, come già in 6,9 e 14,19, tra i più fanatici e intolleranti incontrati da Paolo nei suoi viaggi nella provincia d’Asia, regione dell’odierna Turchia. Le accuse ch’essi muovono sono quelle d’essere antinazionalista, antilegalista, antireligioso, insomma un vero e proprio eretico e profanatore del tempio, un destabilizzatore del mondo giudaico nel suo complesso.
Il pretesto per questa sfilza di accuse gravissime viene chiarito da Luca al v. 29: «Avevano veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel tempio». Evidentemente questi ebrei conoscevano Paolo di persona e non solo di fama: per loro è un gioco da ragazzi trovare il modo di metterlo alle corde.
Infatti «tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse da ogni parte. Impadronitisi di Paolo, lo trascinarono fuori del tempio e subito furono chiuse le porte» (v. 30). Forse Luca esagera quando parla di «tutta la città in subbuglio», ma è indubbio che manifestazioni del genere spesso accadevano proprio in occasioni delle grandi feste ebraiche, in cui era facile trovarsi in tanti, uniti contro la guarnigione romana di stanza presso la fortezza Antonia.
Qui, al sentire che in città vi sono dei giudei traditori, filo-romani, che hanno addirittura il coraggio di violare la sacralità del tempio, è motivo più che sufficiente per scatenare una piccola rivolta, per scaricare su qualcuno, con un linciaggio improvvisato, tutte le frustrazioni che il nemico pagano fa pesare da troppo tempo sulla Palestina.
«Stavano già cercando di ucciderlo, quando fu riferito al tribuno della coorte che tutta Gerusalemme era in rivolta» (v. 31). Anche qui a Luca non sarà parso vero di poter scrivere che «tutta la città» era contro Paolo, che altro non desiderava che una fine gloriosa da martire.
Chi avrà informato il tribuno Claudio Lisia (23,26)? I seguaci di Paolo o gli stessi soldati romani? Perché intervenire se la manifestazione non era esplicitamente contro Roma?
È probabile che il tribuno sia intervenuto proprio perché non si rendeva conto di quel che stava succedendo: se si fosse trattato di un’esecuzione per motivi religiosi, probabilmente avrebbe lasciato correre, anche se di un’iniziativa del genere avrebbe dovuto essere preventivamente avvisato. Suo compito era quello di garantire l’ordine pubblico, per cui non poteva rischiare che un linciaggio si trasformasse, col concorso delle masse, in qualcosa di politicamente eversivo. Egli pertanto è costretto a intervenire, a titolo precauzionale, e a tale scopo gli bastano «dei soldati» (v. 32) e non l’intera coorte (circa 600 militari), benché Luca parli di «centurioni» al plurale, quindi di almeno un paio: il che potrebbe far pensare a due manipoli di 100 soldati ciascuno. D’altra parte avrebbe avuto poco senso far intervenire pochi militari in presenza di un subbuglio in cui, stando a Luca, buona parte della città era coinvolta.
«Allora il tribuno si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con due catene; intanto s’informava chi fosse e che cosa avesse fatto» (v. 33). Non riuscendo però a capirci nulla, perché evidentemente alcuni testimoniavano contro Paolo, altri a favore, preferisce portarlo direttamente nella fortezza Antonia, dove l’avrebbe interrogato di persona. È però indubbio che fossero molti di più quelli che volevano Paolo morto: son proprio questi che seguono i militari continuando a imprecare e inveire.
L’atmosfera doveva essere sicuramente molto calda: la guarnigione romana non si sentiva sicura e temeva che qualunque pretesto potesse diventare occasione per far scoppiare tumulti o sommosse. Il tribuno non era in grado di parlare alla folla, poiché non conosceva l’ebraico o l’aramaico, e quando sente che Paolo parlava perfettamente il greco rimane stupito, perché s’era ormai convinto di aver a che fare con l’ennesimo ebreo agitatore di folle: l’aveva addirittura scambiato per l’egiziano Ben-Stadà che nel 54 aveva sobillato a Gerusalemme quattromila nazionalisti, conducendoli nel deserto per combattere i romani (v. 38) e che, evidentemente, non parlava greco ma solo ebraico.
Se però così fosse stato, il testo non ci aiuta a capire il motivo del linciaggio. Qui infatti la folla ce l’ha con Paolo perché, stando alla sua predicazione, gli ebrei non avrebbero avuto alcuna speranza di liberarsi dal giogo dello straniero. Se davvero fosse stato un terrorista, perché preoccuparsi del linciaggio; e se fosse stato un rivoluzionario, perché la folla gli era così ostile?
Quando poi il tribuno sente da Paolo che questi parlava indifferentemente ebraico e greco e che voleva rivolgersi alla folla in ebraico per poterla calmare, non può far altro che acconsentire, nella speranza che tutto si risolva pacificamente.
La descrizione di Luca è così dettagliata che lui pare esserne stato testimone: sembra quasi di vedere quei volti ammutolirsi improvvisamente, con gli sguardi alzati verso un uomo che dalla scalinata della fortezza, dopo essere riuscito a ottenere il consenso di parlare da parte del tribuno, aveva chiesto il silenzio con un gesto che gli ebrei conoscevano bene e che si accingeva a parlare con tutta la sicurezza e l’autorità di cui era capace.
torna suCap. 22
[1]«Fratelli
e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi».
[2]Quando
sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora
di più.
[3]Ed egli
continuò: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia,
ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele
nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per
Dio, come oggi siete tutti voi.
[4]Io
perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in
prigione uomini e donne,
[5]come può
darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli
anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e
partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a
Gerusalemme, per essere puniti.
[6]Mentre ero in viaggio e mi
avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una
gran luce dal cielo rifulse attorno a me;
[7]caddi a terra
e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?
[8]Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù
il Nazareno, che tu perseguiti.
[9]Quelli che
erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava.
[10]Io dissi
allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e
prosegui verso Damasco; là sarai informato di tutto ciò
che è stabilito che tu faccia.
[11]E poiché non ci
vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per
mano dai miei compagni, giunsi a Damasco.
[12]Un certo Anania, un
devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i
Giudei colà residenti,
[13]venne da me, mi si accostò
e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in quell’istante io
guardai verso di lui e riebbi la vista.
[14]Egli soggiunse: Il Dio
dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà,
a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca,
[15]perché
gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai
visto e udito.
[16]E ora perché
aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati,
invocando il suo nome.
[17]Dopo il mio ritorno a Gerusalemme,
mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi
[18]e vidi Lui
che mi diceva: Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché
non accetteranno la tua testimonianza su di me.
[19]E io dissi:
Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nella
sinagoga quelli che credevano in te;
[20]quando si versava il
sangue di Stefano, tuo testimone, anch’io ero presente e
approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano.
[21]Allora mi
disse: Va’, perché io ti manderò lontano, tra i
pagani».
[22]Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo,
ma allora alzarono la voce gridando: «Toglilo di mezzo; non
deve più vivere!».
[23]E poiché continuavano a
urlare, a gettar via i mantelli e a lanciar polvere in aria,
[24]il tribuno
ordinò di portarlo nella fortezza, prescrivendo di
interrogarlo a colpi di flagello al fine di sapere per quale motivo
gli gridavano contro in tal modo.
[25]Ma quando l’ebbero
legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava
accanto: «Potete voi flagellare un cittadino romano, non ancora
giudicato?».
[26]Udito ciò,
il centurione corse a riferire al tribuno: «Che cosa stai per
fare? Quell’uomo è un romano!».
[27]Allora il
tribuno si recò da Paolo e gli domandò: «Dimmi,
tu sei cittadino romano?». Rispose: «Sì».
[28]Replicò
il tribuno: «Io questa cittadinanza l’ho acquistata a
caro prezzo». Paolo disse: «Io, invece, lo sono di
nascita!».
[29]E subito si
allontanarono da lui quelli che dovevano interrogarlo. Anche il
tribuno ebbe paura, rendendosi conto che Paolo era cittadino romano e
che lui lo aveva messo in catene.
[30]Il giorno seguente, volendo
conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui
veniva accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò
che si riunissero i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio; vi fece
condurre Paolo e lo presentò davanti a loro.
*
Il fatto che sentendo parlare Paolo in perfetta lingua ebraica la folla si sentisse indotta a fare ancora più silenzio, sta forse ad indicare che l’uso dell’ebraico stava ormai diventando obsoleto anche per un ebreo, specie se ellenista o residente fuori della Giudea. La lingua dominante, allora, era il greco e anche il latino si stava imponendo.
Paolo a Gerusalemme era noto quando si chiamava Saulo, il fariseo persecutore dei cristiani, che conosceva sì il greco ma che parlava soprattutto ebraico. Ora, di fronte a loro, c’è una persona molto diversa. Paolo deve precisare per filo e per segno tutti i suoi estremi anagrafici e tutto il suo iter formativo e politico-professionale, poiché stentano letteralmente a riconoscerlo. E in tal senso è abbastanza strano ch’egli invochi, a testimonianza di ciò che dice, le figure del «sommo sacerdote» (Caifa, deposto nel 37) e del «collegio degli anziani» (v. 5), come se queste fossero le stesse del momento in cui stava parlando.
Vediamo una sua breve biografia. Paolo nacque tra il 5 e il 15 a Tarso, capitale della Cilicia (attuale Turchia), da genitori ebrei (discendenti della tribù di Beniamino) di osservanza farisaica. Metropoli cosmopolita, Tarso era, insieme ad Antiochia, un coacervo di tutte le credenze e le superstizioni dell’epoca. Educato e istruito nell’osservanza della legge ebraica, la Torah scritta e orale, egli imparò a parlare correntemente sia il greco che la lingua ebraico-aramaica, ed ebbe una formazione culturale aperta agli influssi della cultura ellenistica. Aveva la cittadinanza di Tarso e quella romana, di mestiere era tessitore di tende (molto probabilmente su commesse militari romane).
Doveva essere dotato di una grande resistenza psico-fisica, poiché superò innumerevoli avversità: veglie, digiuni, freddo, migliaia di chilometri percorsi a piedi, tre naufragi, una lapidazione, flagellato cinque volte dagli ebrei e vergato tre volte dai romani, imprigionato per lunghi periodi..., stando a quanto dicono non solo gli Atti, ma anche le sue Lettere, dove però le esagerazioni non mancano mai. Era dotato d’intelligenza acuta e di una certa capacità oratoria, se è vero che nel primo viaggio alcuni pagani vollero addirittura adorarlo, avendolo creduto un dio (Hermes-Mercurio) per il modo in cui parlava.
Egli giunse a Gerusalemme dopo la morte di Gesù e qui fu discepolo di Gamaliele, capo di una corrente abbastanza liberale, ma non per questo priva di elementi integralistici e nazionalistici. Dati i suoi studi rabbinici o data la sua educazione o per entrambi i motivi egli divenne ciò che, con le sue stesse parole, può esser detto un rigido fariseo. Prese parte alla lapidazione di Stefano e divenne un agente del Sinedrio di Gerusalemme nelle persecuzioni contro i cristiani.
Intorno al 34, proprio nel pieno della sua attività anticristiana, improvvisamente, sulla via di Damasco, vive un’esperienza traumatica che lo porta a rivedere la sua ideologia e a convertirsi, progressivamente, al cristianesimo. Vive per tre anni in Arabia, probabilmente nel regno dei Nabatei, come per farsi dimenticare.
Al suo ritorno cominciò a predicare «Gesù risorto» a Damasco, apertamente, ai Giudei, dai quali incontrò ogni sorta di ostacoli. Dopo la fuga da Damasco va a Gerusalemme, ma senza essere accolto favorevolmente tra i cristiani (incontra però Pietro nel 37), poi ritorna, per pochi anni, nella sua città natale.
Lo andò a prendere Barnaba e lo portò con sé ad Antiochia, procurandogli una posizione di maestro nella chiesa locale. Come compagno di Barnaba fu mandato a Gerusalemme con un’offerta in denaro a favore della comunità locale. Dopo il ritorno ad Antiochia, a Barnaba e Paolo fu concesso dalla Chiesa di Antiochia di predicare il vangelo dove non era stato ancora predicato.
Durante il primo viaggio missionario (45-48) Paolo ebbe con sé Barnaba a Cipro, Perge, Antiochia di Pisidia, Licaonia. Il loro metodo era di predicare prima nelle sinagoghe delle città e di rivolgersi ai gentili solo quando i giudei rifiutavano il loro messaggio. Fu violenta l’ostilità mostrata dagli ebrei della Licaonia. Alla fine del primo viaggio maturò la controversia riguardante l’obbligo per i gentili di osservare la legge. La dottrina di Paolo, che non imponeva ai gentili gli obblighi del giudaismo, fu in parte accettata dalla Chiesa di Gerusalemme.
Il secondo viaggio (49-52) fu intrapreso poco dopo il ritorno di Paolo e Barnaba ad Antiochia. L’inizio del viaggio fu guastato dal dissidio tra Paolo e Barnaba a proposito di Marco (l’evangelista), che fu sostituito da Sila. Il secondo viaggio fu il più importante dei tre; dopo essere passato attraverso la Cilicia, la Licaonia, la Frigia e la Galazia, Paolo predicò per la prima volta nel continente europeo. Il suo forzato ritiro da Berea fu all’origine della sua presenza in Atene, dove il suo discorso all’Areopago fece un’impressione molto superficiale. Da Atene si recò a Corinto, dove incontrò Priscilla a Aquila. L’ostilità degli ebrei fu neutralizzata dall’indifferenza di Gallione e, durante un soggiorno di due anni, Paolo fondò la più importante delle sue chiese.
Il terzo viaggio (53-58) fu iniziato dopo un breve ritorno ad Antiochia. Paolo visitò la Frigia e la Galizia, ma la maggior parte del viaggio fu impiegata nella fondazione della Chiesa di Efeso. La visita in Asia mise Paolo a contatto con Apollo e con altri che avevano ricevuto il battesimo da Giovanni il Battista. Il tumulto degli orefici di Efeso è il primo esempio documentato dell’ostilità verso i cristiani da parte dei gentili. I disordini della Chiesa di Corinto complicarono i suoi piani di viaggio. Scrisse da Efeso la sua prima Lettera ai Corinzi, quindi raggiunse la Macedonia dove scrisse la seconda. Dopo questo viaggio non ritornò ad Antiochia, ma raggiunse Gerusalemme, via Tiro.
Poi vedremo che, dopo l’arresto da parte del presidio romano di Gerusalemme, verrà inviato, sotto scorta, a Cesarea, dal nuovo governatore Festo, e qui tenuto prigioniero per due anni. Paolo, diffidente verso Festo, si appellerà al tribunale dell’imperatore e sarà inviato a Roma. La nave su cui s’imbarcherà farà naufragio al largo della costa di Malta; scampato al naufragio l’apostolo sbarcherà a Pozzuoli nella primavera successiva. Gli Atti dicono che a Roma visse agli arresti domiciliari (60-61), ma non riferiscono nulla sull’esito del processo. In questo periodo devono essere collocate le epistole della prigionia: Filemone, Colossesi, Efesini, Filippesi. Prosciolto nel 63, secondo la tradizione, morì martire a Roma nel 67 d.C. Gli Atti – come noto – sono stati scritti non prima dell’80-90.
Clemente Romano parla di un viaggio di Paolo in Spagna, dopo la sua prigionia a Roma. Le lettere pastorali fanno pensare ad un altro viaggio ad Efeso. La sua seconda prigionia a Roma e la condanna a morte possono essere fissate prima della morte di Nerone verso il 67-68. Dal momento che era cittadino romano, la sua condanna fu eseguita mediante decapitazione.
Tutto questo per dire che l’affermazione di Paolo secondo cui possono dargli «testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani» (v. 5) circa il suo atteggiamento anticristiano, qui può avere un senso solo come motivazione che spiega la lunga assenza di Paolo dalla capitale giudaica. Egli in realtà si riferisce a personaggi che non esistono più o che sicuramente non ricoprono le funzioni del tempo cui Paolo si riferisce. Tant’è che in 23,5 dimostrerà di non conoscere neppure il sommo sacerdote in carica.
Ma qui in realtà il problema è un altro. Abbiamo già letto la descrizione della conversione di Paolo. Ora ci viene riproposta e lo sarà di nuovo più avanti. Ormai questa conversione è diventata una sorta di tema ricorrente. Vediamola in sequenza parallela.
|
Cap. 9
[3] E avvenne che, mentre era in viaggio e stava
per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una
luce dal cielo |
Cap. 22
[6] Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a
Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una gran luce dal
cielo rifulse attorno a me; |
Cap. 26
[12] In tali circostanze,
mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri
da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno |
Cosa sarà effettivamente successo sulla strada di Damasco è evidente che nessuno potrà mai saperlo, però qui si può ipotizzare che Paolo abbia sfruttato un fenomeno naturale insolito per avvolgere in un alone magico il suo travaglio interiore. Paolo fece credere a tutti d’aver avuto una visione diretta e personale del messia Gesù, al fine di dimostrare d’essere stato scelto direttamente da lui e di non aver quindi avuto bisogno di alcuna mediazione da parte dei discepoli oculari o più stretti dello stesso messia.
Ma perché egli ebbe bisogno di questa messinscena? Sentendosi ideologicamente troppo avanti rispetto ai Dodici, temeva forse che se avesse seguito l’iter naturale dell’affiliazione o della sequela ai dettami della comunità cristiana, non avrebbe mai avuto il tempo per diffondere le sue idee innovative? Oppure si rendeva conto che assai difficilmente avrebbero potuto credere, senza un «segno miracoloso», in una genuina conversione da parte di un persecutore incallito?
Indubbiamente egli sapeva che i suoi contemporanei erano superstiziosi e che sarebbero stati disposti a credere in cose paranormali. E forse lui stesso, ad un certo punto, si convinse che quello che diceva corrispondeva in qualche modo alla realtà.
Da notare che le contraddizioni fra le tre versioni sono così stridenti che chiunque sarebbe portato a negare a ognuna di loro un qualche elemento di credibilità, eppure grazie a queste versioni Paolo poté tranquillamente affermare tre principi cardine di tutta la propria teologia:
1. Cristo è il messia ed è ancora vivo in quanto risorto;
2. esiste chiaramente una dimensione ultraterrena, in cui Cristo è Signore;
3. è sufficiente credere in questo per essere salvi.
Se si accettano questi tre punti, ogni aporia nelle tre versioni della conversione risulterà del tutto irrilevante. Qui, pertanto, possono anche essere evidenziate, ma se gli autori stessi degli Atti non si sono preoccupati di garantire una certa coerenza, significa che sapevano bene quanto fosse inutile questa operazione redazionale.
In 9,7 la scorta sente la voce ma non vede nessuno; in 22,9 e 26,14 è il contrario: vedono ma non sentono. La luce avvolge tutti in 26,13, ma in 9,3 e 22,6 avvolge solo lui. In 9,4 e 22,7 cade solo Paolo a terra; in 26,14 tutti. In 9,8 e 22,11 viene detto che Paolo restò cieco; al cap. 26 no. La voce in 26,14 parla in ebraico; negli altri capitoli non è detto. La voce del cap. 26 spiega a Paolo cosa deve fare sul piano ideologico; le voci degli altri due racconti gli spiegano soltanto cosa deve fare sul piano pratico. La frase «Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo» (26,14), che indica una vana resistenza, è un’espressione greca detta da Gesù in aramaico!
Qui è altresì evidente che Paolo non ha sfruttato solo l’occasione del fenomeno naturale inconsueto ma anche la presenza della scorta come testimone dell’evento. È facile rendersi conto come la crisi già in atto, a livello esistenziale, in Paolo, qui abbia raggiunto l’apice e come nel contempo, proprio in questo episodio, siano state poste le basi di un superamento del dramma ideo-politico della sua coscienza (ovviamente sempre nell’ambito illusorio di una qualunque soluzione di tipo religioso).
Oltre alla scorta Paolo può servirsi anche di un altro testimone della sua conversione, Anania, «un devoto osservante della legge» (v. 12), che proprio a Damasco lo aiutò a superare con coraggio il travaglio interiore, la vergogna d’essere stato un persecutore, il timore che i giudei potessero considerarlo un rinnegato.
Sul ruolo di questo Anania permane tuttavia qualche dubbio, poiché se da un lato appare del tutto naturale che Paolo avesse incontrato una persona in grado di aiutarlo, di capirlo nella sua sofferenza umana, dall’altro non si comprende bene perché qualificarlo col termine di «ottimo giudeo», visto che era già «cristiano» (e se non lo era, non si capisce come avrebbe potuto aiutare Paolo).
Stando infatti a 9,6 e 22,10 è proprio Anania che deve spiegare a Paolo come superare la crisi, è addirittura lui che gli fa recuperare la vista, cioè che, metaforicamente parlando, gli ridà fiducia e coraggio, e in 9,10 ss. egli appare chiaramente come un «cristiano», autorizzato a battezzare Paolo. Non è singolare che una figura del genere venga fatta passare per un «ottimo ebreo» al cospetto di un uditorio del tutto giudaico e che non venga neppure citata nella terza versione della conversione, quella che Paolo farà davanti al governatore Agrippa? In quest’ultima ne parla come ne avrebbe parlato Giacomo: Anania era un buon cristiano appunto perché un ottimo ebreo.
È che in realtà Paolo vuol far colpo sui giudei citando un personaggio reale, testimone della sua conversione, e però nello stesso tempo egli è sicuro che, vivendo Anania a Damasco, non sia conosciuto da nessuno dei presenti.
Peraltro è assolutamente da escludere che Anania, piuttosto scettico sulla genuinità della conversione di Paolo, come risulta in 9,13 ss., potesse addirittura spiegare a Paolo che la sua missione doveva rivolgersi ai pagani: «perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito» (v. 15). Qui Paolo racconta le cose come pensa che i giudei vogliano ascoltarle.
Infatti è come se avesse voluto dire: se Anania, che gode a Damasco «di buona reputazione presso tutti i giudei là residenti» (v. 12), è stato capace di riconoscere il mio sforzo di cambiare vita, la mia buona volontà, perché non ottengo il medesimo riconoscimento anche a Gerusalemme?
Da notare che non senza una certa astuzia Paolo evita di pronunciare il ruolo di messia che ebbe il Cristo, limitandosi a qualificarlo come «giusto» (v. 14). Non vuole scatenare le ire degli astanti, visto che non hanno ancora rinunciato all’idea di un liberatore politico-nazionale.
Evita altresì di addossare a qualcuno di loro la responsabilità della sua fuga da Gerusalemme, tre anni dopo la conversione di Damasco, chiamando in causa elementi del tutto fantastici, come l’estasi e il rapimento mistico (v. 17). Mostrando però ch’egli aveva un rapporto personale e diretto col Cristo, ch’era in grado di suggerirgli la cosa migliore da fare al momento opportuno, egli lasciava anche capire d’aver agito in assoluta autonomia rispetto alla stessa comunità cristiana.
Insomma era come arrampicarsi sugli specchi. Avrebbero potuto i giudei lì presenti accettare l’idea che di fronte a loro avevano non un esagitato o un traditore della causa ebraica, ma un uomo la cui conversione andava considerata genuina, autentica, proprio perché enormemente sofferta? Un uomo costretto ad andarsene da Gerusalemme per cause di forza maggiore, la cui missione tra i pagani andava considerata come una sorta di inevitabile conseguenza di questa dipartita?
Avrebbero forse potuto accettare ch’egli, pur avendo già capito a Damasco che doveva predicare tra i pagani, preferì prima di tutto tornare a Gerusalemme, nella speranza di ottenere un mandato molto diverso da quello ottenuto quando perseguitava i cristiani, e che da qui decise d’andar via solo dopo che vi fu costretto?
È incredibile come Paolo possa aver sperato che i giudei della capitale accettassero l’idea che pagani ed ebrei andavano messi sullo stesso piano, quando tutti gli ebrei in quel momento soffrivano della dura persecuzione romana. Qui è evidente che lo scontro si pone su un terreno eminentemente politico: Paolo sta predicando la fine dell’autonomia di Israele, la rinuncia definitiva alla lotta di liberazione nazionale.
Il tribuno, se qualcuno, in quel momento, gli stava traducendo in tempo reale il discorso di Paolo, al massimo era riuscito a capire che questi non poteva essere un sovversivo; di sicuro non aveva capito il motivo di un odio così grande da parte dei giudei, anche perché se Paolo fosse stato un importante collaborazionista di Roma, egli avrebbe pur dovuto saperne qualcosa.
La decisione di farlo frustare nasce appunto non solo dall’esigenza di accontentare folle esagitate, che ne richiedono addirittura la morte, ma anche dall’esigenza di sapere chi egli davvero sia. Paolo appare come una persona sospetta, tendenzialmente falsa.
Qui, proprio nel momento in cui Paolo sta per essere trattato come diversi anni prima era stato trattato Cristo da Pilato, scatta un meccanismo automatico, tipico di chi vorrebbe tenere il piede in due staffe. Se la folla avesse accettato il suo discorso, come sarebbe finito il racconto? La folla avrebbe dovuto accettare l’idea che la resistenza nei confronti di Roma poteva al massimo essere morale, non politica: il che non l'avrebbe certo indotta a considerare irrilevante la predicazione di Paolo ai fini della liberazione nazionale del paese. Se quindi lui aveva ragione, occorreva necessariamente rinunciare a un obiettivo del genere e il tribuno, dal canto suo, l’avrebbe rilasciato, anzi l’avrebbe addirittura ringraziato.
Ma se Paolo aveva torto, cioè se l’intera folla della capitale non aveva alcuna intenzione di seguirlo (né i giudei, perché lo ritenevano politicamente un rinnegato, né i cristiani, perché lo ritenevano troppo spregiudicato nei confronti dell’uguaglianza morale tra ebrei e pagani), allora per Paolo avrebbe avuto ancora un senso cercare di morire come Cristo? Per quale motivo non ha voluto farsi giustiziare, visto che desiderava tanto il martirio? Non è forse stato perché aveva capito che la sua morte, in quel contesto, non sarebbe servita a niente?
Egli ad un certo punto arrivò alla conclusione che sarebbe stato meglio schierarsi decisamente dalla parte del mondo pagano, sfruttando sino in fondo il privilegio della sua cittadinanza romana, acquisita per nascita: questo peraltro gli avrebbe permesso di avvicinare persone autorevoli, di prestigio, disposte anche ad ascoltarlo.
Come si può facilmente notare, col suo rifiuto di farsi flagellare, appellandosi al diritto romano, Paolo non solo rompe definitivamente col mondo giudaico, ma anche con lo stesso mondo cristiano rappresentato dalla corrente di Giacomo. Egli non vorrà avere più niente a che fare né coi giudei nazionalisti, né coi cristiani tradizionalisti.
L’idea del tribuno di convocare il Sinedrio e tutti gli anziani non gli deve essere piaciuta granché, perché sa bene che il Sinedrio lo odia non meno della folla. È comunque evidente che il tribuno teme, rilasciandolo, che il tumulto peggiori, ma è altresì evidente che, essendo Paolo cittadino romano, non può permettere che un’istituzione giudaica lo possa condannare a morte, foss’anche per i peggiori crimini religiosi.
Il tribuno vuole convocare il Sinedrio per un’istanza interlocutoria, al fine di calmare gli esagitati e forse nella speranza di capire qualcosa di più di questo controverso caso, per il quale ha cominciato a sospettare l’esistenza di motivi religiosi che per i giudei avrebbero risvolti politici, ma sa benissimo che se Paolo vorrà appellarsi a un tribunale romano, non potrà certo impedirglielo. È comunque significativo il fatto che contro Paolo il tribuno non riesca a trovare capi d’imputazione analoghi a quelli che Pilato trovò per il Cristo.
torna suCap. 23
[1]Con
lo sguardo fisso al Sinedrio Paolo disse: «Fratelli, io ho
agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di
coscienza».
[2]Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai
suoi assistenti di percuoterlo sulla bocca.
[3]Paolo allora
gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedi
a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di
percuotermi?».
[4]E i presenti
dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?».
[5]Rispose
Paolo: «Non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote;
sta scritto infatti:
Non insulterai il
capo del tuo popolo».
[6]Paolo
sapeva che nel Sinedrio una parte era di sadducei e una parte di
farisei; disse a gran voce: «Fratelli, io sono un fariseo,
figlio di farisei; io sono chiamato in giudizio a motivo della
speranza nella risurrezione dei morti».
[7]Appena egli
ebbe detto ciò, scoppiò una disputa tra i farisei e i
sadducei e l’assemblea si divise.
[8]I sadducei
infatti affermano che non c’è risurrezione, né
angeli, né spiriti; i farisei invece professano tutte queste
cose.
[9]Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del
partito dei farisei, alzatisi in piedi, protestavano dicendo: «Non
troviamo nulla di male in quest’uomo. E se uno spirito o un
angelo gli avesse parlato davvero?».
[10]La disputa
si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse
linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo
via di mezzo a loro e ricondurlo nella fortezza.
[11]La notte
seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio!
Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è
necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma».
[12]Fattosi
giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento
esecratorio di non toccare né cibo né bevanda, sino a
che non avessero ucciso Paolo.
[13]Erano più di quaranta
quelli che fecero questa congiura.
[14]Si
presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Ci
siamo obbligati con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla
sino a che non avremo ucciso Paolo.
[15]Voi dunque
ora, insieme al Sinedrio, fate dire al tribuno che ve lo riporti, col
pretesto di esaminare più attentamente il suo caso; noi
intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi».
[16]Ma
il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto; si
recò alla fortezza, entrò e ne informò Paolo.
[17]Questi
allora chiamò uno dei centurioni e gli disse: «Conduci
questo giovane dal tribuno, perché ha qualche cosa da
riferirgli».
[18]Il centurione lo prese e lo condusse dal
tribuno dicendo: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e
mi ha detto di condurre da te questo giovanetto, perché ha da
dirti qualche cosa».
[19]Il tribuno
lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che
cosa è quello che hai da riferirmi?».
[20]Rispose: «I
Giudei si sono messi d’accordo per chiederti di condurre domani
Paolo nel Sinedrio, col pretesto di informarsi più
accuratamente nei suoi riguardi.
[21]Tu però
non lasciarti convincere da loro, poiché più di
quaranta dei loro uomini hanno ordito un complotto, facendo voto con
giuramento esecratorio di non prendere cibo né bevanda finché
non l’abbiano ucciso; e ora stanno pronti, aspettando che tu
dia il tuo consenso».
[22]Il tribuno congedò il
giovanetto con questa raccomandazione: «Non dire a nessuno che
mi hai dato queste informazioni».
[23]Fece poi chiamare due
dei centurioni e disse: «Preparate duecento soldati per andare
a Cesarea insieme con settanta cavalieri e duecento lancieri, tre ore
dopo il tramonto.
[24]Siano pronte anche delle cavalcature e
fatevi montare Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal
governatore Felice».
[25]Scrisse
anche una lettera in questi termini:
[26]«Claudio
Lisia all’eccellentissimo governatore Felice,
salute.
[27]Quest’uomo è stato assalito dai Giudei e
stava per essere ucciso da loro; ma sono intervenuto con i soldati e
l’ho liberato, perché ho saputo che è cittadino
romano.
[28]Desideroso
di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro
Sinedrio.
[29]Ho
trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma
che in realtà non c’erano a suo carico imputazioni
meritevoli di morte o di prigionia.
[30]Sono stato
però informato di un complotto contro quest’uomo da
parte loro, e così l’ho mandato da te, avvertendo gli
accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui.
Sta’ bene».
[31]Secondo gli ordini ricevuti, i soldati
presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride.
[32]Il mattino
dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne
tornarono alla fortezza.
[33]I cavalieri,
giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli
presentarono Paolo.
[34]Dopo averla
letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che
era della Cilicia, disse:
[35]«Ti
ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori». E
diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode.
*
Poter parlare davanti a un’assise così significativa per Paolo può essere stato un motivo d’orgoglio, ma lui sa bene che faranno di tutto per non farlo parlare: il Sinedrio non è l’Areopago, dove intellettuali sfaccendati amavano disquisire su tutto e dove l’avevano ascoltato per mera curiosità; sommi sacerdoti e anziani, sadducei e farisei integralisti conoscono bene Paolo e lo vorrebbero morto.
Basta vedere l’esordio: non fa neppur in tempo ad aprir bocca che il sommo sacerdote Anania9 ordina a una guardia di percuoterlo. Paolo tuttavia non è tipo da farsi impressionare più di tanto e, di fronte ai torti, reagisce alla sua maniera, salvo poi mordersi la lingua per essere stato troppo impulsivo.
D’altra parte che Paolo non credesse possibile la libera espressione delle proprie idee, in un consesso come quello, è dimostrato anche dal fatto che si presenta autovalutando il proprio operato: «ho agito davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza» (v. 1), senza aspettare che sia il Sinedrio a stabilirlo dopo un regolare dibattimento, cioè dopo aver ascoltato i fatti e interrogato l’imputato. Paolo era entrato nel Sinedrio coll’intenzione di appellarsi a Cesare, se le cose non fossero andate per il verso giusto.
Vista la situazione non gli rimane che giocare d’astuzia l’asso nella manica: cerca d’indurre il Sinedrio a esprimersi ufficialmente su un tema che da tempo i farisei volevano far diventare credo ufficiale: l’apocatastasi o resurrezione finale dei morti. Mira in sostanza a far capire che all’ordine del giorno vi era sì il suo operato, ma in rapporto a una convinzione che aveva il partito da cui egli stesso proveniva: quello farisaico, e ch’egli veniva perseguitato in quanto esponente di un partito che portava avanti un’ideologia avversata dal partito di governo.
È qui significativo il fatto che mentre di fronte al Cristo farisei e sadducei si siano trovati sostanzialmente d’accordo nel volere la sua esecuzione, al cospetto di Paolo invece si trovano divisi, come se le questioni religiose fossero per loro più gravi di quelle politiche, come se un’idea mitologica fosse più importante della liberazione della Palestina. Povero Paolo, lui ch’era andato a Gerusalemme coll’intenzione di finire come Cristo crocefisso, si ritrova a difendere gli interessi del suo vecchio partito.
È evidente ch’egli non fa alcuna paura sul piano politico: i farisei possono facilmente schierarsi dalla sua parte (anche perché lui non ha parlato di «resurrezione di Gesù» ma di «resurrezione dei morti» in generale, che sarebbe dovuta accadere alla fine dei tempi – cfr 2 Mac 7,9). Ciò che li separa è il fatto che Paolo ha tratto dall’idea di non poter realizzare nell’immediato la liberazione della Palestina le conseguenze più radicali, la prima delle quali è l’universalismo etico-spirituale a vantaggio dell’uguaglianza tra ebrei e gentili. I farisei, non meno dei cristiani seguaci di Giacomo, vogliono restare legati alle tradizioni d’Israele, proprio perché sperano che un giorno avvenga la liberazione politico-nazionale.
I sadducei sono contrari non tanto a questa visione politica delle cose, pur essendo essi noti collaborazionisti dei romani, quanto al fatto che vedono nella teoria della resurrezione qualcosa di «eretico», che potrebbe portare a ulteriori spaccature nella compagine ebraica. Il loro partito spera di conservare un certo potere e di salvaguardare il prestigio delle principali istituzioni della nazione (la prima delle quali è il tempio) attraverso le abilità diplomatiche, le mediazioni di vertice, i continui compromessi.
Ad un certo punto alcuni scribi-farisei s’alzano in piedi e fanno un ragionamento e concessis: sono disposti ad ammettere che la visione di Paolo sulla strada di Damasco possa essere stata vera, per quanto escludano trattarsi del Cristo in persona (al massimo uno «spirito» o un «angelo»).
Qui sarebbe sciocco schierarsi dalla parte di qualcuno: non è possibile infatti dar torto ai sadducei, che negavano l’esistenza di esseri sovrannaturali, capaci di interloquire con gli umani, ma è evidente che le motivazioni sottese a questo rifiuto sono per la conservazione dello status quo, e quindi dei loro privilegi di casta.
Qui l’unica cosa che merita d’essere evidenziata è il fatto che secondo i farisei Paolo non può meritare la morte solo per aver avuto una «visione». Se uno «spirito» gli aveva consigliato di andare a predicare presso i gentili un’idea sorta al tempo dei Maccabei, ciò non poteva costituire un pericolo per la nazione.
Sofismi belli e buoni. I farisei parteggiano per Paolo semplicemente perché hanno colto la palla al balzo per far sentire la loro voce in un parlamento che sempre meno li ascolta. Infatti sanno bene che la predicazione paolina è nociva agli interessi politici del paese, né potrebbe essere diversamente quando si va a predicare che il Cristo morto e risorto era il «messia» da tutti atteso.
Il dibattito – come si può facilmente notare – non era che una sorta di commedia degli equivoci e degli inganni, poiché ruotava attorno a pseudo-problemi e tutti evitavano di entrare nel merito delle cose per non far scoppiare una baraonda che, di fronte alle autorità romane (il tribuno era lì presente), avrebbe palesato tutta la pochezza del popolo ebraico e soprattutto della massima istituzione che lo rappresentava.
Non s’è mai discusso, neppure per un momento, se l’idea della resurrezione di Cristo potesse favorire od ostacolare la lotta per la liberazione nazionale. Nessuno ha il coraggio di affrontare l’argomento se la predicazione del Cristo fosse favorevole o contraria a tale liberazione. I termini della questione posti da Paolo (la teoria della «resurrezione finale dei morti») sono del tutto inutili ai fini di un affronto convincente delle problematiche più stringenti. Quanto in questo silenzio abbiano pesato le manovre redazionali degli Atti è difficile dirlo, ma lo si può immaginare.
Paolo comunque aveva ottenuto l’effetto desiderato: «La disputa si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo nella fortezza» (v. 10). Paolo infatti è cittadino romano ed è sotto la tutela del tribuno, il quale da quel dibattito convulso al massimo può aver capito che i motivi del contendere, essendo religiosi, interessavano poco Roma, anche perché non sembravano avere conseguenze politiche dirette o specifiche. Paolo non aveva mai detto di voler fare una guerra santa contro Roma, promettendo ai martiri un premio nell’aldilà.
Il tribuno ovviamente non può immaginare che proprio le idee di Paolo costituiranno per tre secoli un ostacolo insormontabile ai rapporti politici tra impero e cristianesimo, in quanto l’ideologia pagana che a partire da Augusto andrà affermandosi sarà proprio quella di attribuire all’imperatore una ben precisa deificazione.
Paolo comunque in carcere si convince ancor di più quanto sia giusta l’idea di appellarsi a Cesare, per poter andare a Roma e, se possibile, iniziare a predicare direttamente nella capitale dell’impero. Qui, ancora una volta, viene diffusa la notizia di una sua visione, probabilmente per non farlo apparire un vile. Un ebreo che si appella a Cesare per essere giudicato è ancora un ebreo?
Ormai anche il tribuno s’è convinto che Paolo sta per rinnegare definitivamente il suo passato. È talmente impaurito all’idea che i giudei vogliano eliminarlo che quando gli viene svelata una congiura di quaranta sinedriti, organizza una scorta militare incredibilmente cospicua: «Preparate duecento soldati per andare a Cesarea insieme con settanta cavalieri e duecento lancieri» (v. 23). È difficile escludere che qui non vi siano state delle manomissioni redazionali.
Più interessante è la trafila della rivelazione del complotto. Qualche esponente del Sinedrio (un fariseo?) deve aver informato la sorella di Paolo, che per non dare nell’occhio s’è servita del figlioletto, il quale, ascoltato dal tribuno, su richiesta di questo, non ha raccontato niente a nessuno, salvando da morte certa non solo Paolo ma anche la madre. Il trasferimento, avvenuto nella stessa notte, restò senza incidenti di sorta: i fanti arrivarono sino ad Antipatride e i cavalieri proseguirono sino a Cesarea, sede del procuratore della Giudea, ieri di Pilato, oggi di Antonio Felice, che vi restò in carica dal 52 al 59-60.
Il tribuno aveva praticamente scaricato sul governatore la responsabilità dell’incolumità di Paolo, essendo ben certo che la fortezza Antonia non sarebbe stata sufficiente allo scopo e che, se l’avesse lasciato libero, sarebbe stato accusato di non aver fatto tutto il possibile per salvargli la vita, senza considerare il rischio di scatenare un vespaio in tutta la città.
L’unica cosa che Felice vuol sapere è da dove provenga Paolo, per aver modo di verificare s’egli è davvero cittadino romano. Il caso, in sé, non gli interessa, perché dalla lettera di Lisia ha già capito – ed è impossibile dargli torto – che si tratta del solito ebreo fanatico della religione, ma i romani, col loro emergente culto divino della personalità imperiale, erano forse meno fanatici?
torna suCap. 24
[1]Cinque
giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Ananìa insieme
con alcuni anziani e a un avvocato di nome Tertullo e si presentarono
al governatore per accusare Paolo.
[2]Quando questi fu fatto
venire, Tertullo cominciò l’accusa dicendo:
[3]«La
lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state
in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, le accogliamo
in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda
gratitudine.
[4]Ma per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di
darci ascolto brevemente nella tua benevolenza.
[5]Abbiamo
scoperto che quest’uomo è una peste, fomenta continue
rivolte tra tutti i Giudei che sono nel mondo ed è capo della
setta dei Nazorei.
[6]Ha perfino
tentato di profanare il tempio e noi l’abbiamo arrestato e
secondo la nostra legge volevamo giudicarlo;
[7]ma il tribuno
Lisia è intervenuto, e con molta violenza lo ha tolto dalle
nostre mani,
[8]e ha ordinato ai suoi accusatori di presentarsi
davanti a te. Interrogandolo personalmente, potrai renderti conto da
lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo».
[9]Si
associarono nell’accusa anche i Giudei, affermando che i fatti
stavano così.
[10]Quando il governatore fece cenno a Paolo
di parlare, egli rispose: «So che da molti anni sei giudice di
questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia.
[11]Tu stesso
puoi accertare che non sono più di dodici giorni da quando mi
sono recato a Gerusalemme per il culto.
[12]Essi non mi
hanno mai trovato nel tempio a discutere con qualcuno o a incitare il
popolo alla sommossa, né nelle sinagoghe, né per la
città
[13]e
non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano.
[14]Ammetto
invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella dottrina che
essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è
conforme alla Legge e sta scritto nei Profeti,
[15]nutrendo in
Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una
risurrezione dei giusti e degli ingiusti.
[16]Per questo
mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile
davanti a Dio e davanti agli uomini.
[17]Ora, dopo
molti anni, sono venuto a portare elemosine al mio popolo e per
offrire sacrifici;
[18]in occasione
di questi essi mi hanno trovato nel tempio dopo che avevo compiuto le
purificazioni. Non c’era folla né tumulto.
[19]Furono dei
Giudei della provincia d’Asia a trovarmi, e loro dovrebbero
comparire qui davanti a te ad accusarmi, se hanno qualche cosa contro
di me;
[20]oppure
dicano i presenti stessi quale colpa han trovato in me quando sono
comparso davanti al Sinedrio,
[21]se non questa sola frase che
gridai stando in mezzo a loro: A motivo della risurrezione dei morti
io vengo giudicato oggi davanti a voi!».
[22]Allora Felice,
che era assai bene informato circa la nuova dottrina, li rimandò
dicendo: «Quando verrà il tribuno Lisia, esaminerò
il vostro caso».
[23]E ordinò
al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però
una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di
dargli assistenza.
[24]Dopo alcuni giorni Felice arrivò in
compagnia della moglie Drusilla, che era giudea; fatto chiamare
Paolo, lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù.
[25]Ma quando
egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio
futuro, Felice si spaventò e disse: «Per il momento puoi
andare; ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò il
tempo».
[26]Sperava
frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro; per questo
abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con
lui.
[27]Trascorsi due anni, Felice ebbe come successore Porcio
Festo; ma Felice, volendo dimostrare benevolenza verso i Giudei,
lasciò Paolo in prigione.
*
Sadducei, anziani e sommi sacerdoti rinunciano forse ad accusare Paolo, ora che sanno del suo trasferimento a Cesarea, presso il governatore Felice? Assolutamente no. Anzi, la presenza del capo del clero conferisce a questa delegazione quasi un carattere di solenne ufficialità. I giudei sanno bene che, muovendosi in pompa magna per riavere Paolo, individuo che per Felice ha un’importanza minima, possono facilmente far capire al governatore che se non lo riavranno, la responsabilità di eventuali disordini ricadrà unicamente su di lui. La presenza dell’avvocato Tertullo, un ellenista che parla greco e forse latino, è indispensabile quando si ha a che fare con la giurisprudenza romana.
Le parole di Tertullo sono del tutto convenzionali e sostanzialmente contrarie alla realtà dei fatti, non solo perché il popolo giudaico odia a morte i romani, pur avendo dei capi che hanno il coraggio di sostenere che il benessere della Giudea dipende dalle riforme socioeconomiche di Felice, ma anche perché, storicamente, Felice non fu affatto migliore dei suoi predecessori. Infatti, appena insediato nel 52 represse un brigantaggio giudaico; nel 58 disperse sul Getsemani il movimento del profeta egiziano (quello per cui erano sorti dei malintesi su Paolo); l’anno dopo fece pugnalare il sommo sacerdote Gionata, che pur doveva a lui la carica; durante i due anni di prigionia di Paolo, Cesarea sarà teatro di gravi disordini tra giudei e siri; nel 60 comparirà davanti a Festo e si appellerà a Cesare.
Insomma, da bravo avvocato, Tertullo non fa che accattivarsi le simpatie di Felice, poiché sta per chiedergli una cosa che sicuramente lo metterà in imbarazzo: la riconsegna di un cittadino romano, affinché venga giudicato da un tribunale giudaico, dove non meno sicuramente verrà condannato.
Le accuse di Tertullo si pongono a un triplice livello: 1. Paolo con la sua predicazione provoca rivolte e sedizioni tra i giudei sparsi nel mondo: il che mina l’ordine pubblico voluto dai romani; 2. Paolo è a capo di una setta: i nazorei, che per le istituzioni giudaiche va considerate alla stregua di un movimento eversivo ed eretico; 3. Paolo ha profanato il tempio introducendovi persone non ebraiche. Ora, se non fosse stato per il tribuno Lisia, il problema sarebbe già stato risolto, fa capire esplicitamente Tertullo, seppure questi versetti non siano riportati in tutti i manoscritti.
Come s’è precedentemente visto, la profanazione del tempio era stata un’accusa inventata a bella posta per poter immediatamente giustiziare Paolo sul posto, e il linciaggio sarebbe avvenuto se non fossero intervenuti i romani. Roma tuttavia aveva concesso alle guardie del tempio di arrestare chiunque lo violasse.
Il riferimento alla setta dei nazorei probabilmente è stato fatto perché ai tempi di Pilato questa setta, guidata da Gesù, costituì per i romani un problema politico di non poco conto, e prima che i cristiani venissero chiamati «cristiani» (ciò che accadde per la prima volta ad Antiochia, cfr At 11,26), essi venivano appunto chiamati «nazareni» o «nazorei».
Tuttavia, questa «setta» non esisteva più, in quanto la comunità guidata da Giacomo, che pur ne aveva ereditato le motivazioni ideali, era diventata un’altra cosa, e quella guidata da Paolo una cosa ancora più lontana da quelle motivazioni, tant’è che se davvero avesse «fomentato continue rivolte tra tutti i Giudei» (v. 5), al punto da costituire una minaccia per l’ordine pubblico, difficilmente i romani sarebbero rimasti a guardare, come infatti non fecero a Filippi (At 16,22) e come invece fecero nell’Acaia (At 19,14), rendendosi conto che Paolo era politicamente inoffensivo.
Quando Paolo inizia a difendersi, appare evidente che, prima dell’arrivo di questa delegazione, Felice non l’aveva mai interrogato. Anche l’apostolo, avvocato di se stesso, cerca di accattivarsi le simpatie di Felice, esaltando di quest'ultimo il ruolo di giudice (tralasciando quello di riformatore), cioè sostanzialmente facendogli capire, visto che governa «da molti anni» (v. 10), che in un territorio difficile come quello, non può che essere un «buon giudice».
Paolo si discolpa dalla principale accusa che può interessare un giudice romano: aver provocato sommosse e sedizioni, dando come prova il fatto che a Gerusalemme egli si era recato solo dodici giorni prima, venendo da un lungo viaggio compiuto in luoghi remoti e coll’intenzione di «portare elemosine» al suo popolo e «per offrire sacrifici (al tempio)» (v. 17). Neanche se avesse voluto, avrebbe potuto fare ciò di cui l’accusavano.
Comunque Paolo fa ben capire a Felice che se anche avesse avuto tempo e modo per ordire sommosse antiromane, non l’avrebbe fatto, poiché la sua principale motivazione all’agire non era politica bensì religiosa, in particolare il tema della resurrezione dei morti, in cui – precisa Paolo – anche i farisei credono.
Paolo è un uomo astuto, poiché davanti ai romani si dichiara giudeo e davanti ai giudei si dichiara romano. Qui infatti ribadisce vecchie idee giudaiche in cui da tempo ha smesso di credere: il monoteismo assoluto (che per lui è diventato relativo, in quanto il Cristo, risorgendo, ha dimostrato d’avere una natura non meno «divina»); la legge mosaica (cui egli contrappone la teoria della grazia e della fede superiore alle opere della legge); il valore dei profeti (che per lui e per gli altri cristiani è tale solo in quanto giustifica la nuova ideologia cristiana).
Si può qui facilmente immaginare lo sguardo di Felice quando Paolo, sapendo di rischiare di passare per un mentecatto, concluse la sua arringa affermando che avevano cercato di linciarlo semplicemente perché credeva nella resurrezione dei morti.
Neanche la giuria più sprovveduta avrebbe potuto credere in una stupidaggine del genere, non foss’altro perché, se fosse stata vera, non pochi farisei avrebbero dovuto sentirsi in pericolo. È evidente che qui è intervenuta una mano redazionale che ha voluto sintetizzare al massimo una diatriba ben più complessa, in cui non era tanto in gioco un’idea opinabile ma il destino dell’intera nazione. Si sarebbe forse scomodata una delegazione di così alto rango se i motivi non fossero stati gravi?
Tutto ciò ovviamente non esclude che Paolo abbia cercato di minimizzare a bella posta i suoi capi d’accusa, nella speranza che il governatore rimandasse a casa la delegazione. L’importante per Paolo è che Felice creda nella sua incapacità di nuocere sul piano politico o che la sua strategia missionaria non ha alcuna finalità eversiva contro Roma.
Certamente pesca nel vero la frase di Paolo secondo cui avrebbero dovuto essere alcuni «giudei della provincia d’Asia» (v. 19) ad accusarlo in quel momento (col che egli vuol far capire a Felice che le accuse della delegazione non erano che dettate da motivi di risentimento personale); ma ha favore dell'accusa restava il fatto che i viaggi di Paolo erano durati molti anni, durante i quali, dai luoghi remoti della sua missione alla città di Gerusalemme, erano circolate voci coerenti e insistenti circa la pericolosità del suo messaggio per le sorti politiche di Israele. La delegazione era lì perché in sostanza rappresentava non solo gli interessi della Palestina ma anche quelli dei giudei della diaspora, che non avevano rinunciato a credere in una liberazione nazionale della Palestina.
Si ha in sostanza l’impressione che Paolo, con la sua decisione di far valere la cittadinanza romana, sia finito per condurre una difesa piuttosto rocambolesca, cacciandosi in una sorta di cul de sac, da cui egli pensa di poter uscire allontanandosi sempre più dal mondo ebraico, che con le sue problematiche emancipative e indipendentiste ormai gli era diventato del tutto estraneo. Egli può tuttavia avvalersi del fatto che gli accusatori non possono esplicitamente sostenere le loro rivendicazioni di «liberazione nazionale» al cospetto di un'autorità che fa chiaramente gli interessi di Roma.
Ciò forse può spiegare il motivo per cui egli, apparentemente, non voglia porre alcuna differenza tra il fariseismo progressista e la sua versione di cristianesimo: il che assai difficilmente sarebbe stato accettato dai seguaci di Giacomo, memori delle responsabilità del partito farisaico nell’esecuzione del Cristo; e neppure i farisei avrebbero potuto accettarlo, non avendo essi alcuna intenzione di mettere ebrei e pagani sullo stesso piano, di considerare la fede superiore alla legge e obsolete tutte le prescrizioni alimentari o quelle risalenti al patriarca Abramo. Pur di non aver più nulla a che fare con i giudei, Paolo sembra essere disposto ad arrampicarsi sugli specchi.
A questo punto l’unico problema che Felice deve risolvere è quello di come soddisfare le richieste della delegazione senza contravvenire alle leggi romane, cui l’imputato vuole appellarsi. E qui dimostra davvero d’essere un «buon giudice». Da un lato infatti non consegna Paolo ai giudei, dall’altro, col pretesto che vuole ascoltare anche la versione del tribuno Lisia (come se la missiva non gli fosse bastata), afferma di voler tenere Paolo in carcere. Cioè in sostanza non prende alcuna vera decisione. Il fatto d’essere «bene informato circa la nuova dottrina» (v. 22) non è sufficiente né per affermare né per negare un valore probatorio alle accuse della delegazione.
Di sicuro Paolo non è pericoloso politicamente, ma se Felice non lo consegna ai giudei rischia di farlo diventare indirettamente causa di rimostranze, le quali potrebbero portare a inconvenienti anche sul piano politico. Davvero un «buon giudice» questo Felice, come meglio non avrebbe potuto essere un rappresentante legale di una potenza imperiale.
Quando la delegazione se ne andò, Felice non ebbe alcuna difficoltà a ordinare al centurione che al prigioniero Paolo, essendo questi cittadino romano (che avrebbe anche potuto dargli delle noie), gli venisse concessa «una certa libertà», «senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza» (v. 23). E in questa situazione Paolo resterà per più di due anni.
Alcuni esegeti hanno voluto paragonare l’atteggiamento di Felice a quello che tenne Erode nei confronti del Battista, ma il paragone non regge, semplicemente perché Erode temeva Giovanni per la sua popolarità e perché questi aveva trasformato una rivendicazione giuridica (relativa all’adulterio) in una possibile rivendicazione politica; viceversa, l’unico timore che Felice aveva era in relazione alla cittadinanza romana di Paolo, un privilegio per quei tempi davvero considerevole.
Come noto il paragone è stato orchestrato dagli stessi redattori degli Atti, i quali hanno voluto concludere questo episodio citando Felice che, insieme alla moglie ebrea Drusilla, ascolta, apparentemente interessato, la dottrina di Paolo. Non potendo considerare Paolo un emulo di Gesù, la comunità cristiana ha preferito cercare dei collegamenti con la vicenda del Precursore incarcerato da Erode.
Qui in sostanza s’è voluto far credere che Felice teneva in carcere Paolo anche per fare un piacere alla moglie, che, per potersi sposare con lui, aveva dovuto divorziare dal re di Emesa. Quando Paolo si mette a parlare «di giustizia, di continenza e del giudizio futuro» (v. 25), il brutale e dissoluto Felice fa presto a farlo tacere. Un cristiano non faceva paura politicamente ma era pur sempre uno «scocciatore» sul piano etico.
E Felice non era solo brutale e dissoluto, ma anche venale. Infatti, poiché la durata massima della detenzione era di un biennio, scaduto il quale, se non era intervenuta alcuna condanna, Paolo avrebbe dovuto riguadagnare la libertà, egli sperava di ottenere una forte cauzione prima dello scadere dei termini di carcerazione. Della dottrina di Paolo non gli era mai interessato nulla.
Paolo comunque sapeva di avere, col privilegio della cittadinanza romana, un asso nella manica e anche se Felice chiese al suo sostituto Porcio Festo di continuare a tenerlo in carcere per non scontentare i giudei, sapeva bene che prima o poi avrebbero dovuto o liberarlo o trasferirlo a Roma.
torna suCap. 25
[1]Festo
dunque, raggiunta la provincia, tre giorni dopo salì da
Cesarea a Gerusalemme.
[2]I sommi
sacerdoti e i capi dei Giudei gli si presentarono per accusare Paolo
e cercavano di persuaderlo,
[3]chiedendo
come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme;
e intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso.
[4]Festo rispose
che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe
partito fra breve.
[5]«Quelli dunque che hanno autorità
tra voi, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in
quell’uomo, lo denuncino».
[6]Dopo essersi trattenuto
fra loro non più di otto o dieci giorni, discese a Cesarea e
il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si
conducesse Paolo.
[7]Appena
giunse, lo attorniarono i Giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli
numerose e gravi colpe, senza però riuscire a provarle.
[8]Paolo a sua
difesa disse: «Non ho commesso alcuna colpa, né contro
la legge dei Giudei, né contro il tempio, né contro
Cesare».
[9]Ma Festo volendo fare un favore ai Giudei, si
volse a Paolo e disse: «Vuoi andare a Gerusalemme per essere là
giudicato di queste cose, davanti a me?».
[10]Paolo
rispose: «Mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si
deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai
perfettamente.
[11]Se dunque
sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non
rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non c’è
nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi
appello a Cesare».
[12]Allora
Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Ti sei
appellato a Cesare, a Cesare andrai».
[13]Erano trascorsi
alcuni giorni, quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenìce,
per salutare Festo.
[14]E poiché
si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo:
«C’è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice,
contro il quale,
[15]durante la
mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi
sacerdoti e gli anziani dei Giudei per reclamarne la condanna.
[16]Risposi che
i Romani non usano consegnare una persona, prima che l’accusato
sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo
di difendersi dall’accusa.
[17]Allora essi
convennero qui e io senza indugi il giorno seguente sedetti in
tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell’uomo.
[18]Gli
accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle
imputazioni criminose che io immaginavo;
[19]avevano solo
con lui alcune questioni relative alla loro particolare religione e
riguardanti un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere
ancora in vita.
[20]Perplesso di
fronte a simili controversie, gli chiesi se voleva andare a
Gerusalemme ed esser giudicato là di queste cose.
[21]Ma
Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al
giudizio dell’imperatore, e così ordinai che fosse
tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a
Cesare».
[22]E Agrippa a Festo: «Vorrei anch’io
ascoltare quell’uomo!». «Domani, rispose, lo potrai
ascoltare».
[23]Il giorno dopo, Agrippa e Berenìce
vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell’udienza,
accompagnati dai tribuni e dai cittadini più in vista; per
ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo.
[24]Allora Festo
disse: «Re Agrippa e cittadini tutti qui presenti con noi, voi
avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo
dei Giudei si è appellato a me, in Gerusalemme e qui, per
chiedere a gran voce che non resti più in vita.
[25]Io però
mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di
morte ed essendosi appellato all’imperatore ho deciso di farlo
partire.
[26]Ma
sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano; per
questo l’ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te,
o re Agrippa, per avere, dopo questa udienza, qualcosa da scrivere.
[27]Mi sembra
assurdo infatti mandare un prigioniero, senza indicare le accuse che
si muovono contro di lui».
*
Porcio Festo entra in carica nel 60 e morirà due anni dopo. Come di consueto la sua residenza era a Cesarea e il suo viaggio a Gerusalemme aveva unicamente lo scopo di ufficializzare ai giudei l’avvenuta sostituzione del precedente prefetto.
Era già passato un biennio da quando il governatore Felice aveva incarcerato Paolo, ma le autorità giudaiche – testimoni, evidentemente, del crescente successo della corrente cristiana – continuano a chiedere con insistenza che venga loro consegnato. Anzi, pensano di poter approfittare proprio dell’avvicendamento offrendo in cambio il loro rinnovato appoggio, come segno di reciproca fiducia.
Festo, che come tutti i neo-insediati ha bisogno di dimostrare la propria magnanimità, non può essere rimasto insensibile all’offerta di complicità da parte delle autorità giudaiche. Tuttavia, rendendosi conto che non avrebbero permesso a Paolo, cittadino romano, di avere un regolare processo, propone loro una soluzione di convenienza: ripetere a Cesarea il dibattimento che già s’era svolto sotto Felice. La proposta viene accettata.
Qui Luca si limita a scrivere che Paolo veniva accusato di «numerose e gravi colpe» (v. 7), senza specificare altro, probabilmente perché erano le stesse della volta precedente. Infatti Paolo non cambia strategia e si limita a dire che secondo la legge non ha compiuto alcun reato che giustifichi la sua carcerazione. Se di «reato» si può parlare si tratta semplicemente di un reato di «opinione». Ed egli sa benissimo che di fronte a un reato di opinione «religiosa», nessun tribunale romano l’avrebbe mai condannato.
Perciò non ha dubbi nel rifiutare la proposta che Festo gli fa di lasciarsi giudicare da un tribunale ebraico. Festo ovviamente non può obbligarlo ad accettare una soluzione del genere, essendo Paolo libero di appellarsi a Cesare. Può soltanto far vedere ai giudei tutta la sua buona volontà nel cercare di soddisfare le loro richieste.
Paolo, che conosce i giudei molto meglio di qualunque romano, sa benissimo che, nonostante tutte le assicurazioni e le protezioni di Festo, al processo non sarebbe mai arrivato vivo. Anzi, temendo che Festo voglia complottare con i giudei, preferisce decisamente appellarsi a Cesare e quindi di essere trasferito a Roma.
Ora qui bisogna fare alcune considerazioni. Anzitutto è bene evitare con cura di fare un torto all’intelligenza dei capi giudei, poiché se è del tutto verosimile che volessero eliminare Paolo in gran segreto, senza neppure imbastire un processo analogo a quello del Cristo, la cui popolarità e pericolosità politica erano infinitamente superiori a quelle di Paolo; è altresì vero che la dichiarazione d’innocenza di Paolo si poneva in maniera del tutto convenzionale e retorica, in quanto di fatto la predicazione di Paolo risultava particolarmente dannosa agli interessi non solo religiosi ma anche politici della nazione di Israele.
Sostenere la fine del primato della legge mosaica e soprattutto del valore del tempio, nonché il superamento delle tradizioni secolari relative a riti e regole di vario tipo significava in sostanza minacciare l’esistenza di Israele come nazione. Se si vuole accettare la tesi cristiana secondo cui la predicazione paolina era unicamente «religiosa», si deve comunque convenire con gli ebrei ch’essa aveva, indirettamente, delle conseguenze di tipo politico.
In secondo luogo, sia Festo che, prima di lui, Felice non si erano resi conto che la predicazione di Paolo, portata alle conseguenze più logiche, costituiva una minaccia politica anche per l’ideologia romana, in quanto, se da un lato è vero che il «dio» di Paolo veniva a porsi come un’entità in mezzo a tante altre, dall’altro è non meno vero che, facendo dell’uomo-Cristo un «dio» e per giunta l’unico vero dio apparso sulla terra, Paolo veniva a mettere in discussione la tesi secondo cui ogni imperatore andava venerato come una divinità (cosa già iniziata con Augusto nella parte orientale dell’impero). Il rifiuto di considerare gli imperatori un simbolo concreto, terrestre, della divinità celeste verrà scambiato dai giuristi e dai politici romani, che su questo punto non erano meno integralisti dei più integralisti giudei, come una forma intollerabile di «ateismo» e quindi come una forma di slealtà nei confronti delle istituzioni.
Quanto a Paolo, egli da tempo era giunto a conclusioni che potremmo definire «chiare e distinte»: Israele non ha la forza per liberarsi dei romani e rischia anzi di scomparire come nazione; tuttavia lo spirito d’Israele, riveduto e corretto alla luce di quanto avvenuto con le vicende del Cristo, può continuare a sopravvivere e anzi a diffondersi nel mondo intero, come mai prima era successo.
Paolo non ha e non vuole avere un progetto politico-rivoluzionario favorevole alla liberazione nazionale della Palestina, però ne ha uno di tipo culturale, a sfondo religioso, sicuramente cosmopolitico, che presume d’essere alternativo sia alla sapienza greca che alla legge ebraica.
Le autorità giudaiche lo vogliono morto non solo perché vedono in lui una minaccia alla causa della liberazione dal dominio straniero, ma anche perché sono tenacemente legate ai loro privilegi di casta, al loro stretto nazionalismo, alla loro politica e cultura conservatrice.
Per Paolo non ha più alcun senso morire martire per un popolo che non sente più suo, o per una comunità – come quella capeggiata da Giacomo il Minore – che si differenzia dai giudei tradizionali solo in un aspetto: l’attesa del ritorno trionfale del Cristo, un ritorno ch’essi credono ancora imminente, mentre per Paolo occorre procrastinarlo sine die, addirittura per la fine dei tempi.
Ci si può facilmente immaginare la reazione di Festo, che, appena nominato, aveva già un serio grattacapo da affrontare: da un lato non vuole scontentare l’autorevole delegazione giudaica, dall’altro non può rischiare, specie per la sua carriera, che un cittadino romano lo denunci di aver violato la legge. Sicché, previa consultazione del consiglio, decide di trasferirlo a Roma (l’imperatore in carica era Nerone: 54-68).
Si stava ancora provvedendo a organizzare il lungo viaggio, quand’ecco giungere a Cesarea il re Agrippa con la moglie Berenice, ch’erano venuti per conoscere il nuovo governatore romano. Festo ne approfitta per sottoporre ad Agrippa il caso di Paolo e per avere da lui qualche consiglio. Agrippa e Berenice (e anche Drusilla) erano figli di Erode-Agrippa I. Nel 49 Agrippa II era stato nominato dai romani ispettore del tempio di Gerusalemme, col diritto di designare il sommo sacerdote.
Di tutto quello che Festo dice ad Agrippa una frase, in particolare, pare messa apposta dai redattori degli Atti per far sembrare i romani più equi degli ebrei, ed è questa: «Risposi che i romani non usano consegnare una persona, prima che l’accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall’accusa» (v. 16).
Un’affermazione del genere non avrebbe potuto essere detta davanti alle autorità giudaiche, perché anche nella prassi giudaica era prevista la stessa cosa (cfr p. es. Gv 7,51). Festo può aver detto che un cittadino «romano» non avrebbe potuto essere giudicato, contro la propria volontà, da un tribunale giudaico. Ma anche in questo caso difficilmente sarebbe potuto sfuggire a un qualunque cittadino la considerazione che il diritto romano, non meno di quello giudaico, era al servizio del potere politico ed economico.
E anche se Festo avesse detto di non poter consegnare un imputato al boia prima di un regolare processo, specie se questo imputato non ha commesso crimini contro il patrimonio o contro le istituzioni, neppure in questo caso la giustizia ebraica avrebbe avuto qualcosa da imparare da quella romana.
Qui insomma si ha l’impressione che i redattori cristiani abbiano voluto ridicolizzare le accuse dei capi giudei, mostrando che le loro vere intenzioni erano omicide e che un cristiano come Paolo non avrebbe avuto nulla da temere da parte delle autorità romane.
Solo che così facendo essi sono incappati in due contraddizioni di non poco conto: la prima è che invece di far vedere le autorità romane all’altezza di un caso come quello di Paolo, hanno fatto di Festo un incapace, un inetto, in quanto non ha saputo reagire subito, con la dovuta perspicacia, alle false accuse dei giudei, di cui conosceva bene le reali intenzioni; la seconda è che, mostrando Festo non solo incapace ma anche imbelle, hanno indirettamente fatto vedere che il potere giudaico era piuttosto temuto dai romani, evidentemente perché le sommosse erano all’ordine del giorno, per quanto in questi racconti ci si guardi bene dal farle apparire.
La parte finale di questo episodio rasenta la comicità. Festo s’immaginava accuse politicamente o giuridicamente terribili contro Paolo, come l’omicidio, il terrorismo, la sedizione... Poi aveva capito che Paolo non solo non era politicamente pericoloso, ma che anche le accuse giuridiche non riguardavano direttamente la legge romana, quanto una semplice questione «religiosa»: la resurrezione di un uomo. Dunque perché non liberarlo? perché lamentarsi con Agrippa che sul conto di Paolo non aveva «nulla di preciso da scrivere al sovrano» (v. 26)?
È che Festo non riesce a comportarsi come un giudice imparziale, non riesce ad evitare la connotazione politica che i giudei vogliono dare a questo processo, non riesce a scrollarsi di dosso i condizionamenti istituzionali che dietro questo processo legano i rapporti di Roma con la Giudea.
Agrippa vuol conoscere Paolo semplicemente per curiosità, forse l’avrà sentito nominare: in fondo un suo prozio, Erode Antipa, aveva fatto uccidere il Battista e aveva desiderato catturare Gesù (Lc 9,9); qui viene interpellato da Festo, cui piace ostentare il proprio senso della giustizia, semplicemente perché esprima un parere personale, quale stimato alleato di Roma.
A partire dal v. 23 si ha l’impressione di trovarsi al cospetto di un’udienza molto importante, ma è evidente che si tratta di un’esagerazione redazionale. E non è da escludere che Festo abbia voluto far vedere ad Agrippa che il suo prigioniero era molto importante, visto che lo volevano morto a tutti i costi.
È curioso qui il fatto che mentre da un lato Festo affermi che tutto il popolo ebraico vuole Paolo lapidato, dall’altro dichiari che secondo lui egli è innocente, sicché nello stesso tempo egli evita di consegnarlo e di liberarlo. L’ha tenuto in catene solo per motivi politici e non l’ha consegnato ai giudei solo per motivi personali, in quanto avrebbe rischiato una denuncia di violazione della legge, comportandosi, in questo, esattamente come i suoi predecessori. E si noti come qui i redattori cristiani vogliano far passare questa prassi come decisamente superiore a quella giudaica.
Festo sembra addirittura supplicare Agrippa di trovargli un capo d’accusa convincente, per cui abbia un senso trasferire Paolo a Roma, altrimenti teme di fare nei confronti dei suoi superiori una figura non meno meschina di quella che avrebbe fatto consegnando nelle mani degli aguzzini giudei un uomo con la cittadinanza romana, di cui sapeva con sicurezza non essere colpevole di nulla.
torna suCap. 26
[1]Agrippa
disse a Paolo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa».
Allora Paolo, stesa la mano, si difese così:
[2]«Mi
considero fortunato, o re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le
accuse di cui sono incriminato dai Giudei, oggi qui davanti a te,
[3]che conosci a
perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i Giudei. Perciò
ti prego di ascoltarmi con pazienza.
[4]La mia vita
fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme,
la conoscono tutti i Giudei;
[5]essi sanno
pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che, come fariseo,
sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione.
[6]Ed ora mi
trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da
Dio ai nostri padri,
[7]e che le
nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio
notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora
incolpato dai Giudei!
[8]Perché
è considerato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i
morti?
[9]Anch’io credevo un tempo mio dovere di lavorare
attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno,
[10]come in
realtà feci a Gerusalemme; molti dei fedeli li rinchiusi in
prigione con l’autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e,
quando venivano condannati a morte, anch’io ho votato contro di
loro.
[11]In
tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a
bestemmiare e, infuriando all’eccesso contro di loro, davo loro
la caccia fin nelle città straniere.
[12]In tali
circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e
pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno
[13]vidi sulla
strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che
avvolse me e i miei compagni di viaggio.
[14]Tutti
cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in
ebraico: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per
te ricalcitrare contro il pungolo.
[15]E io dissi:
Chi sei, o Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu
perseguiti.
[16]Su,
alzati e rimettiti in piedi; ti sono apparso infatti per costituirti
ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui
ti apparirò ancora.
[17]Per questo
ti libererò
dal popolo e
dai pagani, ai
quali ti mando
[18]ad
aprir loro
gli occhi,
perché passino
dalle tenebre
alla luce e
dal potere di satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e
l’eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati
per la fede in me.
[19]Pertanto, o re Agrippa, io non ho
disobbedito alla visione celeste;
[20]ma prima a quelli di
Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della
Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a
Dio, comportandosi in maniera degna della conversione.
[21]Per
queste cose i Giudei mi assalirono nel tempio e tentarono di
uccidermi.
[22]Ma
l’aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso
ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null’altro
io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che
doveva accadere,
[23]che cioè
il Cristo sarebbe morto, e che, primo tra i risorti da morte, avrebbe
annunziato la luce al popolo e ai pagani».
[24]Mentr’egli
parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei
pazzo, Paolo; la troppa scienza ti ha dato al cervello!».
[25]E Paolo:
«Non sono pazzo, disse, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo
parole vere e sagge.
[26]Il re è
al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza.
Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, poiché non
sono fatti accaduti in segreto.
[27]Credi, o re Agrippa, nei
profeti? So che ci credi».
[28]E Agrippa a Paolo: «Per
poco non mi convinci a farmi cristiano!».
[29] E Paolo:
«Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non
soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano diventassero così
come sono io, eccetto queste catene!».
[30]Si alzò
allora il re e con lui il governatore, Berenìce, e quelli che
avevano preso parte alla seduta
[31]e avviandosi
conversavano insieme e dicevano: «Quest’uomo non ha fatto
nulla che meriti la morte o le catene».
[32]E Agrippa
disse a Festo: «Costui poteva essere rimesso in libertà,
se non si fosse appellato a Cesare».
*
Agrippa II era considerato da Paolo un grande conoscitore di cose ebraiche, a differenza evidentemente di Festo, nei cui confronti Paolo aveva scarsa fiducia. Ad Agrippa egli sta per dire delle cose che a Festo non erano minimamente interessate.
Oggi, dopo duemila anni di cristianesimo, siamo soliti attribuire ai romani molto più ateismo di quanto essi ne attribuissero ai cristiani, col loro rifiuto di considerare l’imperatore una sorta di divino-umanità; senza considerare che oggi il cristianesimo è vissuto da gran parte dei credenti in maniera ateistica, pur nella salvaguardia di alcuni postulati teorici irrinunciabili, il primo dei quali è l’esistenza di un Dio uno e trino.
Tuttavia qui bisogna rendersi conto che le questioni teoriche attorno a cui si svolgevano i dibattiti ai tempi di Paolo – questioni che, a motivo dei processi di secolarizzazione, oggi riteniamo quanto mai superate – costituivano una sorta di trasposizione simbolica di problemi molto concreti, sempre di natura sociale o economica.
In altre parole, non si deve pensare che duemila anni fa gli uomini non avessero consapevolezza del fatto che i problemi sociali andavano affrontati socialmente e politicamente. La predicazione di Paolo e se vogliamo tutti gli scritti del Nuovo Testamento stanno appunto a testimoniare che tale consapevolezza esisteva, ma che, non sapendo come concretarla operativamente, si preferiva circoscriverla entro discorsi di tipo religioso.
Dunque se da un lato le diatribe teologiche possono apparirci del tutto insensate o scontate le soluzioni che ad un certo punto sono prevalse, dall’altro però è bene sapere ch’esse rappresentano, seppure in maniera distorta se non addirittura mistificata, un’esigenza reale di giustizia, di eguaglianza sociale.
Il fatto che il cristianesimo paolino abbia finito col prevalere su ogni altra forma di cristianesimo deve farci riflettere non solo sulla grandezza del personaggio in questione, ma anche sulla scarsa capacità che gli uomini di allora sapevano dimostrare nell’affronto dei problemi socio-economici.
Questa scarsa capacità non può però essere attribuita a un livello primitivo dello sviluppo produttivo o ad altri fattori quantitativi (ivi incluso il livello delle conoscenze), altrimenti oggi non riusciremmo a spiegarci perché, nonostante i duemila anni di progresso storico continuino a permanere dei sistemi sociali antagonistici. Si tratta semplicemente di capire che gli uomini sono liberi di reagire alle situazioni di disagio o di accettarle passivamente; che poi, in questo secondo caso, si diano delle giustificazioni religiose o di altra natura, non fa molta differenza. Non esiste alcun processo storico che indichi con sicurezza che le attuali generazioni siano le più favorite nel cercare una soluzione ai loro problemi.
Questa premessa per dire che il dibattito che ora andremo a esaminare non va semplicemente visto come un dibattito a contenuto religioso in una sede giudiziaria, ma va anche visto come una forma di scontro simbolico tra due culture: greco-romana ed ebraico-cristiana, ognuna delle quali si sentiva autorizzata a negare all’altra le stesse possibilità di successo nella soluzione dei problemi sociali della gente. Essendo inficiato da argomentazioni di tipo religioso, lo scontro, evidentemente, ruota attorno a dei problemi e a delle soluzioni che solo indirettamente avrebbero potuto avere una ricaduta positiva o negativa sulla vita della gente.
Qui dunque non dobbiamo vedere Paolo solo come uno che dà sfoggio di tutta la propria arte da imbonitore, ma anche come uno che si sforza di cercare un’alternativa alla crisi della cultura dominante, ch’era pagana, cioè greco-romana e, per quanto riguarda la Palestina, giudaica. E Festo inizia a capire che forse si era sbagliato sul suo conto, che forse i giudei non avevano tutti i torti a volerlo eliminare e che la pretesa di Paolo d’insegnare a vivere ai pagani era a dir poco priva di senso, in quanto nessun romano avrebbe mai potuto credere a una versione dei fatti come quella raccontata da lui, in relazione alla propria conversione sulla strada di Damasco, per non parlare della teoria della resurrezione, qui presentata non come mito o leggenda, ma addirittura come un fatto assolutamente reale: una teoria che Paolo ha sempre predicato in stretta connessione al monoteismo assoluto, secondo la più schietta tradizione ebraica.
Tuttavia, la cosa più singolare è che Agrippa rimanga colpito molto favorevolmente dal racconto di Paolo. Infatti, visto ch’egli viene qui presentato come un re ebreo o semi-ebreo, che, diversamente da Festo, conosce «a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i giudei» (v. 3), risulta ben strano ch’egli non si sia accorto quanto Paolo «vaneggiasse» (v. 24) quando diceva che i profeti e Mosè avevano predetto che il Cristo, cioè il messia liberatore, doveva soffrire e resuscitare dai morti (vv. 22-26). Anche perché qui è evidente che Paolo stava facendo un discorso rivolto più a un uditorio di tradizione o cultura ebraica che non pagana.
Sostenendo che il «Dio dei nostri padri» (v. 6) aveva fatto una promessa del genere, Paolo stravolge completamente l’esegesi canonica delle Scritture, e può farlo soltanto perché sa di avere di fronte uno che non s’intende granché di teologia ebraica, poiché in nessuna parte dell’Antico Testamento viene mai detto che il messia sarebbe dovuto morire e risorgere. Il concetto di «resurrezione» si fa strada solo al tempo dei Maccabei (2 Mac 7, 9 e Dn 12, 2) e non in riferimento al messia, ma solo in chiave escatologica, in relazione a una possibile resurrezione finale di tutti i morti della storia. Paolo invece ne parla come se gli ebrei vi credessero da sempre, e parla anche di dodici tribù (v. 7) quando ai suoi tempi ne esistevano solo due o poco più.
Se Agrippa ha accettato questa tesi e se addirittura si è lasciato scappare che volendo sarebbe anche potuto diventare «cristiano» (v. 28), evidentemente doveva essersi reso conto che il discorso di Paolo poteva tornargli politicamente comodo. La frase con cui egli chiude questo capitolo è significativa: «Costui poteva essere rimesso in libertà, se non si fosse appellato a Cesare» (v. 32). Non è da escludere, in tal senso, che Agrippa odiasse il giudaismo chiuso, aristocratico, settario e che preferisse decisamente il sincretismo etico-religioso tra ebraismo ed ellenismo.
Luca però non lascia capire bene se quella frase nascesse da una considerazione meramente politica o anche da una qualche convinzione interiore, o se invece non si trattasse di una mera battuta ironica, che si era voluta contrapporre all’ardore predicatorio dell’apostolo Paolo. Si riesce soltanto a intuire che, una volta deciso l’appello a Cesare, nessuno avrebbe più potuto far recedere Paolo, neanche se Festo o Agrippa in persona si fossero convinti della sua innocenza. Il che forse voleva dire che Paolo, piuttosto che accettare una libertà che avrebbe potuto mettere a repentaglio la propria vita, preferiva essere scortato fino a Roma e qui essere sottoposto a processo, dove sicuramente avrebbe vinto, avendo egli perfettamente capito che nella sua attività pratico-teorica non vi potevano essere appigli per un verdetto di colpevolezza in un tribunale romano.
Paolo al v. 27 dice: «Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi». Pone una domanda in questi termini perché sarebbe sicuramente apparso troppo presuntuoso chiedere ad Agrippa se credeva in quello che fino a quel momento gli aveva detto. Pertanto non può che giocare d’astuzia e cercare di far passare un sillogismo sibillino: se Agrippa crede nei profeti (specialmente in Ezechiele, Isaia e Geremia) e la teoria di Paolo è conforme a quella dei profeti, allora Agrippa deve per forza credere anche nella teoria di Paolo.
Da un lato quindi si ha l’impressione che come uomo Agrippa sarebbe anche potuto diventare cristiano (o comunque lo si vuol far passare così da un punto di vista redazionale); dall’altro però è evidente ch’egli, come politico, avendo a che fare con la gestione delle cose ebraiche, al massimo avrebbe potuto tollerare pacificamente lo sviluppo del cristianesimo paolino, avendo capito che tra questa corrente e il dominio romano non esisteva una vera incompatibilità di sostanza. Il che però non significa che ad Agrippa sia sfuggito quanto fossero stridenti le divergenze tra cristianesimo paolino e giudaismo «classico».
Agrippa uscì dall’aula incerto sull’idea di diventare «cristiano», ma è fuor di dubbio che quanto più gli imperatori pretenderanno, per motivi politici, il riconoscimento del loro proprio carattere divino, tanto meno un personaggio come Agrippa avrebbe potuto rimanere incerto sull’atteggiamento da tenere nei confronti dei cristiani.
Ma torniamo a Festo. La reazione del governatore è stata meno intelligente di quella tenuta dal re Agrippa. È difficile qui capire se Festo abbia reagito più in quanto romano o più in quanto «padrone di casa» che chiede all’ospite di ascoltare un caso difficile. Temeva di aver fatto una brutta figura esponendo un caso che in quel momento stava diventando molto strampalato, oppure effettivamente Festo aveva cominciato a rendersi conto che Paolo fosse davvero pazzo e quindi pericoloso?
Sia come sia Festo non si rende conto che le cose dette da Paolo facevano un favore al dominio romano, anche se Paolo presumeva di poter insegnare ai pagani quale fosse il vero dio da adorare. È scritto infatti al v. 25: «Non sono pazzo, disse, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge». Cioè parole per lui ideologicamente irrinunciabili e che per Roma potrebbero diventare politicamente convenienti.
Valutando le cose non come scaltro politico, ma come uomo che bada ai princìpi, Festo non s’è reso conto di avere torto proprio mentre il senso comune gli avrebbe dato pienamente ragione. Che Paolo infatti si comportasse come un «pazzo» era evidente, poiché nessuno avrebbe potuto credere alla storia della visione o della resurrezione del Cristo, eppure Paolo proponeva un’inedita soluzione di compromesso, che avrebbe potuto far convivere pacificamente romani ed ebreo-cristiani, in nome di una nuova illusione religiosa, più avanzata di quella pagana politeistica. E Festo sottovaluta, anticipando in questo l’atteggiamento di tutti gli imperatori romani fino a Costantino, la proposta politica di Paolo, anteponendole, pur senza farne esplicito riferimento, delle questioni di tipo ideologico (la prima delle quali era l’impossibilità di mettere sullo stesso piano romani e giudei).
Non era forse nell’interesse di un qualunque governatore romano credere nell’idea di un messia liberatore morto e sepolto? È vero, Paolo sosteneva che fosse «risorto», ma egli aggiungeva, per inciso, che il compito del messia risorto si limitava unicamente ad annunciare la «luce», cioè la «verità», alle nazioni del mondo. Il Cristo redivivo, in sostanza, non aveva più nulla del politico rivoluzionario, essendosi rivestito di panni esclusivamente filosofici e teologici.
Una proposta del genere avrebbe dovuto porre i cristiani a un gradino di credibilità molto più alto di quello in cui stavano gli ebrei nazionalisti, integralisti e politicamente ribelli. Invece Festo, che non è un politico scaltro, non riesce a soprassedere sui «vaneggiamenti» di Paolo e ha bisogno di schierarsi in maniera esplicita. D’altra parte come avrebbe potuto un romano separare così nettamente una «follia» espressa sul terreno ideologico, in virtù della quale si sarebbe dovuta mettere nel dimenticatoio tutta la pletora pagana degli dèi falsi e bugiardi, con la possibilità di utilizzare il cristianesimo come un’arma di dominio, come uno strumento di conservazione del potere? Ci vorranno secoli prima che si arrivi a sfruttare questa grande opportunità.
Il politico romano non è mai riuscito, neppure sotto Costantino e Teodosio, a separare nettamente le questioni religiose da quelle politiche. Lo Stato romano riconosceva piena libertà di religione solo fino al punto in cui poteva permetterlo la non-libertà politica. Cioè il potere pretendeva sempre dalla religione, in ultima istanza, un riconoscimento istituzionale. Il cittadino poteva credere negli dèi che voleva, ma non poteva non fare sacrifici sugli altari che legittimavano il suo status legale di cittadino.
Il cristianesimo paolino è la prima corrente ideologica ebraica che introduce, negando il proprio ebraismo, la separazione tra le questioni religiose e quelle politiche. Il cristiano avrebbe rispettato le leggi e le istituzioni, ma non fino al punto di dover rinnegare la propria convinzione, e cioè che l’unico vero dio era quello ebraico, nonché il figlio di lui, che gli ebrei non avevano voluto riconoscere.
Viceversa, per i romani la non-ammissione della divino-umanità dell’imperatore equivaleva, in sostanza, a un reato di tradimento, di lesa maestà, quindi a un reato politico. Le persecuzioni diventeranno sempre più inevitabili. Quanto più i cristiani professavano il loro dualismo, tanto meno gli integristi pagani del mondo romano sarebbero stati disposti a credervi. Paradossalmente questa situazione si capovolgerà subito dopo la svolta costantiniana: i cristiani diventeranno i nuovi integristi dei secoli futuri.
Prima di passare al capitolo successivo è bene spendere alcune parole sull’ultima versione che Paolo darà della propria conversione. Qui la crudezza con cui vengono esposti gli antefatti è notevole rispetto a quella che abbiamo letto al cap. 22.
|
Cap. 26
[4] La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta
tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i
Giudei; |
Cap. 22
[3] Ed egli continuò: «Io sono un
Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città,
formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme
della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti
voi. |
C’è una certa differenza tra il v. 11 del cap. 26 e il v. 4 del cap. 22: la prassi di torturare il prigioniero costringendolo a rinnegare il nome di Gesù, risparmiandogli quindi la vita, verrà adottata anche dai romani contro i cristiani. E, stando a 26,10, noi dobbiamo dare per scontato che Paolo non fosse solo favorevole alle torture, ma avesse chiesto l’eliminazione di quei non pochi cristiani che avevano resistito alle torture, sino al linciaggio di Stefano, che rappresentò probabilmente il caso più eclatante e l’ultimo nella carriera di «ottimo israelita» del fariseo Saulo.
Qui comunque appaiono evidenti due cose:
– la
prima è che Paolo vuole colpire il suo uditorio dicendo per
filo e per segno tutto quello che aveva fatto ai danni dei cristiani,
mostrando come sin dall’inizio i giudei ritenessero impossibile
una qualunque intesa con questa nuova corrente;
– la seconda
è che Paolo si serve proprio di questa estrema crudezza della
persecuzione per sentirsi più legittimato nel momento in cui
avrà bisogno di usare toni non meno enfatici ed anzi molto
fantasiosi per descrivere la propria conversione.
In sostanza è come se volesse far capire che doveva apparire assolutamente credibile una conversione miracolosa a un uomo che nella prima parte della sua vita era stato un acerrimo nemico del cristianesimo. Cioè preferisce passare per pazzo raccontando d’aver avuto una visione piuttosto che lasciare all’uditorio facoltà di dare una propria interpretazione a questo repentino mutamento di convinzioni ideali.
C’è da dire che è psicologicamente normale che uno preferisca attribuire a un particolare evento il motivo della propria subitanea trasformazione, piuttosto che cercare di spiegare pubblicamente tutto il percorso, intellettuale e morale, sicuramente molto complesso e tortuoso, che l’aveva portato a prendere una determinata decisione. Qui poi, avendo noi a che fare con un’ideologia di tipo religioso, che fa del «miracolo» una delle proprie ragioni d’essere, i fattori sensazionalistici sono ancor più giustificati a livello redazionale.
In ogni caso Paolo doveva essere una persona molto coraggiosa, poiché sapeva benissimo che, anche parlando di conversione miracolosa, i compagni d’un tempo avrebbero fatto di tutto per toglierlo di mezzo.
Relativamente alle altre incongruenze tra le versioni della conversione si rimanda a quanto già detto sul cap. 22. Qui però è interessante notare che quanto più ci si allontana dal giorno in cui si verificò l’evento fondamentale della vita di Paolo, tanto più diventa fantasiosa la versione con cui lo si racconta. E questo semplicemente perché sono sempre meno le persone in grado di smentirla. Questa metodologia redazionale verrà adottata per la stesura di tutto il Nuovo Testamento.
In sostanza Paolo propone una versione che legittimi in maniera univoca l’essenza della sua innovativa ideologia, che qui si può riassumere nei seguenti punti.
Anzitutto bisogna premettere la singolare pretesa di «autovocazione cristiana» rivendicata da Paolo, in netto contrasto coi principi di sequela e affiliazione riscontrati nella vita della comunità apostolica o, prima ancora, del movimento nazareno guidato dal Cristo. Nei racconti di Paolo non c’è per così dire una sorta di «apprendistato alla vita cristiana», ma una folgorazione improvvisa: il Cristo può parlare direttamente a Paolo appunto in quanto risorto, prescindendo quindi da qualunque altra mediazione, e questo è sufficiente per far sentire Paolo un «cristiano», cioè qualcosa di diverso dall’ebreo e dal pagano tradizionali, pur essendo egli, di etnia e di cultura, tanto l’uno quanto l’altro.
Questo modo di presentare le cose è funzionale al fatto che Paolo in realtà non è mai andato d’accordo con la comunità cristiana, né quando la perseguitava come fariseo integrista, né dopo (duri furono gli scontri con Pietro, Marco, Giacomo il Minore ecc.).
Detto questo, ecco in sintesi i punti salienti della teologia paolina:
1. se il Gesù che è morto era anche il vero Cristo, cioè egli va considerato il messia proprio in quanto è risorto, e questo fatto clamoroso esclude che possano esservi altri messia, allora Israele non può più liberarsi dei romani. In altre parole, se il Cristo non ha liberato Israele quand’era in vita e non l’ha fatto subito dopo risorto, ciò significa non solo che nessun altro potrà mai farlo, ma anche che l’obiettivo stesso della liberazione d’Israele era sbagliato. Ciò in cui bisogna credere è la resurrezione di Cristo, ossia il fatto che la liberazione integrale dal male è possibile solo nell’aldilà.
2. La liberazione offerta dal Cristo sulla terra non è socio-politica ma soltanto etico-religiosa: occorre credere, in coscienza, nella remissione dei peccati che si ottiene con la fede personale nella resurrezione e, oggettivamente, con la grazia divina: Dio non è più in collera con l’uomo a causa del peccato d’origine, che introdusse il male nella storia. Il Cristo, con la sua morte, ha espiato la colpa. Egli dunque non va visto come un liberatore nazionale ma come un redentore universale.
Una liberazione integrale dell’uomo, che riguardi non solo gli aspetti interiori ma anche quelli esteriori, è possibile solo alla fine della storia, quando ognuno verrà giudicato per le azioni che ha fatto. Il timore per il giudizio finale, unitamente alla perseveranza nella fede, permetteranno di ottenere l’eredità promessa.
3. Prima di questo evento finale, occorre mettere sullo stesso piano tutti gli uomini della terra, sia che essi provengano dal mondo ebraico, sia che provengano da quello pagano. Israele ha perso ogni primato storico, ma d’ora in poi sono da bandire anche tutte le pretese pagane alla deificazione di un uomo come l’imperatore.
torna suCap. 27
[1]Quando
fu deciso che ci imbarcassimo per l’Italia, consegnarono Paolo,
insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio
della coorte Augusta.
[2]Salimmo su una nave di Adramitto, che
stava per partire verso i porti della provincia d’Asia e
salpammo, avendo con noi Aristarco, un Macedone di Tessalonica.
[3]Il giorno
dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, con gesto cortese verso Paolo,
gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure.
[4]Salpati di
là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari
[5]e,
attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira
di Licia.
[6]Qui
il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per
l’Italia e ci fece salire a bordo.
[7]Navigammo
lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all’altezza di
Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare,
prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone,
[8]e
costeggiandola a fatica giungemmo in una località chiamata
Buoni Porti, vicino alla quale era la città di
Lasea.
[9]Essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai
pericolosa la navigazione poiché era già passata la
festa dell’Espiazione, Paolo li ammoniva dicendo:
[10]«Vedo,
o uomini, che la navigazione comincia a essere di gran rischio e di
molto danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le
nostre vite».
[11]Il centurione però dava più
ascolto al pilota e al capitano della nave che alle parole di Paolo.
[12]E poiché
quel porto era poco adatto a trascorrervi l’inverno, i più
furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a
svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e a
maestrale.
[13]Appena cominciò a soffiare un leggero
scirocco, convinti di potere ormai realizzare il progetto, levarono
le ancore e costeggiavano da vicino Creta.
[14]Ma dopo non
molto tempo si scatenò contro l’isola un vento
d’uragano, detto allora «Euroaquilone».
[15]La nave fu
travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento,
abbandonati in sua balìa, andavamo alla deriva.
[16]Mentre
passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a
padroneggiare la scialuppa;
[17]la tirarono
a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave.
Quindi, per timore di finire incagliati nelle Sirti, calarono il
galleggiante e si andava così alla deriva.
[18]Sbattuti
violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a
gettare a mare il carico;
[19]il terzo
giorno con le proprie mani buttarono via l’attrezzatura della
nave.
[20]Da
vari giorni non comparivano più né sole, né
stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni
speranza di salvarci sembrava ormai perduta.
[21]Da molto tempo
non si mangiava, quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse:
«Sarebbe stato bene, o uomini, dar retta a me e non salpare da
Creta; avreste evitato questo pericolo e questo danno.
[22]Tuttavia ora
vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà
alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave.
[23]Mi è
apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e
che servo,
[24]dicendomi:
Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco, Dio ti
ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione.
[25]Perciò
non perdetevi di coraggio, uomini; ho fiducia in Dio che avverrà
come mi è stato annunziato.
[26]Ma è inevitabile che
andiamo a finire su qualche isola».
[27]Come giunse la
quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell’Adriatico,
verso mezzanotte i marinai ebbero l’impressione che una qualche
terra si avvicinava.
[28]Gettato lo
scandaglio, trovarono venti braccia; dopo un breve intervallo,
scandagliando di nuovo, trovarono quindici braccia.
[29]Nel timore
di finire contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore,
aspettando con ansia che spuntasse il giorno.
[30]Ma poiché
i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano
calando la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da
prora, Paolo disse al centurione e ai soldati:
[31]«Se
costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo».
[32]Allora i
soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in
mare.
[33]Finché non spuntò il giorno, Paolo
esortava tutti a prendere cibo: «Oggi è il
quattordicesimo giorno che passate digiuni nell’attesa, senza
prender nulla.
[34]Per questo vi esorto a prender cibo; è
necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo
andrà perduto».
[35]Ciò
detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò
e cominciò a mangiare.
[36]Tutti si sentirono rianimati, e
anch’essi presero cibo.
[37]Eravamo
complessivamente sulla nave duecentosettantasei persone.
[38]Quando si
furono rifocillati, alleggerirono la nave, gettando il frumento in
mare.
[39]Fattosi giorno non riuscivano a riconoscere quella
terra, ma notarono un’insenatura con spiaggia e decisero, se
possibile, di spingere la nave verso di essa.
[40]Levarono le
ancore e le lasciarono andare in mare; al tempo stesso allentarono i
legami dei timoni e spiegata al vento la vela maestra, mossero verso
la spiaggia.
[41]Ma
incapparono in una secca e la nave vi si incagliò; mentre la
prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi
sotto la violenza delle onde.
[42]I soldati
pensarono allora di uccidere i prigionieri, perché nessuno
sfuggisse gettandosi a nuoto,
[43]ma il centurione, volendo
salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto; diede
ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e
raggiunsero la terra;
[44]poi gli
altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così
tutti poterono mettersi in salvo a terra.
*
In questo capitolo viene descritto il quarto e ultimo viaggio di Paolo, il primo da prigioniero, da Cesarea a Roma. Stando agli esegeti qui si è in presenza di uno dei più importanti diari di bordo dell’antichità. Ne è autore lo stesso Luca, che appare presente sin dal v. 1 («ci imbarcassimo»).
La comitiva era composta di 276 persone, quindi almeno la metà era costituita da prigionieri (per lo più ebrei) destinati ai mercati romani di schiavi. Capo della spedizione era un centurione chiamato Giulio, appartenente alla coorte Augusta, una delle cinque di stanza a Cesarea, ai tempi del governatore Quirino. Forse si tratta di quel Giulio Prisco che Vitellio avrebbe nominato prefetto delle coorti pretoriane.
Aristarco, un macedone di Tessalonica, già incontrato in At 19,29 e 20,4, viene qui citato in quanto accompagnatore di Paolo (era uno dei suoi principali collaboratori), quindi come persona libera. Sarà anche compagno di prigionia di Paolo, come da Col 4,10.
La prima tappa è Sidone e qui già si può notare come Paolo, cittadino romano, potesse fruire, col consenso del centurione, di privilegi impensabili agli altri prigionieri. Giulio sa bene che Paolo non è un prigioniero di guerra o un criminale comune e anche in quanto detenuto politico sa che non è un tipo pericoloso. Qui è da presumere che Paolo abbia ricevuto da alcuni discepoli di Sidone tutto quanto gli occorresse per intraprendere un viaggio piuttosto lungo.
La nave passa a nord di Cipro, allungando il viaggio, affinché l’isola li protegga dall’urto dei venti che soffiavano da ponente, poi tocca il mare della Cilicia e della Panfilia, e giunge dopo 15 giorni a Mira di Licia. Già da questi versetti si comprende bene che la nave stava compiendo un percorso molto noto a Paolo, infaticabile predicatore proprio in quelle e altre zone limitrofe.
A Mira di Licia Giulio trova una di quelle navi mercantili che portavano in Italia il grano d’Egitto: erano navi grandi che facevano regolarmente la traversata. Tuttavia, poiché il vento soffiava da ponente (da nord-ovest), non riuscivano a dirigersi direttamente verso la Sicilia, ma piuttosto in direzione sud-ovest, verso il promontorio all’estremità nord-orientale dell’isola di Creta, il capo Salmone. Creta viene poi costeggiata, a fatica, nella parte meridionale, nella speranza di potersi dirigere verso la Sicilia.
Viaggi come quello qui descritto si facevano soltanto in determinati momenti dell’anno (dall’11 novembre al 10 marzo il mare era clausum). Luca ci fa capire che stava cominciando l’equinozio d’autunno, cioè che si era verso la fine di ottobre, e il rischio di finire in una tempesta era diventato molto serio, per cui bisognava cercare un rifugio sicuro per l’inverno. Paolo, già reduce da tre naufragi (2 Cor 12,25), consiglia all’equipaggio romano di sospendere il viaggio e di fermarsi a Buoni Porti, ma il capitano e il suo pilota non ritengono adatto il luogo e, col consenso del centurione, decidono che si debba tentare di giungere, verso ovest, a un porto migliore (Fenice), riparato dai colpi di vento e che distava circa 34 miglia. Forse Fenice, rispetto a Buoni Porti, offriva maggiori garanzie di sicurezza anche per la detenzione dei prigionieri, in quanto per tutto l’inverno non sarebbero più potuti ripartire.
Appena doppiato il capo di Matala, poco dopo Buoni Porti, la nave venne colpita da un tifone che soffiava verso nord-est, detto Euroaquilone, ben conosciuto, e avendo la prua controvento evidentemente la nave non poteva proseguire e anzi finì alla deriva.
Ad un certo punto si decise di tirare a bordo la scialuppa di salvataggio, tenuta al traino, per non perderla o per impedire che si sfasciasse contro la stessa nave. Poi si cercò di rafforzare con robuste corde (le gomene) la chiglia della nave, introducendo tra le pareti dei fianchi alcune travi o dei legni per attutire i colpi in caso d’urto contro gli scogli; infine ammainarono le vele per diminuire al massimo la velocità e calarono il galleggiante per evitare il fondale basso della Sirti maggiore, al largo della costa di Cirene.
Il secondo giorno, per rendere la nave più leggera, buttarono a mare tutto quello che del carico potevano sacrificare; ma il terzo giorno bisognò dar mano anche alla mobilia, alle masserizie della nave. La tempesta però non accennava a diminuire e, poiché non lasciava neppure vedere il sole e le stelle per orientarsi, il timore di non farcela era divenuto grande.
Paolo, a quel punto, si rende conto che il rischio di un ammutinamento è molto forte: annegare o finire in qualche circo come gladiatore o presso qualche padrone romano come schiavo rurale o servo domestico, non sarebbe stato molto diverso per quei detenuti. Ecco perché di sua iniziativa si rivolge ai comandanti della nave, facendo capire di saperne più di loro.
La seconda parte di questo racconto è un esempio molto eloquente di cosa volesse dire, nel concreto, diventare seguaci del cristianesimo paolino.
Paolo non vuole che i prigionieri si ribellino approfittando dell’occasione, ma preferisce cercare un compromesso tra oppressi e oppressori. Proprio mentre parla ai comandanti della nave, egli in realtà sembra rivolgersi ai detenuti ebrei come portavoce del mondo romano e, come spesso succede in casi del genere, prende a svolgere un ruolo da imbonitore, raccontando fatti straordinari capitati solo a lui, i soliti sogni e le solite visioni. In tal modo ha anche la possibilità di fare propaganda del proprio vangelo, evitando tuttavia di citare il nome di Cristo, a cui probabilmente nessun detenuto ebreo lì presente credeva.
Scopo di Paolo è quello di far credere agli ebrei ch’egli era uno di loro, o quasi, in quanto, sebbene non incatenato come uno schiavo, era comunque costretto ad affrontare un processo a Roma in nome di una fede religiosa sconosciuta al mondo pagano.
C’è da dire che in racconti analoghi (si pensi p. es. a quelli omerici), appartenenti al mondo ellenico, gli aspetti mitologici sarebbero stati introdotti sin dall’inizio dell’evento, mentre qui, al contrario, è molto forte il realismo. Il genere fantastico, nei testi di ispirazione ebraica, appare più accettabile semplicemente perché inserito in un contesto in cui ci si può più facilmente immedesimare.
Le forze cosiddette «extraterrestri», in ciò che Paolo dice, non appaiono come indipendenti dalla volontà degli uomini, non trattano gli uomini come oggetto dei loro capricci, ma anzi sono un elemento di conforto, di sicuro aiuto, per quanto indimostrabile, ovvero accettabile solo con un atteggiamento di fede: anche da questo si può capire come il passaggio dall’ingenuo politeismo pagano (in cui il concetto di fato dominava incontrastato su qualunque altro concetto religioso) al più smaliziato monoteismo ebraico-cristiano vada qui considerato come una delle tappe dello sviluppo della coscienza umana verso l’ateismo o l’umanesimo laico.
In un primo momento i prigionieri sembrano accettare il compromesso, probabilmente perché si rendevano conto che se anche fossero riusciti a sopraffare la scorta armata, non per questo avrebbero ottenuto maggiori garanzie di sopravvivere al naufragio. Non a caso Paolo, facendo vedere d’avere più esperienza di tutti, aveva assicurato che la nave sarebbe comunque affondata.
L’occasione buona infatti giunge dopo quattordici giorni (dalla partenza di Buoni Porti) di deriva nell’Adriatico, come allora si chiamava tutta la parte del Mediterraneo fra Creta e la Sicilia. I marinai ebbero l’impressione, dal rumore delle onde che s’infrangevano contro la riva o dalle linee bianche della spuma, scorte, in qualche modo, malgrado l’oscurità della notte, o forse dai versi di alcuni volatili, che la terra fosse vicina. E ne hanno conferma usando lo scandaglio (20 braccia erano circa 37 metri di profondità).
Temendo di finire contro gli scogli, un gruppo di marinai getta da poppa quattro ancore, per fermare la nave, poi cerca di calare di nascosto la scialuppa in mare, pensando soltanto a fuggire. Tutto ciò deve essersi svolto in maniera molto repentina, coi favori dell’oscurità, facendo il minimo rumore.
Paolo, che s’era esposto facendosi portavoce dei prigionieri ebrei, garantendo che non si sarebbero ammutinati, non può ora rischiare l’accusa di tradimento o comunque di fare una pessima figura al cospetto del centurione, per cui avvisa quest’ultimo delle intenzioni dei fuggitivi. Sicché i soldati, che sicuramente sarebbero stati uccisi dai loro superiori se avessero lasciato fuggire i prigionieri, recidono le corde che sorreggevano la scialuppa e l’abbandonano in mare.
Cosa sia accaduto dopo questa sortita infelice di Paolo, che pensò anzitutto a mettersi dalla parte dei romani, è difficile dirlo. Se prima il compromesso poteva starci, in quanto l’ammutinamento non avrebbe assicurato una salvezza dal naufragio, che dire ora di questo atteggiamento delatorio? È difficile pensare che i marinai fuggitivi non abbiano pagato con la vita il loro sfortunato tentativo.
Spesso infatti quando non si ha il coraggio di dire la verità, i redattori del Nuovo Testamento la nascondono parlando di cose fantastiche, come quelle che si notano nei versetti 33-38, che sembrano un’edizione riveduta del miracolo evangelico dei pani, dove Paolo assume le sembianze di un novello Gesù di Nazareth (ma sono evidenti anche i riferimenti ai racconti sinottici dell’ultima cena). E questo al cospetto di un uditorio che tutto era meno che «cristiano»!
La contraddizione più stridente riguarda proprio il motivo del digiuno, poiché mentre al v. 21 il fatto sembra dovuto alla sfiducia di potersi salvare e forse anche alla scarsezza di viveri, in quanto molte cose erano state gettate in mare; al v. 33 invece si ha l’impressione che il digiuno sia volontario, cioè voluto per motivi più che altro religiosi o forse per protesta. Ma è impensabile un digiuno prolungato per quattordici giorni di 276 persone in balìa del mare (un numero già in sé molto elevato e poco credibile).
Inoltre mentre ai vv. 22-25 Paolo aveva promesso, in nome del suo Dio o dell’angelo avuto in visione, la vita salva a tutto l’equipaggio, senza condizioni, proprio perché egli avrebbe dovuto essere processato davanti a Cesare; al v. 31 invece dichiara che la presenza dei marinai è assolutamente necessaria ad assicurare la salvezza di tutti. (Da notare che il v. 34 è identico a Lc 21,18 s.)
È probabile che dopo la spiata di Paolo, Giulio si fosse convinto di poter contare su di lui al 100%, ma è non meno probabile che i giudei rimasti a guardare la fine dei fuggitivi, abbiano pensato che di Paolo non ci si potesse più fidare e che alla prossima occasione avrebbero dovuto essere più scaltri e risoluti.
Paolo, il cui cristianesimo qui vuole porsi al servizio dell’impero romano, sembra voglia convincere i detenuti ebrei che si salveranno non grazie alla fuga o alla ribellione, ma grazie alla sua intercessione (tra lui e il potere romano, tra lui e il Dio che lo protegge, diverso da quello tradizionale degli ebrei). Successivamente, coi versetti aggiunti dal 33 al 38, il redattore ha voluto far vedere che i detenuti potevano trasgredire o rinunciare al lungo digiuno di precetto, diventando così cristiani a tutti gli effetti. La «salvezza» dei detenuti qui viene interpretata in maniera del tutto distorta: come un qualcosa di fisico e di morale, lontano mille miglia da considerazioni di liberazione sociale, civile, politica.
Quando vedono la terra abbastanza vicina cominciano a organizzarsi diversamente: buttano via il frumento e le ancore, che ormai costituivano solo un’inutile zavorra (anche se c’era sempre il pericolo di sfracellarsi contro gli scogli), sciolgono le funi che tengono legati i due timoni (cioè i due remi di pala larga posti ai due fianchi di poppa) e li rimettono al loro posto per manovrarli (infatti erano stati tirati su e legati mentre la nave era ancorata) e, spiegata al vento la vela maestra (o di mezzana), si dirigono verso la spiaggia.
La nave s’incaglia in un fondale basso: evidentemente non avevano avuto modo di fermarla in tempo, pur usando lo scandaglio. Ora il pericolo è che si sfasci la poppa sotto il peso delle onde. Di fronte a ciò i detenuti pensano subito di fuggire, in quanto sarebbero bastate poche nuotate per ottenere la libertà.
La legge romana però parlava chiaro: il soldato che lasciava fuggire il prigioniero affidatogli, pagava la sua negligenza con la vita (cfr At 12,19; 16,27). Di qui l’idea di uccidere preventivamente tutti i prigionieri. Tuttavia il centurione scongiura la carneficina, ordinando che i capaci a nuotare si buttino in acqua per primi, seguiti dagli altri, con l’aiuto dei rottami della nave.
Incomprensibile, almeno apparentemente, che l’intervento di Giulio sia stato mosso dall’intenzione di salvare la vita di Paolo. Cioè quel che appare strano non è tanto che Giulio volesse salvare Paolo, quanto che i militari non sapessero già che andava risparmiato.
Un uomo che scongiura il pericolo di un ammutinamento e di una fuga dei prigionieri, che dichiara la propria lealtà a Roma e che per di più non avrebbe avuto alcuna intenzione di approfittare dell’occasione per mettersi in salvo, e che oltre tutto era cittadino romano, per quale motivo avrebbe dovuto essere ucciso?
Il motivo in realtà è uno solo: considerando Paolo un prigioniero come gli altri, lo si sarebbe aiutato a riscattarsi dalla colpa d’aver fatto il delatore per i romani e il traditore della causa ebraica. È stato necessario dirlo perché il finale è a doppio senso: «tutti poterono mettersi in salvo a terra» (v. 44), nessuno ovviamente riuscì a mettersi in salvo dal proprio destino.
torna suCap. 28
[1]Una
volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta.
[2]Gli indigeni
ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a
un gran fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la
pioggia ed era freddo.
[3]Mentre Paolo
raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera,
risvegliata dal calore, lo morse a una mano.
[4]Al vedere la
serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro:
«Certamente costui è un assassino, se, anche scampato
dal mare, la Giustizia non lo lascia vivere».
[5]Ma egli
scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male.
[6]Quella gente
si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma, dopo
avere molto atteso senza vedere succedergli nulla di straordinario,
cambiò parere e diceva che era un dio.
[7]Nelle vicinanze
di quel luogo c’era un terreno appartenente al «primo»
dell’isola, chiamato Publio; questi ci accolse e ci ospitò
con benevolenza per tre giorni.
[8]Avvenne che il padre di Publio
dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria; Paolo
l’andò a visitare e dopo aver pregato gli impose le mani
e lo guarì.
[9]Dopo questo fatto, anche gli altri isolani
che avevano malattie accorrevano e venivano sanati;
[10]ci
colmarono di onori e al momento della partenza ci rifornirono di
tutto il necessario.
[11]Dopo tre mesi salpammo su una nave di
Alessandria che aveva svernato nell’isola, recante l’insegna
dei Dioscuri.
[12]Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni
[13]e di qui,
costeggiando, giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò
lo scirocco e così l’indomani arrivammo a Pozzuoli.
[14]Qui trovammo
alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una
settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma.
[15]I fratelli di
là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al
Foro di Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a
Dio e prese coraggio.
[16]Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di
abitare per suo conto con un soldato di guardia.
[17]Dopo tre
giorni, egli convocò a sé i più in vista tra i
Giudei e venuti che furono, disse loro: «Fratelli, senza aver
fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono
stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei
Romani.
[18]Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi,
non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte.
[19]Ma
continuando i Giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a
Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio
popolo.
[20]Ecco
perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è
a causa della speranza d’Israele che io sono legato da questa
catena».
[21]Essi gli
risposero: «Noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo
conto dalla Giudea né alcuno dei fratelli è venuto a
riferire o a parlar male di te.
[22]Ci sembra bene tuttavia
ascoltare da te quello che pensi; di questa setta infatti sappiamo
che trova dovunque opposizione».
[23]E fissatogli un giorno,
vennero in molti da lui nel suo alloggio; egli dal mattino alla sera
espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di
Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù, in base alla
Legge di Mosè e ai Profeti.
[24]Alcuni
aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere
[25]e se ne
andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase:
«Ha detto bene lo Spirito Santo, per bocca del profeta Isaia,
ai nostri padri:
[26]Va’
da questo popolo e di’ loro:
Udrete con i vostri orecchi, ma
non comprenderete;
guarderete con i vostri occhi, ma non
vedrete.
[27]Perché
il cuore di questo popolo si è indurito:
e hanno ascoltato
di mala voglia con gli orecchi;
hanno chiuso i loro occhi
per
non vedere con gli occhi
non ascoltare con gli orecchi,
non
comprendere nel loro cuore e non convertirsi,
perché io li
risani.
[28]Sia
dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai
pagani ed essi l’ascolteranno!».
[29]E avendo egli
detto queste cose, i giudei se ne partirono, avendo fra loro stessi
una grande discussione.
[30]Paolo trascorse due anni interi nella
casa che aveva preso a pigione e accoglieva tutti quelli che venivano
a lui,
[31]annunziando
il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù
Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
*
La baia fra la Punta di Koura e Salmonetta, presso l’isola di Malta, ove approdarono i naufraghi, si chiama ancora oggi «Baia di San Paolo».
Vengono accolti «con rara umanità» (v. 2) dagli abitanti del luogo, perché in genere i naufraghi venivano spogliati dei loro beni se non addirittura uccisi. Luca fa qui capire che, nonostante l’arretratezza di quegli indigeni, rispetto alla civiltà greco-romana, la loro umanità era spiccata e genuina.
L’isola di Malta era, originariamente, una colonia fenicia. Cadde nelle mani di Cartagine nel 402 a.C. e fu ceduta a Roma nel 241 a.C. Il suo tempio di Giunone, molto importante e ricco, fu saccheggiato da Verrei, pretore romano della Sicilia. I maltesi quindi parlavano o greco o latino, o addirittura entrambe le lingue, visto che erano quelle ufficiali di chi li governava. È strano che qui Luca li definisca col termine di «barbari», allora usato in maniera convenzionale, per indicare quanti non parlavano una di queste due lingue. Non è da escludere che questi indigeni siano popolazioni primitive, dedite a caccia e pesca.
Luca tuttavia approfitta della loro ignoranza per descrivere un episodio indegno di uno scrittore del suo talento, ma è probabile che i versetti siano stati aggiunti in un secondo tempo, in quanto non hanno un nesso organico col resto del capitolo. A meno che non si tratti di un racconto molto particolare, che cerca di mascherare la fine improvvisa e inaspettata dell’apostolo: una morte banale che non poteva essere divulgata in quanto non conforme alla sua grande personalità.
«Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la Giustizia non lo lascia vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma, dopo avere molto atteso senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un Dio» (vv. 3-6).
Luca parla proprio di «vipera» e non di un serpentello qualunque, per quanto nel testo greco non sia così evidente ch’egli fosse stato proprio morso (la serpe infatti, contrariamente al suo naturale comportamento, gli era rimasta attaccata alla mano). Qui comunque il redattore ha tutto l’interesse a mostrare la superiorità del cristianesimo sul paganesimo, che è idolatra per definizione (quando non videro gli effetti immediati del veleno, i maltesi cominciarono a pensare che Paolo fosse un dio, al pari di Apollo o Esculapio, che passavano per divinità con potestà sopra i serpenti).
Soprattutto Luca ha necessità di mostrare come Paolo si fosse comportato, durante il naufragio, da delatore, sventando il tentativo di liberazione dei prigionieri, proprio perché godeva di una particolare protezione divina, infinitamente superiore a quella che poteva offrire la dea «Giustizia» o Nemesi, figlia di Giove e di Temi.
L’altro episodio fantastico che accadde sull’isola e che vede protagonista, ovviamente, lo stesso Paolo, è relativo alla guarigione del padre di Publio (quest’ultimo rappresentante del pretore della provincia di Sicilia, da cui Malta dipendeva), che era stato colpito da febbre maltese.
Anche qui gli Atti non hanno dubbi di sorta nel paragonare Paolo a Gesù Cristo. Sembra anzi che quanto più egli frequenti gli ambienti pagani, tanto più sia facile far vedere a questi ambienti superstiziosi, di alto o di basso rango, quanto sia superiore la civiltà ebraico-cristiana. Ma se il primo racconto può essere un camuffamento della morte di Paolo, questo indubbiamente rappresenta una sorta di canonizzazione.
È straordinario vedere con quale spregiudicatezza Luca (o chi per lui) si prenda gioco della creduloneria degli abitanti dell’isola e degli stessi lettori degli Atti. Qui infatti è evidente che se anche Paolo fu in grado di risolvere, con la sua scienza, un caso di difficile soluzione per una cultura primitiva come quella degli abitanti dell’isola, ciò non avrebbe dovuto in alcun modo favorire atteggiamenti ancora più superstiziosi di quelli consueti: «anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati» (v. 9). Questo poi senza considerare che tutte le culture primitive hanno sempre avuto conoscenze mediche di tutto rispetto, da cui allora dipendeva la medicina delle civiltà più avanzate.
A parte queste stravaganze, che difficilmente potrebbero essere attribuite a una persona seria come Luca, per di più medico di professione, non può certamente sfuggire al lettore che l’autore di questo capitolo non dice assolutamente nulla della fine che fecero i 276 naufraghi (che salparono dopo ben tre mesi), in quanto là dove si scrive che Publio li ospitò per tre giorni (v. 7), occorre intendere, al massimo, soltanto Paolo, Giulio e lo stesso Luca. Solo in alcuni manoscritti è stato aggiunto, evidentemente per colmare una lacuna macroscopica, che «il centurione, arrivato a Roma, consegnò i prigionieri al prefetto del Pretorio».
Sia come sia, la comitiva riuscì a riprendere il viaggio imbarcandosi su una nave alessandrina, che caricava il grano e faceva commerci fra Egitto e Italia e che aveva svernato sull’isola. La prima tappa fu Siracusa, una delle città più floride della Sicilia, dove stettero tre giorni, poiché aspettavano il vento favorevole al proseguimento del viaggio. La seconda tappa fu Reggio Calabria, dove si fermavano sempre le navi che da Alessandria venivano in Italia.
Poi, levatosi l’Austro, il vento di mezzogiorno, fu la volta di Pozzuoli, il porto principale di Roma e grande emporio ove convenivano la navi egizie recanti il grano che sostentava il popolo romano. Qui inspiegabilmente gli Atti affermano che Paolo e Luca (di Aristarco non si dice più nulla) furono ospiti, addirittura per una settimana, di «alcuni fratelli» (v. 14). Evidentemente Paolo godeva di ampia fiducia da parte di Giulio, anche se non doveva mancare la scorta, come infatti risulta al v. 16.
Ma chi siano queste persone non è dato sapere: molto probabilmente sono degli ebrei chiamati «fratelli» solo in senso lato, che non sapevano nulla di Paolo (come risulta dal v. 21) o che forse lo conoscevano solo come persona autorevole o addirittura come persecutore dei cristiani. Qui non viene neppure ricordata l’importantissima Lettera ai Romani ch’egli scrisse a Corinto negli anni 57-58. C’è però da dire che Luca non cita mai alcuna lettera di Paolo.
I «fratelli» di Pozzuoli avvisano quelli di Roma, affinché si preparino ad ospitare Paolo e Luca. A Roma s’incontrano, molto stranamente, con due diverse comitive nei pressi del Foro di Appio e alle Tre Taverne: il primo, a 43 miglia da Roma, era luogo dove i venditori girovaghi e i mercanti si fermavano a bere; le Tre Taverne invece distavano circa 33 miglia da Roma. E con questi Paolo ha una prima breve conferenza, in cui spiega loro, molto genericamente, ch’era a causa della speranza d’Israele ch’egli portava le catene, «senza aver fatto nulla contro il popolo e contro le usanze dei padri» (v. 17).
A Roma, nel suo alloggio, Paolo ha una seconda conferenza, e questa volta sono presenti anche i capi giudei della comunità locale, che vogliono conoscere in dettaglio il motivo del suo arresto. Naturalmente Paolo dà la sua versione dei fatti, che i giudei lì presenti, non conoscendoli, non possono smentire, non avendo avuto di lui – anche questo molto stranamente – alcuna notizia negativa, per quanto sappiano che la setta del cristianesimo incontri ovunque forti opposizioni (v. 22). Egli comunque presume di dimostrare che «la legge e i profeti» avevano trovato il loro lento, graduale e sicuro compimento non in un regno terreno, politico-nazionale, ma in un regno dei cieli, di tipo etico-religioso: Gesù è l’unico vero figlio di Dio, quindi più grande di tutti i patriarchi, di Mosè, di tutti i re e profeti che Israele abbia mai avuto, semplicemente perché è «risorto».
Come si può notare, Paolo iniziò a comportarsi coi giudei di Roma esattamente come fino a quel momento aveva fatto coi giudei della diaspora. Infatti, dopo aver parlato con lui «alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere e se ne andavano discordi tra loro» (vv. 24-25).
La chiusa degli Atti è un semplice replay di altre analoghe conclusioni di precedenti capitoli, al punto che si ha l’impressione che Paolo sia già morto o sia diventato un soggetto che ormai ha fatto il suo tempo, in quanto i nuovi cristiani di origine pagana non cercano neppure un rapporto col mondo ebraico. Si ha quasi l’impressione che a Roma abbiano celebrato il suo funerale.
Luca e Paolo vogliono far sembrare il cristianesimo un inveramento o superamento dell’ebraismo classico, ma il tentativo – come al solito – viene condiviso solo da un’infima minoranza, al punto che viene citato Isaia ad uso e consumo della propaganda ideologica del cristianesimo paolino, cioè senza alcun riferimento contestuale. Il v. 28 infatti sarebbe stato improponibile anche per il profeta più progressista.
Ma la cosa più curiosa viene detta nell’ultimo versetto, in quanto Luca fa capire che Paolo a Roma poté sfruttare le sue conoscenze tra i romani, la sua stessa cittadinanza romana per poter predicare nel proprio alloggio preso in affitto per ben due anni, «con tutta franchezza e senza impedimento» (v. 31). Come se fosse la cosa più naturale di questo mondo che un accusato politico fosse tenuto prigioniero a Roma per ben due anni, senza che un qualche atto di procedura fosse fatto.
Gli esegeti si sono lamentati assai di questa laconicità di Luca, di questa conclusione repentina del romanzo, della voluta assenza di riferimenti circa la fine dell’apostolo. In realtà più chiaro di così Luca, che a Roma non andò mai, non poteva essere.
Secondo alcuni esegeti Paolo scrisse a Roma le Lettere agli Efesini e ai Colossesi, il biglietto a Filemone (con cui rimanda al padrone lo schiavo Onesimo, ch’era fuggito), e forse anche le Lettere ai Filippesi. Altri pensano che tutte queste lettere siano state scritte a Cesarea. Dopo i due suddetti anni sarebbe andato in Spagna (come da Rm 15,24). Dopo il 62-63 avrebbe scritto, forse dalla Macedonia, la prima Lettera a Timoteo e quella a Tito. Più tardi, di nuovo a Roma, la seconda Lettera a Timoteo, e nella capitale sarebbe morto sotto Nerone dopo una seconda prigionia.
Mappe
[Primo e secondo viaggio di Paolo]
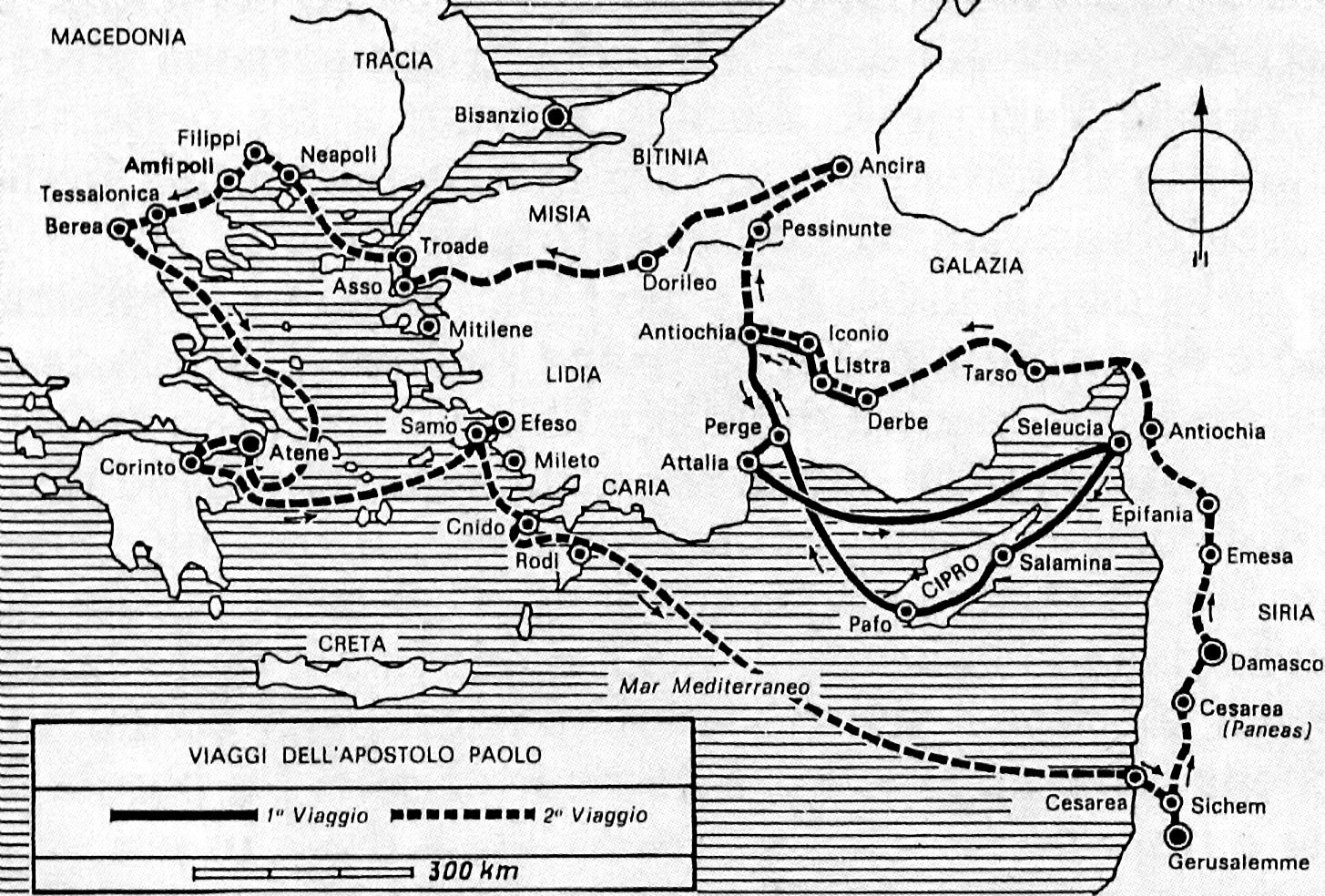
[Terzo e quarto viaggio di Paolo]

1 S. Brandon, Gesù e gli zeloti, ed. Rizzoli, Milano 1983, ma di lui bisogna leggersi anche La caduta di Gerusalemme e il Processo a Gesù.
2 Il 135 è l'anno della definitiva distruzione di Gerusalemme ed è l'anno in cui i cristiani di origine giudaica scomparvero. La loro memoria è conservata solo molto debolmente negli Atti, i quali non avrebbero mai potuto parlare di “ascensione” prima del 135. Questo non vuol dire che parte degli Atti non sia stata scritta prima. Il testo però non è stato concluso da Luca (non pochi esegeti sostengono che l'autore aveva semplicemente a sua disposizione un diario di viaggio tenuto da un compagno di Paolo). Consideriamo inoltre che quanto attribuito a Pietro (e molto di quello attribuito a Paolo) ha un carattere completamente leggendario: il che presuppone la scomparsa anche di quelle generazioni coeve ai due protagonisti. Luca inoltre non sa nulla delle lettere di Paolo, che infatti vennero raccolte solo nel II secolo.
3 Abbastanza strana qui la presenza della madre di Gesù, nei cui confronti il vangelo di Marco non era certo stato tenero e che solo il quarto vangelo cita fra le donne ai piedi della croce. Probabilmente la figura di Maria venne recuperata quando cominciò a diffondersi il mito del parto verginale.
4 Giuda il Galileo, che capeggiò una rivolta antiromana, fu giustiziato poco prima del censimento di Quirinio del 6-7 d.C.: duemila zeloti galilei furono crocifissi dal governatore Varo. Teuda fu decapitato dai Romani intorno al 44-45. I figli di Giuda, Giacomo e Simone, vennero crocifissi dai Romani nel 46 circa.
5 Sulla figura di Giacomo il Giusto (personaggio centrale della chiesa giudaico-cristiana dal 40 al 60 e principale avversario di Paolo) bisogna leggersi il testo, assai corposo, di Robert Eisenman, Giacomo, il fratello di Gesù, ed. Piemme, Casale Monferrato 2007. Qui si può far notare che, secondo lui, il «Cefa», di cui parla Paolo nella lettera ai Galati, non è affatto Pietro, ma Simeone bar Cleofa, cugino di Giacomo e suo successore alla carica di vescovo della comunità cristiana di Gerusalemme, sempre che Cleofa sia stato fratello o cognato di Giuseppe, padre di Gesù. Questo perché l'eredità della missione di Gesù fu presa soprattutto dai suoi parenti giudei. Noi invece vorremmo aggiungere che neanche Giovanni è il figlio di Zebedeo, ma probabilmente quel Giovanni l'Anziano o il Presbitero che alterò il vangelo dell'apostolo.
6 Si noti come la parola «tenda» usata da Paolo, appartenga al linguaggio dei misteri orfici. Il dio principale della città di Tarso, al tempo di Paolo, era un certo Sandan, che muore e risorge, come i suoi omologhi pagani: Adone (Siria), Attis (Frigia), Osiride (Egitto) e Tammuz (Babilonia). L'espressione paolina, apparentemente indecifrabile, «rivestirsi in Cristo», è frutto di antiche credenze della sua città, relative al risorgere della natura, dopo essere morta sotto gli strali cocenti del sole.
7 Per «monolatria» s'intende la fede in un solo dio senza però escludere l’esistenza e il culto di uno o più dèi minori. Il culto dell’imperatore cominciò ad essere tributato ad Augusto nelle province orientali, e Caligola fu il primo che cercò d’imporre con forza la propria divinizzazione mentre era ancora in vita.
8 Per vincere il culto di Artemide i cristiani, quando la loro religione diverrà l’unica ammessa, dovranno inventare due leggende: quella della permanenza di Maria, madre di Gesù, a Efeso, al seguito dell’apostolo Giovanni, cui il Cristo in croce l’aveva affidata, e quella dell’ascesa in cielo della stessa Maria.
9 Anania fu sommo sacerdote nel 47. Tratto in arresto e inviato a Roma, fu destituito nel 51-52. Riabilitato, venne assassinato nel 66, all’inizio della guerra giudaica.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube