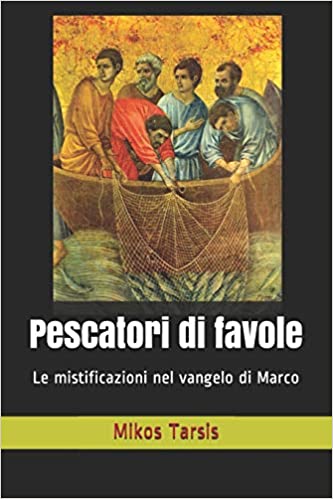
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
PESCATORI DI FAVOLE
Le mistificazioni nel vangelo di Marco
Introduzione - 1) Biografia di Marco - 2) Il vangelo di Marco - 3) Una nota sul genere letterario del vangelo - 4) La predicazione di Gesù - 5) L'attacco contro il giudaismo - 6) L'uso distorto delle parabole e delle guarigioni - 7) Il background dei pani miracolati - 8) Le diatribe del Cristo - 9) La svolta petrina - 9.1) Addendum sulle guarigioni - 9.2) Addendum sul segreto messianico - 10) Il viaggio verso Gerusalemme - 10.1) Addendum sul giovane ricco - 11) L'ingresso trionfale nella Città Santa - 11.1) Addendum sul fico sterile e seccato - 11.2) Addendum sui vignaioli omicidi - 11.3) Addendum sulla povera vedova - 12) Il discorso sul Monte degli Ulivi - 13) La fine del messia politico - 14) I due processi farsa - 15) La sepoltura - 16) La scomparsa del corpo - 16.1) Post scriptum 1 - 16.2) Post scriptum 2 - Conclusione - Appendice
I
Il primo libro che scrissi sui vangeli riguardava le guarigioni e gli eventi miracolosi. Lo intitolai I malati dei vangeli. Saggio romanzato di psicopolitica. Feci finta che fosse tutto vero e mi chiesi, escludendo che il Cristo volesse dimostrare d'essere una divinità, se si poteva arguire la politicità del suo messaggio di liberazione, estrapolando da quei racconti alcuni valori umani o esistenziali o delle considerazioni di tipo etico.
Fu appunto un'operazione di "psico-politica", che mi aiutò a capire la dipendenza di Luca e di Matteo da Marco, nonché l'autonomia di Giovanni rispetto a Marco. Tuttavia oggi non la ripeterei, poiché sui vangeli non si può lavorare e concessis, cioè dando per scontato, col pretesto che non si hanno altre fonti, che le cose siano andate, più o meno, come descritte, salvo il fatto, ovviamente, che non si può parlare di un Cristo teologo o divino-umano.
A dir il vero cercai di affrontare le guarigioni sostenendo che potevano essere virtualmente alla portata di chiunque, e che in ogni caso, per loro tramite, Gesù non chiedeva di avere "fede in Dio", ma semmai in se stessi o, al massimo, nel guaritore, ovviamente non in quanto guaritore bensì in quanto leader politico, il quale, in attesa della liberazione nazionale, si limitava a concedere grossi favori personali alle persone più bisognose. Oppure le guarigioni le interpretavo simbolicamente, nel senso che il cieco è colui che non vuol vedere, che ha una visione scettica della vita, ecc.
Oggi invece penso che ai vangeli non si possa concedere nulla. Essi sono una mistificazione in piena regola, se non dal primo versetto all'ultimo, quasi. Se si concede qualcosa su qualche punto, ecco che i clericali ne approfittano subito per farci dire delle cose che non abbiamo mai detto e neppure pensato. Questo per dire che nel presente libro il lettore non può sperare di trovare analisi dettagliate di questi racconti fantastici. Se proprio lo desidera si deve andare a leggere quel delitto di gioventù.
II
Prima di accingersi a esaminare i vangeli uno dovrebbe leggersi qualcosa di Samuel Brandon o di Karlheinz Deschner: il primo perché fa capire bene la tendenziosità di questi testi, ovvero la volontà dei redattori di spoliticizzare al massimo la figura di Gesù, onde poter favorire il compromesso tra cristianesimo e paganesimo e tra chiesa e Stato1; il secondo è utile per poter capire le dipendenze del cristianesimo dal paganesimo, soprattutto quando si narrano cose inverosimili, al di là della portata di qualunque essere umano.
Sinceramente parlando questo secondo aspetto mi ha sempre interessato poco, in quanto preferisco dare per scontato che là ove vi sono fatti che vanno oltre l'umana capacità, si è sempre in presenza di una falsificazione o mistificazione o invenzione pura e semplice. Che poi essa dipenda più dalla mitologia greca che non dalle fantasticherie del mondo ebraico, non fa molta differenza. Mi pare irrilevante sostenere che i vangeli non sono autentici o che non possono essere definiti delle "fonti storiche", in quanto contengono aspetti irrazionali, desunti appunto dal paganesimo o dall'ebraismo veterotestamentario.
La metodologia che ho sempre cercato d'applicare è stata quella di individuare le mistificazioni all'interno degli stessi vangeli, le quali, in genere, hanno per oggetto il contenuto politico del messaggio originario del Cristo. Trovate queste, il resto viene da sé. Al massimo si può cercare di capire i motivi per cui si sia voluta stravolgere un certo tipo di realtà piuttosto che un'altra.
Non bisogna mai dimenticare che i vangeli sono frutto dell'ideologia petro-paolina, presente anche in quello attribuito a Giovanni Zebedeo, un testo molto manipolato, e che tale ideologia ha permesso la confluenza di varie culture, laiche e religiose, nell'ambito del cristianesimo, mediante le quali essa ha cercato di mostrare la propria sostanziale differenza dal giudaismo.
A volte ci si chiede, in considerazione dei tre cocenti smacchi subiti dagli ebrei nelle loro insurrezioni antiromane del 66-73, del 115-17 e del 132-352, che possibilità avesse il Cristo di farcela. Cioè ci si chiede se erano più maturi, in senso rivoluzionario, i suoi tempi o se non sia stato proprio il suo movimento a rendere più rivoluzionari i tempi della prima grande guerra giudaica.
Su questo - bisogna ammetterlo - non vi sono grandi studi. Di sicuro si può fare la seguente osservazione: ogni rivoluzione comporta un margine di rischio, che può anche essere mortale; è impossibile che il Cristo non lo prevedesse. Sarebbe stato un avventuriero e, in tal caso, non si capisce perché non abbia fatto un colpo di stato, o quanto meno perché non abbia accettato l'offerta dei 5000 Galilei di salire a Gerusalemme e fare l'insurrezione. E soprattutto non si capirebbe una cosa: per quale motivo un Cristo "teologico" va considerato altamente responsabile, disposto a eseguire a puntino la volontà del Padre, mentre un Cristo "politico" sarebbe stato un folle irresponsabile, che avrebbe fatto rischiare la pelle a migliaia o addirittura a decine di migliaia di persone?
Personalmente ritengo che se egli accettò l'idea di compiere l'insurrezione armata, doveva avere un certo margine di probabilità di successo. In tal senso potremmo dire che non il Battista ma lui stesso ha anticipato le insurrezioni ebraiche dei decenni successivi. Ai tempi del Cristo la misura era già colma, non solo perché l'oppressione romana era diventata assolutamente insopportabile, ma anche perché la casta sacerdotale, gli scribi e gli anziani, in una parola il Sinedrio (composto da 71 membri) non stavano svolgendo alcun ruolo propositivo. Era giunto il tempo di procedere a una liberazione nazionale non solo del nemico esterno, ma anche di quello interno.
Semmai si dovrebbe cercare di capire il motivo per cui fallirono tutte le altre grandi rivolte. In tal caso possiamo ipotizzare una spiegazione, che però andrebbe approfondita: Gesù cercava una mediazione politica tra Giudei, Galilei e Samaritani. Dopo la sua sconfitta i Galilei, con l'aiuto degli Idumei, cercarono di sottomettere preventivamente i Giudei, prima di muovere guerra a Roma, mentre i Samaritani agirono per conto loro. Tali divisioni furono fatali in tutte le insurrezioni.
(torna su)1) Biografia di Marco
I
Il nome di Marco ricorre più volte negli Atti degli apostoli, nelle lettere di Paolo e di Pietro. A volte viene anche chiamato col nome di Giovanni: questo perché Marco era il nome che usava per presentarsi negli ambienti pagani.
Figlio di una certa Maria, vedova e benestante, che aveva una casa a Gerusalemme, dove fu consumata l'ultima cena, dove si radunava la primitiva comunità cristiana e dove, probabilmente, si rifugiò anche Pietro dopo la sua fuga dal carcere erodiano (At 12,11 ss.).
Marco fu ad Antiochia con Barnaba, suo cugino (At 12,25), che aiutò il suo decollo nella comunità cristiana. Poi seguì sia Barnaba che Paolo nel primo viaggio apostolico di quest’ultimo attraverso Cipro e la Panfilia tra il 46 e il 47 (At 13,5). Separatosi da costoro a Perge per un grave diverbio con Paolo, se ne tornò a Gerusalemme, dove incontrò Pietro per il Concilio del 48 o 49. A causa di tale defezione, Paolo, quando intraprese il suo secondo viaggio nel 49-50, respinse la proposta di Barnaba di portare nuovamente Marco con loro, per cui i due cugini si diressero da soli a Cipro (At 15,37-39). A partire da quel momento il suo nome non compare più negli Atti degli apostoli.
Tuttavia negli anni successivi Marco fu di nuovo a Roma con Paolo prigioniero, di cui era ridiventato collaboratore, come attesta l'apostolo stesso nelle lettere ai Colossesi, a Filemone e nella seconda a Timoteo. In quella città fu pure collaboratore e discepolo di Pietro, che lo chiama affettuosamente "mio figlio" (1 Pt 5,13), forse perché l'aveva battezzato. In genere si pensa che Marco sia più vicino alle idee di Pietro che non a quelle di Paolo, ma si tratta di sfumature, in quanto la teologia paolina è una prosecuzione coerente, sebbene più radicalmente ellenistica, di quella petrina. Comunque Giustino, nei suoi Dialoghi, chiama il vangelo di Marco con l'espressione "Memorie di Pietro".
Dopo la morte di Pietro a Roma non vi sono più notizie certe su Marco. La tradizione lo vuole evangelizzatore in Egitto e fondatore della chiesa di Alessandria, della quale sarebbe stato il primo vescovo. Riguardo alla sua morte Eusebio sostiene che avvenne nella stessa Alessandria, dove fu ucciso facendo trascinare il suo corpo per la città. Di sicuro si sa che nell'828 le sue ossa furono trafugate da due mercanti veneziani, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, e portate nella loro città.
II
Lo stile del suo vangelo conferma che si tratta di un semita palestinese, che scrisse in greco per i Romani. Infatti la sua opera, che pur ha uno spiccato colore aramaico, presenta una notevole frequenza di latinismi (per due volte dà anche la spiegazione latina di due termini greci in 12,42 e 15,16). Che i suoi destinatari siano cristiani di origine pagana è dimostrato dal fatto ch'egli non pone il suo vangelo nella prospettiva dell'Antico Testamento (come invece fa Matteo), né spiega i costumi giudaici e spesso traduce i termini aramaici in greco.
Resta comunque il fatto ch'egli ha scarsa dimestichezza con la geografia della Palestina: p.es. Gerasa non è affatto sul lago di Genezaret ma a due giorni di cammino, e Betsaida non è un villaggio, ma una città. Inoltre in 2,26 scambia il sommo sacerdote Achimelec col figlio Abiatar.
È appurato dagli esegeti ch'egli non ha scritto il vangelo di getto, ma si è servito di vari materiali preesistenti, orali e scritti. Tuttavia egli non è un semplice compilatore, poiché è ben visibile l'impronta della sua personalità, tant'è che viene definito - come s'è detto - "interprete di Pietro" (è Papia, vescovo di Ierapoli, il primo ad attribuirgli la paternità del testo, il quale, a sua volta, aveva ricevuto la notizia dal presbitero Giovanni, vissuto nell'ambiente efesino nel 90-120).
Si pensa che la data di composizione finale oscilli fra il 60 e il 70, e comunque o subito prima o subito dopo la morte di Pietro, proprio perché quest'ultimo è stato il principale responsabile di una deformazione intellettualistica dell'originario pensiero gesuano, nonché di una mistificante interpretazione della sua strategia rivoluzionaria e dell'episodio della tomba vuota, che troverà in Paolo di Tarso uno svolgimento che lui stesso non riuscì a prevedere e inizialmente neppure a condividere.
Se Marco ha conosciuto Pietro a Roma nel 42, può aver iniziato il vangelo anche nel 44. Non è detto che abbia ricevuto l'approvazione definitiva da parte dell'apostolo, anche perché l'attuale vangelo canonico è stato oggetto di non poche revisioni, a partire dal titolo: "Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio", per non parlare della cosiddetta "piccola apocalisse" del cap. 13, che presume la distruzione del Tempio. D'altra parte tutti i vangeli canonici sono stati prodotti da Autori Vari in momenti successivi.
All'inizio vi furono non poche difficoltà ad accettarlo, data una certa mancanza di ordine, dovuta al fatto che l'intera predicazione di Gesù, sino alla sua morte, viene racchiusa nell'arco di un anno. Ma anche perché presentava le cose in maniera troppo sfavorevole agli apostoli e troppo umanizzata nei confronti del Cristo.
Col tempo però ci si convinse che Marco poteva essere addirittura considerato il creatore del genere letterario "vangelo"3; un genere molto particolare, che non vuol certo porsi come una biografia, quanto piuttosto come una confessione di fede su chi è il Cristo. Tutta la vita di Gesù è - come già detto - circoscritta nell'arco di un anno, senza alcun interesse, peraltro, per le sue origini familiari, la sua infanzia/adolescenza o il suo luogo di nascita, anche perché Marco sarebbe, in tal caso, costretto a parlare del giudaismo e non ha alcuna intenzione di farlo, se non in maniera negativa.4
Il finale del suo testo (16,9-20) viene considerato spurio, in quanto manca nei manoscritti più importanti. In pratica quindi esso termina con la constatazione della tomba vuota.
È il più breve dei vangeli, in quanto ha solo 16 capitoli e 661 versetti. Il punto centrale di esso è la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo in Galilea, raccontata in 8,27-30, con cui si chiude la prima parte del vangelo e si apre la seconda. Fino a Cesarea Gesù predica il suo vangelo a tutti, con un riserbo riguardante la sua persona (segreto messianico); a partire da 8,27 il riserbo rimane per le folle, ma non per i discepoli, i quali comunque fanno sempre molta fatica a capirlo.
Alcuni esegeti hanno creduto di vedere la firma di Marco in quel giovanetto che, nell'orto degli Ulivi, mentre Gesù viene catturato, scappa via nudo, lasciando in mano alle guardie il lenzuolo che lo ricopriva. In tal caso avrebbe conosciuto Gesù da bambino.
III
Sino alla fine dell'Ottocento il vangelo di Marco veniva poco consultato dagli esegeti, in quanto appariva come un riassunto malriuscito di Matteo. La liturgia pre-Vaticano II lo aveva estromesso quasi completamente dal lezionario. Inoltre veniva snobbato anche sul piano stilistico, poiché si è in presenza di una grande semplicità di esposizione, con un vocabolario abbastanza povero, benché colpisca il senso della concretezza.5
Tuttavia, dopo tale riscoperta6, si è cominciato ad attribuire a questo testo, pur essendo il più corto e con meno discorsi pronunciati dal Cristo, un'importanza considerevole, anzi eccessiva.
Indubbiamente fu alquanto significativo che, ad es., si fosse capito che l'impostazione generale della biografia di Gesù, da esso delineata, risultava, nelle sue linee fondamentali, pienamente condivisa nella stesura finale dei vangeli di Matteo e Luca. Si dovette inoltre constatare che, per quanto riguardava i racconti di guarigioni e di eventi miracolosi, Matteo e Luca avevano sostanzialmente copiato da Marco7, sintetizzando i suoi racconti e, a volte, aggiungendo dei particolari del tutto irrilevanti o addirittura inverosimili.
La stessa personalità di Gesù è molto più caratterizzata da Marco con particolari realistici (come p.es. la stanchezza, l'ira, lo sdegno, l'insofferenza...), che non negli altri due. Il che ha lasciato pensare a una testimonianza diretta, oculare (ovviamente in riferimento a Pietro), rifluita poi nel vangelo, che pur risulta prodotto da una redazione collettiva.
Oggi non è inusuale che l'esegesi laica arrivi a dire che Pietro, quando decise di dettare le proprie memorie a Marco sulla vita di Gesù, sapeva bene che l'unico che poteva contraddirlo era Giovanni, il più giovane e longevo degli apostoli. Gli altri o erano già morti o erano fuggiti lontano dalla Palestina o comunque non avrebbero avuto motivo, dopo aver accettato la sua idea di resurrezione, di smentirlo.
La generazione che aveva seguito Gesù, costituendo il movimento nazareno, era praticamente scomparsa negli anni 66-70, a causa della grande guerra contro Roma. A quel punto chi era riuscito a sopravvivere, tra gli apostoli, poteva raccontare ciò che voleva di Gesù Cristo. Probabilmente lo si era già fatto con la tradizione orale, come attesta la fonte Q. Una volta accettata l'idea di resurrezione, il resto veniva da sé. Si poteva produrre anche un vangelo scritto.
Pietro non ebbe scrupoli a inventarsi una storia molto fantasiosa, dal sapore di una biografia teologico-politica, che però venne contestata da Giovanni. Successivamente la Chiesa si preoccuperà di allineare il più possibile la versione giovannea con quella petrina, per il tramite della teologia paolina, e la prima cosa che farà, quella ritenuta fondamentale, sarà di eliminare qualunque riferimento identificativo all'apostolo Giovanni.
Senonché, da un po' di tempo a questa parte, ci si sta concentrando proprio sul vangelo di Giovanni, non solo perché esso riporta cose che i Sinottici non hanno trattato, ma anche perché le motivazioni con cui si pone in polemica nei loro confronti sono tutt'altro che spiritualistiche. Il quarto vangelo è stato per molto tempo sottovalutato sul piano laico, in quanto appariva, a causa del suo alto tasso di teologia, il più lontano dalla realtà dei fatti. Oggi invece si pensa ch'esso abbia un'importanza di molto superiore a quella di Marco.
Purtroppo però, mentre il protovangelo8 è il frutto di una manipolazione del vero vangelo (non scritto) del Cristo, quello di Giovanni è frutto di una manipolazione ancora più sofisticata, poiché esso ha ereditato la teologia petro-paolina, inserendola in una cornice molto mistica, di derivazione gnostica ed essenica, pur essendoci un substrato che, meglio di altri testi, lascia intuire una forte caratterizzazione politica nel messaggio di Gesù, per non parlare di quella ateistica.
Questo per dire che, se si vuole cercare di districare il filo di una matassa molto ingarbugliata, occorre partire da Giovanni e tenere sempre a mente che questo testo non si pone a completamento dei Sinottici, bensì come un loro superamento. E, a tale scopo, si dovrebbe guardare la Sindone non come uno strumento da utilizzare per confermare le tesi dei vangeli, ma, al contrario, come un reperto storico fondamentale per interpretare gli stessi vangeli.9 Ovviamente non come prova fisica della resurrezione, ma come prova della politicità del Cristo.
(torna su)2) Il vangelo di Marco
Il vangelo attribuito a Marco è stato scritto come se fosse una fiaba per adulti. Con questa differenza, che l'autore intende riferirsi a episodi realmente accaduti, di cui però non vuol dare le coordinate esatte per meglio interpretarli. Cioè i fatti vengono raccontati in una maniera volutamente deformata, anzi mistificata, e questo soprattutto in due direzioni: anzitutto si vuole presentare un messia spoliticizzato; in secondo luogo si vuole presentare un messia più galilaico che giudaico.
Questi due aspetti sono tra loro in contraddizione, almeno in parte, in quanto la tradizione galilaica, duemila anni fa, era connotata molto politicamente, e in maniera eversiva (basta vedere il ruolo determinante giocato dal partito zelota nelle guerre antiromane). Tuttavia la tradizione galilaica è anche quella più vicina agli influssi ellenistici, nei confronti dei quali l'ostilità giudaica era più netta. I Giudei consideravano i Galilei dei credenti di serie B e addirittura i Samaritani degli eretici, con cui era bene non avere alcun rapporto.
Il vangelo di Marco si è servito proprio dell'ellenismo (il cui interprete per eccezione era stato Paolo) per togliere al Cristo qualunque caratterizzazione politico-rivoluzionaria. La politicità del messia appare soltanto come una conseguenza indiretta della sua contestazione rivolta all'ideologia giudaica. Il messia Gesù è un teologo-politico che fa del proprio messaggio religioso un motivo per creare uno scisma all'interno del giudaismo. Marco presenta la predicazione del Cristo come una forma di cristianesimo galilaico in opposizione al giudaismo sadduceo e farisaico.
Ovviamente all'interno del suo vangelo sono confluite tradizioni di vario tipo, diverse dalla propria, che poi il cristianesimo primitivo ha accettato definitivamente, canonizzandole. Ma sono tradizioni che non determinano, in maniera decisiva, l'impianto teorico dell'opera, che ha una propria logica interna, da individuare in maniera chiara e distinta. Una di queste tradizioni spurie appare sin dall'inizio del vangelo (1,1-13), ed è quella del giudeo Giovanni, detto Battista o Battezzatore o Precursore.
È vero che Marco è stato un discepolo di Paolo (nel primo viaggio in Asia minore.), e anche di Barnaba (di cui era cugino), ma è anche vero che con Paolo ruppe molto presto, preferendo porsi al servizio di Pietro. E il vangelo lo scrisse a Roma, ascoltando la predicazione di quest'ultimo, che non era esattamente la stessa di Paolo, almeno non in un primo momento (ne fa fede la diatriba ch'essi ebbero ad Antiochia). Di questa precisazione bisogna sempre tener conto nella lettura del suo vangelo, benché Marco utilizzi Pietro come fonte quando questi ormai è prossimo al martirio e quindi molto vicino alle tesi di Paolo, la cui principale è appunto quella di qualificare Gesù come "unigenito figlio di Dio": un appellativo che Marco usa non solo come titolo del suo libro, ma anche nel momento da lui ritenuto più importante, cioè quando Gesù viene riconosciuto come tale dal centurione romano (15,39), che aveva materialmente predisposto la modalità della crocifissione.
Si può comunque dire, con ragionevole approssimazione, che né Pietro né Marco erano interessati a riportare la predicazione del Battista, né il battesimo10 e la tentazione di Gesù nel deserto. Il suo vangelo potrebbe iniziare benissimo al v. 1,14: "Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il vangelo di Dio". Marco non si sforza neppure di spiegare come i due eventi stiano insieme, cioè come il primo possa essere considerato una causa del secondo. Indicativamente quel versetto potrebbe essere interpretato così: dopo il fallimento della predicazione del Battista, Gesù lasciò la Giudea e si trasferì in Galilea, predicando nella stessa maniera: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo" (1,15).11
In altre parole Gesù, quale discepolo del Battista, dopo la cattura del suo maestro, preferisce predicare in Galilea. Qui Marco non spiega né da chi e perché Giovanni era stato messo in prigione, né il fatto, sufficientemente chiaro nel quarto vangelo, che tra Gesù e Giovanni vi fu una rottura circa la cosiddetta "epurazione del Tempio", in quanto Giovanni non vi aderì. Quella era stata una sorta di tentata insurrezione contro la casta sacerdotale, che non trovò l'appoggio neppure del partito farisaico, pur ostile a quello sadduceo.
Che Gesù venga presentato come un discepolo di Giovanni è attestato anche dalle parole riassuntive della sua predicazione: "regno di Dio" e "ravvedetevi". Parole che Gesù, essendo un politico rivoluzionario, assai diverso da Giovanni e non esattamente in linea col partito zelota, non poteva però averle pronunciate, proprio perché la prima era troppo teologica e la seconda troppo moralistica.
Marco inoltre ci tiene a sottolineare che i primi discepoli che Gesù chiamò alla sua sequela furono Pietro e suo fratello Andrea; solo dopo chiamò Giacomo e Giovanni Zebedeo. Fa passare tutti per Galilei, quando, in realtà, gli ultimi due erano Giudei. Nel quarto vangelo, tra i primi discepoli, Pietro non viene neppure citato, proprio perché non era un discepolo del Battista (semmai lo era suo fratello Andrea), e noi sappiamo che i primi discepoli di Gesù provenivano tutti dal movimento di Giovanni, dal quale si erano staccati per compiere l'attacco contro la casta sacerdotale. Pietro semmai può aver assistito, o anche aderito, a quella epurazione, in quanto esponente del movimento zelota.
Giacomo e Giovanni non erano affatto dei pescatori, ma non è da escludere che, una volta recatisi in Galilea con Gesù, si fossero messi a fare, per un certo tempo, proprio quel mestiere per poter vivere. Il fatto che qui tutti e quattro si siano messi a seguire Gesù, subito dopo aver ascoltato il suo invito, significa che si conoscevano da tempo.
(torna su)3) Una nota sul genere letterario del vangelo
In genere le biografie si scrivono sui morti, in quanto non ha senso farle sui vivi, altrimenti avrebbero a priori le caratteristiche dell'incompletezza, che difficilmente un autore potrebbe sopportare, a meno che non si tratti di un'autobiografia, come p.es. quella agostiniana.
Quando gli evangelisti hanno iniziato a scriverle, davano per scontato che non ci sarebbe stata alcuna parusia imminente del Cristo, per cui non aveva senso limitarsi alla narrazione orale, alle lettere estemporanee (quelle paoline e cattoliche) o alla scrittura dei detti (fonte Q).
Le biografie di Gesù sono testi politicamente rinunciatari, in quanto non prevedono un mutamento significativo nel presente. Fanno parte di comunità che si accontentano di sopravvivere, essendo stata Israele completamente distrutta.
Non solo, ma quando si cominciano a raccontare delle cose a chi non ne sa nulla, in quanto non era stato un testimone oculare, né aveva mai visto i luoghi ove gli eventi erano avvenuti, o aveva soltanto un vago sentore degli eventi accaduti, ad un certo punto viene naturale, da parte dell'interlocutore, chiedere una biografia del personaggio propagandato come eroe o martire.
La richiesta di una biografia fa parte della cultura ellenistica, viziata da quella curiosità intellettualistica tipica dei soggetti basati sull'individualismo.
La biografia, come genere letterario, è un concetto estraneo alla cultura ebraica, e se la vediamo apparsa nei vangeli, è stato solo perché i loro autori erano venuti a contatto col mondo pagano (Marco, Matteo, Giovanni...) o lo erano già da tempo (Luca).
In sé le biografie appartengono a un genere letterario semileggendario, in cui facilmente le cose vengono edulcorate o travisate o presentate in maniera tendenziosa o distorta, in quanto vi sono, a monte, degli interessi occulti o dei motivi inconfessati. Sicché anche quelle evangeliche non si sottraggono al genere delle biografie romanzate. Nel mondo romano il campione di questo genere letterario era Svetonio, criticato proprio perché nelle sue biografie degli imperatori s'interessava di più alle dicerie su di loro che non a vederli come espressione paradigmatica dei loro tempi: fu forse il fondatore delle biografie psicologistiche.
L'idea stessa di poter "descrivere adeguatamente" la vita di una persona, è illusoria per definizione. Quando gli evangelisti presero a farlo, sapevano già che su molte cose avrebbero dovuto mentire. In tal senso i vangeli spesso ci appaiono non meno incredibili delle agiografie dedicate ai santi.
Se vogliamo, è più affidabile una trasmissione orale delle conoscenze, anche se neppure questa è in grado di garantire l'autenticità di nulla.
Certo, ci possiamo chiedere perché, p.es., uno come Paolo, continuamente a contatto col mondo pagano, non abbia prodotto alcuna biografia di Gesù. Personalmente ritengo che non fosse interessato all'argomento perché all'inizio della sua carriera credeva sinceramente in una parusia imminente del Cristo, per cui lo strumento delle "lettere" era, secondo lui, quello più idoneo per attenderla e propagandarla (al massimo, di tanto in tanto, si cimentava in abbozzi di autobiografia). Quando invece rinunciò a questa idea, rinviandola al giudizio universale, non ebbe né modo né tempo per scrivere una biografia di Gesù. Le biografie, in fondo, appartengono a nature contemplative e hanno bisogno di una mentalità storiografica, cronachistica, certamente non quella di chi fa politica attiva. Non è da escludere ch'egli pensasse che uno dei suoi discepoli, Luca, fosse intenzionato a produrne una; così come fece Pietro con Marco.
(torna su)4) La predicazione di Gesù
I
Nel testo di Marco la predicazione del "vangelo" non avviene, da parte di Gesù, con dei discorsi, ma con dei fatti, e questi generalmente sono esorcismi e guarigioni miracolose.
La descrizione di quegli eventi straordinari ha un che di surreale, come spesso succede in questo protovangelo: p.es. Gesù dice di voler "predicare" in tutta la Galilea (1,38), ma, in realtà, non fa alcun discorso.
Marco lo presenta subito come un extraterrestre, una mezza divinità, un uomo dotato di poteri sovrumani, in grado di comandare gli spiriti immondi, di curare qualunque malattia, anche le più terribili come la lebbra e la tetraplegia. Guarisce tranquillamente di sabato, pur non avendo dei casi in pericolo di vita; lo fa in piena autonomia, senza appellarsi a Dio; anzi, perdona i peccati, cioè è in grado di giudicare dove sta il bene e il male, come se egli stesso fosse Dio, senza aver bisogno di confrontarsi con nessuno.
Marco presenta Gesù come un contestatore delle tradizioni ebraiche, dell'ideologia giudaica: "insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi" (1,22); "comanda con autorità perfino gli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono!" (1,27).
Guarisce il lebbroso dicendogli di mostrarsi al sacerdote e di portargli per la sua purificazione ciò che Mosè ha prescritto; e poi aggiunge: "Questo serva loro di testimonianza" (1,44). Perché questo livore? Marco non lo spiega. È partito in tromba, facendo capire subito che tra Gesù e gli scribi vi era un abisso d'incomprensione; eppure non c'è stato alcun dibattito: lui nelle sinagoghe insegna, ma che cosa non è dato sapere.
I racconti di miracoli ed esorcismi sembra siano stati messi a bella posta per celare il suo messaggio di liberazione. Peraltro ha qualcosa di abbastanza ridicolo che Gesù si servisse di guarigioni miracolose per annunciare un messaggio di liberazione. Di fronte ad esse chiunque avrebbe potuto pensare due cose: 1) è facile ottenere un vasto consenso popolare compiendo miracoli; 2) non è detto che chi compie miracoli meriti d'essere considerato un messia liberatore. Cosa c'entrano gli esorcismi e le guarigioni col vangelo di liberazione? C'è forse dell'antisemitismo in questo modo di esporre l'operato di Gesù? Infatti, se, al cospetto di prodigi del genere, tutti a favore di casi umani molto gravi, gli scribi continuano a pensare ch'egli "bestemmi" (2,7), allora Gesù faceva bene ad essere prevenuto contro di loro: essi non volevano ammettere l'evidenza, lo odiavano senza ragione. A questa conclusione un lettore può facilmente arrivare. Più avanti Gesù dirà che non ci può essere perdono per chi "bestemmia contro lo Spirito Santo" (3,29). Marco gli fa usare le parole "Spirito Santo" che agli ebrei erano del tutto sconosciute.
II
La predicazione di Gesù, che in questo vangelo viene fatta iniziare in Galilea, subito dopo l'arresto di Giovanni Battista, è sintetizzata da Marco in quest'unica frase, analoga a quella che diceva il Battista, divisa in due parti: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo" (1,15).
Ora, la domanda che qui ci si pone è la seguente: davvero Gesù voleva realizzare un "regno di Dio"? Ciò è tutto da dimostrare, sia perché un "regno" presuppone un "monarca", e Gesù non ha mai fatto nulla (neppure in questo vangelo) per volerlo diventare (tant'è che rifiuterà di marciare su Gerusalemme coi cinquemila Galilei che glielo chiedevano, e quando deciderà di farlo, sceglierà di entrarvi in maniera pacifica, in groppa a un asino e non a un cavallo: questo perché era un politico democratico, che avrebbe voluto fare un'insurrezione di popolo); sia perché un "regno di Dio" presuppone che il suo realizzatore abbia un interesse spiccato per la religione, e Gesù non ha mai fatto nulla per dimostrarlo, neppure in questo vangelo.
Infatti, non lo si vede mai compiere sacrifici al Tempio o dei gesti rituali, tipici delle usanze ebraiche (non crede neppure nel sabato e non ha mai detto di ritenere indispensabile la circoncisione). Si considerava superiore a Mosè e riteneva che il Battista, da cui pur si era distaccato polemicamente, a motivo dell'epurazione del Tempio, fosse il maggiore dei profeti che Israele avesse mai avuto. Quando frequenta le sinagoghe o lo stesso Tempio, lo fa per discutere non per pregare. Quando guarisce gli ammalati, non invoca mai il nome di Dio; né ha mai amministrato alcun sacramento (l'eucaristia gli è stata attribuita dalla teologia paolina, di derivazione ellenistica, in quanto per gli ebrei mangiare carne umana e berne il sangue sarebbe stato inconcepibile, anche solo sul piano simbolico).
Alla samaritana, nel vangelo di Giovanni, afferma che nei confronti della religione deve valere il principio della libertà di coscienza. Nei confronti dei Giudei ha il coraggio di sostenere che tutti gli uomini sono dèi (Gv 10,33), per cui non ha senso credere nella perfezione di un'entità esterna all'essere umano (peraltro il nome di Jahvè non appare mai nei vangeli, e il nome di "Signore" - a differenza di quanto si faceva nell'Antico Testamento - non viene mai attribuito a Jahvè). Lo stesso vangelo di Marco, quando parla della cosiddetta "resurrezione" di Gesù, non la descrive mai e non sostiene ch'essa sia stata opera di Dio, e questo nonostante che tutti i vangeli abbiano fatto di tutto per trasformare il Gesù politico in un Cristo teologico. Anzi, in questo vangelo "Dio" non è che un'entità astratta, un concetto che viene utilizzato per spiegare la morte di Gesù, il quale, essendo scomparso misteriosamente dal sepolcro e quindi lasciando pensare che avesse una natura sovrumana, non permetteva di credere in una casualità degli eventi.
Quindi non è proprio il caso di parlare di "regno di Dio", se non in riferimento agli zeloti, ai farisei, ai battisti, agli esseni... Gesù voleva soltanto liberare la Palestina dai Romani e dalla corrotta casta sacerdotale che sfruttava il Tempio per arricchirsi a dismisura e che aveva realizzato con l'invasore straniero un rapporto di reciproco interesse. La società che voleva costruire era di tipo democratico, basata sulla liberazione nazionale e sulla giustizia sociale.
E che, per realizzare questo, egli si rivolgesse soltanto agli ebrei, è vero sino a un certo punto. Nei vangeli non lo si vede mai fare distinzioni etniche di principio tra Giudei, Galilei, Samaritani, Idumei ecc., ma, al contrario, per liberarsi di Roma chiede la collaborazione di tutti. Non lo si vede rifiutare il contatto con città o territori o persone riguardanti il cosiddetto "mondo pagano"; anzi, frequenta la Decapoli, Tiro e Sidone, s'incontra con una donna siro-fenicia e coi Greci durante l'ingresso messianico, ecc. Peraltro i Romani avevano occupato la Palestina sin dai tempi di Pompeo: era impossibile non frequentare i loro ambienti o non avere a che fare con persone che realizzavano con loro rapporti d'affari (un ex pubblicano faceva persino parte della ristretta cerchia dei Dodici).
Gesù poteva constatare coi suoi occhi che tutto il Medioriente era dominato da Roma. Non avrebbe avuto alcun senso che la Palestina ebraica non cercasse alleati fuori del proprio territorio. Gli ebrei erano sicuramente una popolazione molto combattiva, ma contro Roma non avrebbero disprezzato l'aiuto di nessun'altra popolazione.
È tuttavia evidente che una liberazione "nazionale" va compiuta con la popolazione che soffre l'oppressione straniera, di cui si conoscono meglio usi, costumi, mentalità, tradizioni, cultura... Non si possono aspettare aiuti esterni "decisivi" per compierla. Una popolazione deve anzitutto aver fiducia in se stessa, nella propria capacità di liberarsi autonomamente. Gli aiuti esterni possono servire come forma di supporto, poiché nelle fasi tipiche degli scontri armati o delle rivoluzioni si ha sempre bisogno di un sostegno materiale o finanziario, essendo temporaneamente ridotta la gestione dell'economia, la vita lavorativa. Poteva risultare utile anche un appoggio straniero di tipo politico-diplomatico o propagandistico. Perché escluderlo? È assurdo pensare che gli ebrei volessero fare una guerra di liberazione nazionale per dimostrare d'essere una popolazione migliore di altre, sottoposte alla medesima colonizzazione romana.
Gli esegeti favorevoli all'idea secondo cui Gesù si rivolgeva esclusivamente agli ebrei, lo fanno o perché loro stessi sono di origine ebraica e sostengono che Gesù non fosse molto diverso dai migliori rabbini d'Israele e che il principale responsabile della sua morte fu Pilato e non Caifa; oppure perché credono di potersi opporre alla deformazione "ellenistica" della figura di Gesù (compiuta dalla teologia paolina), cercando di accentuare le sue caratteristiche giudaiche. Così facendo, però, sia in un modo che nell'altro finiscono col misconoscere o il lato eversivo della sua strategia politica (la liberazione nazionale contro Roma e l'abbattimento dell'aristocrazia sacerdotale), oppure quello eversivo della sua cultura, ch'era estranea alla sensibilità religiosa.
(torna su)5) L'attacco contro il giudaismo
Tutto il capitolo due del vangelo marciano è un attacco polemico contro le tradizioni ebraiche rappresentate dagli scribi e dai farisei presenti in Galilea.
Il paralitico viene guarito per far vedere che tra colpa e malattia non vi è alcuna relazione e che Gesù era in grado di guarire l'una e perdonare l'altra senza chiedere l'autorizzazione a nessuno. Si noti come qui egli si autodefinisca "Figlio dell'uomo"12 e non "Figlio di Dio" (2,10). In 1,24 viene chiamato dall'ossesso con due appellativi, "Gesù Nazareno" e "Santo di Dio", senza alcun riferimento alla sua esclusiva natura divina. Questo è importante per capire la differenza tra la teologia petrina (più materialistica) e quella paolina (più spiritualistica).
In questo capitolo Gesù smonta altre tre consuetudini, tipicamente rabbiniche: 1) quella di non frequentare peccatori e pubblicani13 per non contaminarsi moralmente: e qui se la prende con scribi e farisei, i quali non capiscono - si potrebbe aggiungere, ma certamente non per essere in linea con Marco - che a nessuno si può togliere il diritto di schierarsi contro chi opprime una determinata nazione (come lo era Israele da parte dei Romani); 2) quella di associare la rettitudine morale alla pratica del digiuno: e qui non polemizza solo con i farisei, ma anche col movimento battista, lasciando chiaramente capire - ma anche questo Marco non può dirlo - che contro Roma e gli ebrei collaborazionisti occorre un impegno di tipo politico, non essendo sufficiente puntare su istanze di tipo morale e individuale; 3) quella di fare del sabato un idolo da adorare: anche qui se la prende con i farisei, dicendo loro una sentenza d'importanza capitale, valida per ogni religione, filosofia e ideologia e anche per qualunque etica di ogni tempo e luogo: "Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato" (v. 27).
I farisei sono così inviperiti contro di lui che, nel racconto dell'uomo dalla mano secca (3,1-6), decidono addirittura di allearsi coi loro nemici in Galilea, gli erodiani, "per farlo morire" (v. 6).
Tutti questi presunti miracoli sono serviti per ridurre all'osso, in un tempo brevissimo, una controversia ideologica che invece dovette durare molti mesi, forse anni, in cui i contendenti erano su posizioni paritetiche, opposte sì, ma entrambe "umane", e non invece come appare nel vangelo, dove Gesù è in grado d'imporsi ideologicamente proprio perché l'interlocutore non ha gli stessi suoi straordinari poteri taumaturgici.
Marco ha trasformato il Cristo in un fenomeno da baraccone, in grado di fare prodigi portentosi su ogni tipo di malattia, anche se quando gli spiriti cosiddetti "immondi" gridano "Tu sei il figlio di Dio", lui li sgrida forte, "affinché non rivelino la sua identità" (3,11 s.). Diventa quasi patetico, anzi ridicolo far dire a Gesù che i demoni - che ovviamente, per la mentalità primitiva dell'epoca, non potevano che essere gli unici a conoscere l'origine di prodigi del genere - non devono rivelare chi egli sia veramente. Nelle figure retoriche della grammatica italiana, quando si finge di voler tacere ciò che in realtà si dice, si parla di "preterizione", ma si potrebbe anche chiamare in causa l'"antifrasi", che consiste nell’esprimere ironicamente l'opposto di quanto si vuole in realtà dire. In questo l'ironico Marco è maestro.
Di fatto i postulanti vengono da tutta la Palestina, e persino dalle città pagane di Tiro e Sidone, per vederlo e toccarlo (3,8). Qui si ha l'impressione - anche perché è stato usato l'appellativo "Figlio di Dio" - che un secondo redattore ne abbia approfittato per accentuare al massimo la straordinaria immagine che di Gesù ha voluto dare Marco.
Quando poi sceglie i Dodici14, li incarica proprio di predicare col "potere di scacciare i demoni" (3,15). Qui è impossibile non vedere come, parlando degli apostoli, Marco si stia in realtà riferendo alle figure sacerdotali post-pasquali, i cui poteri religiosi venivano gestiti appunto attraverso i sacramenti. Di qui l'affermazione esegetica, condivisa da tutti, secondo cui tale vangelo aveva anche una funzione di tipo "catechistico".
Di rilievo il fatto che ora l'apostolo più importante è Simon Pietro; Andrea viene messo dopo i due fratelli Zebedeo, qui chiamati "Boanerghes" ("figli del tuono")15, a motivo delle loro qualità personali, di cui Giacomo sembra essere maggiormente in possesso rispetto a Giovanni, probabilmente perché con questo Giacomo Pietro andava più d'accordo che non con Giovanni, o forse perché Giacomo era più anziano di Giovanni.
A dir il vero Pietro, essendo un galileo, non vedeva di buon occhio neppure i parenti di Gesù, tutti giudei. Nella pericope di 3,31 ss., dovendo scegliere tra gli interessi dei parenti e quelli del proprio movimento, Gesù mostra di non avere dubbi. Tuttavia non è da escludere che qui sia stata ricordata negativamente la madre di Gesù solo perché questa, dopo la morte del figlio, andò a vivere con l'apostolo Giovanni nei pressi di Efeso, allontanandosi dalla predicazione petrina. Troviamo comunque dei parenti di Gesù anche tra gli stessi apostoli.
(torna su)6) L'uso distorto delle parabole e delle guarigioni
Quando Marco parla delle parabole di Gesù si ha l'impressione che menta sapendo di mentire. Esse infatti venivano utilizzate quando il linguaggio non poteva essere diretto, a causa delle persecuzioni politiche, o quando, pedagogicamente, si pensava che fosse più efficace esprimere dei concetti astratti attraverso delle immagini.
Di sicuro Gesù non le raccontava allo scopo di non essere capito, come invece appare là dove afferma: "A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto accade in parabole, affinché guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato" (4,11 s.). Triste questo misticismo che fa dell'enigma un motivo di aristocraticismo politico!16
Cristo non era un semplice intrattenitore di folle ignoranti, che non avrebbero potuto comprenderlo sino in fondo. In questi passi marciani sembra di sentir parlare il Pietro già "cristiano", sfiduciato nei confronti del popolo, dei suoi compatrioti galilei, ch'egli stesso, d'altra parte, non seppe guidare, dopo la morte del Cristo, verso l'insurrezione nazionale.
Gli apostoli appaiono come una casta privilegiata, un'aristocrazia intellettuale, che non può, anzi non deve mescolarsi con lo spontaneismo popolare. Il popolo chiede miracoli, guarigioni, prodigi... e, siccome chiede solo questo, merita di non essere perdonato per le proprie colpe, almeno finché non capisce che si deve chiedere altro. E questo "altro", nel vangelo di Marco, è appunto il "regno di Dio", cioè quella cosa non fatta da mano d'uomo (acheropita, come certe immagini sacre); quella cosa che, in questo vangelo, appare coincidere con ciò che Cristo stesso fa e dice, dove la presenza del Dio-padre, tutto sommato, è abbastanza relativa, poco significativa.
Il "regno di Dio" è - nella teologia petrina - il "regno di Cristo"; egli è il nuovo "dio" in cui credere. Ciò viene dimostrato anche nel racconto della tempesta sedata (4,35 ss.), in cui Gesù è in grado di dare ordini, autonomamente, persino al vento e al mare.
Nella mente politicizzata del giovane Pietro il Gesù uomo (il "Figlio dell'uomo") era così grande che poteva anche sostituire il Padre eterno; nella mente teologizzata del Pietro maturo a Gesù vengono fatte compiere delle cose che solo un "dio" potrebbe fare. Gesù diventa un "dio" vero e proprio, che insegna agli uomini - soprattutto ai discepoli più stretti - a diventare delle "divinità"; solo che lo potranno diventare non per meriti propri. Egli infatti dice loro, che temono la forza degli elementi naturali: "Come mai non avete fede?" (4,40).
Ma fede in chi? in che cosa? Supponiamo che Gesù pretendesse la fede mentre era ancora in vita. Doveva per forza essere la fede in se stessi, individualmente e come gruppo apostolico, senza riferimenti alla religione. Dovevano essere convinti di poter compiere qualcosa d'importante, di poter diventare "pescatori di uomini".
Nel vangelo però le cose cambiano. Il Cristo non è più politico, bensì religioso. Di conseguenza la fede non è più la stessa. Diventa la fede in lui, nella sua divinità, nella sua onnipotenza. "Maestro non ti curi che noi periamo?" (4,38) - gli dicono, svegliandolo, mentre la loro barca è sballottata dalla tempesta. La risposta è un insegnamento di vita: "Perché siete così paurosi?" (v. 40).17
Dovevano quindi aver fede in se stessi o soltanto nel Cristo-Dio? Qui la differenza è sottile, ma è proprio su ambiguità del genere che si gioca la mistificazione di tale vangelo. Nella vita, infatti, nessuno avrebbe mai potuto fare gli stessi prodigi del Cristo, per cui quando lui dice di aver fede nella possibilità di compiere cose analoghe, sta in realtà auspicando un desiderio impossibile da realizzare. Ecco, la chiesa cristiana nasce e continuerà a svilupparsi sfruttando proprio tale impotenza operativa: essa infatti potrà sempre dire che gli uomini non hanno "abbastanza fede" per meritarsi la pienezza della grazia divina.
Cos'è questo: un modo di prendersi gioco degli uomini? Qui non solo l'evangelista disprezza le masse dei fedeli, ma induce anche i dirigenti di tali masse a un comportamento indegno. Essi infatti devono instillare nelle coscienze una sorta di "credulità popolare", quella che serve per illudersi che la soluzione dei problemi sociali e personali può avvenire solo "dall'alto"; e che, se questa non viene, è perché non ci si è pentiti abbastanza delle proprie colpe.
D'altra parte Marco non ha scrupoli nel prendersi gioco del lettore. Lo fa anche nel racconto dell'indemoniato geraseno, là dove sostituisce la paura del popolo ebraico nei confronti delle legioni romane con l'identità del demone che possiede il corpo di quel folle pagano: "Il mio nome è Legione, perché siamo in molti" (5,9). E riconosce Gesù quale "Figlio del Dio altissimo" (v. 7), come se il fatto che i demoni lo riconoscano nella sua divina natura, debba essere considerato, per il lettore, una garanzia sufficiente per la giustezza della propria fede cristiana.18
Qui la turlupinatura è doppia: le questioni politiche sono ridotte a questioni religiose (l'oppressione nazionale è trasformata in una possessione demoniaca); e le questioni religiose devono indurre a credere che Gesù, in vita, non si comportava come un uomo, bensì come un dio, in grado di fare prodigi che nessun uomo avrebbe mai potuto compiere. Marco non poteva scrivere cose così assurde se non fosse stato sicuro che nessuno avrebbe potuto smentirlo, e soprattutto se non avesse avuto il consenso da parte di un proprio autorevole superiore, che nella fattispecie era appunto Pietro.
Il fatto che il suo vangelo debba essere considerato una sorta di fiaba popolare è testimoniato proprio dall'uso spregiudicato delle guarigioni miracolose, che sono servite per mistificare situazioni o eventi di tipo umano e politico, che di religioso non avevano nulla.
Nel racconto dell'indemoniato geraseno vi è anche la denuncia dell'egoismo economico dei pagani della Decapoli, ma in un senso che stravolge la realtà dei fatti. Quegli abitanti si rifiutavano di combattere contro Roma (nel testo vuol dire che si rifiutavano di credere nell'esigenza di un "regno di Dio"), proprio perché erano strettamente legati ai loro affari materiali; e quando vedono la possibilità di superare l'egoismo materiale, non l'accettano soltanto perché rifiutano un Cristo taumaturgo. "Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la Legione, e s'impaurirono" (v. 15).
Cioè il rifiuto di allearsi politicamente coi nazareni viene deformato con il rifiuto di credere nella potenza dell'esorcismo. I geraseni vengono stigmatizzati non tanto perché non vogliono liberarsi dell'oppressore, quanto perché non vogliono redimersi del loro peccato di cupidigia, neanche di fronte a una guarigione miracolosa. Sotto questo aspetto Marco considera migliori gli ebrei, almeno quelli di modesta condizione sociale, che più facilmente possono assumere atteggiamenti religiosi; anzi - guardando il comportamento della emorroissa (5,25-34) - dovremmo parlare di atteggiamenti superstiziosi, in quanto la donna è convinta di poter guarire semplicemente toccando un lembo del mantello o della tunica di Gesù. E la fede superstiziosa la premia, proprio perché in tal modo viene avvalorata la tesi della divinità del Cristo.
Invece tra le persone ebraiche facoltose la fede religiosa non è mai una cosa così ingenua e semplicistica. L'archisinagogo Giairo, che pur non aveva impedimenti fisici come l'emorroissa per incontrare Gesù, lo cerca solo nel momento del bisogno più estremo: la morte della figlia (5,22 ss.). È vero ch'egli si prostra ai suoi piedi in pubblico (fatto del tutto eccezionale per un'autorità religiosa), ma è anche vero che i suoi parenti non perdono l'occasione per sbeffeggiare Gesù quand'egli afferma che la figlia non è morta ma sta dormendo (5,39 s.).
Il controsenso più inverosimile di questi presunti miracoli è che Gesù, da un lato, è disposto a compiere prodigi inusitati, mentre, dall'altro, chiede di non divulgarne l'accaduto. Marco lo fa comportare come un dio, ma poi gli fa dire di non volere che la gente lo sappia! Motivo di questa stranezza (che peraltro ritroveremo anche nel cosiddetto "segreto messianico")?19 Sembra che Gesù chieda alla gente di credere solo a titolo individuale, ovvero ch'egli tema che una fede collettiva possa indurlo a prendere delle responsabilità lontane dalla sua strategia salvifica etico-religiosa. Quand'egli vede che la popolarità è troppa, vi si sottrae, invece di indirizzarla verso qualcosa di più significativo delle singole guarigioni. Queste devono servire soltanto a credere nella sua divinità; in un certo senso devono sì essere finalizzate a uno scopo religioso, ma, tutto sommato, tale scopo deve rimanere fine a se stesso.
Non a caso qui non si vede - come nella predicazione di Paolo - l'esigenza di costituire comunità di seguaci, aventi dei compiti aggregativi, assistenziali e propagandistici. Solo gli apostoli vengono mandati in missione, ma di ciò che fanno, concretamente, non viene detto nulla. Gesù predica una nuova dottrina, sulla quale però Marco è silente, in quanto preferisce fargli compiere parecchi prodigi, il cui scopo è quello di meravigliare chi ne beneficia e chi li osserva, salvo poi sentirsi vincolati a non divulgarli, altrimenti il taumaturgo verrebbe soffocato da una miriade di richieste.
Gesù si propone come una sorta di "superman", ma, di tanto in tanto, lo si vede schermirsi di fronte all'incredibile popolarità causata dalle sue prodigiose guarigioni: e qui non si capisce se lo faccia per una falsa modestia o perché è una sua tattica particolare, avente un obiettivo non ben identificato.
In che cosa consiste il "regno di Dio" di cui si era parlato all'inizio del vangelo? Se doveva consistere soltanto nelle guarigioni miracolose, perché non organizzare una sorta di "catena di montaggio"? Marco lascia intendere che i miracoli dovevano servire per credere nella divinità di Gesù. Cioè quanto più essi erano portentosi, tanto maggiore doveva essere la possibilità, anzi la necessità di avere una fede in lui come essere "divino-umano". Però a volte Marco fa agire Gesù come se, con le sue guarigioni, volesse soltanto offrire un antipasto. Egli infatti si nasconde, cambia sede, sceglie chi miracolare..., come se volesse far capire ai suoi interlocutori che la grazia va meritata, ovvero che occorre una fede significativa, convincente: "ti ho dato un assaggio, ma il resto te lo devi guadagnare".
Qui si è in presenza non solo di una "istigazione alla credulità popolare", ma anche di una sorta di "circonvenzione d'incapace". Gli uomini non solo devono credere in cose assurde, ma devono farlo anche con convinzione. Tutti devono aver fede che qualunque cosa è possibile, se si crede. Ma "tutto" cosa? Dove sono gli altri problemi da risolvere, oltre quelli fisici o psicosomatici?
Quando, dopo aver fatto un'infinità di prodigi, egli torna nella sua Nazareth, insieme ai Dodici, il risultato è sconcertante: non gli crede nessuno (6,1 ss.)! Si meravigliano della sua sapienza, di cui però Marco tace; sanno che sa far guarigioni miracolose, ma non le ritengono sufficienti per credere che Gesù sia una persona straordinaria. "Non è questi il falegname20, il figlio di Maria e il fratello di Giacomo e di Ioses, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui" (v. 3).
La situazione, per come la descrive Marco, è così paradossale che alcuni esegeti han preferito tradurre il termine δύναμις, che appare in 6,2, come "potenze" (riferito al linguaggio) - come risulta in Gv 7,15 - e non come "prodigi" (riferito ai miracoli), anche perché i suoi compaesani, essendo la prima volta che in questo vangelo Gesù viene nella sua patria (adottiva), non hanno ancora potuto vederlo in azione. Possono aver sentito parlare di lui e dei suoi prodigi, ma il loro dubbio potrebbe anche riferirsi alla sua saggezza o alla sua capacità di agire (come dimostrato nella sinagoga di Cafarnao). Lo stesso termine, tuttavia, in 6,5, esprime un chiaro riferimento alla sua attività taumaturgica.
Si noti comunque che il padre di Gesù, Giuseppe, non viene neppure ricordato, nonostante che nel mondo ebraico si identifichi un uomo in rapporto a suo padre. Infatti, mentre Matteo (13,55) parla di "figlio del falegname", Marco invece si limita a dire "il falegname, figlio di Maria". D'altra parte perché parlare del padre, visto ch'egli è "Figlio di Dio"? Che figura ingombrante questo Giuseppe! Il quale però, visti i tanti figli di Maria, doveva pur esserci stato! Infatti Gv 6,42 ne parla. Grazie comunque a Marco veniamo a sapere che Gesù non era figlio unico, ma che la madre aveva partorito almeno altri quattro maschi e varie femmine.21 Possibile che nessuno di loro credesse in Gesù? Possibile ch'egli si fosse sentito in dovere di affermare che "nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua" (v. 4)? Disprezzato per le guarigioni miracolose che faceva? Ha senso un atteggiamento del genere? Chi mai avrebbe avuto il coraggio di farlo? Forse Marco voleva dire che, vedendolo esporsi così pubblicamente contro Roma, i suoi parenti temevano per la loro sorte? Se l'avesse fatto sarebbe stato più comprensibile, anche perché in questa maniera si sarebbe capito il significato della parola "profeta", usata da Gesù; e avremmo anche potuto capire che lo emarginavano non per quello che faceva ma per quello che diceva.
Non avendo detto nulla sulle sue parole, Marco diventa quasi un classista o addirittura un razzista, creando delle divisioni insostenibili: infatti, quando mai Gesù veniva accettato solo dagli estranei? Nella Palestina di allora, in cui i rapporti di sangue erano fondamentali, sarebbe stato impossibile mettere in piedi un movimento popolare escludendo l'apporto dei parenti.
Ancora una volta Marco vuol porre una differenza abissale tra "popolo" e "apostoli". All'interno del popolazione solo qualcuno, individualmente preso, merita d'essere considerato "discepolo". Gli altri sono seguaci sensu lato, massa informe che seguiva Gesù per ottenere qualcosa in cambio e che in genere lo rifiuta quando la classe dirigente diventa minacciosa nei confronti della sua predicazione.
Marco è così refrattario nel riportare le parole della "campagna elettorale" di Gesù (letteralmente soffocate dagli innumerevoli miracoli) che anche quando parla della missione propagandistica degli apostoli (peraltro già detta in 3,13 ss.), si limita semplicemente a dire che "predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano" (6,12 s.). Una descrizione del tutto irreale, in quanto li fa agire come se fossero dei sacerdoti; l'esegesi critica direbbe che è una descrizione post-pasquale, in cui elementi del cristianesimo petro-paolino si sovrappongono nettamente, sino a renderli irriconoscibili, a elementi storicamente attendibili.
Cioè che Gesù mandasse i suoi più stretti collaboratori a fare proseliti per l'imminente insurrezione armata contro Roma, può apparire piuttosto scontato; ma che li mandasse a esorcizzare, ad amministrare sacramenti e a compiere guarigioni, ciò è del tutto inverosimile, anche perché - a questi livelli - essi non avrebbero fatto qualcosa di qualitativamente superiore a quanto facevano i discepoli del Battista. Qui, peraltro, appare evidente che tra i due gruppi, sul piano etico-religioso, non vi fosse alcuna differenza sostanziale: entrambi, infatti, chiedevano alla popolazione di "convertirsi", come se questa avesse fatto chissà quali peccati.
Ovviamente Marco vuol far vedere che i cristiani erano superiori ai battisti, in quanto praticavano esorcismi e guarigioni e non semplici digiuni e battesimi. Ma se vogliamo davvero fare un confronto tra i due movimenti, alla fine è quello cristiano a rimetterci. Infatti, mentre col Battista la predicazione aveva lo scopo di preparare la gente alla venuta di un messia liberatore; nell'atteggiamento degli apostoli si dà invece per scontato che non esisterà alcun messia "liberatore", ma soltanto un "redentore". Gesù quindi non sarebbe superiore a Giovanni sul piano etico, bensì su quello teologico, in quanto, avendo una natura sovrumana, era in grado di compiere qualunque prodigio.
Nel vangelo di Marco si assiste alla riconciliazione tra cristiani e battisti (almeno con una parte di quest'ultimi), la cui rottura era avvenuta in occasione dell'epurazione del Tempio, come ben documenta il quarto vangelo. Di qui l'inizio del testo marciano dedicato alla pratica battesimale di Giovanni, che verrà fatta propria anche dai cristiani, al punto che persino Cristo viene fatto battezzare da lui (cosa che il quarto vangelo non conferma affatto). Nei Sinottici il battesimo giovanneo è trasformato in un sacramento di tipo esorcistico, cioè ben di più di un semplice atto simbolico di penitenza. Di qui la lunga descrizione del martirio del Battista, che non tutti gli autori dei vangeli si sono sentiti in dovere di riportare.22
Questo può far pensare che durante la permanenza di Pietro a Gerusalemme, dopo la crocifissione del Cristo, vi sia stato un certo riavvicinamento alle posizioni etico-religiose dei battisti, le quali, una volta private della loro carica filo-messianica, avrebbero potuto tornare ad essere simili a quelle esseniche23, trovando un terreno favorevole al compromesso con la teologia petro-paolina, la quale, non a caso, prenderà dagli esseni vari riti e sacramenti, il più importante dei quali sarà proprio quello dell'eucarestia, come ben documentano i papiri di Qûmran.24
Nel vangelo di Marco il nesso tra il Cristo e il Battista viene proposto addirittura da Erode Antipa, che aveva fatto ammazzare Giovanni nella prigione del Macheronte (e che non era "re", come viene detto in 6,14, ma solo tetrarca). Naturalmente il collegamento, agli occhi dello stesso evangelista, appare in una luce piuttosto ridicola. Infatti Erode sostiene che Gesù non sia altro che la reincarnazione di Giovanni, nel senso che questi, da semplice uomo che era, è diventato di natura divina grazie ai prodigi miracolosi compiuti da Gesù.
Può Erode aver sostenuto una tesi così bizzarra? Se sì, a che scopo? Se davvero l'ha fatto, le finalità potevano essere soltanto due: 1) attenuare il forte dissenso contro di lui, per aver fatto uccidere una persona stimata da tutto il popolo; 2) sminuire il valore dell'alternativa proposta da Gesù, che pretendeva d'essere superiore a quella di Giovanni.
Marco tuttavia può aver approfittato di qualcosa che Erode può aver detto, in riferimento all'esecuzione del Battista e alla predicazione di Gesù (certamente non ai miracoli di quest'ultimo), per sostenere una delle tesi fondamentali del suo vangelo: i morti possono risorgere. Un'anticipazione di tale tesi l'aveva data col racconto della figlia di Giairo. Ora lo ribadisce a chiare lettere: se è il potere stesso che crede in questa possibilità (e qui non importa se lo fa per giustificare degli interessi personali, vergognosi quanto mai), allora non si capisce perché non debba credervi la gente comune. Il cristianesimo dovrà semplicemente accettare l'idea che Gesù non può essere considerato una reincarnazione del Battista, neanche in senso metaforico, in quanto, essendo di natura divina, solo lui poteva resuscitare. La resurrezione o ridestazione da morte è una sua personale prerogativa.
Quanto alla morte del Battista, Marco dice chiaramente che Erode lo temeva, a motivo del suo vasto consenso popolare, e che prese la decisione di farlo fuori su istigazione della moglie Erodiade, donna molto ambiziosa, assetata di potere, che sarà la rovina dello stesso marito, sia perché lo fece confliggere col suocero della prima moglie, ripudiata, che lo sconfisse militarmente; sia perché lo mandò a Roma a chiedere il titolo di re, al posto di quello di tetrarca; senonché l'imperatore, non fidandosi più di lui, preferì esiliarlo, privandolo di tutti i suoi beni in Palestina. Al che la moglie, sentendosi in colpa, deciderà di condividere con lui la sua ingloriosa fine.
Nel racconto di Marco appare abbastanza chiaro che Giovanni era stato incarcerato perché contestava a Erode un matrimonio illegittimo, cioè lo faceva per motivi giuridici, non politici; inoltre l'esecuzione non era stata premeditata, ma accidentale, legata a una promessa che Erode, in un festino, aveva fatto alla figlia di Erodiade, come omaggio per la danza sensuale fatta davanti a tutti i convitati: una vera e propria scelleratezza.
(torna su)7) Il background dei pani miracolati
Il racconto dei pani miracolati (6,30 ss.) è uno dei più mistificanti di tutto il vangelo di Marco. Non a caso nel quarto vangelo Giovanni aveva deciso di riscriverlo; senonché un altro redattore ha poi provveduto a manometterlo pesantemente, al fine di renderlo più vicino al racconto marciano o comunque alla teologia petro-paolina. L'episodio che vi si narra, infatti, aveva un contenuto altamente politico.
Il testo, piuttosto lungo, si ricollega alla predicazione degli apostoli, mandati da Gesù in tutta la Galilea. Evidentemente dovevano aver detto, alla popolazione che di volta in volta incontravano, i giorni in cui Gesù avrebbe fatto un decisivo discorso alle grandi masse della Galilea.
Cinquemila uomini erano convenuti ai piedi del monte Tabor, per ascoltarlo, in un mese primaverile (c'era "l'erba verde"). Gli apostoli erano stanchissimi. Marco qui finge di non sapere che l'incontro era stato debitamente preparato. Lo presenta invece come un raduno casuale, al punto che Gesù e i Dodici, al vedere quella moltitudine, si preoccupano e cercano un luogo appartato, attraversando con una barca il lago di Genezaret (o di Tiberiade). Ma la folla li riconosce e li precede sull'altra riva. A quel punto è impossibile sottrarsi alle loro esigenze.
Marco questa volta non parla di richiesta di guarigioni, ma di "pecore senza pastore" (v. 34). Ha un atteggiamento di commiserazione. Non vuol dare al lettore l'impressione che si trattasse di un raduno politico. Infatti il Cristo si mette a insegnare come un filosofo o un teologo. Ha pietà di loro e cerca, in qualche modo, di consolarli, ma quali siano le sue parole il lettore non può saperlo. Marco insiste nel non farci sapere nulla. Ci si chiede tuttavia che senso abbia farlo parlare a cinquemila persone (un numero sufficiente per fare un'insurrezione armata contro le legioni romane stanziate in Palestina, anche se non lo era per resistere alle inevitabili ritorsioni) e non riportare una sola parola del suo discorso. Il quale, peraltro, dovette essere piuttosto lungo, poiché sono gli stessi apostoli che devono ricordargli l'ora tarda e che il luogo era desertico, per cui sarebbe stato meglio congedare tutti, affinché andassero a cercare nelle contrade vicine qualcosa da mangiare. Come se tutto ciò lui non potesse capirlo.
Ecco, la mistificazione maggiore scatta proprio adesso, nella soluzione che Gesù propone al problema della fame: "Date voi da mangiare a loro" (v. 37). Una frase, tutto sommato, abbastanza innocua, che poteva essere interpretata in chiave simbolica, senza scomodare alcuna istanza religiosa. Infatti poteva semplicemente voler dire: "Diventate voi i leader di queste masse. Dimostrate che potete esserlo".
Tuttavia Marco sa, quando scrive il suo vangelo, che gli apostoli non sono stati capaci di proseguire il progetto insurrezionale del Cristo, per cui qui deve, in qualche modo, giustificare la loro inettitudine. Li fa passare per ottusi, per discepoli che interpretano le parole del loro maestro solo in maniera letterale: "Andremo noi a comprare del pane per 200 denari25 e daremo loro da mangiare?" (v. 37).
Marco in sostanza fa capire che dei discepoli così intellettualmente limitati non avrebbero mai potuto prendere il posto di Gesù, il quale ovviamente lo comprende e se ne fa una ragione. Di qui la decisione d'intervenire in maniera del tutto miracolosa.26 Cinque pani e due pesci verranno moltiplicati per sfamare cinquemila uomini. Un evento politico, che non si poteva censurare, è stato trasformato in un'occasione per dimostrare che Gesù era di natura divina e che il suo obiettivo non era di natura politica. Pur di giustificare la pochezza degli apostoli, si è preferito fare del Cristo un extraterrestre. In sostanza si è rifiutata l'idea di fare autocritica e di conservare di Gesù l'immagine di un uomo politicamente impegnato, lontanissimo dall'esibire delle caratteristiche sovrumane. Questo spiega il motivo per cui i vangeli vanno definiti come una forma di legittimazione dell'impotenza politica.
Gesù si congeda poi, molto tranquillamente, dalla folla, che si è appena "sfamata", e si ritira da solo sul monte a pregare (sic!). Viceversa nel vangelo di Giovanni viene detto che la folla aveva cominciato a salire sul monte per farlo diventare re, intenzionata seriamente a condurlo a Gerusalemme per compiere la liberazione nazionale. Lui riuscì a sottrarsi a stento, ben sapendo che una rivolta con la sola popolazione galilaica, senza l'apporto di quella giudaica e samaritana, sarebbe stata un fallimento su tutti i fronti. E la folla, vedendo questo suo rifiuto, smise di seguirlo, al punto che anche i Dodici erano quasi intenzionati a lasciarlo.
Dunque, come si può notare, una bella differenza tra le due versioni. In Giovanni la popolazione ha una certa coscienza politica, anche se la manifesta in maniera istintiva; in Marco non ne ha invece alcuna e s'accontenta d'averlo ascoltato in chiave etica o filosofica o teologica e di essersi sfamata fisicamente.
È a questo punto che Marco introduce il racconto della tempesta sedata (6,47 ss.). Perché lo fa? Lo si può solo ipotizzare. Nell'occasione di quell'evento - abbiamo detto - gli apostoli rimasero molto delusi, in quanto il Cristo aveva rifiutato di salire a Gerusalemme per compiere l'insurrezione nazionale. Marco però non può dirlo; e così trasforma la delusione in fatica, la fatica in paura e la paura in rassicurazione: dalla politica si passa alla psicologia.
Dentro la loro barca faticavano a remare, avendo il vento contro; vedono lui che, camminando speditamente sulle acque del lago27, li raggiunge, e pensano che sia un fantasma. Ma lui, con molta nonchalance, fa fermare il vento ed entra nella barca, rassicurandoli.
Il racconto è assurdo, ma la motivazione con cui si cerca di spiegarlo ancora di più: "Non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito" (v. 52). Di che cosa sta parlando Marco? In pratica sta dicendo che mentre lui distribuiva i pani e i pesci, in realtà stava amministrando un sacramento, quello dell'eucarestia: infatti, prima di moltiplicarli, aveva "alzati gli occhi verso il cielo e benedetto i pani" (v. 41), cioè aveva compiuto un gesto squisitamente religioso. Loro non l'avevano capito, in quanto avevano interpretato quella portentosa moltiplicazione come un prodigio di tipo materiale, straordinario sì, ma tranquillamente alla portata di un superman come Gesù.28
Di che cosa non sta parlando Marco? L'abbiamo già detto: della delusione politica conseguente al fatto che Gesù, in Galilea, con cinquemila uomini pronti a marciare con lui, aveva rifiutato di compiere la liberazione nazionale dall'oppressore romano e dalla classe sacerdotale vergognosamente collusa. Gli apostoli erano molto depressi, quasi intenzionati a lasciarlo, poiché essi stessi avevano fatto delle promesse impegnative ai loro connazionali. Marco però pensa di risolvere la crisi politica, ricorrendo, com'è solito fare in questi casi, a degli espedienti di natura magica: Gesù cammina sulle acque, quindi è in grado di fare qualunque cosa; gli apostoli non devono avere paura di nulla; piuttosto devono cercare di capire che la folla agisce in maniera istintiva e che di essa non ci si può fidare più di tanto.
Infatti Gesù lo dimostra subito dopo essere approdato all'altra riva. Scrive Marco, con non poca sfrontatezza nell'attribuire alla folla una concezione di vita così fortemente cinica: "Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, ovunque si sentiva dire ch'egli si trovasse" (v. 55). Il versetto successivo rincara la dose del precedente.
Ora, chiunque si rende conto che con una popolazione di tal fatta sarebbe stato impossibile compiere qualunque insurrezione. Marco non lo dice, ma il lettore lo può facilmente intuire. La folla anonima soffre di un volgare materialismo e gli apostoli non hanno le forze sufficienti per farle cambiare atteggiamento. L'unico che potrebbe farlo è Gesù, che però ha scelto per sé un destino molto diverso dalle umane aspettative.
(torna su)8) Le diatribe del Cristo
Solo al capitolo 7 si comincia a capire qualcosa dei discorsi di Gesù. Con questo non è che Marco abbia rinunciato a scrivere racconti di miracolose guarigioni. Semplicemente ha spostato l'attenzione prevalente sui rapporti tra Gesù e le autorità costituite, che risultano sempre molto conflittuali. E, bisogna dire, finché egli resta in Galilea, è soprattutto nei confronti dei farisei che muove le sue aperte contestazioni.
In questi dialoghi, infatti, non vi è alcuna possibilità d'intesa. Scribi e farisei - Marco ci tiene a sottolinearlo - provengono direttamente da Gerusalemme, da dove sono stati mandati proprio per interloquire con Gesù, saggiando la sua "ortodossia".
Il confronto tra i due schieramenti è su questioni etiche o giuridiche, e la contrapposizione è subito netta: Gesù passa per un eretico su tutti i fronti. Marco ci tiene a far vedere che un'ostilità così forte proviene soprattutto dalla Giudea.
Il primo motivo di contesa riguarda le regole formali della purificazione rituale, che né Gesù né i suoi discepoli seguono, neanche in misura parziale. La Galilea appare come un territorio non particolarmente legato alle vecchie tradizioni ebraiche. Cioè - diremmo con altro linguaggio - non fa dell'attaccamento alle tradizioni il principale motivo per resistere alla colonizzazione culturale romana, come appunto facevano i farisei.
L'attacco a questo partito politico-religioso è piuttosto netto, ma più etico che politico (7,1 ss.). I farisei vengono accusati d'ipocrisia, in quanto guardano la purezza esteriore, quella delle mani, dei calici, dei boccali e dei vasi di rame, e non si curano di quella interiore, o meglio, fanno coincidere questa con quella.29 La polemica però appare poco significativa, anzi, assai improbabile da parte di un leader che cercava alleati contro Roma e che non poteva certo preoccuparsi se vedeva i farisei più vicini alle "tradizioni degli uomini" e meno al "comandamento di Dio" (vv. 6-9). Gesù aveva bisogno di alleati e non di farsi dei nemici per delle questioni meramente etiche o religiose, molte delle quali si sarebbero risolte a rivoluzione compiuta.
In tal senso anche l'altro esempio di cui parla Marco, pur essendo eticamente più grave dei precedenti, non sfiora neppure lontanamente la problematica politica vera e propria. Vi erano dei farisei che, pur di non assistere materialmente i propri genitori, impegnavano le proprie sostanze al Tempio come offerta a Dio (v. 11).30
L'odio per i farisei, provenienti da Gerusalemme, sembra essere l'odio per tutti i Giudei, o, quanto meno, per la loro classe dirigente o per il ceto intellettuale. Essi sono accusati di superficialità, di schematismo ideologico, infantile, di non capire una regola fondamentale della civile convivenza: "Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo" (v. 15).
La cosa curiosa di questa pericope è che Gesù "dichiarava puri tutti cibi" (v. 19), quando Pietro, negli Atti degli apostoli, è ancora alle prese con questo problema e non sa bene come risolverlo, tanto che ha bisogno di chiamare in causa un sogno (10,9 ss.).
Vi è poi da chiedersi se davvero Gesù sia stato così categorico nel rifiutare gli usi ebraici nei confronti della purità esteriore, o se invece non si sia limitato a relativizzarla, considerandola poco significativa ai fini dell'insurrezione nazionale. In fondo non avrebbe avuto senso per lui scandalizzare eticamente chi avrebbe potuto accettare un'alleanza politica eversiva. È probabile quindi che questo racconto sia stato aggiunto successivamente al vangelo originario di Marco (Ur-Markus), anche se presenta una problematica che ai suoi lettori di origine pagana poteva interessare assai poco.
In fondo tutto il capitolo 7 e buona parte del successivo sembrano trovare il loro significato nell'antagonismo tra Giudei e Galilei oppure tra cristiani di origine pagana e quei cristiani di origine ebraica che volevano portare nelle nuove comunità cristiane qualcosa della loro esperienza pregressa. Il fatto stesso che si sia voluto duplicare il racconto dei pani miracolati, lo dimostra: qui è evidente che i neo-pagano-cristiani volevano rompere col passato ebraico-cristiano.
In ogni caso Gesù continua ad assomigliare a un discepolo del Battista, con l'aggiunta della facoltà di compiere miracoli. Anche in questa sezione, infatti, deve compiere un esorcismo, una guarigione straordinaria con un sordomuto, ecc.
Forse si può dire che la guarigione del cieco di Betsaida costituisce uno spartiacque tra i cristiani di origine pagana e quelli di origine ebraica. Betsaida infatti è in Galilea, ma il cieco sembra avercela coi propri concittadini, oppure è Gesù che ce l'ha con loro, in quanto chiede al cieco risanato di "non entrare neppure nel villaggio" (8,26). Forse se l'era presa perché sperava di vedere, almeno da parte dei Galilei, un atteggiamento meno materialistico nei suoi confronti, cioè più interessato a lui come maestro e profeta.
Ma facciamo un passo indietro. La figlia indemoniata della donna sirofenicia (7,25 ss.) guarisce miracolosamente soltanto perché la madre ammette che la cultura pagana è inferiore a quella ebraica; solo che, facendo tale ammissione, mostra una tale umiltà da risultare superiore a molti ebrei, duri di cuore e di cervice, per cui viene immediatamente premiata. Gesù non le chiede neppure di aver "fede" in qualcosa: dà per scontato che sia già predisposta ad averla. D'altra parte da Tiro e Sidone erano già venuti in massa per conoscerlo, quindi non ha bisogno di chiedere alcunché alla donna.
Qui l'autore del vangelo vuol mostrare che i cristiani di origine pagana, quanto a rettitudine morale, non avevano niente da imparare dagli ebrei. In realtà, il fatto che dei pagani chiedano soltanto miracoli, non li fa molto diversi dagli ebrei della Galilea, se non forse in un fatto, che i Galilei, avendo già visto che Gesù li sa fare, dovrebbero smettere di richiederglieli, pensando piuttosto a come - direbbe Marco - "salvare l'anima".
Nella pericope del sordomuto (7,32 ss.) è chiarissima la pochezza della popolazione pagana, che chiede soltanto guarigioni miracolose e non si preoccupa di altro: apprezzano Gesù esclusivamente come taumaturgo.
A dir il vero non si sa perché l'autore abbia messo racconti del genere, il cui valore appare piuttosto limitato. Gesù va in una terra straniera, pagana (sia essa la Fenicia o la Decapoli), a fare guarigioni miracolose e non tiene alcun discorso; sembra che vada là solo per miracolare, e però non vuol farlo sapere a nessuno, se non ai diretti interessati, ovviamente (7,24; 7,33.36). Non vuol dare adito a incomprensioni, a malintesi sul ruolo ch'egli intende svolgere, che naturalmente non vuole essere solo terapeutico. Sembra quasi che si accontenti d'essere considerato una persona "buona", che fa udire i sordi e parlare i muti (v. 37). Non vuol far credere d'esser giunto in quei territori per fare miracoli dalla mattina alla sera: vorrebbe anche lasciare un messaggio, di cui però Marco non dice nulla.
Sembra che dietro questi racconti vi sia un giudizio piuttosto negativo nei confronti delle masse popolari, nel senso che l'autore usa le richieste di assistenza terapica come escamotage per nascondere la loro immaturità politica o l'incapacità degli apostoli di organizzare il consenso per compiere la rivoluzione. Forse è stato questo il motivo che ha indotto Marco a non riportare i discorsi di Gesù. Infatti a che sarebbero serviti, visto ch'essi non hanno sortito l'effetto desiderato? Cioè visto che le masse continuavano a restare uguali a prima d'averli ascoltati?
Le guarigioni infatti sembrano essere fine a se stesse: non producono seguaci, affiliati, discepoli..., anche perché, in genere, i risanati fanno il contrario di quanto viene loro richiesto da parte di Gesù. Se Paolo di Tarso si fosse presentato anche come guaritore, con la capacità organizzativa che aveva, avrebbe conquistato l'impero romano!
Una strategia del genere, nel vangelo di Marco, non ha davvero alcun senso: sarebbe stata troppo faticosa o dispendiosa, assai poco produttiva. Nonostante ciò chi ha inserito queste pericopi ha voluto far vedere che quando i pagani chiedevano guarigioni, lo facevano in buona fede, e non si sarebbero mai permessi di considerare Gesù un impostore. Invece i farisei gli chiedevano, "per metterlo alla prova, un segno dal cielo" (8,11).
In realtà anche questa richiesta non ha alcun senso, poiché per la mentalità ebraica non sarebbe stato sufficiente alcun "segno dal cielo" per credere con sicurezza che chi l'avesse compiuto meritasse d'essere considerato una persona degna di rispetto, nei cui confronti era giusto porsi in un atteggiamento d'ascolto.
D'altra parte lo stesso Marco aveva scritto poc'anzi: "Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: egli ha Belzebù [dio del letame], ed è con l'aiuto del principe dei demoni, che scaccia i demoni" (3,22). Questo per dire che era nell'interesse di Marco sostenere, indirettamente, che il progetto rivoluzionario del Cristo era fallito a causa della chiusura mentale preconcetta dell'intellighenzia giudaica. Solo che non può dirlo, almeno non nei seguenti termini. Per questo usa lo stratagemma dei miracoli: gli serve per porre un abisso tra Gesù e i suoi interlocutori. Quando questi non hanno potere politico, vengono, in un certo senso, compatiti, perdonati, in quanto si dà per scontato che siano masse sbandate, inconsapevoli, piene di problemi nei confronti della quotidiana sopravvivenza. In questi casi Gesù compie guarigioni con fare paternalistico, per poter lasciare loro qualcosa di significativo, non avendo potuto liberarli dall'oppressione romana. I miracoli in fondo servono anche per illudere che un giorno le cose cambieranno in meglio e per sempre.
Viceversa, nei confronti dei poteri costituiti i miracoli servono per porre degli steccati insuperabili. Chi non vi crede è destinato alla perdizione. Chi non crede che Gesù li compie perché di natura divina, sta peccando contro lo Spirito, cioè nega l'evidenza sapendo di farlo.
Questo modo d'impostare le cose, da parte di Marco, è semplicemente orribile, poiché da un lato si esclude a priori il dialogo, mentre dall'altro lo si usa per imbonire le masse. Non solo, ma l'evangelista è costretto a far passare per ottusi, tardi di comprendonio gli stessi apostoli, i quali proprio non riescono a capire il loro leader (8,14-21).
Il dialogo, in questi versetti, ha qualcosa di surreale. Si ha la netta impressione che Marco voglia prendersi gioco dei propri lettori. Cioè vuol cercare di far vedere che nei confronti di Gesù, essendo egli di natura divina, qualsiasi cosa si faccia o si dica, rischia d'essere sbagliata, per cui è meglio non contraddirlo, non provocarlo, non metterlo alla prova, come invece fanno i farisei, che, non rendendosi minimamente conto di chi sta loro di fronte, farebbero meglio ad avere un atteggiamento prudente, sottomesso, disposto a ricevere rimbrotti, come scolaretti che devono imparare l'alfabeto.
(torna su)9) La svolta petrina
Il riconoscimento della messianicità del Cristo, da parte di Pietro (8,27 ss.), a Cesarea di Filippo31, è uno spartiacque nel vangelo di Marco. D'ora in poi, infatti, l'evangelista farà dire a Gesù che deve andare a Gerusalemme per morire come un martire. Cioè proprio mentre Gesù è intenzionato a compiere l'insurrezione, Marco vuole presentarlo al suo lettore come un condannato a morte che deve rispettare la consegna ricevuta dal Padre eterno.
La questione dei miracoli o delle guarigioni passa in secondo piano, nel senso che se i prodigi non sono serviti per convincere i capi del giudaismo ch'egli era di natura divina e quindi il messia promesso dai profeti, allora bisogna cambiare strategia, bisogna passare alle maniere "forti", in senso etico, le quali, nel caso di Gesù, pacifista ad oltranza, possono essere soltanto quelle che producono un forte impatto emotivo, come può essere, ad es., la crocifissione e la resurrezione.
Ma se il Cristo deve arrivare a questi livelli di categoricità, allora vuol dire che per Israele è finita, nel senso che i Giudei hanno concluso il loro ciclo storico relativamente alla legge mosaica, la tradizione orale, il primato del Tempio, il patto dell'alleanza con Jahvè e così via. D'ora in poi mondo pagano e mondo ebraico saranno posti sullo stesso piano, quello cristiano. Il messia di Marco non vuole tanto la salvezza d'Israele, quanto piuttosto la salvezza dell'umanità e deve fare in modo di dimostrare che Israele non se la merita, o comunque non merita di sentirsi più importante, sul piano etico-religioso, di qualunque altra nazione pagana.
La domanda cruciale che Gesù pone ai Dodici è: "Chi dice la gente che io sia?" (8,27). Cioè, dopo aver elargito gratuitamente tante guarigioni straordinarie, la popolazione cosa pensa di lui? Le risposte sono quattro, di cui tre evidentemente sbagliate: per quello ch'egli dice, assomiglia - secondo la gente comune - al Battista o a Elia o a uno dei profeti; invece per quello ch'egli fa ovviamente no, visto che compie prodigi spettacolari.
Tuttavia Pietro vuol far vedere che gli apostoli lo seguono per motivi politici, non terapeutici: ecco perché gli dice apertamente che per loro è il messia che tutti attendono, senza riferimenti espliciti alla divinità (quelli del centurione in 15,39, o di Dio in persona in 1,11; 9,7, o degli spiriti immondi in 3,11; 5,7), anche se ovviamente restano impliciti. In greco è scritto Χρίστος (Chrístos), per cui il lettore, di origine pagana, non ha neanche ben chiaro che questo termine vuol dire "messia" e che questo è un titolo politico, o meglio teologico-politico, secondo la tradizione giudaica. Il "messia" (di stampo davidico) è "Unto del Signore", cioè re e sacerdote contemporaneamente. Per il credente di origine pagana il titolo di "Cristo" diventa una sorta di soprannome di tipo religioso, totalmente privo di riferimenti politici.
Pietro dunque lo riconosce come messia tradizionale, ma così compie - nell'economia del protovangelo - il quarto errore di identificazione. Gesù infatti - stando alla mistificazione redazionale di questo testo, che risente dell'influenza paolina - non voleva apparire come un messia teologico-politico, ma solo teologico, mentre per l'esegesi laica si dovrebbe dire solo politico. Infatti, per quale motivo Gesù gli dice di non rivelare a nessuno la sua identità? Proprio perché nel vangelo marciano Gesù non ha intenzione di diventare né messia politico (in quanto sostanzialmente il suo vero regno è nei cieli), né messia teologico-politico (poiché egli rifiuta la tradizione giudaica). Gesù ha l'intenzione opposta: quella di diventare "martire", e questa scelta esistenziale è possibile soltanto a un Cristo meramente teologico. Se proprio si vuol attribuire a tale scelta esistenziale un valore politico, questo non può essere che indiretto, nel senso che il cristianesimo si pone in maniera scismatica nei confronti del giudaismo.
Ma se ha intenzione di diventare "martire", davvero la gente sbaglia a equipararlo al Battista, a Elia, a uno dei profeti? Non sono forse morti in maniera violenta i profeti veterotestamentari? Quindi chi ha più ragione: Pietro o la gente comune? Nel testo sembra che Gesù voglia dar ragione all'apostolo, in quanto gli dice di non rivelare a nessuno la sua intenzione alla messianicità, ma poi, nei versetti seguenti, cosa scrive Marco? "Poi cominciò a insegnar loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni resuscitasse" (8,31).
Cerchiamo ora di capire. Gesù pare convinto d'essere di più di uno dei profeti (ivi incluso il Battista), non foss'altro perché compie prodigi che nessuno ha mai fatto. Tuttavia, quando Pietro lo riconosce come messia, cioè qualificandolo come un "novello Davide", quindi rendendolo superiore alle figure dei profeti, ecco che Gesù afferma sì d'essere superiore ai profeti, ma non perché vuole diventare un messia in senso tradizionale, cioè un liberatore nazionale in nome di Jahvè. Dunque Pietro ha ragione nel ritenerlo un messia, ma ha torto nel ritenerlo tale secondo i parametri consueti. Gesù dichiara di voler morire come un profeta (non come un leader politico-religioso), aggiungendo però che dovrà anche risorgere fisicamente.
Naturalmente Pietro non poteva capire queste parole, sicché "lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo" (8,32). Si faccia ora attenzione a come Marco pone la diatriba e a come, attraverso di essa, mistifichi le cose. Per come viene descritta nel suo vangelo la questione è chiara: Pietro (che qui parla da solo, come se fosse più intelligente degli altri Undici o come se questi l'avessero delegato a rappresentarli) è alla sequela di Gesù perché lo vede come messia teologico-politico, che deve fare l'insurrezione armata.
I Dodici lo seguono per questa ragione, non per altro. È anche possibile che per loro la caratterizzazione teologica fosse meno importante di quella politica vera e propria. Senonché Gesù nega la sua vocazione politica e, per come espone le cose, parlando di resurrezione, ne afferma una che è soltanto teologica.
Come saranno andate in realtà le cose? quelle che Marco non può dire perché troppo compromettenti nei rapporti tra impero romano e cristianesimo primitivo? La diatriba sarà avvenuta sul senso della parola "messianicità". Secondo la tradizione ebraica il messia doveva avere una specificità religiosa, che Cristo però rifiutava; inoltre il messia veterotestamentario era a favore della monarchia, non della democrazia; s'imponeva più che altro con la forza delle armi, non disdegnando il colpo di stato, e sempre era aiutato da un esercito di professionisti.
Gesù invece voleva una rivoluzione popolare, democraticamente intesa, senza la quale sarebbe stato impossibile vincere le legioni romane. Quindi la controversia era tra avventurismo galilaico e realismo intertribale (o interterritoriale): l'insurrezione armata non avrebbe mai potuto prescindere dal contributo decisivo, paritetico, di almeno tre realtà geopolitiche ben distinte: Giudea, Galilea e Samaria. Le altre realtà, in quel frangente, avevano un'importanza secondaria, in quanto meno combattive: Siria, Libano, Decapoli, Idumea ecc., anche se non è da escludere che, vedendo Israele avere la meglio sulle legioni romane, sarebbero potute insorgere.
In ogni caso se davvero Gesù avesse parlato di martirio a tutti i costi, Pietro avrebbe fatto bene a "rimproverarlo" (v. 32). Di chi erano seguaci? di un pazzo autolesionista? L'obiettivo non era forse quello di liberare Israele dall'oppressione romana?
Nel vangelo di Marco le cose vengono sempre rovesciate: il matto è Pietro, il quale non capisce che la missione di Gesù è di tipo etico-religioso, non politico. Quindi è giusto che sia piuttosto lui ad essere rimproverato dal suo maestro: "Vattene da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini" (v. 33).
È straordinaria questa mistificazione delle cose. Nella realtà sarà stato sicuramente il Cristo a togliere dalla testa dei suoi discepoli il legame tra teologia e politica. Qui invece appare il contrario: Pietro vuol fare il politico e Gesù il teologo, per di più moralista, poiché chiede, come prezzo del discepolato, una cosa che difficilmente avrebbero potuto accettare, in quanto non erano dei grandi proprietari terrieri che, per ritrovare il senso della loro vita, si devono anzitutto spogliare dei loro beni, frustandosi con fare penitenziale e cose del genere (come accadeva in Italia quando i figli della nobiltà o della borghesia medievale diventavano frati o monaci privi di beni, spesso su posizioni ereticali e coi fianchi martoriati dal cilicio).
"Se uno vuol venire dietro di me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua" (8,34). Il che, sul piano personale, poteva anche starci, in quanto la vita del militante di un movimento eversivo non è certo una passeggiata. Ma che questo dovesse essere considerato l'obiettivo finale del proprio impegno, solo a un depresso poteva venire in mente, a un pessimista di maniera, a una persona sfiduciata sui destini della propria nazione.
Non a caso Gesù parla di "generazione adultera e peccatrice" (v. 38), la quale - si può arguire - non merita certo d'essere liberata dall'oppressione romana. Prima bisogna fare penitenza, e non una ma cento volte, poiché il peccato è sempre dietro l'angolo; poi si vedrà, e il "poi", per il Cristo di Marco, non è mai alla portata dell'uomo. Infatti Gesù conclude la sua filippica contro Pietro nella maniera più mistica possibile: "Il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli" (v. 38). Il che, in sostanza, voleva dire che gli uomini, da soli, non hanno alcuna possibilità di liberarsi dalle catene dell'oppressione; possono soltanto limitarsi alla penitenza, all'automortificazione (esattamente come chiedeva il Battista), in attesa della parusia trionfale del Cristo (come invece il Battista non avrebbe mai potuto promettere).
Qui siamo solo alla fine del capitolo 8, ma si è già capito molto bene che il messaggio del vangelo di Marco, ovvero di Pietro (ampiamente confermato da Paolo), è altamente revisionistico, rispetto al messaggio originario del Cristo; e fa specie che l'unica risposta antitetica, da parte di qualche testimone oculare della vicenda del Cristo, a questa tendenziosità (ci riferiamo ovviamente al quarto vangelo e all'Apocalisse), sia stata ampiamente manomessa, anzi travisata da redattori obbligati a tener conto della teologia petro-paolina. Praticamente l'unico vero documento in controtendenza rispetto alle falsificazioni di Marco e degli evangelisti che lo imitano, è la Sindone.
La rilettura in chiave ateistica e politicizzata dei vangeli va fatta a partire da questo reperto archeologico. Senonché chi si azzarda a tenerne conto, si preoccupa soltanto di cercare nei vangeli quelle conferme che gli servono per sostenere la tesi petrina della "resurrezione". Messe le cose in questi termini, la Sindone non serve a nulla, e bene fece Pietro a non prenderla neppure in considerazione come prova per la sua tesi mistica. Noi invece sosteniamo che è sempre meglio sforzarsi di ricomprendere i vangeli alla luce di quel lenzuolo, piuttosto che cimentarsi a capire delle sentenze sibilline messe in bocca da Marco a Gesù, come p. es. la seguente: "In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il regno di Dio venuto in potenza" (9,1).
Sembra una frase di tipo consolatorio: dopo tanto scetticismo, espresso dal Cristo, sulle capacità umane di liberarsi dal male, finalmente una piccola speranza, seppur riservata a pochi eletti. Ma in che senso intenderla? Alcuni non sarebbero morti prima della parusia trionfale del Cristo: voleva forse dire questo?32 Ma che senso ha parlare di "gusto della morte"?33 È una espressione orribile, perlomeno inquietante. Fa venire in mente quella di Paolo quando diceva che, siccome faceva il contrario di ciò che voleva, avrebbe preferito essere liberato dal suo corpo di morte (Rm 7,24). Per non parlare del fatto che egli stesso considerava la morte un "guadagno" (Fil 1,21). In ogni caso, se davvero si pensa che possa esistere una parusia trionfale, non dovrebbe essere maggiore il "gusto" per questo evento positivo?
Questa frase enigmatica assomiglia a un'altra riportata nel vangelo di Giovanni: "Se voglio che lui [l'apostolo Giovanni] rimanga finché io venga, che t'importa? Tu seguimi" (21,22). Una frase ambigua, detta da Gesù a un Pietro che in quel contesto appare come una specie di traditore del messaggio originario del Cristo, tant'è che questi gli chiede di ritornare a seguirlo nei panni di un novizio; una frase che, in teoria, avrebbe voluto dire che di tutti gli apostoli solo Giovanni avrebbe meritato di continuare ad esistere finché egli non fosse tornato per il giorno del giudizio.
Nel contesto di Marco però non si capisce proprio a chi Gesù faccia riferimento, parlando di discepoli nazareni a lui coevi, e certamente non poteva essere Giovanni, visto che fra questi e Pietro i rapporti si guastarono ben presto dopo la scoperta della tomba vuota. Sappiamo però essere una caratteristica di questo protovangelo buttare lì delle frasi criptiche, senza offrire alcuna spiegazione, giusto per circonfondere la personalità di Cristo di un'aureola magica. A proposito della quale, col racconto della trasfigurazione (9,2 ss.) siamo addirittura in presenza di una nuvola eterea, anzi empirea, da cui proviene la voce di Dio-padre, il quale sentenzia: "Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!" (v. 7).
Una pericope, questa, di genere fantastico, sulla quale i teologi mistici hanno speculato a iosa, dicendo che "Dio è tenebra", per cui nessuno può vederlo, se non appunto il Figlio, il quale ha potuto trasfigurarsi, come molti secoli dopo faranno gli esicasti greci o i russi san Serafino di Sarov e san Sergio di Radonež. Peraltro proprio la trasfigurazione era il primo dipinto in cui gli iconografi dovevano cimentarsi se volevano iniziare la loro attività artistica.
In realtà tale metamorfosi34 venne posta come una sorta di zuccherino a favore degli apostoli prediletti che, più di altri, si sentivano politicamente molto depressi. D'altra parte - si potrebbe parafrasare questa pericope - se la liberazione non si può fare e dobbiamo soltanto punirci per i nostri peccati, come evitare la crisi esistenziale? Ecco quindi la soluzione: la trasfigurazione è un piccolo anticipo di ciò che il Cristo potrebbe davvero fare su questa Terra e che però non vuol fare, affinché gli uomini si abituino a soffrire per le loro colpe, fino a quando non arriveranno a capire che senza la grazia divina non possono far nulla.
Cristo viene collocato in mezzo, tra il più grande legislatore, Mosè, e il profeta immortale Elia, rapito da Jahvè in un carro di fuoco.35 I tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, restano storditi e abbagliati, senza capire minimamente ciò che stava accadendo. Tanto che Pietro arriva a dire, come per voler eternizzare qualcosa che in questo mondo è irrealizzabile: "Facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia: (9,5), in cui il primo viene a porsi su un piano superiore al più grande legislatore d'Israele e al maggiore dei suoi profeti.
La cosa ridicola di questo racconto e che Gesù intima ai discepoli di non raccontare nulla di ciò che hanno visto, se non dopo che fosse risorto dai morti (v. 10): come se quest'ultima cosa fosse la più naturale del mondo!
Nel finale non poteva mancare una frecciatina contro gli scribi di Gerusalemme, i quali dicevano che prima del messia doveva arrivare un profeta simile ad Elia, che ne anticipasse la venuta. E Gesù risponde: "Elia è già venuto, ma gli hanno fatto quello che hanno voluto" (v. 13). Si riferiva ovviamente alla tragica fine del Battista, ed è questa, probabilmente, l'unica cosa vera del racconto.
(torna su)9.1) Addendum sulle guarigioni
Detto questo, il lettore non si aspetterebbe di trovare altre guarigioni nel prosieguo del vangelo. Invece ve ne sono altre due, che forse stanno ad indicare l'immaturità dei postulanti, i quali, pur sapendo che le guarigioni non sono l'opera fondamentale del Cristo, non perdono occasione per continuare a chiedergliene: una riguarda l'epilettico indemoniato e avviene in Galilea, l'altra il cieco Bartimeo ed è l'unica che avviene in Giudea.36 Poi finalmente gli autori del vangelo lo faranno smettere con questi prodigi.
Nel testo appare chiaramente che Gesù ha dovuto fare controvoglia queste ultime due guarigioni: infatti nella prima mostra una particolare insofferenza per i supplici, arrivando a dire: "O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò?" (9,19). Dopodiché cede alla tentazione di esibirsi, anche perché vede un padre che, pentito d'aver fatto il prepotente, lo implora in ginocchio. Nella seconda invece fa finta di non ascoltare la supplica del cieco, anche perché questi lo paragona a un messia davidico; poi però ci ripensa.
La cosa strana nella prima guarigione è che, da un lato, giudica incredula la sua generazione, mentre, dall'altro, quando sente gli apostoli che, di fronte a un caso del genere, si erano dichiarati impotenti, deve ammettere che effettivamente era un caso difficile, per il quale occorreva "pregare" (!) e molto (!!) (9,29).
Il punto nodale della pericope (che ovviamente è tutta inventata, a meno che non si voglia credere in una sorta di psicoterapia) sta nel v. 23, dove Gesù dice al padre del ragazzo epilettico (fatto passare per "indemoniato"): "Ogni cosa è possibile a chi crede". Quindi, se non erano riusciti a guarire il ragazzo, la ragione stava unicamente nella poca fede di chi lo frequentava o di chi lo assisteva, nella scarsa determinazione a volere la guarigione; e in tale mancanza di volontà rientravano anche gli apostoli.
Ora, quando si leggono i racconti terapeutici del vangelo di Marco, è abbastanza facile capire come siano andate effettivamente le cose. È sufficiente prendere la frase centrale del racconto, che è appunto, in questo caso, quella del v. 23, cercando di ricavarci un insegnamento utile a dar fiducia alla possibilità di una liberazione dall'oppressione romana.
Nel racconto del lebbroso risanato (1,40 ss.) la frase centrale era racchiusa in due versetti: "Se vuoi, puoi guarirmi"; "Lo voglio, sii guarito!". Il lebbroso in pratica metteva in dubbio che Gesù volesse davvero coinvolgere, nel suo progetto di liberazione, anche le persone più reiette della società, le più isolate ed emarginate.
Qui invece il postulante mette in dubbio che i discepoli di Gesù abbiano davvero le forze per compiere l'insurrezione armata. Al che Gesù risponde che ognuno dovrebbe cercare in se stesso le forze necessarie, senza aspettarsi la manna che cade dal cielo.
(torna su)9.2) Addendum sul segreto messianico
[1,25] E Gesù lo sgridò: "Taci! Esci da quell'uomo".
[1,34] Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni;
ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano.
[1,43] E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: [44] "Guarda di non dir
niente a nessuno, ma va', presentati al sacerdote, e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro".
[3,12] Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.
[5,43] Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e
ordinò di darle da mangiare.
[7,36] E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più
essi ne parlavano.
[8,26] E lo rimandò a casa dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio".
[8,29] Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". [30] E impose loro severamente di
non parlare di lui a nessuno.
*
Uno dei temi dominanti del vangelo di Marco è - come noto - il cosiddetto "segreto messianico". Sin dall'inizio si assiste a una singolare insistenza di divieti, da parte di Gesù, circa la propria identità messianica, che subito però gli viene riconosciuta dai demoni. Si accorse di questa stranezza, nel 1903, uno studioso tedesco, W. Wrede, il quale affermò che in questo vangelo l'insistenza su tale "segreto" tende a diminuire soltanto quando il Cristo comincia a parlare delle sofferenze che devono inesorabilmente attenderlo a Gerusalemme, e il primo di questi tre preannunci è immediatamente successivo alla professione di fede di Pietro, che per primo, tra i Dodici, lo riconosce come "messia".
Ebbene, l'interpretazione ufficiale della chiesa cristiana, quella che ha dominato per duemila anni, vuole che col comando tassativo di tacere sulla propria messianicità, il Cristo volesse non tanto opporsi a un'idea teocratica di messia, il cui modello era Davide, a favore di un'idea più democratica di leader politico, quanto in realtà volesse affermare un titolo ben più importante: quello di "figlio di dio", che né la popolazione giudaica, né, tanto meno, le autorità sinedrite e religiose riuscirono mai ad accettare e, tanto meno, a capire.
Una delle maggiori contraddizioni di tale esegesi sta proprio nel fatto che si imputa ai giudei l'aver rifiutato l'idea di un messia sofferente (a tale proposito si usò la figura del "servo sofferente" di Jahvè descritta nel Deutero Isaia) quando tale idea era nata proprio in conseguenza di quel rifiuto, cioè dopo la scoperta della tomba vuota. La chiesa ha cercato di nascondere questa contraddizione affermando che in realtà il giudaismo era già "destinato" a non credere, onde lasciare spazio alla conversione dei gentili.
Secondo la chiesa gli ebrei avrebbero potuto salvarsi dalla colpa di aver ucciso il loro messia, pentendosi di averne desiderato uno di tipo politico, cioè accettando appunto la tesi petrina della "morte necessaria", cui faceva seguito quella della "resurrezione", con cui Pietro aveva interpretato il fatto della tomba vuota.
In sostanza la chiesa arrivò a sostenere che se gli ebrei avessero accettato l'idea di un messia morto e risorto, la loro nazione non sarebbe stata distrutta dai romani, poiché non vi sarebbe più stata una irriducibile opposizione politica e nazionale tra ebraismo e romanità, tra oppressi e oppressori.
Quegli ebrei che accettarono una tesi del genere ebbero il privilegio di apparire nei vangeli nei panni di un Giovanni Battista intento a battezzare il Cristo e a riconoscerlo come "figlio di dio", a lui infinitamente superiore. Cosa che nel vangelo di Giovanni viene esplicitamente contraddetta in occasione del racconto sull'epurazione del Tempio, allorquando il movimento nazareno si stacca definitivamente da quello esseno del Battista.
Ma ora facciamo un passo indietro, parlando più in generale del vangelo di Marco: questo potrà servirci a capire meglio l'origine della teoria del "segreto messianico".
Questo vangelo ha alle spalle una tradizione galilaica molto diversa da quella giudaica, una tradizione che rispecchia una cultura ebraica più soggettivista, politicamente più estremista, meno legata al passato d'Israele, al rispetto scrupoloso di leggi e consuetudini, più proiettata verso il futuro, che viene immaginato con ingenuo ottimismo, in cui un giorno avverrà la tanto agognata liberazione dai romani oppressori; una cultura che giudicava gli atteggiamenti dei loro "cugini" giudei come troppo complicati, troppo vincolati a lacci e laccioli di un passato irrimediabilmente perduto, troppo incoerenti tra quanto andavano predicando a favore della liberazione e quanto effettivamente riuscivano a fare. Ciò che soprattutto non si sopportava di questa cultura era l'eccessiva importanza che si attribuiva al Tempio di Gerusalemme, l'enorme potere che ancora deteneva la casta sacerdotale e aristocratica, la maniacale scrupolosità con cui i farisei dicevano di voler obbedire alla legge.
La tradizione e la cultura della Galilea si riflettono soprattutto nel vangelo di Marco, ovvero nella lezione petrina, che è molto diversa da quella giovannea. Per esempio, una delle caratteristiche fondamentali del vangelo di Marco è quella di presentare Gesù come un "superman", in grado di fare straordinari prodigi miracolosi, di cui però non approfitta per imporsi come messia. Anzi, nel momento in cui, a forza di farli, la gente comincia davvero a convincersi ch'egli lo sia, ecco che scatta in lui la decisione di affermare che il messia sarebbe dovuto morire di morte violenta. Tutte le volte che in questo vangelo si vorrebbe vedere Gesù come protagonista assoluto della liberazione d'Israele, lui si schermisce, vieta di parlarne, addirittura si nasconde, fino a profetizzare cose terribili sul suo destino.
Da un lato dunque l'evangelista Marco vuol mostrare un Cristo grandioso, che fa cose umanamente impossibili, dall'altro invece gli impone un ruolo minimo, anonimo, misconosciuto. Perché un atteggiamento redazionale così contraddittorio? Le motivazioni sono due:
1. la prima è semplice da capire: Gesù fu un politico tradito e sconfitto, e i suoi discepoli non seppero fare meglio di lui per la liberazione della Palestina. Ora, siccome non si voleva far apparire questo aspetto negativo nei resoconti delle vicende che lo riguardavano (i vangeli), si preferì far vedere che non era mai stata nelle sue intenzioni quella di liberare il paese dall'occupazione romana. La sua missione era di tipo etico-religioso, sulla scia di quella del Battista (che infatti venne chiamato "Precursore del Cristo", dai Padri della chiesa), con l'unica differenza che il corpo di Cristo era scomparso dalla tomba e non fu più ritrovato. In questa maniera anche i suoi discepoli più importanti (il primo dei quali fu Pietro) potevano giustificare la loro incapacità politico-rivoluzionaria.
2. La seconda motivazione è invece più complessa. Per capirla noi dobbiamo anzitutto ricordare che il movimento nazareno fu il collettore di varie esperienze politiche sparse su tutto il territorio della Palestina. Finché il Cristo rimase in vita, queste esperienze riuscirono a coesistere pacificamente, salvo tensioni di poco conto (come quando p.es. nell'imminenza dell'ultimo ingresso nella capitale i fratelli Zebedeo pretendevano di porsi alla testa dell'insurrezione armata, come luogotenenti del messia - cfr Mc 10,35 ss.). Ma, dopo la sua morte, ripresero ad accentuarsi le differenze, la principale delle quali era il contrasto tra giudei e galilei. La corrente galilaica aveva come principale esponente Pietro, quella giudaica Giovanni. Quest'ultima, nel prosieguo non più rivoluzionario ma riformista voluto da Pietro, ebbe la peggio e venne progressivamente emarginata dal nuovo movimento "cristiano".
Ora, quando si trattò di scrivere il primo resoconto organico della vita di Gesù, quello appunto di Marco, influenzato dall'ideologia petrina, si capì subito che se si fosse presentato un Gesù grandioso, dalle capacità straordinarie, esercitate prevalentemente in Galilea, l'inferiorità dei giudei - i principali responsabili della morte di Gesù - sarebbe apparsa molto più accentuata. Infatti, se prima della morte di Gesù, l'ala giudaica del movimento nazareno godeva di maggior prestigio, al punto che si ritenevano i fratelli Zebedeo i naturali eredi politici del messia, dopo la morte di quest'ultimo, essendo stata evidente la maggiore responsabilità giudaica nella decisione di eliminare il Cristo, prese il sopravvento l'ala galilaica guidata da Pietro.
Si badi che quando diciamo "Pietro" non intendiamo anche suo fratello Andrea, poiché questi ha un ruolo del tutto marginale nei vangeli, e anzi risulta del tutto assente negli Atti degli apostoli, i quali per la prima metà vedono Pietro al centro dell'attenzione, sostituito poi dalla predicazione paolina, che trasformerà la diatriba Giudea/Galilea in una contrapposizione, ben più vasta e radicale, del Paganesimo (cristianizzato) all'Ebraismo tradizionale e neo-cristiano.
Infatti, finché rimase la diatriba voluta da Pietro, si continuerà a sperare, pur nella rinuncia all'attività politico-rivoluzionaria, nel ritorno glorioso del Cristo "ridestato" (parusia del risorto), in quanto non si riusciva ad accettare l'idea che la scomparsa del corpo nella tomba non implicasse delle conseguenze politiche sui destini di Israele; in caso contrario non si sarebbe riusciti a comprendere il motivo per cui un "superman" avesse accettato di morire in croce quando avrebbe potuto benissimo evitarlo.
Secondo Pietro la croce era stata accettata per dimostrare che i giudei avevano perduto qualunque primato politico: gli pareva cioè evidente, con un ragionamento a dir poco fantasioso, che agli occhi del messia questa soluzione era l'unica possibile per far capire a quella gente ostinata e orgogliosa che, continuando col loro attaccamento morboso alle tradizioni, non avrebbero avuto alcuna possibilità di liberarsi di Roma e dei loro ambienti collaborazionisti.
Questo però non significava per Pietro che Gesù non sarebbe tornato per affermarsi come messia nazional-popolare. Dentro la tomba vuota Marco fa dire al giovane seduto, rivolto alle mirofore: "Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"(16,7). E' vero che il finale lascia pensare che le donne non abbiano mai fatto una cosa del genere, poiché "uscite, fuggirono via dal sepolcro, essendo piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura", ma questo finale venne messo perché poi in realtà non ci fu alcun rendez-vous in Galilea.
Era tuttavia dalla Galilea che secondo Pietro si sarebbe dovuto, al seguito di un messia esplicito e non più nascosto, ritornare in Giudea per farla finita non solo coi romani ma anche coi giudei collaborazionisti e con quelli che, a vario titolo, avevano contribuito a eliminare il messia. Infatti, secondo Pietro, il fatto che la crocifissione fosse prevista nel piano originario di dio, non toglieva minimamente alcuna gravità alla colpa dei giudei, i quali avrebbero potuto "salvarsi" soltanto credendo nella sua idea di "Cristo risorto", in procinto di tornare in maniera gloriosa. Questo negli Atti degli apostoli risulta molto evidente.
La differenza tra Pietro e Giovanni stette proprio in questo, che di fronte alla tomba vuota Pietro si convinse ch'era meglio aspettare passivamente la parusia trionfale del messia, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso una tomba vuota fine a se stessa. E anche su questo Paolo, all'inizio della sua improvvisa conversione, la pensava uguale. Soltanto quando ci si accorgerà che la teoria della parusia trionfale non reggeva all'evidenza dei fatti, entrambi furono costretti ad andarsene definitivamente dalla Palestina, preferendo cercare il martirio con cui riscattarsi agli occhi dei cristiani che avevano ingannato.
L'illusione della parusia infatti s'era rivelata in tutta la sua gravità quando, nell'imminenza della guerra giudaica, scoppiata nel 66, i cristiani s'erano trovati spaesati, incerti sul da farsi, troppo presi da aspirazioni e attese prive di riscontri reali. Noi non sappiamo che fine fecero i cristiani residenti in Palestina (soprattutto in Giudea) al tempo della guerra giudaica: probabilmente molti espatriarono prima che cominciasse, altri invece vi perirono a fianco dei giudei. Sappiamo soltanto che la produzione letteraria rimastaci è tutta conforme all'ideologia petro-paolina. L'unica voce divergente, la cui contestazione però è stata notevolmente ridimensionata, fu quella di Giovanni.
Dunque, tornando alla teoria marciana del "segreto messianico", è bene affrontarla in due maniere distinte:
1. se la si mette in rapporto all'esigenza di liberare politicamente Israele, va considerata falsa, in quanto Gesù voleva porsi come liberatore nazionale; invece va considerata vera se la si mette in relazione all'esigenza di voler fare un'insurrezione nazionale e popolare, in senso democratico, e non un colpo di stato, in senso dittatoriale;
2. se invece quella teoria viene rapportata alla suddetta diatriba tra Giudea e Galilea, essa va considerata come un motivo specifico di Marco (di cui Pietro è fonte), finalizzato a contestare il primato dei giudei, i quali non seppero riconoscere il messia che già avevano, anche perché, secondo loro, proveniva dalla Galilea (che poi in realtà Gesù era originario della Giudea e fu costretto a espatriare in Galilea sono dopo l'epurazione del Tempio). La "patria" di cui si parla in Mc 6,1 ss. non va considerata la Galilea - come invece Marco vorrebbe - ma la Giudea, esattamente come conferma la versione giovannea della stessa pericope: "Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria"(4,44), cosa che viene ribadita in 6,41: "Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre", dicono i giudei.
Presentando inoltre un Gesù "superman", i galilei han voluto far vedere che i giudei, nonostante questi mirabolanti "segni", continuavano a restare increduli, quando in realtà Gesù non fece mai nulla perché si pensasse che in lui vi erano capacità sovrumane. Quindi sono evidenti due cose:
1. che all'intolleranza giudaica va associata l'incapacità dei galilei di proseguire in maniera coerente il messaggio rivoluzionario del Cristo; i galilei cioè mascherarono questa loro incapacità attribuendo ai giudei il peso della condanna a morte del messia;
2. tutti i racconti miracolosi sono stati inventati da una tradizione galilaica quando ormai nessuno era più in grado di smentirli. I racconti analoghi ambientati in Giudea sono stati invece elaborati per dimostrare ai cristiani di origine galilaica che l'interpretazione giudaico-cristiana dell'attività di Gesù non era da meno. Naturalmente nessun racconto di guarigione miracolosa presente nel quarto vangelo può essere attribuito a Giovanni: dietro di essi vi è una redazione di origine giudaica influenzata dalla cultura giovannea, ma costretta a sottostare all'ideologia petro-paolina dominante.
Un esempio di diversità interpretativa tra le due culture è proprio dato dal fatto che mentre in Marco il segreto messianico è usato per nascondere l'identità politica del Cristo, ritenuta fallace rispetto a quella religiosa; in Giovanni (nella parte manipolata del suo vangelo) Gesù evidenzia invece un'identità religiosa esplicita, che però nessuno è in grado di capire. Al silenzio imposto alle folle (ai soggetti risanati) corrisponde, in Giovanni, una rivelazione mistica ai Dodici, ma in nessun caso si riesce a capire esattamente ciò che lui voglia dire. "Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?"(Gv 6,59).
In effetti, chi può capire la natura del paradosso secondo cui da un lato la chiesa vuole sostenere che il Cristo, con la sua morte, ci avrebbe liberato dall'ira divina causata dal peccato originale, mentre dall'altro non s'accorge che proprio a causa di quella morte gli uomini sono piombati in un'ira ancora più tragica, essendosi lasciati sfuggire con leggerezza la possibilità di vivere un'esistenza più umana e democratica?
(torna su)10) Il viaggio verso Gerusalemme
I (Annunci della passione)
Una cosa che nel vangelo di Marco non si può umanamente capire è il motivo per cui Gesù abbia deciso di recarsi a Gerusalemme sapendo in anticipo che l'avrebbero ucciso. Se voleva farsi catturare, non bastava che restasse in Galilea?
In tale vangelo Gesù predice per ben tre volte il suo destino di martire. Il motivo di questa scelta autolesionista sta sempre in ciò che avverrà dopo la morte: la resurrezione. È incredibile pensare che gli apostoli abbiano potuto accettare di seguirlo a queste condizioni. Voleva morire per poi risorgere: cioè in pratica avrebbe fatto una cosa insensata, per compierne poi un'altra del tutto impossibile, almeno per i comuni mortali. Chi mai nel mondo ebraico era riuscito a risorgere? O, anche ammesso che qualcuno vi fosse riuscito, chi mai, per farlo, aveva desiderato morire in modo violento? E perché scegliere per tale evento proprio Gerusalemme, la città che in questo vangelo è la più odiata di tutte? Gesù Cristo non poteva morire di vecchiaia, nella sua Galilea o in qualunque altro luogo, per poi risorgere tranquillamente? Se fosse morto in maniera naturale e poi avessero trovato vuota la tomba, non avrebbe insegnato ugualmente ch'esiste un aldilà, un regno dei cieli?
Marco, usando la tesi della resurrezione, non è in grado di spiegare con chiarezza la decisione di Gesù di farsi ammazzare nella Città Santa. Deve limitarsi a racchiudere quella decisione all'interno di tre profezie indefinibili, non interpretabili. Infatti qualunque cosa il redattore volesse aggiungere, rischierebbe inevitabilmente di far passare il Cristo per un folle ancora più grande di quello che umanamente appare, o lascerebbe comunque pensare che i suoi discepoli fossero completamente plagiati, privi delle loro facoltà mentali. Tant'è che sui discepoli è costretto a dire delle cose spiacevoli, al fine di cercare di giustificare la loro decisione di seguirlo.
In effetti, se il leader di un movimento popolare decide di farla finita con la sua vita, l'intero movimento può anche pensare di dover compiere un suicidio di massa, come avvenne p.es. a Masada, nel 73, quando si concluse la prima grande guerra giudaica. A volte l'autoesaltazione è così forte che si perde la capacità di distinguere il bene dal male. Si diventa fanatici di un'idea, disposti a compiere qualunque cosa pur di restarvi coerenti. La religione o l'ideologia in generale si trasforma in una sostanza psicotropa.37
Nel secondo annuncio della passione gli apostoli "non capivano le sue parole e temevano d'interrogarlo" (9,32). Cioè chi avrebbe potuto dissuaderlo, temeva d'essere redarguito severamente e preferiva passare per uno sprovveduto. Al terzo annuncio la stessa cosa: "erano turbati e pieni di timore" (10,32). Non solo perché rischiavano di perdere un leader di prestigio, ma anche perché loro stessi ne avrebbero pagate le conseguenze (e non si poteva certo sapere in anticipo in che misura o fino a che punto). Qui è evidente che l'evangelista ha trasformato il naturale timore che avevano gli apostoli di seguirlo per compiere l'insurrezione armata in un timore reverenziale di tipo religioso, avvolto in un mistero solenne.
Marco ritiene che i principali responsabili della morte di Gesù saranno "i capi dei sacerdoti e degli scribi", cioè le autorità giudaiche, come mandanti, e successivamente i "pagani" (10,33), come esecutori, il "braccio secolare". La differenza tra le tre profezie è che si precisa sempre di più chi saranno gli autori della sua morte violenta e che cosa gli faranno. Non si parla di Giuda, il cui tradimento - si dirà poi negli Atti degli apostoli (2,23) - rientrava nella "prescienza divina"38; né si parla del motivo per cui i pagani lo vogliono morto: Marco evita sempre di fare riferimento esplicito ai "Romani", per ovvie ragioni opportunistiche, senza però rendersi conto che i sommi sacerdoti erano scelti dagli stessi imperatori.
Sembra che a Gerusalemme Gesù non salga con una folla di seguaci, ma solo coi Dodici: "attraversarono la Galilea, e Gesù non voleva che si sapesse" (9,30). Cosa vuol far capire Marco? Anzitutto che un ingresso nella capitale col solo gruppo degli apostoli non avrebbe potuto comportare alcuna idea politicamente eversiva; in secondo luogo che una folta presenza di seguaci avrebbe potuto indurlo a tradire il proprio mandato autoimmolatorio. Nessuno quindi deve saper niente, se non gli apostoli più stretti, i quali devono essere convinti che il loro leader va a Gerusalemme per uscirne sconfitto come uomo e vincitore come dio.
Inutile quindi affrontare il problema di chi, tra loro, sarà il maggiore, una volta entrati nella capitale. "Se qualcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti" (9,35). Tutte le questioni e le esigenze di tipo politico sono per questo Gesù - agnello sacrificale - assolutamente fuori luogo. Bisogna essere puri e innocenti come bambini (9,36 s.), senza usare scaltrezze di alcun genere. Non è necessario cercare alleanze strategiche o punire chi scaccia i demoni nel nome di Gesù, pur non facendo parte del suo movimento. La vita va affrontata con filosofia, sul piano meramente etico, poiché "chi non è contro di noi, è per noi" (9,40), anche se non è "con noi".
Da notare che quanto più Gesù s'avvicina a Gerusalemme, tanto più il vangelo di Marco pone sotto accusa i fratelli Zebedeo e, in particolare, Giovanni, cioè colui che sarà il principale avversario di Pietro a motivo dell'interpretazione forzata della tomba vuota come "resurrezione". Giovanni viene citato negativamente sia in 9,38 che in 10,35, facendolo passare per un settario e, insieme al fratello, per un ambizioso, al punto che gli altri apostoli cominciarono a indignarsi con loro (10,41).
I redattori di questo vangelo fanno dire a Gesù parole terribili contro chi, nel movimento cristiano, predica azioni rivoluzionarie in senso politico: "Chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono [cioè gli ingenui, quelli che non fanno politica], meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare" (9,42). Questo in pratica voleva dire che gli intellettuali con manie rivoluzionarie dovevano rassegnarsi, se volevano continuare a militare nella comunità cristiana; e che, inoltre, dovevano educare i fedeli a credere soltanto in una salvezza ultraterrena.
II (La questione del divorzio)
Le due pericopi del matrimonio e del giovane ricco riguardano unicamente la perfezione morale. Succede sempre così: là dove si rinuncia a una lotta di liberazione nazionale, si è poi costretti, se si vuole mantenere alto l'ideale di vita, a proporre comportamenti di tipo "assolutistico", per i quali occorre una disciplina di ferro, una categorica decisione esistenziale. Peccato che proprio in questo modo si creino soltanto dei mostri.
Vediamo anzitutto la questione del matrimonio. La pericope è ambientata in Giudea: Gesù viene interrogato dai farisei, i quali gli chiedono se un uomo può separarsi dalla moglie per qualsiasi motivo e prenderne un'altra. La legge mosaica lo permetteva, anche se fino a un certo punto. Infatti in Dt 24,1 è detto che l'uomo poteva ripudiare la moglie solo in presenza di qualcosa di "vergognoso" (in genere la fornicazione), e in Lv 20,10 è scritto che la pena di morte per il reato di adulterio doveva prescindere dalla differenza di genere.39
Quindi in sostanza al tempo dei farisei si era proceduto a un'interpretazione forzata (estensiva) delle disposizioni mosaiche. Il che non esclude che col tempo, in ambito giudaico, si fosse data la facoltà di divorziare facilmente proprio perché il tradimento era divenuto non l'eccezione ma la regola. È abbastanza naturale che un legislatore pensi di risolvere un male maggiore con un male minore. D'altra parte salvaguardare forzosamente delle apparenze, in un matrimonio eticamente distrutto, è soltanto fonte di un'ipocrisia insostenibile. Il che però non dovrebbe portare a usare il male minore per giustificare quello maggiore. Evidentemente ai tempi del Cristo s'usava il libello del ripudio con la stessa leggerezza con cui ai tempi di Mosè, o a quelli successivi, gli uomini tradivano le mogli.
Cosa risponde Gesù? "È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma" (10,5).40 Qui egli sembra riferirsi ai soli Giudei, i quali - come noto - erano maschilisti, nel senso che il diritto alla separazione non era reciproco, in quanto alle donne era concesso solo per gravi motivi. Strano però che una domanda del genere gli venga rivolta dal gruppo religioso più restrittivo sulle questioni morali. Sotto questo aspetto non si capisce che tipo di risposta si aspettassero da Gesù. Se per loro era pacifico il divorzio unilaterale da parte dell'uomo, perché porgli una domanda del genere? Evidentemente nutrivano qualche dubbio sul valore della legge mosaica (o sulle interpretazioni che se ne erano date), la quale, in questo, risultava molto meno democratica di quelle presenti nel mondo greco-romano. Se invece non era pacifico, perché lo vogliono mettere alla prova (10,2)?
Detto altrimenti: se per loro la legge di Mosè andava superata, avrebbero dovuto essere contenti della sua risposta. Se invece ritenevano giusto il divorzio unilaterale e lui si fosse espresso a favore dell'uguaglianza di genere, in che maniera avrebbero potuto contestarlo? Chiunque infatti si rendeva conto che la facilità con cui si scriveva l'atto di ripudio unilaterale, senza ascoltare le ragioni della controparte, era un privilegio ingiustificato. Lo stesso Gesù può facilmente riconoscere ch'esso era stato concesso per l'egoismo dei maschi. Mosè infatti doveva aver pensato che fosse meglio un ripudio unilaterale che un matrimonio forzatamente indissolubile, in cui l'uomo, sessualmente debole, finisce col tradire la moglie, creando situazioni insostenibili anche per i figli.
Tutta la pericope, quindi, non sta in piedi. La stessa risposta di Gesù non ha un vero senso etico. Infatti egli sostiene che la coppia deve restare unita non tanto finché c'è l'amore, quanto perché lo vuole Dio. Chi si separa, uomo o donna che sia, commette adulterio. La sua è un'eguaglianza al negativo, in cui l'amore ha un ruolo subordinato. A una forzatura unilaterale a favore del maschio ne propone un'altra a sfavore di entrambi i coniugi.
Quindi, una volta sposati, il matrimonio andava considerato indissolubile. Marco non prevede neppure l'eccezione del concubinato presente in Mt 19,9. Se si deve stare insieme perché Dio ha voluto così sin dagli inizi della creazione, l'amore diventa facoltativo. Più importante dell'amore è la fedeltà reciproca.41
Ma la cosa più stupefacente è un'altra, che è poi quella che invalida, in maniera definitiva, l'attendibilità dell'intera pericope. L'autore fa parlare Gesù in maniera del tutto astratta, in quanto viene messo a confronto un periodo edenico, di tipo comunistico, con uno invece basato sullo schiavismo. Infatti egli afferma che in origine non ci si separava, si era una carne sola, ecc.; e poi afferma che quella condizione relazionale la si dovrebbe vivere anche nelle società antagonistiche, basate sui conflitti di classe, e quindi, inevitabilmente, di genere. Come se fosse la cosa più facile del mondo amarsi là dove i conflitti sono la regola o solo perché in origine Dio voleva così.
Gesù fa un discorso moralistico senza mettere in discussione le fondamenta che reggono in piedi i sistemi oppressivi. Ma questo dipende dal fatto che quando Marco fa il purista sul piano etico, lo scopo è quello di non offrire alcuna prospettiva su quello politico. Non a caso subito dopo questa pericope fa fare a Gesù l'elogio dei bambini, che sono la categoria sociale più vicina al sentire dell'uomo primitivo: "Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto" (10,15). Vivere "come bambini" in società dominate dai conflitti sociali, senza che di queste realtà si vogliano rovesciare i presupposti, è davvero possibile? è davvero auspicabile o conveniente? Come potevano i lettori cristiani di origine pagana accettare un'intransigenza del genere? Avrebbero fatto del rigore morale il principale motivo di distinzione rispetto a tutti gli altri credenti?
III (Il giovane ricco)
Vediamo ora il secondo racconto, quello del giovane ricco (10,17 ss.)42, qui collocato perché in fondo assomiglia molto al precedente: è la stessa ideologia della perfezione morale con cui supplire alle deficienze della politica.
Il giovane chiede a Gesù come essere "perfetto"43, e Gesù, invece di fargli capire che per compiere una liberazione nazionale non occorre essere eticamente perfetti, altrimenti pochissime persone si sentirebbero autorizzate a compierla, gli assicura - da "buon cristiano" - che si può essere eticamente perfetti anche in una situazione di gravi conflitti sociali. L'importante è non lasciarsi condizionare dal potere economico (di qui la necessità ch'egli venda tutte le proprie sostanze), rinunciando altresì al potere politico, che corrompe non meno di quello economico.
Tuttavia il giovane era molto facoltoso, per cui rinunciò a vendere tutti i propri beni e a distribuirne il ricavato ai poveri. Gesù gli aveva anche proposto di diventare suo discepolo, ma a una condizione pauperistica tale che quello non se la sentì di accettare.
Morale della favola? L'autore del vangelo non solo rifiuta tutto ciò che proviene dal giudaismo (in particolare il potere dei sadducei, l'ipocrisia dei farisei e il legalismo degli scribi), ma rifiuta anche la posizione di chi vorrebbe diventare cristiano senza rinunciare alle proprie ingenti ricchezze. Pietro rappresenta l'ideologia piccolo-borghese che, da un lato, si pone degli obiettivi etici esigenti, cui ovviamente non potrebbero aspirare i ceti benestanti, mentre, dall'altro, è incapace di compiere una vera rivoluzione politica, non avendo piena fiducia nella volontà popolare.
In questa pericope le stranezze sono più di una, ma non le vedremo tutte. Per esempio, gli apostoli si stupiscono che i ricchi non possano convertirsi al cristianesimo. Levi, Zaccheo, Giairo, Nicodemo, Cuza, Giuseppe d'Arimatea... non erano certo degli emarginati o degli spiantati. Dunque perché togliere ai ricchi questa possibilità? Sarebbe stato sufficiente chiedere loro di mettere i beni in comune con gli aderenti alla comunità, come viene appunto fatto negli Atti degli apostoli (2,44 ss.). Che bisogno c'era di accettarli come discepoli previa la vendita di tutti i loro averi? Nei passi paralleli di Matteo (19,18) e di Luca (18,20) non viene neppure detto che il giovane "non doveva frodare".
Qui sembra che Gesù parli come un leader politico che vuol compiere una rivoluzione anche contro le classi più agiate, che di regola campano sfruttando i più deboli. Ma è solo un'apparenza. Infatti dice agli apostoli che se anche loro hanno lasciato tutto, nel regno dei cieli riavranno tutto e con gli interessi (10,30). In questa valle di lacrime devono purtroppo abituarsi a patire "sofferenze" d'ogni genere, anche se il fatto di passare per martiri dovrebbe renderli fieri.
D'altra parte, che abbiano o non abbiano qualcosa, agli uomini è impossibile salvarsi - Marco lo fa dire chiaramente a Gesù -; possono soltanto mettersi nelle mani di Dio (v. 27). Su questa Terra nessuno riuscirà mai ad essere completamente perfetto. Gesù stesso, rivolgendosi al giovane, arriva a dire, piuttosto paradossalmente: "Perché mi chiami maestro buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio" (v. 18). "Buono" ovviamente stava per "perfetto": un aggettivo che serviva proprio per smontare l'idealismo di cui il giovane faceva mostra.
Eppure nel vangelo di Marco tutto ciò che Gesù fa e dice serve proprio a dimostrare ch'egli era l'unico a essere "buono". Strano, quindi, ch'egli contesti un appellativo del genere rivolto a se stesso. Sembra quasi che l'autore l'abbia messo per evitare che qualcuno potesse sostenere l'inutilità di credere in Dio, visto e considerato che Gesù non gli era da meno. Infatti se Gesù era "perfetto", a che pro credere in Dio? Chi ha detto che non si può essere "buoni" restando su posizioni ateistiche? Chissà, forse per questo Matteo, che cerca di parare in anticipo tutte le possibili obiezioni alle frasi di Gesù, ha preferito scrivere non "Maestro buono", bensì "Maestro, cosa devo fare di buono…?" (19,16).
IV (Il primato di Giacomo e Giovanni)
Il terzo annuncio della passione è una ripetizione, più dettagliata, del secondo, per cui non val la pena esaminarlo. Semmai ci si può chiedere di che cosa debba essere considerato una mistificazione. È fuor di dubbio, infatti, che la decisione di entrare a Gerusalemme per compiere un'insurrezione armata non poteva esser stata presa a cuor leggero. Non avevano a che fare con un nemico qualunque, ma col più grande impero schiavistico della storia antica, con l'esercito più agguerrito e meglio armato. Se, nonostante questo, il movimento nazareno pensava di farcela, doveva avere delle buone ragioni. E la prima buona ragione - che qui però non appare - doveva per forza essere determinata da un grande seguito popolare, in grado di andare ben oltre i confini della Galilea.
Delle due, infatti, l'una: o il Cristo era un pazzo irresponsabile, ovviamente non nel senso in cui lo presentano i vangeli (quello del martire suicida), ma nel senso del politico incapace di valutare con realismo e obiettività le forze in campo; oppure una possibilità doveva esserci, probabilmente di livello anche superiore a quelle che gli ebrei cercarono di sfruttare nei decenni successivi. Gesù infatti cercava consensi a 360 gradi, non voleva imporsi con un colpo di stato, né voleva che un territorio prevalesse sugli altri (p.es. la Galilea sulla Giudea, come volevano gli zeloti), né che l'insurrezione nazionale venisse gestita da un unico partito o movimento.
Peraltro Gesù, pur avendo vissuto vari anni della sua vita in Galilea come profugo, era un giudeo, conosceva bene la sua terra, poteva contare su due apostoli d'eccezione, come Giacomo e Giovanni, i quali provenivano dagli ambienti del Battista, e poteva contare anche su Giuda, che probabilmente veniva dagli ambienti farisaici progressisti. Nella sua cerchia più ristretta non aveva solo esponenti dello zelotismo. E noi non sappiamo se avesse anche un affiliato proveniente dalla Samaria: sappiamo solo che qui lo accolsero con molto entusiasmo dopo che aveva cercato di epurare il Tempio dalla casta sacerdotale corrotta.44
Entrando in Giudea e avvicinandosi il momento di salire a Gerusalemme, l'importanza, tra i Dodici, di Giacomo e Giovanni andava crescendo. Marco però, che riflette le posizioni di Pietro, ne approfitta per metterli in cattiva luce45, come aveva già fatto a carico di Giovanni nel secondo annuncio. I due, quando Gerusalemme sarebbe stata occupata, pretendevano di porsi come luogotenenti del messia, come principali ministri per la gestione della città e della resistenza armata contro Roma.
A questo punto Marco, che deve assolutamente censurare le questioni politiche, fa dire a Gesù una frase che nel contesto sarebbe stata priva di senso. "Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo?" (10,38). Cioè - parafrasando la domanda - "volete equipararvi a me nella ricerca del martirio?". L'insensatezza di questa frase sta proprio nel fatto che se tutti gli apostoli fossero stati convinti che, entrando a Gerusalemme, Gesù sarebbe stato sicuramente ammazzato, nessuno l'avrebbe seguito. Al massimo, infatti, potevano avere qualche timore, non la certezza assoluta. In fondo quando si fanno le rivoluzioni, è impossibile evitare un certo margine di rischio personale, anche molto grave: non si stanno compiendo delle semplici riforme, ancorché di rilievo.
Tuttavia l'insensatezza maggiore, nella pericope, deve ancora venire. In effetti, se ci pensiamo bene, anche Giacomo e Giovanni avrebbero potuto dire ch'erano disposti al martirio, pur di fare la rivoluzione. Più avanti Pietro dirà la stessa cosa, cioè ch'era disposto a morire per Gesù, pur di salvargli la vita. Il fatto è però che Marco non vuole presentare Gesù come politico, bensì come teologo. Di conseguenza egli deve far passare i due discepoli come altamente presuntuosi, non perché hanno dichiarato di voler diventare ministri di spicco del messia politico, né perché erano disposti a lasciarsi martirizzare senza battere ciglio, ma proprio perché stavano chiedendo una cosa che in nessun modo Gesù avrebbe potuto soddisfare.
Marco mistifica così tanto le cose che nel suo racconto Giacomo e Giovanni stanno chiedendo di sedere alla destra e alla sinistra di Gesù nel "regno dei cieli". Cioè essi si stanno proponendo come suicidi in nome di Gesù, a condizione d'avere un posto privilegiato nell'aldilà. Al che Gesù è costretto a dire: "Voi certo berrete il calice che io bevo..., ma quanto a sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato" (10,39 s.).46
In pratica Marco detesta così tanto i due discepoli (e in questo riflette la posizione di Pietro), che li fa passare come superbi nei confronti di Dio, cioè superiori allo stesso Gesù. Una cosa teologicamente infame, una specie di bestemmia. Di qui l'inevitabile indignazione da parte degli altri apostoli, i quali fanno mostra d'aver capito, meglio di loro due, le intenzioni suicide del Cristo, che "non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti" (10,45).
Questa mistica della morte purificatrice, riparatrice di sofferenze, redentiva nei confronti del male compiuto, che viene cercata quasi con ossessione, con una cura meticolosa dei particolari, è una caratteristica che si ritrova in molti soggetti fanatici, siano essi laici o religiosi, e che, per il forte impatto emotivo che suscita, può anche portare a delle autentiche follie di massa, o quanto meno ad atteggiamenti mimetico-imitativi, a fortissimi desideri di emulazione, soprattutto se il soggetto che fa da modello o da prototipo dimostra d'essere capace di cose non comuni, come p.es. guarire il cieco Bartimeo (il "figlio dell'onore") senza neppure toccarlo (10,46 ss.).
Un racconto, quest'ultimo, che pare quanto mai inverosimile.47 Sembra messo apposta per far vedere che Gesù era l'unico autorizzato a parlare di autoimmolazione, in quanto era l'unico a poter compiere prodigi di natura così straordinaria. Tale postulante, poi, viene guarito in maniera stranissima: chiama Gesù con un titolo sbagliato ("Figlio di Davide"), mentre lui ne preferiva un altro ("Figlio dell'uomo"), meno caratterizzato secondo la teologia politica giudaica.48 Accetta lo stesso di guarirlo, ma non prima d'avergli chiesto - proprio mentre lo vedeva ch'era cieco - che cosa avrebbe dovuto fargli. E quello, che avrebbe potuto chiedergli di seguirlo appunto da non vedente, dimostrando così di avere per lui una grandissima considerazione, che andava ben al di là delle sue capacità taumaturgiche e delle proprie drammatiche limitazioni fisiche, ne approfitta per chiedergli di tornare a vedere. E Gesù lo esaudisce, dicendogli: "Va', la fede ti ha salvato" (10,52).
Quale fede l'aveva salvato? e salvato da cosa? La fede semmai l'aveva guarito. Ma quale fede l'aveva guarito, se quella espressa lungo il ciglio della strada era una rappresentazione sbagliata di Gesù? Qui Marco è sottile. Egli ha voluto far differenza tra "Figlio di Davide" e il secondo appellativo che usa Bartimeo al cospetto di Gesù: "Rabbunì", cioè "Mio maestro". Se avesse ripetuto l'appellativo di "Figlio di Davide", Bartimeo avrebbe chiesto la guarigione sulla base di una pretesa: "Se sei davvero il Figlio di Davide, dimostralo guarendomi, cioè fammi capire che meriti di diventare messia politico e che per te il potere non potrà impedirti di aiutare gli indigenti, le persone sfortunate, i reietti della società".
Invece Marco cosa fa? Trasforma Bartimeo da politico a religioso: gli fa dire "Rabbunì", mostrando così ch'egli non voleva metterlo alla prova nelle sue aspirazioni politico-rivoluzionarie. Voleva soltanto riconoscerlo come proprio "maestro spirituale", che va a Gerusalemme col chiaro intento di riscattare gli uomini da tutti i loro peccati. Questa la fede di Bartimeo, che, dopo la guarigione, decide di seguire non il "Figlio di Davide", bensì il "Figlio dell'uomo", che con la resurrezione dovrà diventare "Figlio di Dio".
(torna su)10.1) Addendum sul giovane ricco (Mc 10,17-22)
[17] Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?".
[18] Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
[19] Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre".
[20] Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza".
[21] Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi".
[22] Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.
*
Il racconto dell'uomo ricco è uno dei più indicati per comprendere la differenza tra "coscienza soggettiva" (il desiderio) ed "esperienza oggettiva" (la realtà).
L'uomo che corse incontro a Gesù, mentre questi "usciva per mettersi in viaggio", e che "in ginocchio davanti a lui" gli chiese cosa doveva fare "per avere la vita eterna" (v. 17), è un soggetto usato da Marco simbolicamente, per evidenziare che anche gli uomini di "potere" (in questo caso "economico") possono avere delle "buone intenzioni".
Il simbolismo è evidente per almeno due ragioni:
- la domanda è di tipo etico (di morale personale) o, se vogliamo, di tipo filosofico-esistenziale, in quanto fondamentalmente astratta, mentre il movimento nazareno, avendo un obiettivo strategico generale (la liberazione d'Israele dall'oppressione e dallo sfruttamento), non era disposto a rispondere alle domande di "senso" in termini vaghi, idealistici o personalistici, cioè svincolati dall'esigenza di un impegno sociale e politico concreto;
- la domanda viene posta a Gesù in un momento in cui chiunque avrebbe saputo darvi una risposta precisa, circostanziata, anche se non avesse fatto parte del movimento nazareno.
Lo sconosciuto manifesta il suo particolare "idealismo" soprattutto nell'appellativo con cui ha interrogato Gesù: "Maestro buono", che nel linguaggio di allora significava "perfetto".
Con la sua controdomanda Gesù contesta il valore di tale idealismo soggettivo, benché apprezzi l'interesse e la buona fede di quel "notabile" (stando alla definizione di Luca. Matteo invece lo considera un "giovane", ed è la sua versione che è passata nella tradizione della chiesa. Il termine "giovane" probabilmente è stato usato da Matteo in luogo di "ingenuo" o addirittura di "illuso", ancorché per motivi correlati all'età e non alla volontà. Trasformando quest'uomo in un "giovane", Matteo ha cercato di giustificarne il comportamento, ma così ha di molto attenuato il dramma psicologico del racconto di Marco).
"Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo" (v. 18) - così risponde Gesù. Qui è evidente che Marco vuole evitare il culto della personalità, ma la sua preoccupazione (o di qualche altro redattore) è anche quella di dimostrare che tale culto può essere superato solo ribadendo il culto esclusivo per la divinità. Il che lascia già presagire che la risposta di Gesù o l'interpretazione che lo stesso vangelo ne vorrà dare - come vedremo -, sarà inficiata da argomentazioni di contenuto religioso.
La prima risposta che Gesù dà è di carattere etico e rappresenta la soluzione minore, proporzionata a un'esigenza superficiale, spontaneistica, anche se sincera. "Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la padre" (v. 19). L'uomo dunque era "sposato" ed è altresì significativo che un secondo redattore abbia aggiunto il divieto di "frodare" a quello di "non rubare", che evidentemente, in considerazione del ruolo sociale ricoperto da quell'uomo, non era parso sufficiente. Quest'aggiunta in realtà rispecchia un'ideologia spoliticizzata del redattore, secondo cui - almeno così sembra - il senso etico dell'esistenza consiste non in un impegno fattivo contro le ingiustizie sociali e l'oppressione (che nella Palestina di allora dominavano ampiamente), ma semplicemente nella conduzione di un'esistenza la più possibile onesta. Sul piano pedagogico è però interessante la preoccupazione del redattore di verificare, attraverso Gesù, l'effettiva coerenza, nel notabile, tra desiderio e vita. La comunità cristiana primitiva, benché spoliticizzata, prevedeva al suo interno un forte rigorismo morale.
La testimonianza del notabile è comunque positiva, almeno riguardo al dovere di rispettare la legge. "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza" (v. 20). Già da questo Matteo avrebbe dovuto capire che l'"uomo" di Marco non poteva essere scambiato per un "giovane". La sua domanda rispecchiava uno stato d'insoddisfazione personale, tipico di quella persona che, dopo essere entrata nel mondo degli adulti, si chiede se i suoi progetti giovanili abbiano qualche possibilità di realizzarsi. Quell'uomo, in pratica, si chiedeva se c'era la possibilità, nella vita adulta, di superare le illusioni della gioventù senza rischiare di cadere nel cinismo. Egli infatti aveva già maturato l'idea che il rispetto scrupoloso della legge non era bastevole alla realizzazione di sé.
Di qui la seconda risposta di Gesù, che è più impegnativa, in quanto è rivolta sia alla professione dell'uomo che alla sua coscienza sociale e politica. "Una sola cosa ti manca: Vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi" (v. 21).
La risposta è caratterizzata da due elementi: uno costrittivo, la povertà; l'altro propositivo, la sequela. La prima soluzione è una critica indiretta dei limiti della legge. Con essa cioè si vuole dimostrare che la legge può permettere un'onestà personale puramente formale: sia nel senso che non aiuta l'uomo onesto e virtuoso a trovare un senso vero di liberazione, poiché la legge può solo proibire non promuovere (ed è il caso del notabile in questione); sia nel senso ch'essa, di per sé, non può farsi carico di tutti i tentativi disonesti dell'individuo, in quanto se veramente ci fosse la possibilità di utilizzarla così, gli uomini non avrebbero bisogno di alcuna legge.
La risposta di Gesù è radicale, non moralistica, poiché si dà per scontato che l'opulenza, se è conciliabile col rispetto della legge (almeno apparentemente, in quanto Gesù, fidandosi, non ha verificato l'attendibilità delle affermazioni del notabile), non lo è mai con l'istanza umana di liberazione. Di qui la richiesta di seguirlo in un impegno politico attivo a favore degli oppressi, uscendo non solo dai limiti della legge, il cui rispetto non può assolutamente comportare un progresso qualitativo verso la democrazia; ma anche dai condizionamenti della ricchezza personale, la quale, agli occhi dei ceti marginali, appariva inevitabilmente come motivo di sospetto.
Occorre in sostanza ribadire che l'aspetto più costruttivo della proposta di Gesù sta anzitutto nell'offerta di un discepolato attivo e diretto, vissuto in prima persona. Nessuno infatti rinuncerebbe alla propria sicurezza materiale se non fosse convinto di ottenere, in cambio, la soddisfazione di un'esigenza di giustizia molto più sentita. Tuttavia, è significativo come Gesù ponga in stretta correlazione la lotta politica per la giustizia con la rinuncia all'opulenza. L'interdipendenza dei due fattori può essere usata non solo per denunciare il limite della prassi dell'elemosina o dell'assistenza a favore dei poveri, ma per mettere anche sull'avviso quanti credono possibile restare coerenti con l'obiettivo rivoluzionario vivendo un'esistenza agiata. Da notare che qui - essendo il testo manomesso per motivazioni religiose - l'affermazione relativa al "tesoro nel cielo" può contribuire in misura rilevante a cercare un alibi per non impegnarsi politicamente.
Gesù si rendeva conto che il cospicuo patrimonio che il notabile possedeva avrebbe potuto ostacolarlo anche nel caso in cui l'avesse conservato in minima parte. In astratto è senza dubbio vero che chi prova un grande desiderio di liberazione deve essere disposto a fare grandi sacrifici, anche da subito; ma nella fattispecie del racconto questo è ancora più vero, poiché qui si è in presenza di un "notabile", non di un uomo qualunque.
"Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni" (v. 22). La conclusione è molto amara, ma realistica, anche se - diversamente da come vorrà far credere il commento redazionale dei vv. 23 ss. - non era inevitabile ("Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!"; "È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago..."; "Impossibile salvarsi presso gli uomini, ma non presso Dio!").
Detto commento è alquanto moralistico, poiché non solo è pregiudizievole nei confronti dei ceti benestanti, condannando la ricchezza in sé e ritenendo "impossibile" una qualche modifica comportamentale in direzione della giustizia sociale (cosa però che gli stessi vangeli, in altri racconti, non dicono), ma anche perché si affida interamente alla "divinità" il compito di "salvare" l'individuo. Paradossalmente, proprio questi versetti favoriscono l'accumulo delle ricchezze, in quanto distolgono gli uomini dal compito di combatterne l'uso antisociale.
In realtà, l'insegnamento del racconto di Marco doveva essere un altro, quello per cui l'idealismo (sia nella forma oggettiva, connessa al rispetto della legge, sia nella forma soggettiva, connessa al bisogno di autorealizzazione) è di per sé inutile ai fini della liberazione sociale e personale, e che le "buone intenzioni" sono sempre insufficienti quando non si concretano nella prassi quotidiana. I fatti stanno proprio lì a dimostrare che si può essere nello stesso tempo "moralmente giusti" e "politicamente ingiusti".
Dal punto di vista della legge, l'opulenza può non essere incompatibile con la ricerca della perfezione morale, ma essa è comunque un impedimento notevole alla realizzazione della giustizia sociale, perché profondamente contraddittoria con la realtà della miseria e dello sfruttamento. Solo chi ha coscienza di questa contraddizione e avverte forte dentro di sé il bisogno di superarla, è disposto a rifiutare l'idea che opulenza e onestà siano compatibili. Che questa consapevolezza possa maturare anche in una coscienza "borghese", va considerato come un'eventualità remota, ma non impossibile, anche se non sarà certo dalla speranza che tale eventualità si verifichi che dipenderà la battaglia politica per la giustizia sociale, e tanto meno si dovrà rinunciare a tale battaglia - come invece vuole ogni religione - affidandone l'esito alla volontà divina.
(torna su)11) L'ingresso trionfale nella Città Santa (fonti)
I (Il fico seccato)
Quando inizia a parlare dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme (11,1 ss.), Marco dimostra di non avere le idee molto chiare. Ed è strano, perché su questo punto poteva avvalersi di una fonte diretta come Pietro. Si ha l'impressione che, sul piano logistico, voglia confondere le acque a bella posta. Infatti parla di Betfage e di Betania, presso il Monte degli Ulivi, quando sarebbe stato sufficiente dire che quelle due località erano vicine alla Città Santa. E poi perché citare Betfage? La decisione di compiere l'insurrezione venne presa a Betania, dopo la morte di Lazzaro e la sconfitta del suo movimento politico eversivo, così come viene detto, seppur non a chiare lettere ovviamente, nel quarto vangelo.49
Lo stesso Getsemani, in genere, viene ricordato come vicino a Gerusalemme, non come vicino a Betania. È vero che sul pendio orientale del Getsemani si trovano i due suddetti villaggi, ma non ha alcun senso citare i villaggi e il monte per indicare che Gesù stava per entrare nella capitale, cioè senza spiegare quel che di decisivo avvenne a Betania.
Probabilmente infatti fu proprio lì che si stabilì un patto di alleanza con l'ala farisaica progressista che simpatizzava per Lazzaro (o Eleazar), senza la quale sarebbe stato difficile compiere un'insurrezione nella capitale giudaica. Quel che Gesù non era riuscito a fare con loro durante l'epurazione del Tempio (sulla cui opportunità il fariseo Nicodemo non aveva avuto nulla da eccepire), doveva poterlo fare adesso, e non più solo contro la casta sacerdotale corrotta, ma anche contro la guarnigione romana stanziata nella fortezza Antonia.
L'ingresso viene descritto in maniera completamente mistica, privandolo di tutto il suo contenuto politico. Basta fare il confronto con la versione di Giovanni per rendersene conto. In questa, p.es., Gesù trova, molto semplicemente, un asino da cavalcare, al fine di dimostrare il proprio senso della democrazia (rifiutando quindi il cavallo dei conquistatori di città e di regni), mentre in quella di Marco vengono spesi molti versetti per mostrare che Gesù, dall'alto della propria preveggenza divina50, è in grado d'indicare a due discepoli il punto esatto ove prelevare l'animale, su cui nessuno era mai salito (11,2).51
L'accoglienza, incredibilmente trionfale, risulta abbastanza inspiegabile nel contesto marciano, sia perché Gesù non aveva mai messo piede in Giudea, sia perché non vengono spiegati i preliminari che giustificano l'ingresso e che lo rendono possibile senza incidenti di sorta. Peraltro, mentre in Gv 12,13 è chiarissimo che lo accolgono come un "re d'Israele", in Marco lo omaggiano solo come profeta o come sacerdote52, tant'è ch'egli si limitò a entrare nel Tempio e ad "osservare ogni cosa attorno" (v. 11), senza fare alcunché, almeno in un primo momento.
Tutta questa reticenza nel mostrare il lato politico del Cristo fa inevitabilmente pensare che Marco abbia scritto le parti principali del suo vangelo prima della caduta di Gerusalemme, al fine di risparmiare i cristiani dall'accusa di essere sediziosi, che i Romani, a partire dal 66, cominciarono ad applicare a gran parte degli ebrei della Palestina. Seguaci di Pietro e di Paolo i cristiani non volevano essere confusi con gli zeloti che stavano per far scoppiare la prima grande guerra giudaica. Di qui forse la loro fuga in massa a Pella, di cui parlano gli storici Eusebio ed Epifanio.
Che Marco voglia presentare un Cristo religioso, alternativo soltanto ai sommi sacerdoti, è dimostrato anche dal fatto che nella capitale gli fa compiere un gesto fuori contesto: la purificazione del Tempio (11,15 ss.), che fa precedere dalla maledizione del fico (11,12 ss.). Una maledizione apparentemente inspiegabile, in quanto, siccome egli aveva fame e l'albero era però privo di frutti, non essendo quella la stagione giusta, decise che, d'ora in avanti, non ne avrebbe più fatti. Un gesto che ha scandalizzato non pochi atei, ma che si spiega considerando che la Giudea appare a Gesù già "seccata" sul piano teologico, impossibilitata a dare buoni frutti sua sponte. E siccome è già morta, è inutile sperare che possa migliorare.
Il fico non è altro che un'illusione, che va spogliata dei suoi fronzoli, un miraggio che va svelato per quello che è. Il Gesù di Marco non entra a Gerusalemme per dare una nuova speranza, ma per dimostrare che, di fronte al suo messaggio di redenzione universale, i Giudei non potevano che condannarlo; e se anche l'hanno accolto in maniera trionfale al suo ingresso, di lì a qualche giorno gli si rivolteranno contro. La teologia petrina è tanto più rassegnata politicamente quanto più intransigente sul piano etico.
L'epurazione del Tempio viene posta come controprova dell'inutilità del fico, che possiede solo foglie ingannatrici. In realtà essa viene qui compiuta fuori tempo massimo, in quanto ormai l'espulsione della classe sacerdotale dal Tempio - che nel IV vangelo è collocata all'inizio della carriera politica di Gesù - va considerata in subordine rispetto alla necessità di compiere la liberazione nazionale contro l'oppressore romano. Infatti, se si vincerà la partita contro Pilato, inevitabilmente i nazareni vinceranno anche quella contro Caifa. E non era forse più facile trovare alleati contro un nemico evidente a tutti, ancorché molto forte, che non contro un'autorità subdola, che pensava di salvare le prerogative della Giudea avvalendosi di compromessi con l'invasore (come in genere fanno i ceti aristocratici e affaristici)?
Cosa fa invece il Gesù di Marco? Prende di mira anzitutto i sommi sacerdoti e gli scribi, senza avere alcuna intenzione di muover guerra ai Romani. Fa la parte di un nuovo sacerdote, che desidera vedere un Tempio purificato, privo di affari commerciali, preposto esclusivamente alla preghiera. Per questo si limita a espellere i mercanti, sperando forse che per cacciare i sacerdoti intervenga la folla, la quale però si limita soltanto a proteggerlo dalle intenzioni omicide delle autorità religiose. Tutta la folla è soltanto "piena d'ammirazione per il suo insegnamento" (11,18), ma materialmente non fa nulla per aiutarlo a estromettere i capi dei sacerdoti e gli scribi dal Tempio, sicché Gesù e gli apostoli, "quando fu sera, sono costretti a uscire dalla città" (v. 19).
Il giorno dopo Pietro deve constatare che il fico è morto (11,21). Marco ha riportato qui lo stesso atteggiamento che la folla ebbe nel racconto di Giovanni riguardo alla medesima epurazione del Tempio: evidentemente Pietro, che in quell'occasione era presente e che conobbe Gesù per la prima volta, se lo ricordava e se ne è servito per ridurre la strategia politica insurrezionale a una strategia religiosa redentiva.
Al vedere il fico seccato Gesù, che qui viene fatto passare da Marco come un dio affetto da delirio di onnipotenza, non può mancare di dire: "Abbiate fede in Dio. In verità vi dico che chi dirà a questo monte: Togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuore suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto" (v. 23). Si ha come l'impressione che quanto più si sia costretti a parlare del principale momento politico del Cristo, gli autori di questo vangelo facciano di tutto per negarne il valore, mistificandolo con atteggiamenti e parole di tipo teologico.
Qui sembra di sentir parlare Pietro, il quale, rivelatosi incapace di proseguire il messaggio di liberazione del Cristo, si affida completamente all'aiuto di un'entità astratta a lui totalmente esterna. Sembra l'autoconvinzione, portata all'eccesso, di un disperato, come se dicesse a se stesso: "Quello che sul piano politico non ho potuto fare come uomo, spero che lo faccia Dio, su quello religioso, attraverso di me".
Il mezzo per ottenere questo lo indica lo stesso Gesù: la "preghiera". Non riportando il Padre nostro, questo è l’unico luogo nel vangelo di Marco ove si parla della preghiera e della sua efficacia. "Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato" (11,24). Bisogna solo fare attenzione a non esagerare. Infatti non è possibile chiedere che i propri nemici vengano eliminati o rimossi: "Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati" (v. 25). In altre parole il cristiano può dimostrare di avere una fede eccezionale, ma non può desiderare di far fuori o di neutralizzare gli oppressori, gli sfruttatori, i violentatori. Solo Dio può far giustizia e questa, su questa Terra, non è mai pienamente possibile, se non in forma molto limitata e transitoria.
La fede quindi a cosa serve? Quale montagna può essere spostata? Serve a se stessi, a rimanere puri in una società corrotta. Questo il moralismo, politicamente opportunistico, della teologia petrina, che Marco ha messo per iscritto. Se quanto dice la tradizione, a proposito del fatto ch'egli si fece crocifiggere a testa in giù, in quanto era convinto di non essere stato un degno discepolo del Cristo, è vero, con questi suoi ragionamenti possiamo capirne la ragione.
II (Epurazione del Tempio) (fonti)
Abbiamo quindi visto che Marco fa ruotare tutto il capitolo 11 intorno al tema dell'espulsione dei mercanti dal Tempio, quando in realtà quell'episodio neppure avvenne in quel momento. E, per quanto Giovanni lo collochi nella sua giusta cronologia, lo spazio che gli dedica è nettamente inferiore a quello usato da Marco. Questo quindi vuol dire che nel protovangelo l'episodio riveste un ruolo di capitale importanza. Infatti la vera diatriba, in questo testo, non è tra Ebrei e Romani (anche se nella pericope relativa al tributo da dare a Cesare, qualcosa di significativo si dirà), ma piuttosto tra Gesù e i sommi sacerdoti, o comunque tra il movimento nazareno, prevalentemente galilaico, e le autorità del Tempio e del Sinedrio, che per Marco sono tutte giudaiche.
Non a caso il capitolo in oggetto si conclude col dibattito tra Gesù e "i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani" (11,27). La domanda che gli pongono appare abbastanza scontata: "Con quale autorità fai tu queste cose?" (v. 28). Cioè - parafrasando - "con che diritto ti sei permesso di espellere dal Tempio un'intera categoria sociale (commercianti e cambiavalute), autorizzata espressamente con permessi e licenze rilasciati dalle autorità religiose costituite?".
Una domanda che, in quel frangente, non avrebbe avuto molto senso porre, in quanto, in nome della popolarità con cui era stato fatto trionfalmente entrare nella capitale, Gesù avrebbe potuto fare del Tempio ciò che voleva. Anzi, se avesse cacciato anche i sacerdoti, pochi vi si sarebbero opposti, poiché a tutti era nota la loro corruzione (nella prima guerra giudaica Galilei e Idumei faranno un generale repulisti di questa casta privilegiata). Il sommo sacerdote era addirittura scelto dall'imperatore e Caifa non aveva mai avuto noie da Pilato.
In ogni caso Marco vuol mostrare che tra Gesù e queste autorità religiose non poteva esserci alcun dialogo. Sicché Gesù, provocatoriamente, alla loro domanda risponde con un'altra domanda, ponendo come condizione alla concessione della propria risposta, che loro rispondano alla sua: "Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?" (11,30); cioè aveva un carattere teologico, conforme alla volontà divina, e - potremmo aggiungere noi - per chi l'accettava comportava precise responsabilità politiche per la realizzazione terrena del "regno di Dio", o era frutto di una semplice iniziativa umana, di tipo morale e personale, non vincolante per chi la condivideva, in quanto non implicava la realizzazione politica di alcunché?53
Era una domanda che Gesù non avrebbe mai potuto porre, proprio perché per lui il battesimo di Giovanni, in sé e per sé, non costituiva affatto una strategia efficace per abbattere la corruzione del Tempio, e tanto meno avrebbe potuto servire per suscitare la resistenza armata contro Roma. Evidentemente la domanda riflette una riconciliazione tra il movimento cristiano e quello battista (o almeno una parte di questo) l'indomani della distruzione del Tempio. Qui infatti Gesù si dichiara discepolo di Giovanni, con la differenza che egli vuole attaccare più direttamente la classe sacerdotale, mentre Giovanni si era limitato ad attaccare esplicitamente soltanto Erode Antipa, a motivo del suo secondo matrimonio. È solo nel quarto vangelo che veniamo a scoprire quanto il Precursore criticasse, seppur solo sul piano etico, anche le autorità religiose.
Nel dialogo con tali autorità il Gesù marciano si sente nettamente superiore ai membri del Sinedrio e vorrebbe che lo riconoscessero come pontefice, mentre il Battista aveva sin dall'inizio dichiarato di non essere il messia e di non volersi sostituire al potere istituzionale.
Marco prosegue il racconto allo scopo di mostrare che l'intera classe dirigente giudaica era totalmente screditata e che non avrebbe mai potuto sostenere alcun dibattito pubblico con Gesù. Sommi sacerdoti, anziani e scribi dovevano semplicemente dimettersi en bloc. Ecco perché Marco, qui molto ideologico ed estremista, li fa passare per un branco di ipocriti, impossibilitati a rispondere, senza contraddirsi, alla chiara domanda di Gesù. "Ed essi discutevano tra sé dicendo: Se rispondiamo dal cielo, dirà: Perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta. Allora diedero a Gesù questa risposta: Non sappiamo. E Gesù disse loro: Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose" (11,31 ss.).
Un racconto davvero strano, questo, in quanto riduce completamente la questione dei rapporti politici tra Roma e Israele a una semplice questione teologica tra conservazione e innovazione, tra istituzione e profetismo (nell'ambito del giudaismo). Il racconto vuole apparire teologicamente sovversivo, ma politicamente è inoffensivo. Non mette in discussione le istituzioni giudaiche, la loro legittimazione, ma solo il loro modo concreto di vivere i valori dell'ebraismo, la legge mosaica, le tradizioni... Il Cristo eversivo è tutto racchiuso in una proposta religiosa che, sul piano dei contenuti, chiede soltanto a quelle autorità d'essere maggiormente coerenti tra l'idea di "Bene" (platonicamente intesa) e la pratica, cioè di essere meno schematiche nell'interpretare le esperienze che non provengono dai loro specifici ambienti, più vicine alle esigenze popolari e meno chiuse nei loro privilegi di casta.
Supponiamo infatti che Gesù avesse potuto dire con quale autorità aveva epurato il Tempio: che cosa avrebbe detto di diverso da Giovanni? Forse ch'egli era "Figlio di Dio"? o il messia teo-politico che tutti attendevano? o che il primato del Tempio era finito e ognuno poteva pregare Dio dove voleva? o che riguardo al precetto del sabato si dovevano allargare i casi di trasgressione? o che sui vincoli alimentari si poteva essere molto più elastici? Questi non erano affatto argomenti decisivi attorno ai quali poter costruire un consenso popolare, un'organizzazione politica, una resistenza armata con cui compiere l'insurrezione nazionale. Con essi, al massimo, si poteva democratizzare il giudaismo o "umanizzarlo" - ciò che appunto Giovanni Battista voleva fare, in attesa che arrivasse un messia liberatore dell'oppressione romana -, ma non sarebbe stato in virtù di essi che si sarebbe potuto fare un sicuro passo avanti rispetto al movimento battista.
Tutto il dialogo di Gesù con le autorità costituite è quindi non solo irreale per i risvolti religiosi che avrebbe potuto comportare se fosse andato avanti, ma è anche antistorico, in quanto in quel momento le preoccupazioni del Cristo erano di tutt'altra natura. Egli non stava cercando un consenso da parte delle autorità politico-religiose della Giudea, ma un consenso da parte della popolazione intenzionata a insorgere e da parte dell'ala progressista del partito farisaico (quella di Hillel?), il quale, senza dubbio, a Gerusalemme era molto influente, visto che "anche tra i capi molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga" (Gv 12,41). Probabilmente Gesù stava chiedendo anche ai seguaci del Battista e agli esseni di tenersi pronti all'insurrezione armata.
Che Marco escluda questa visione delle cose è attestato dalla parabola con cui fa chiudere a Gesù il dibattito in oggetto. La parabola dei vignaioli (12,1 ss.) sta ad indicare: 1) l'odio dei Galilei nei confronti dei Giudei, in quanto la vigna verrà tolta ai vignaioli e data ad altri; 2) la decisione di collocare il Battista tra i grandi profeti veterotestamentari, considerandolo l'ultimo della lista; 3) la convinzione che Gesù sia l'unico vero "Figlio di Dio", la cui uccisione, da parte dei contadini della parabola, è stata permessa dal Dio padrone della vigna proprio per togliere alla Giudea qualunque primato storico e onorifico.
Con questa parabola si fa del cristianesimo, sorto in Galilea, la prosecuzione più coerente del movimento battista e l'alternativa più radicale al giudaismo ufficiale. Tutto quanto apparirà dopo questa parabola, fino al discorso sul Monte degli Ulivi, servirà soltanto a far capire al lettore in che cosa si differenzia il cristianesimo dal giudaismo. E questo sarà molto importante dopo la catastrofe del 70.
III (Tributo a Cesare)
Il tributo a Cesare (12,13 ss.) è una pericope famosissima, in cui la teologia petro-paolina ha voluto far vedere la propria differenza dal paganesimo, generalmente prono alla volontà degli imperatori, nonché la propria differenza dal giudaismo politico-nazionalistico, insofferente a qualunque colonizzazione da parte di potentati stranieri.
Il cristianesimo primitivo vuole porsi come semplice culto religioso che non tollera una netta subordinazione della teologia alla politica dei poteri dominanti (a quel tempo romano-pagani), ma che non vuole neppure trasformare la propria teologia in un'ideologia politica eversiva. Quindi è una confessione disposta a un compromesso.
Nei confronti dei sovrani imperiali di Roma il cristianesimo chiede soltanto di poter esercitare un culto religioso diverso da quello pagano, anzi, alternativo, in quanto il politeismo viene decisamente rifiutato, e chiede anche che nessun cristiano sia costretto a compiere sacrifici per l'imperatore, in quanto la chiesa non può ritenerlo un'autorità religiosa (il titolo che aveva era "pontefice massimo") e tanto meno una divinità. I cristiani erano disposti a riconoscere l'autorità imperiale a condizione che questa riconoscesse la loro autonomia in campo religioso. Naturalmente erano anche disposti a riconoscere il sistema schiavistico qua talis: lo stesso Gesù viene presentato come un Dio che si è fatto servo per redimere l'umanità. Tale pericope è quindi la proposta di un patto: il cristianesimo può sostenere politicamente gli imperatori se questi permettono ai cristiani di autogestirsi come vogliono sul piano religioso.
Come noto, ci vorranno tre secoli di persecuzioni prima che l'impero si renda conto dell'opportunità di accettare un'intesa del genere. E quando deciderà di farlo, troverà un cristianesimo disposto a tradire se stesso, in quanto, diventando "religione di stato", assumerà il ruolo che il paganesimo aveva avuto in precedenza, anzi comincerà a perseguitare tutte le confessioni religiose non solo dichiaratamente pagane, ma anche quelle cristiane non conformi all'ortodossia ufficiale. Quindi là dove nella pericope in oggetto si chiedeva al potere imperiale di rispettare la libertà di coscienza, con la svolta teodosiana del 381 si chiederà invece alla società civile di accettare l'idea di uno Stato confessionale.
In ogni caso la pericope non rispettava affatto la posizione di Gesù, sia perché egli era ateo, sia perché era intenzionato a compiere un'insurrezione contro la presenza romana in Palestina. Questo per dire ch'egli non avrebbe riconosciuto nulla né a Dio né a Cesare. E a una domanda del genere avrebbe inevitabilmente risposto che a Cesare il tributo54 andava riconosciuto finché non si avevano le forze sufficienti per negarglielo. Essendo entrato trionfalmente a Gerusalemme, la risposta ch'egli poteva dare a una domanda del genere doveva apparire scontata ai suoi interlocutori. Tutta l'organizzazione politica del suo movimento aveva lo scopo di non far pagare alle masse popolari né il tributo a Cesare, né quello alla casta sacerdotale del Tempio. E, in quel frangente storico, tale scopo poteva anche essere dichiarato pubblicamente.55
IV (Il tema della resurrezione)
In un certo senso è singolare come Marco, nei dibattiti che Gesù sostiene pubblicamente dopo l'ingresso messianico, riporti solo quelli in cui gli interlocutori gli sono ostili (sommi sacerdoti, anziani, scribi, sadducei, farisei ed erodiani) e non dica nulla di qualche intesa positiva: come avrebbe potuto fare un'insurrezione nazionale senza alleati? Sembra che nessuno condivida le sue idee, che tutti gli siano fortemente avversi: ma allora come spiegare il grande consenso popolare ottenuto durante l'ingresso? Marco vuol fare di tutto per dimostrare che la crocifissione di Gesù era inevitabile, anzi necessaria, quando invece tutto era ancora possibile.
Un altro argomento trattato pubblicamente - questa volta con i sadducei56 - è stato, secondo l'autore, quello della resurrezione (12,18 ss.). Un tema che il Cristo non avrebbe mai affrontato, né pubblicamente né in quel momento storico, in cui si doveva pensare a ben altro. Ridurre poi la diatriba tra Cristo e i sadducei - come ha fatto Marco - a una così mistica questione, è piuttosto ridicolo, anche se la risposta che gli viene fatta dire è sicuramente più intelligente di quella che avrebbero potuto dare i farisei, che su questo tema erano anche disposti a esprimere un vago parere favorevole, ovviamente non ben circostanziato.
La cosa curiosa è che la parte degli scettici viene svolta dai sadducei, che invece avrebbero potuto utilizzare quell'argomento per imbonire le masse. Il fatto è che, giudicandolo appartenente alla tradizione orale, essi tendevano a escluderlo dalle loro convinzioni.
I farisei invece avevano iniziato a crederci proprio perché, non ritenendo più possibile un'insurrezione vincente contro Roma, tendevano a rimandare all'aldilà la liberazione definitiva dalle sofferenze, dall'oppressione.
La risposta di Cristo resta comunque interessante per due motivi: anzitutto perché prospetta una prosecuzione della vita nell'universo non esattamente in linea con le condizioni terrene che ci sono date da vivere; in secondo luogo perché se è vero che parlare di resurrezione può significare, almeno in apparenza, parlare di morte, è anche vero che la morte non esiste, esistendo soltanto una trasformazione della materia. Il concetto di "resurrezione" è quindi del tutto insensato, proprio perché si è destinati a esistere.
Marco si rendeva conto di ciò che scriveva? Si rendeva conto che la stessa idea petrina di "resurrezione" era il frutto di una mente ignorante e superstiziosa? Se qualcuno morisse e poi, dopo un certo tempo, si ridestasse, bisognerebbe parlare di "morte apparente" o, come diciamo oggi, di "uscita dal coma": il termine di "resurrezione" al massimo potrebbe essere usato metaforicamente.
Parlare poi di "resurrezione" nei confronti del Cristo è ancora più assurdo, poiché il suo corpo non è più stato trovato; lo stesso vangelo di Marco non prevedeva, nella versione originaria, alcun racconto di riapparizione del Cristo redivivo. Dunque come si può parlare di "resurrezione" senza aver rivisto da vivo il morto? E se anche per ipotesi lo si rivedesse, come si potrebbe essere sicuri che sia davvero morto? Poiché non è possibile uscire da questo inghippo, è del tutto inutile discuterci sopra.
Il concetto di "resurrezione" può essere usato solo in senso simbolico, e non ci si può costruire sopra alcuna strategia politica, alcuna considerazione filosofica o teologica, alcun comportamento etico. Di questo, secondo noi, era pienamente consapevole l'apostolo Giovanni.
Il torto dei sadducei non stava nel non crederci, ma nel negare la trasformazione della materia e l'eternità della vita, che sono caratteristiche tipiche dell'universo, di cui il genere umano è parte integrante.
V (Dialogo con lo scriba)
Il dialogo con lo scriba (12,28 ss.) ha qualcosa di paradossale, non tanto perché in questo vangelo è la prima e unica volta che Marco mette in buona luce una figura del genere (cosa che potrebbe anche far pensare che la pericope sia stata inserita successivamente); quanto perché Gesù dice le stesse cose che avrebbe potuto dire un qualunque scriba o fariseo, sicché non si comprende assolutamente dove stia la diversità. Perché quindi farsi ammazzare a Gerusalemme, visto che la teologia cristiana, negli aspetti etici, è la stessa di quella giudaica?
Qui l'autore obbliga Gesù a fare una piena professione di teismo ebraico, ribadendo inoltre il grande comandamento etico di questa religione: "Ama il prossimo tuo come te stesso" (12,31). Lo scriba non fa che ripetere le sue parole, limitandosi ad aggiungere che amare il prossimo come se stessi "è molto di più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (v. 33). Dopodiché "Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio" (v. 34).
Risposto con intelligenza? Ma se ha ripetuto alla lettera le medesime parole! E poi perché dire - visto che le ha ripetute alla lettera - che è soltanto "vicino" al regno di Dio? Come minimo avrebbe dovuto invitarlo a diventare un seguace del suo movimento.
Cerchiamo di capire meglio. In ciò che ha detto lo scriba, dove sono quelle parole per le quali si è meritato l'appellativo di "intelligente"? Probabilmente stanno solo in quel brevissimo riferimento agli olocausti e ai sacrifici. Praticamente quindi che cosa aveva detto lo scriba? Che per essere salvi o giustificati è sufficiente amare Dio e il prossimo come se stessi. Però aveva anche lasciato intendere che, pur essendo subordinati alla devozione per Dio e all'amore del prossimo, gli olocausti e i sacrifici potevano continuare ad essere fatti: cosa che invece i cristiani (e, prima di loro, i nazareni) avevano smesso di fare. Quindi in pratica Gesù gli sta chiedendo, se vuole davvero partecipare alla nuova comunità cristiana, di semplificare i propri contenuti di vita religiosa, cioè di privarli di tutti quegli aspetti formali ed esteriori (e nel mondo ebraico erano davvero tanti e assai minuziosi) che non garantivano, di per sé, l'autenticità della fede.
Questo poi senza considerare che, nell'ambito del cristianesimo, "amare gli altri come se stessi" non è un'affermazione eticamente molto pregnante, proprio perché fa dipendere il "noi" dall'"io", nel senso che prima di decidere quanto e come amare il prossimo, dovremmo verificare quali potrebbero essere i parametri dell'amore se al posto del "prossimo" ci fossimo "noi". In altre parole manca in quel comandamento la relazione paritetica tra l'io e il tu; anzi manca proprio la relazione sociale che fonda l'identità dell'io, tant'è che nel quarto vangelo Gesù parla di un "comandamento nuovo", quello di "amarsi gli uni gli altri".57
Amare gli altri come se stessi non può bastare per vivere l'amore. Spesso bisogna amare gli altri anche più di se stessi, e di ciò non ci si deve affatto vergognare. È del tutto normale incontrare persone che, sul piano umano, riteniamo migliori di noi. Peraltro gli ebrei tendevano a escludere che, nell'amore per il prossimo, fossero inclusi anche i pagani: gli olocausti e i sacrifici rituali imponevano proprio tale differenziazione. Persino i cristiani della prima ora, seguaci di Giacomo fratello di Gesù, non mettevano certo sullo stesso piano l'amore per il prossimo di matrice ebraica, con quello per un prossimo considerato di estrazione pagana (si pensi solo alla decisione di continuare a praticare la circoncisione e i divieti alimentari). Ci vorrà Paolo prima di capire che tra ebrei e pagani non ci poteva essere alcuna differenza, una volta diventati cristiani.
VI (Dialogo coi farisei)
Che l'autore del vangelo detesti gli scribi, nonostante il racconto precedente, è dimostrato anche da ciò che fa dire a Gesù al loro riguardo, mentre interroga i farisei: "Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più grave" (12,38 ss.). Sembra che stia parlando di un atteggiamento che oggi diremmo "mafioso", salvo che l'odierna criminalità organizzata è più laica e in grado di sfruttare chiunque, anche i poteri forti.
Ma perché se la prende con gli scribi, visto che sta parlando coi farisei? Semplicemente perché molti scribi militavano nel partito farisaico. Quindi giudicando gli uni, giudica anche gli altri; e le parole che usa sono proprio "condanna più grave" o "più severa" (v. 40).
La domanda che rivolge ai farisei è del tutto assurda, proprio perché troppo mistica per trovare una risposta. Infatti i farisei restano muti. E, ciononostante, o forse proprio per questo, Gesù spara a zero contro chi meglio li rappresenta, davanti alle istituzioni: gli scribi.
Cerca di mettere in difficoltà i farisei, ai quali si rivolge dicendo: "Come mai gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide", quando lo stesso Davide lo qualifica come suo Signore? (12,35). Titolo, quello di "figlio di Davide", che Gesù ha sempre rifiutato, essendo troppo caratterizzato sul versante teo-politico. Qui ne parla tranquillamente perché ha spostato lo scenario nell'aldilà, o ha comunque stravolto i fatti originari della versione anticotestamentarie.
Questo è uno dei rari luoghi in cui il Cristo si autodefinisce "Signore", che è certamente un titolo più grande dell'altro, anche perché lo usa in riferimento a un regno ultraterreno, in cui lui stesso sarà padrone di tutto, mentre Davide era padrone soltanto di una piccola porzione del Medioriente.
In pratica cosa vogliono dire gli autori di questo vangelo? Semplicemente che il titolo di "Signore", riguardante l'oltrevita, si addice di più al Cristo risorto, mentre l'altro titolo, esclusivamente terreno, è alquanto riduttivo, pur avendo anch'esso una connotazione di tipo teologico, in quanto la rappresentazione ebraica della politica ha sempre degli addentellati religiosi.
Si noti comunque l'interpretazione, in funzione apologetica del cristianesimo, del Salmo 110,1, ove si parla di un "Oracolo del Signore al mio Signore", cioè di Jahvè che dice a Davide: "Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi". È una frase dura, eminentemente politica e che non prevede nulla di positivo per i nemici sconfitti in battaglia o in guerra. D'altra parte Jahvè, per gli ebrei, è il "Dio degli eserciti". "Sedere alla destra" viene detto in senso metaforico, in quanto il messia Davide ha sì stravinto, ma non è salito in cielo. Gli appartengono, di diritto, la regalità universale e il sacerdozio perpetuo, riconosciuti dallo stesso Jahvè, sulla base dei fatti concreti che ha compiuto, ma tutto finisce lì. Davide non ha vinto la morte.
Si guardi ora come viene stravolto quel testo. Nel versetto "Oracolo del Signore al mio Signore" il primo Signore è rimasto Dio, mentre il secondo è diventato Cristo, quando in realtà chi sta parlando è Davide. Cioè nell'aldilà chi siede alla "destra" di Dio non è Davide ma Cristo, che di "politico" (e tanto meno di "militare") non ha fatto nulla, ma che, essendo "risorto", gode del privilegio di essere considerato unico, vero "Figlio di Dio". Vincere la morte è ben di più che sconfiggere dei nemici in carne ed ossa, e Davide, "cristianizzato", lo riconosce. Gli scribi vengono quindi fatti passare per esegeti incapaci, duri di comprendonio, soltanto perché non sanno vedere nel Cristo le sue qualità sovrumane, la sua natura divina! Quella stessa natura che Pietro e Paolo gli attribuiranno soltanto dopo la sua morte! E proprio per questo motivo, nella pericope, vengono bollati come persone indegne, meritevoli di condanne inappellabili!
VII (Offerta della povera vedova)
Tanto duro con gli intellettuali e gli uomini di potere, nel proprio schematismo ideologico, quanto tenero con la povera gente, della quale si esalta l'ignoranza e l'ingenuità: ecco spiegato il passaggio che Marco pone tra la pericope dell'offerta della vedova (12,41 ss.) e tutte quelle che l'hanno preceduta del capitolo 12.
Ciò fa parte del moralismo dell'autore, interprete di Pietro, il quale, politicamente, era diventato un opportunista, dopo essere stato in gioventù vicino alle idee del partito zelota.
La povera donna58 esprime l'unica tipologia di giudaismo che Pietro era in grado di accettare: un giudaismo incapace di competere intellettualmente coi Galilei del movimento nazareno, poi divenuto "cristiano" in forza del tradimento politico ch'egli aveva operato, ben diverso dal semplice e comprensibile misconoscimento personale compiuto al momento della cattura di Gesù.
La contrapposizione che Marco pone tra la povertà della vedova e la ricchezza degli offerenti agiati è sociologicamente netta.59 È una differenza di classe, in cui si scontrano l'intenzione generosa dell'una e la donazione superflua degli altri. Almeno in apparenza sembra così.
Marco però guarda la scena con gli occhi del moralista, il quale, dopo aver severamente condannato le autorità politiche e intellettuali della capitale, non vede nella vedova che la buona fede, trascurando completamente ch'essa, in maniera oggettiva, a prescindere dalle sue personali intenzioni e dall'entità dell'offerta, sta puntellando il sistema, lo sta legittimando proprio nella sua istituzione più corrotta.
L'autore della pericope non si rende neppure conto che se si guardano le cose in maniera oggettiva, cioè politica, ha un peso anche la diversa quantità delle offerte: più si dona e maggiore è la responsabilità a favore della corruzione.
Ecco dunque cosa fa l'ideologia cristiana: si serve della miseria altrui per avvalorare le mere intenzioni, le quali, per sentirsi giuste, non hanno bisogno di dipendere dai mutamenti radicali del sistema. Dunque per entrare nel "regno di Dio" basta essere puri di cuore, a prescindere da qualunque forma di contestazione nei confronti di chi ne impedisce la realizzazione.
(torna su)11.1) Addendum sul fico sterile e seccato (Mc 11,12-25)
[12] La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame.
[13] E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi.
[14] E gli disse: "Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti". E i discepoli l'udirono.
[20] La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici.
[21] Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: "Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è seccato".
[22] Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio!
[23] In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
[24] Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.
[25] Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati".
*
La pericope è stata collocata da Marco tra l'ingresso messianico e la purificazione del Tempio, a titolo di anticipazione e insieme di conferma della tragedia che sarebbe successa di lì a poco. Essa quindi è il frutto di una considerazione filosofica relativa alla morte del Cristo.
Se si dà per scontato che il racconto abbia radici storiche si finisce col cadere in un labirinto interpretativo del tutto artificioso. Le contraddizioni sono talmente tante che sarebbe fatica sprecata cimentarsi sopra speculativamente.
Non ci resta dunque che affrontarlo in maniera simbolica, mettendoci nei panni di un redattore cristiano che ha appena rinunciato, non senza travaglio, alle proprie origini giudaiche.
Stando a Marco, e questo trova conferma anche in Giovanni, Gesù e i Dodici, nel momento cruciale dell'ultimo ingresso nella capitale, avevano trovato un punto d'appoggio a Betania, a pochi chilometri di distanza, presso l'abitazione di Marta e Maria, dove, secondo il Giovanni interpolato, Gesù avrebbe compiuto il prodigio più importante e più spettacolare di tutta la sua vita: la resurrezione dell'amico Lazzaro, di cui i Sinottici non sanno assolutamente nulla.
La differenza tra Marco e Giovanni sta nel fatto che quest'ultimo spiega molto chiaramente che a Betania giunse il solo Gesù, accompagnato da un paio di discepoli, uscendo a suo rischio e pericolo dalla clandestinità, al fine di soccorrere l'amico Lazzaro gravemente malato (forse ferito in uno scontro armato con le truppe romane). Successivamente si sarebbero ritrovati tutti presso il Monte degli Ulivi per organizzare l'ingresso pubblico nella capitale. Nonostante tutto tale versione appare la più convincente.
Al v. 12 di Marco vi è la prima contraddizione cronologica: Gesù ha fame appena uscito, di mattina presto, dalla dimora di Marta e Maria. È evidente che qui il redattore intende per "fame" qualcosa di immateriale, il cui cibo non poteva essere trovato nell'umile Betania.
Betania stessa è qui considerata come un villaggio simbolico. Essa rappresenta il modello ideale della “verità soggettiva”, i cui esponenti più significativi per Gesù erano appunto Marta, Maria e Lazzaro, dei quali sappiamo pochissimo: gente semplice, di condizioni sociali modeste, le cui aspettative di giustizia sociale e di liberazione nazionale avevano trovato nel movimento nazareno un solido punto d'appoggio.
Ciò tuttavia non basta. L'obiettivo del Cristo non era soltanto quello di valorizzare l'interiorità umana, dandole un nuovo contenuto da vivere, ma anche quello di proporre un programma politico a tutta la nazione e il luogo principe dove avrebbe potuto farlo era soltanto uno: Gerusalemme.
Anche questa capitale è nel vangelo di Marco un simbolo: il modello ideale della “verità oggettiva”. Nonostante tutto, dirà il Cristo alla samaritana, la salvezza viene dai Giudei. Finché Gesù non entra come messia nella capitale, proponendo un nuovo modello di società, la sua missione resta incompiuta. Marco però lo farà entrare proprio per dimostrare che i Giudei erano peggiori dei Galilei e che solo per colpa loro Gesù fu crocifisso e Israele distrutta da Roma.
Betania ha compreso la lezione etica, umana del Cristo, ma questo non basta a saziare la sua fame di rivelarsi compiutamente a quegli uomini che la storia ha prescelto come guida della nazione.
A Gerusalemme è più forte l'esigenza della verità assoluta, la necessità di dover prendere delle decisioni strategiche per tutto il paese: qualunque opposizione a questa aspettativa di liberazione è destinata a ripercuotersi gravemente sul destino dell'intera nazione.
Se Gesù non entrasse nella capitale con tutto il seguito di discepoli che gli è possibile, e non si proponesse esplicitamente alla guida della rivolta antiromana, tutta l'attività propagandistica condotta fino a quel momento andrebbe irrimediabilmente perduta.
È solo a questo punto che Marco introduce l'elemento del fico, traendo in inganno il lettore superficiale sulla vera natura della fame del Cristo.
La descrizione del redattore è realistica e non vi sarebbe motivo apparente per non credervi. Marco fa capire che l'ingresso messianico del Cristo nella capitale fu in realtà un ingresso nel Tempio. La prima volta "dopo aver guardato ogni cosa attorno (cioè dopo aver constatato la corruzione commerciale nel luogo principale del culto religioso), essendo ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània" (v. 11).
Il mattino dopo lascia Betania per tornare a Gerusalemme e, mentre cammina coi discepoli, egli vede, lontano dalla strada, un fico pieno di foglie; supponendo che abbia dei frutti, gli si avvicina e grande è la sua delusione nel notare che non vi è neppure un frutto. Marco precisa subito che la pianta non poteva averne, non essendo ancora giunto il momento adatto. Nonostante questo Gesù la maledice. Dopodiché egli entra nella capitale e caccia i mercanti dal Tempio: a causa di questa iniziativa Marco dice che "i sommi sacerdoti e gli scribi cercano il modo di farlo morire" (v. 18). Gesù, la sera, torna di nuovo a Betania. "La mattina seguente, passando, vedono il fico seccato fin dalle radici" (v. 20).
A Marco serve mostrare un Cristo profeta e moralizzatore proprio per mistificare il lato eversivo della sua politica. Il fico seccato rappresenta il giudizio schematico di un redattore moralista. Il senso di questo racconto è la critica unilaterale dell'illusione, o meglio dell'ipocrisia di chi fa mostra di avere ciò che non ha, di essere ciò che non è.
I profeti veterotestamentari avevano usato la medesima simbologia: la delusione attende Jahvè nel giorno della sua visita (Ger 8,13; Mi 7,1; Os 9,10; Ab 3,17). Insieme alla vigna il fico rappresenta il popolo d'Israele che porta frutto (Is 5,1-7; 36,17; Dt 8,8; Ct 2,13; Ag 2,20) o che deperisce (Nm 20,5; Ps 105,3; Is 34,4; Ger 5,17), a seconda della sua fedeltà o infedeltà all'alleanza.
I profeti si sono serviti di queste immagini anche per indicare il giudizio definitivo di dio, che retribuisce ciascuno secondo le sue azioni (Os 2,12; Zc 3,10). In Pr 27,18 il fico viene addirittura paragonato alla Torah.
La differenza tra i profeti e il redattore di questa pericope è che qui non c'è possibilità di ripensamento da parte del Cristo-giudice: il fico d'Israele viene seccato definitivamente, senza soluzione di continuità. La presenza ingannevole delle foglie, cioè la maschera dell'ipocrisia, ha fatto il suo tempo.
Il versetto principale che legittima un'interpretazione dubbia della pericope è il 13: "Non era quella la stagione dei fichi". Il senso di quest'espressione lo si evince solo pensando alla collocazione di tutta la pericope. Il fico sterile non rappresenta semplicemente una inadeguatezza della coscienza ebraica al vangelo di liberazione, che col tempo si sarebbe risolta, ma rappresenta proprio l'irrisolvibilità di tale inadeguatezza, cioè l'autunno del giudaismo.
"Non era quella la stagione dei fichi" sta appunto ad indicare che per quel tipo di presenza storica - il giudaismo classico - non vi sarebbe più stata, dopo la morte cruenta del Cristo, una stagione in cui poter maturare frutti significativi.
Il fatto che il Cristo abbia voluto infierire condannando a morte certa un fico fuori stagione, può urtare la sensibilità di una persona di vedute laiche e democratiche. Il filosofo razionalista Bertrand Russell, p.es., si scandalizzò di questo atteggiamento e dichiarò che non avrebbe mai potuto diventare cristiano.
Qui tuttavia la pianta rappresenta Israele, soprattutto nelle sue espressioni ufficiali di potere, che sotto la fronda ingannevole delle sue pratiche religiose, esteriori e formali, nasconde una profonda sterilità spirituale. La maledizione non è che l'esplicita constatazione di una falsità che ormai non può più ingannare nessuno: il redattore della pericope, cristiano di origine giudaica, sta ragionando col senno del poi.
Se poi il lettore vuol vedere in questa condanna, in maniera più estensiva, il destino inevitabile cui va incontro ogni uomo che vuol fare dell'ipocrisia un modo per imporsi, allora si potrebbe dire che la condanna è relativa non tanto alla mancanza del frutto quanto alla falsità delle foglie, cioè è relativa al dualismo tra apparenza e realtà e soprattutto alla pretesa che, in nome di questo dualismo, il potere possa trarre in inganno le masse.
È facile notare come il redattore abbia voluto indicare una sorta di parallelismo con l'albero della scienza del bene e del male che la Genesi pone nel mitico Eden. Sono entrambe piante ingannatrici, con la differenza che nei vangeli il Cristo viene rappresentato come un soggetto che ha una chiara consapevolezza della verità.
In tal senso l'espressione che il redattore ha messo in bocca a Pietro è indicativa del diverso livello di consapevolezza che distingueva il Cristo dagli apostoli: la pianta non si era seccata perché maledetta, ma era stata maledetta perché fingeva di avere frutti.
Che poi il disseccamento immediato possa dipendere dalla volontà del credente, questo fa parte della mitologia religiosa. In luogo di un "Gesù della storia" che non è riuscito a realizzare la sua missione politica, Marco ha avuto bisogno di accentuare al massimo le caratteristiche sovrumane del "Cristo della fede".
(torna su)11.2) Addendum sui vignaioli omicidi (Mc 12,1-12)
[1] Gesù si mise a parlare loro in parabole: "Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano.
[2] A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna.
[3] Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote.
[4] Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti.
[5] Ne inviò ancora un altro, e questo lo uccisero; e di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero.
[6] Aveva ancora uno, il figlio prediletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio!
[7] Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra.
[8] E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna.
[9] Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri.
[10] Non avete forse letto questa Scrittura:
La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo;
[11] dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri"?
[12] Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono.
*
Benché descritta in forma parabolico-allegorica, la vicenda dei vignaioli omicidi può essere vista a partire dalla situazione economica della Galilea di duemila anni fa, dove il terreno coltivabile era in gran parte nelle mani di grandi proprietari terrieri stranieri, che molto spesso avevano la loro residenza all'estero. Il che però può suscitare delle perplessità esegetiche che vedremo più avanti.
Il vigneto viene impiantato a regola d'arte dallo stesso agrario: la siepe di recinzione serviva per delimitare una proprietà privata e per proteggerla da animali predatori e da ladri; il torchio per lavorare l'uva; la torre era il casolare ove si abitava durante la vendemmia: conteneva il frantoio e il magazzino dell'uva e del vino, mentre sul tetto aveva un punto d'osservazione per la vigilanza. Una volta avviata, la vigna veniva data a mezzadria: era questo il rapporto di lavoro che in genere si stipulava fra proprietari terrieri e fittavoli o coloni ebrei.
Il fatto di risiedere all'estero per un lungo periodo di tempo rendeva necessario l'invio di servi esattori per la riscossione dell'affitto pattuito, che in pratica era una quota del raccolto annuale. Secondo la legge ebraica la prima scadenza avveniva al quinto anno.
Nel testo non appare che il latifondista fosse una persona particolarmente esosa; d'altra parte ciò non è indispensabile saperlo: il rapporto di sfruttamento era oggettivo e doveva sottostare a determinate leggi economiche. Né viene detto che il suo primo riscuotitore avesse trattato con disprezzo gli operai: non ne aveva bisogno.
La condotta dei vignaioli può essere messa in relazione al clima rivoluzionario diffuso tra i contadini della Galilea (soprattutto in virtù dell'attività eversiva degli zeloti), ma ciò non sembra giustificare la prevaricazione su un intermediario che svolge un semplice ruolo esecutivo. È vero che l'intenzione è quella di bastonarlo a titolo dimostrativo, non di ucciderlo, ma è anche vero che in tal modo essi inevitabilmente creano un precedente di cui, prima o poi, dovranno rendere conto. Qui si ha l'impressione che la resistenza all’oppressione colonialistica romana si manifesti in forme istintive e superficiali, tipiche peraltro della Galilea.
Se il maltrattamento al primo esattore poteva sembrare dettato da quel sentimento di ribellione che si ritrova facilmente in quei coltivatori espropriati della loro terra e costretti a lavorare sotto padrone, il secondo maltrattamento appare invece più deciso e razionalmente motivato, e quindi, per il tenutario della vigna, ancor più minaccioso del precedente. I contadini infatti non si aspettavano l'invio del secondo esattore, ma probabilmente una manifestazione di forza più convincente. Pensano quindi di poterne approfittare: ecco perché al peggioramento delle prepotenze uniscono una pretesa di autolegittimazione ("lo coprirono d'insulti").
Perché mai il proprietario della vigna non era intervenuto subito con autorevolezza? Probabilmente perché conosceva la loro volontà di resistenza e sperava, inviando il secondo servitore, ch'essi avrebbero ridimensionato le pretese. Vuole evitare di esasperare i conflitti mediante dure ritorsioni, ben sapendo d'essere proprietario in una terra straniera, e tuttavia vuol far capire di non essere intenzionato a scendere a compromessi che vanifichino il rapporto di sfruttamento. In sostanza temporeggia ribadendo diplomaticamente il proprio potere.
Nella pericope viene detto che inviò molti esattori, ma ciò appare esagerato o comunque finalizzato dal redattore ad accentuare il comportamento irresponsabile di quei contadini. È probabile che nella versione originaria (confermata dal vangelo apocrifo di Tommaso) gli esattori fossero soltanto tre, di cui l'ultimo nei panni dello stesso figlio. Se così non fosse, difficilmente si potrebbe spiegare l'atteggiamento lassista del proprietario, il cui permissivismo non può essere giustificato semplicemente col fatto ch'egli risiedeva all'estero. Qui il redattore ha voluto accentuare il comportamento visibilmente irrazionale tenuto da quei contadini, che non avevano valutato bene i rapporti di forza in campo.
La pazienza raggiunge il culmine quando il proprietario decide d'inviare suo figlio: cosa che però difficilmente avrebbe fatto se gli operai avessero ucciso tutti i suoi esattori. Limitandosi a bastonarli gli operai potevano anche pensare di risparmiarsi un'immediata e categorica reazione da parte del padrone della vigna, ma dopo aver preso a ucciderli era come se si fosse dichiarata guerra. Qui dunque si ha l'impressione che quel latifondista si stia comportando un po' ingenuamente, specie in considerazione del fatto che non sembra aver inviato il figlio in condizioni di potersi difendere militarmente. Non dimentichiamo però che la parabola ha lo scopo di dimostrare qualcosa a favore dei cristiani contro gli ebrei.
Il latifondista, inviando un intermediario così importante: il figlio erede universale di tutte le sue risorse, sembrava offrire a quei coltivatori un'ultima possibilità d'intesa, consapevole di non voler sottovalutare la gravità della loro protesta. Spera insomma d'accordarsi diplomaticamente senza dover ricorrere all'uso della forza.
Il modo di ragionare dei contadini, al veder giungere il figlio, non è illogico, ma dettato da un certo senso di superiorità, da una percezione ottimistica delle cose. Se maltrattando, insultando e uccidendo gli esattori essi avevano soltanto sperato di entrare in possesso della vigna (o forse di rientrare in possesso della terra), ora, pensando di uccidere il figlio del padrone, sono certi di poterlo fare pienamente, cioè da una situazione di fatto essi vogliono entrare in una situazione di diritto.
Perché sono così convinti di questo? Proprio perché il proprietario fondiario non è intervenuto di persona. La comparsa del figlio-erede fa loro supporre o che il padrone sia morto, o che sia troppo debole per agire. E così, se prima avevano bastonato e insultato chi per loro era indirettamente responsabile del rapporto di sfruttamento, ora pensano di uccidere chi per loro è fonte di questo stesso rapporto. Qui si può anche pensare a uno scontro armato, seppure di lieve entità.
Secondo le disposizioni giuridiche di allora, ebraiche e romane, si permetteva a chiunque d'impadronirsi di un bene (anche immobile) qualora fosse rimasto senza proprietario. Ecco perché gli operai agricoli pensano di diventare i nuovi padroni della vigna, uccidendo chi, secondo loro, ne sarebbe stato l'erede. È talmente grande la loro sicurezza che nel testo si ha l'impressione che gli abbiano persino negato la sepoltura (qui la chiesa vedrà addirittura un'allusione alla crocifissione al di fuori delle mura di Gerusalemme!): non si preoccupano di salvare le apparenze perché sanno che nessun concittadino li denuncerà per aver ucciso uno sfruttatore e nemico della patria. Senonché la parabola è tutt'altro che favorevole a questa conclusione eversiva: infatti i contadini verranno eliminati e la vigna data ad altri.
Cerchiamo ora di capire la collocazione semantica di questo testo nel vangelo di Marco. Là dove è molto forte l'opposizione delle autorità nei confronti di Gesù, è facile che questi, in pubblico, si serva di strumenti linguistici il cui significato, per essere adeguatamente compreso, va spiegato (cosa ch'egli faceva privatamente ai propri discepoli). Qui non solo viene confermata detta opposizione, ma le autorità (Matteo enfaticamente parla di "sommi sacerdoti e farisei") non hanno alcun bisogno che qualcuno spieghi loro il significato di quella parabola, tant'è che, se non fossero state impedite dalla folla, l'avrebbero arrestato immediatamente.
Se si esclude l'inizio del capitolo 11 di Marco, in cui s'illustra il trionfale ingresso messianico, tutto il resto non è che una sequela di minacce in direzione di Gesù, in funzione prolettica della tragedia che sta per compiersi sul Golghota. Dopo quell'ingresso il Cristo può soltanto constatare, a dimostrazione dell'aridità spirituale d'Israele (v. 14), un "fico seccato" (che peraltro maledice); compiuta la purificazione del Tempio, la casta sacerdotale cerca "il modo di farlo morire" (v. 18); sacerdoti, scribi, anziani rifiutano di riconoscere la sua autorità, esattamente come prima nei confronti del Battista (v. 28); col dibattito sulla questione del tributo a Cesare e della resurrezione pensano di coglierlo in fallo per denunciarlo o di eversione o di ateismo... Nonostante questa fortissima opposizione, e dopo aver criticato duramente tutta l'ipocrisia di un partito, quello farisaico, che pur vedendola, non fa nulla per sostenerlo (anche i farisei erano ben consapevoli della corruzione del Tempio), Gesù si accinge ugualmente a entrare a Gerusalemme per autoimmolarsi (è questa la tesi petrina e Marco la registra a livello redazionale).
La parabola non fa che confermare una situazione di grave conflitto. L'esegesi confessionale ha naturalmente visto in essa un'anticipazione di quella che sarà la fine del primato d'Israele, simbolizzato dai coltivatori ebrei fatti fuori dal latifondista, e sostituiti da nuovi coltivatori "cristiani". Ma per quale ragione le autorità dovevano sentirsi prese di mira da una parabola del genere? E in che senso la folla doveva invece sentirsi valorizzata da essa, al punto da prendere le difese del Cristo?
Se il proprietario della vigna appare come uno sfruttatore romano e i contadini come ebrei che vogliono ribellarsi, è assurdo pensare che Gesù volesse esaltare la figura dell'oppressore, colonialista e proprietario "privato", e che potesse trovare in questo un consenso popolare. Stava forse criticando il ribellismo infantile dei leader politici ebrei, paventando una soluzione di tipo "matteano", cioè mettendosi esplicitamente dalla parte del nemico? Ma non era stato lui a chiedere a Matteo di smettere di lavorare per Roma e d'impegnarsi seriamente in un progetto contro l'oppressione nazionale?
L'esegesi confessionale qui rischia di cadere in un'assurdità dietro l'altra. Leggere misticamente la parabola (col senno "mistificato" del poi) come se il padrone della vigna fosse dio e suo figlio lo stesso Gesù, e gli operai salariati le autorità che non riconoscono i profeti e li uccidono, fino a eliminare il più grande di loro, al punto che per questo delitto il Cristo si ritiene in diritto-dovere di assicurare il passaggio del primato storico d'Israele al mondo pagano (che in quel momento rappresentava l'oppressione!), è, a dir poco, molto fantasioso.
Se la folla lì presente ha apprezzato quella parabola, evidentemente doveva aver capito ch'essa era diretta contro dei leader politici ebrei che non sapevano fare il loro mestiere di oppositori risoluti a Roma. Ma la cosa strana è che nella parabola l'opposizione dei contadini al latifondista c'è ed è anche forte: dunque per quale motivo quei leader pensarono ch'essa era diretta contro di loro?
Qui si ha l'impressione che se la parabola è stata davvero detta (esisteva una versione quasi analoga in Is 5,1 ss.), non può esserlo stato così come ci è arrivata. Cioè si ha l'impressione che i vv. 10-11 di Marco, quelli in cui si cita un passo veterotestamentario, usato in maniera apologetica, celino un finale molto diverso. Marco ha compiuto una duplice operazione redazionale: ambigua e tendenziosa. Ambigua perché ha voluto far vedere, senza specificarne il motivo, che le autorità gestivano il potere in maniera sbagliata e che la folla era consapevole di questo limite. Tendenziosa perché lascia presupporre che il motivo non fosse affatto di tipo "politico" bensì di tipo "religioso" o comunque di tipo "politico-religioso": il Cristo non venne riconosciuto né come "messia" né come "figlio di dio".
Di certo questa parabola, se è stata detta, deve esserlo stata in Galilea, la terra di Pietro, che nutriva sentimenti di ostilità nei confronti della Giudea, anche se non ai livelli dei samaritani. Quindi la collocazione in Giudea è del tutto convenzionale. Ma se non è una parabola contro i sommi sacerdoti, gli anziani, i sadducei, che non hanno bisogno dello strumento delle parabole per essere additati come corrotti e collaborazionisti, non è neppure un intervento contro gli scribi e i farisei, altrimenti Marco, sempre molto attento a queste cose, lo avrebbe detto esplicitamente.
Questa è una parabola che non aveva bisogno d'essere interpretata per essere capita: qui veniva denunciata l'incapacità dei partiti rivoluzionari nell'organizzare una resistenza efficace contro Roma. Il proprietario fondiario doveva apparire nella parabola come uno che fa giustizia di chi s'illude di poter andare avanti con un ribellismo spontaneistico e di maniera.
Gesù ce l'aveva con chi stava avallando una resistenza miope, istintiva, che si accontentava di piccoli risultati ma era priva di una strategia di largo respiro e che alla fine rischiava soltanto di fare gli interessi di Roma. Stava insomma accusando gli zeloti residenti in Galilea. Quello che manca in questa parabola è proprio la parte costruttiva, propositiva, mistificata dal riferimento religioso all'Antico Testamento.
Il lettore oggi si deve accontentare del fatto che la conclusione resta obiettiva, in quanto, avendo sottovalutato la forza del padrone della vigna e sopravvalutato la propria, gli operai agricoli hanno duramente ma giustamente pagato il prezzo del loro infantile estremismo: quando si organizza una rivendicazione socioeconomica bisogna essere capaci di valutare oggettivamente i fatti, il peso delle forze in campo, bisogna essere capaci di "realismo politico".
La resistenza unilaterale, irriducibile a qualsiasi forma di negoziato, di contrattazione, era diventata politicamente perdente, e non perché eticamente ingiusta, ma perché non sostenuta da una forza equivalente a quella che si voleva combattere.
(torna su)11.3) Addendum sulla povera vedova (Mc 12,41-44)
[41] E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte.
[42] Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino.
[43] Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: "In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
[44] Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere".
*
Il racconto del vangelo di Marco sull'obolo della povera vedova, ripreso da Luca (21,1 ss.), è stato collocato dagli evangelisti poco prima dell'ultima tragica settimana a Gerusalemme, nell'ambito della più generale critica mossa nei confronti della principale istituzione del giudaismo: il Tempio, e delle principali categorie sociopolitiche (scribi e farisei) che non fecero nulla per impedire la palese corruzione dei suoi amministratori: sadducei e sommi sacerdoti. È una pericope direttamente morale e indirettamente politica.
Il tesoro apparteneva al Tempio di Gerusalemme e i sacerdoti usavano le offerte dei fedeli o per compiere olocausti o per aiutare i poveri. Si trattava infatti di contributi volontari, non di tasse, che pur essi richiedevano per la manutenzione della struttura e per le loro necessità quotidiane. Oltre a ciò - come noto - esistevano altre forme commerciali di sfruttamento del luogo santo, specie in occasione delle grandi festività, che permettevano ai suoi gestori di arricchirsi notevolmente.
Qui Marco racconta che Gesù e i suoi discepoli osservano "come" i credenti fanno le loro offerte, e anzitutto vedono i ricchi che gettano con ostentazione molte monete. Quando si presenta la vedova che offre "due spiccioli", Marco si sente in dovere di specificare che il loro importo era equivalente a un "quattrino", per spiegare al suo lettore di origine pagana il valore del "leptà" ebraico, e quindi il fatto che si trattava di un'offerta poverissima. Che fosse propriamente una "vedova", solo il suo abbigliamento poteva rivelarlo agli astanti.
Gli esegeti si sono chiesti come sia stato possibile stabilire l'esatto importo dell'offerta. Storicamente si sa che nell'atrio del tempio, dove potevano accedere anche le donne, esisteva un corridoio (detto "gazofilacio") in cui erano collocati tredici salvadanai a forma di tromba, che servivano per raccogliere le libere offerte e quelle destinate a determinati scopi. Non si gettava il denaro personalmente, ma lo si consegnava al sacerdote incaricato, il quale poi lo metteva in questo o quel salvadanaio secondo l'indicazione dell'offerente.
Ma che la donna nominasse apertamente l'ammontare dell'offerta, così da poter essere ascoltata da Gesù e i suoi discepoli, è davvero improbabile. Il racconto non è storicamente attendibile, non foss'altro che per una ragione: da tempo i seguaci del movimento nazareno avevano smesso di fare offerte al Tempio, sicuramente a partire dall'episodio della cacciata dei mercanti da parte dello stesso Gesù, avvenuta, stando alla cronologia di Giovanni, alcuni anni prima. Essendo giudicato come luogo di corruzione morale e di collaborazionismo politico con l'invasore romano, al Tempio le offerte non andavano fatte, né poche né molte.
La pericope appare come una semplice illustrazione del valore dei sacrifici dei poveri, un valore che in quel momento non è stato capito da chi (i discepoli lì presenti) si è lasciato ingannare dalle apparenze materiali (l'infimo importo), senza comprendere che dietro di esse si celava lo stato poverissimo dell'offerente. Il Cristo insomma sembra rispondere a un'osservazione di disappunto da parte dei discepoli, che hanno avuto la pretesa di giudicare senza cognizione di causa.
Visto così, il senso del racconto è tutto di tipo etico. La vedova è "generosa" non tanto perché "ha pensato" di fare l'offerta, lei che avrebbe potuto obiettivamente farne a meno, né perché ha dato i due leptà a Jahvè o ai poveri più poveri di lei, ma proprio perché in quella misera offerta essa ha dato "tutto quanto aveva per vivere".
Il suo desiderio era quello di realizzare una comunione totale (materiale e spirituale) con ciò in cui credeva. Nei confronti di chi, pago di sé, ha dato il superfluo, lei, pur nella sua indigenza, ha dato di più. Non quindi la quantità in sé fa il "modo", ma la quantità vista a partire dalla condizione sociale dell'offerente.
In altre parole, questa vedova, dando tutto, non ha fatto in verità una semplice offerta, ma ha cercato di realizzare una comunione totale dei beni. È vero che questo gesto è rimasto a livello di esigenza personale, senza potersi concretizzare nella realtà (in quanto è mancata la volontà positiva del ricevente), ma ciò non toglie ch'esso sia stato molto più grande di quello che a prima vista apparisse.
Se si fosse tenuta una delle due monetine avrebbe fatto lo stesso un'offerta generosa (essendo di condizione poverissima), ma non avrebbe manifestato di credere nella possibilità di una comunione totale dei beni, cioè non avrebbe messo se stessa in comunione piena con la realtà in cui credeva.
L'obiezione che a questo punto si è soliti fare è nota: la donna ha potuto dare tutto proprio perché non aveva niente. Contro tale obiezione almeno due osservazioni valgono: in primo luogo la donna aveva dato tutto perché credeva in un ideale (altrimenti avrebbe dato una sola moneta o forse niente), mentre i ricchi danno il superfluo proprio perché non credono in quello che fanno, ovvero compiono formalmente un gesto che non mette in discussione il loro status sociale privilegiato; in secondo luogo, dire che questa donna non aveva paura di diventare più povera di quello che era, è come dire che uno può talmente abituarsi alla propria povertà da non desiderare più d'uscirne. Il che però viene proprio contraddetto dal fatto che la donna ha dato tutto non per la disperazione di non avere niente, ma per la speranza di ottenere qualcosa, anche se per il suo gesto essa meritava di ricevere in cambio tutto (e di riceverlo hic et nunc, non nell'aldilà).
Con ciò ovviamente non si vuole sostenere che il ricco dia soltanto il superfluo perché avaro: questa sarebbe una considerazione psicologistica. Il ricco non dà tutto semplicemente perché non crede nella possibilità di una reale socializzazione dei beni, cioè nella possibilità di riottenere tutto compatibilmente alle esigenze di tutta la collettività.
Anzi, se si guarda la consapevolezza culturale di entrambi gli offerenti, occorre dire che il ricco professa già nella sostanza l'ateismo, pur contraddicendosi nella ritualità della devozione religiosa, usata in maniera strumentale, come forma d'inganno delle masse inconsapevoli. La vedova invece appare credente sia nella forma che nella sostanza, e manifesta quindi una maggiore coerenza, pur all'interno di una grande ingenuità.
Nonostante l'indifferenza verso gli ideali della religione, il ricco di duemila anni fa, ostile alla comunione dei beni, ha contribuito a impedire al gesto della donna di assumere un significato politico positivo, anche se il redattore evangelico si sforza di connettere quel gesto al precedente discorso di Gesù indirizzato agli scribi, che ingoiano le case delle vedove, e a quello successivo, indirizzato alla distruzione militare del Tempio da parte di una istituzione governativa ancora più corrotta, quella romana. Come se questa distruzione fosse una conseguenza meritata per la mancata volontà, da parte del potere giudaico, di valorizzare gli enormi sacrifici della popolazione più debole.
Ma ciò su cui il vangelo tace (e diversamente non potrebbe fare) è il fatto che, sul piano oggettivo, il gesto della vedova non avrà alcuna vera conseguenza, in quanto né il sacerdote incaricato né i ceti sociali ch'egli rappresenta sono disposti a coinvolgersi con l'offerente povero, onde realizzare una comunione dei beni.
L'impotenza del vangelo sta appunto in questo, che mentre elogia l'individuo, a livello morale, per talune sue azioni di onestà, generosità, sincerità..., lo condanna poi, a livello politico, a restare quello che è, cioè emarginato, sfruttato e schiavo di tutti, invitandolo ad aver fiducia nelle istituzioni, a non giudicare mai nessuno e a sperare in un premio nell'aldilà, lasciando a dio la punizione dei nemici.
Soggetta a rapporti di produzione schiavistici, questa donna "sogna" di poter concorrere, con la sua generosa e poverissima offerta, al mutamento della realtà, s'illude di poter ottenere di più versando tutto. L'incapacità di comprendere i meccanismi del modo di produzione economico e di gestione del potere politico purtroppo fa sì che proprio mentre, soggettivamente, si crede di poter modificare le leggi dello sfruttamento, in realtà, oggettivamente, non si fa che prolungarle nel tempo. Pur essendo buone le sue intenzioni, la vedova non fa che avvalorare la gestione corrotta del Tempio.
Mentre il povero spera, nella sua inconsapevolezza e ingenuità, che lo schiavismo venga rimosso con un'azione "dall'alto", il ricco, dal canto suo, versa le proprie elemosine affinché il clero continui a illudere gli oppressi che per emanciparsi socialmente è sufficiente fare delle semplici offerte.
In tal modo i ricchi potevano apparire "buoni credenti" proprio perché vi erano persone, come la vedova, che, con le loro offerte, contribuivano a tenere in piedi, pur senza esserne consapevoli, il luogo principale della corruzione e dell'inganno.
(torna su)12) Il discorso sul Monte degli Ulivi
Il discorso sul Monte degli Ulivi (13,1 ss.)60 è l'unico discorso impegnativo del Cristo nel vangelo marciano. Non è un discorso politicamente programmatico, come sarebbe stato naturale in quel momento, ma è una piccola apocalisse, in quanto ha un contenuto escatologico e un tono apodittico, catastrofista.
Nel complesso non si può dire che sia rivolto a un futuro molto prossimo (anche se non mancano riferimenti alla sciagura che si sta per abbattere su Israele o che è appena venuta), quanto piuttosto a un futuro remoto, indefinito. Si fa parlare Gesù come se tutto quello che dovrà accadere in Palestina e nel resto del mondo, dipenderà strettamente da ciò che di mostruoso verrà fatto a lui.
Si profetizza la fine di Gerusalemme e soprattutto del suo Tempio61: il che ha fatto ritenere, da parte di molti esegeti, che il testo sia stato scritto, o comunque revisionato, subito dopo il 70 (però è anche vero che la rovina della città non sembra essere ben distinta dalla fine del mondo). Il capitolo 13, in effetti, è a sé stante: se lo si toglie, il vangelo non perde di organicità. Ciò di cui si dà per scontato è che in Israele non si riuscirà a costruire alcun "regno di Dio", e che quindi il vangelo andrà diffuso in tutto il mondo. Solo quando lo sarà stato, si potrà pensare a una "fine della storia umana".
Gesù parla come se fosse già morto e risorto, come se avesse la scienza infusa. In tal senso il capitolo, con qualche ritocco, avrebbe potuto esser messo dopo la scoperta della tomba vuota. Il quadro che Gesù delinea è terrificante, in perfetta coerenza con l'impostazione moralistica dei valori etici e della scelta opportunistica compiuta nei confronti dell'esigenza di un'insurrezione armata contro Roma.
L'apocalisse deve avere qualcosa di mostruoso per essere credibile, proprio perché la teologia petrina non si è rassegnata completamente alla sconfitta politica: ha semplicemente procrastinato nel tempo, a data da destinarsi, la vittoria del Cristo risorto. Ecco perché presenta molti aspetti vendicativi, rancorosi, appartenenti a uno scenario piuttosto manicheo, in cui da una parte vi sono i cristiani, soggetti a vessazioni e soprusi d'ogni genere (i quali, per questa ragione, vanno definiti "giusti" per definizione), mentre, dall'altra, vi sono gli aguzzini, i torturatori, che arriveranno a compiere scelleratezze d'ogni tipo, in quanto ci si odierà persino tra fratelli e tra figli e genitori. I cristiani saranno odiati da tutti a causa del nome di Cristo. Come se la verità potesse stare solo da una parte!
Marco considera che il momento peggiore sarà quando avverrà "l'orribile sacrilegio".62 Il testo è stato tradotto così dalla Bibbia di Gerusalemme: "Quando vedrete l'abominio della desolazione [devastazione] stare là dove non conviene (chi legge capisca), allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti... Quei giorni saranno una tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio, fino al presente, né mai vi sarà" (13,14 ss.).
Qui Marco non sta parlando della fine del mondo, ma della fine d'Israele. Pare dunque inverosimile ch'egli non abbia in mente almeno alcune delle brutalità di cui i Romani si resero responsabili, profanando ogni cosa sacra, derubando il Tempio di tutto il suo tesoro, sterminando e schiavizzando decine di migliaia di persone, distruggendo l'intera nazione e, successivamente, trasformando Gerusalemme in una località del tutto pagana, in cui l'accesso agli ebrei verrà persino vietato.
Alcuni esegeti si sono chiesti se Marco non si stia rivolgendo a dei cristiani che sono ancora presenti nella Città Santa e ai quali sta chiedendo di fuggire il più presto possibile, evitando di collaborare con la resistenza armata, in quanto non avrebbe avuto alcun senso difendere una nazione che uccide i propri profeti e messia. Qui infatti appare evidente che la distruzione della Palestina avverrà col consenso di Dio, per punire gli assassini del Cristo; e anzi i Giudei dovranno ringraziarlo, poiché se Dio non accorcerà i giorni dello sfacelo, per amore dei suoi eletti, nessuno riuscirebbe a scampare (v. 20).
Gli uomini devono mettersi in testa che il margine di libertà che hanno è molto limitato, in quanto Dio sa bene ch'essi tendono a usare negativamente la facoltà di scelta che a loro è stata data. Ecco perché devono imparare, a loro spese, che Dio può fare degli uomini ciò che vuole. Questo il messaggio della piccola apocalisse di Marco.
E Dio è così libero di fare ciò che vuole che nessun uomo potrà pensare di realizzare ciò che Cristo non ha potuto fare sulla Terra. Nessuno potrà proseguire il suo vangelo in chiave politica.63 Su questo Marco è categorico: l'uomo non ha alcuna possibilità di realizzare sulla Terra il "regno di Dio". Il fatto di non aver riconosciuto il Cristo come messia politico costituisce un'ipoteca pesantissima, che mai potrà essere riscattata, sulle proprie autonome capacità di liberazione e di edificazione del bene. Gli uomini sono destinati all'autodistruzione e quindi a non imparare mai nulla di decisivo dai loro errori. Se imparano qualcosa, è solo in via temporanea; poi ricominciano a sbagliare.
Ecco perché l'evangelista fa dire al Cristo: "Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, ecco è là - non ci credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti". (vv. 21-22). È solo nel vangelo di Giovanni che è scritto: "Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi" (14,12). Qui invece no, qui viene chiesto soltanto di non farsi ingannare, di resistere, nella convinzione d'essere gli "eletti", anche perché la fine d'Israele non sarà sufficiente per la parusia trionfale del Cristo. Prima dovranno accadere fenomeni naturali catastrofici, assolutamente irreversibili, irreparabili, riguardanti il Sole, la Luna e le stelle.
Stranamente al v. 30 viene detto che "questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute". Ciò lascia pensare che sino all'ultimo Pietro abbia sperato in un evento clamoroso che confermasse la fondatezza della sua idea di "resurrezione". In effetti lui stesso non poteva non essersi reso conto che parlare di "resurrezione", senza parlare di "parusia imminente", non aveva alcun senso.
È vero che ad un certo punto dovette rassegnarsi all'idea di Paolo, secondo cui il Cristo sarebbe tornato solo alla fine dei tempi, e che, di fronte a Dio, un giorno vale mille anni e mille anni un giorno; e tuttavia il riferimento alla generazione del presente lascia pensare che Pietro, ancora negli ultimi anni della sua vita, si sentisse in colpa d'averla tradita con la sua interpretazione politicamente disfattista della tomba vuota. Infatti, se Cristo è risorto, a che pro insorgere? Era lui che doveva tornare a fare strage dei propri nemici. Con Pietro i cristiani erano diventati come i Giudei ai piedi della croce: "Se tu sei il messia, salva te stesso". Scendere dalla croce o dimostrare con la parusia d'essere immortale e vincente, volevano dire, in sostanza, la stessa cosa.
Pietro però vorrebbe far capire alla sua generazione che, pur avendo detto la verità sulla resurrezione, e pur sapendo con sicurezza che la resurrezione implica un ritorno trionfale del Cristo, non poteva sapere il momento esatto in cui ciò sarebbe avvenuto. "Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre" (v. 32).
Con ciò però viene giustificato tutto, anche la necessità di non pentirsi, di non fare alcuna autocritica per aver ingannato il movimento nazareno. Persino il Cristo viene fatto passare per uno che non sa esattamente quando dovrà tornare sulla Terra a rivendicare la propria signoria, materiale e spirituale. Il cristianesimo nasce così, come nuovo culto religioso, in cui la figura di Dio-padre viene ad assumere un'importanza nettamente superiore al Figlio dell'uomo, che pur nella sua vita non aveva mai cercato di porsi in maniera sovrumana. Questa piccola apocalisse di Marco sembra il testamento teologico-politico di un apostolo che sente prossima la fine e che quasi cerca il martirio per mostrare che, in fondo, non aveva avuto tutti i torti.
(torna su)13) La fine del messia politico
I
I capitoli 14 e 15 sono dedicati alla cosiddetta "passione" del Cristo, mentre i primi otto versetti di quello successivo riguardano la scoperta della tomba vuota da parte di alcune discepole. Il resto del capitolo 16 è stato aggiunto successivamente. Di fatto il vangelo di Marco si conclude con l'interpretazione petrina della tomba vuota come "resurrezione", cioè come "ridestamento miracoloso di un corpo morto". Non vi è alcuna apparizione del Cristo. I due capitoli suddetti, alla luce del vangelo marciano, vanno letti a partire da questi ultimi otto versetti.
Marco esordisce dicendo che la preoccupazione dei capi dei sacerdoti e degli scribi di non arrestare e uccidere Gesù durante la Pasqua, era determinata dal timore che scoppiasse un tumulto popolare (14,1-2). È una premessa che appare un po' ingenua, in quanto lascia sottintendere alcune cose spiacevoli per la sua linea tendenziosa di spoliticizzare al massimo la figura di Gesù. Anzitutto lascia capire che Gesù era considerato dalle autorità giudaiche come un individuo eversivo, anti-istituzionale, e quindi come un soggetto politico; secondariamente lascia intuire ch'egli aveva un seguito popolare davvero considerevole, politicamente temibile; in terzo luogo appare evidente che la Pasqua era il momento ideale per compiere una rivolta popolare contro la casta sacerdotale e per fare una insurrezione armata contro la guarnigione romana acquartierata nella fortezza Antonia, e quindi contro la sede prefettizia di Cesarea e contro tutta la presenza romana nella Palestina.
Che Gesù potesse essere temuto solo come profeta pacifista o come messia non violento è semplicemente ridicolo. Marco si rende conto di non poter sostenere la tesi di un Cristo sedizioso, altrimenti il compromesso con Roma, da parte della teologia petro-paolina, sarebbe impossibile; ma non può neppure sostenere la tesi di un Cristo semplice seguace del Battista. Egli vuole dimostrare quanto sia stato assurdo eliminare, nell'arco di pochi giorni, un soggetto popolarissimo e, nel contempo, odiatissimo come Gesù, cioè vuol dimostrare l'insostenibilità della cultura giudaica, l'improponibilità di far sussistere, nella loro integrità, delle tradizioni e dei valori così fortemente contraddittori. Ma per poterlo fare si dovrà arrampicare sugli specchi.
L'ultima notizia che ci offre è che di Gesù avevano paura unicamente le autorità giudaiche e non anche quelle romane. Il che è inverosimile, proprio perché Pilato si trasferiva con la sua truppa nella capitale proprio in occasione delle principali feste, temendo i tumulti popolari. È impensabile che i Romani non avessero tremato vedendo Gesù entrare trionfalmente in città con un grande seguito popolare. In quell'occasione non avrebbero avuto alcuna possibilità di scampo, se non quella di arrendersi senza combattere. Una volta catturato Pilato ed espugnata Cesarea, si sarebbe anche potuta stabilire una trattativa con Roma. L'importante era far capire all'imperatore che in Palestina le legioni non potevano fare ciò che volevano. Vinto il primo round, Giudei, Galilei, Idumei, Samaritani..., se fossero rimasti uniti contro Roma, avrebbero ottenuto l'appoggio anche della Decapoli, della Transgiordania o Perea, della Nabatea, della Fenicia e forse si sarebbero ribellati anche in Siria.
L'importante era che qualcuno cominciasse a fare sul serio, in maniera corale e organizzata, esponendosi in prima persona. Poi da cosa nasce cosa. Le speranze concrete di una vittoria c'erano e chi, tra gli odierni esegeti, non vi crede è perché non crede nella possibilità di cambiare il suo stesso presente. Egli non dovrebbe guardare il fallimento politico del Cristo come un evento inevitabile al cospetto del colosso romano, bensì come la conclusione di una serie di tradimenti, interni al movimento nazareno, ma anche tra gli alleati, che avrebbero potuto benissimo essere evitati.
Chi non guarda questi eventi con gli occhi imparziali dello storiografo, è portato a considerare il Cristo come un folle avventuriero, un pazzo irresponsabile; e non è che ci si possa esimere da una considerazione del genere, dicendo ch'egli, essendo "Figlio di Dio", non aveva intenzione di compiere alcuna insurrezione. Non ci si può trincerare dietro il pretesto mistico che il suo regno non era di questo mondo, e che quindi il suo vero obiettivo era la redenzione universale dell'umanità, ovvero la liberazione dalla condanna del peccato originale e dalla maledizione della morte. Amenità del genere, oggi, non reggono più: siamo troppo laicizzati per crederci. Le alternative sono diventate altre due: o in Palestina vi era una possibilità concreta di vincere Roma, o non vi era affatto. Ed è sulla base di queste alternative che Caifa e Giuda si giocano la loro credibilità: questo perché se avevano ragione loro, dobbiamo necessariamente rivalutarli.
II
Marco offre una cronologia sbagliata dell'unzione di Betania (14,3 ss.), in quanto la colloca dopo l'ingresso trionfale nella capitale; essa in realtà avvenne prima, in riferimento alla morte di Lazzaro, quando Gesù prese la decisione di compiere l'insurrezione nazionale. Almeno così dice il quarto vangelo (12,1 ss.). Quando Gesù arrivò per la seconda volta a Betania, la sorella di Lazzaro, Maria, lo unse con un olio profumato proprio perché aveva capito ch'egli voleva entrare a Gerusalemme come messia liberatore.
In Marco le cose sono capovolte, come spesso succede quando danno fastidio politicamente. I manipolatori dell'evangelista Giovanni dicono che quando Gesù entrò a Betania per la seconda volta, Lazzaro era vivo, in quanto da lui risorto la volta precedente. Il che però è assurdo. O Lazzaro non era morto la prima volta, ma era soltanto malato, seppur gravemente; oppure ciò che di lui Cristo ha fatto risorgere era stata semplicemente l'idea d'insorgere contro Roma. E di questo la sorella Maria l'aveva ringraziato col profumo. Se la seconda volta, a Betania, Gesù avevo deciso di entrare a Gerusalemme, era stato perché aveva ottenuto l'appoggio del movimento politico-giudaico legato al nome di Lazzaro, che doveva per forza essere quello farisaico, almeno nella sua ala più progressista.
A questo punto che Lazzaro fosse davvero morto o ancora vivo, non fa più molta differenza: ciò che di sicuro "viveva" era l'idea di farla finita con l'oppressione straniera e i collaborazionisti interni. L'unico problema esegetico da risolvere è in realtà un altro: come mai Marco sostituisce il nome di Lazzaro con quello, molto improbabile, di un certo Simone il lebbroso, un personaggio mai nominato altrove? Come gli è venuto in mente di mettere un lebbroso in una casa privata, disposto a ospitare Gesù e i suoi apostoli? E come mai questi accettano l'ospitalità senza tanti problemi?
Marco non dice che Maria era imparentata con Simone: non la ricorda neppure per nome. Essa entrò mentre tutti erano a tavola e, di punto in bianco, versò un olio profumato64 sulla testa di Gesù. Se Lazzaro fosse stato davvero resuscitato da Gesù, Marco non si sarebbe certo lasciata sfuggire l'occasione di parlarne. Avremmo avuto a che fare con un miracolo di molto superiore a quello compiuto alla figlia di Giairo. Ma se non è mai stato resuscitato, perché evitare di parlare chiaramente di Lazzaro? Perché riportare l'episodio dell'unzione - di cui Pietro fu testimone - in una maniera così distorta? Evidentemente Lazzaro doveva essere una persona scomoda per un vangelo forzatamente spoliticizzato come quello marciano.
Ma allora perché non eliminare del tutto l'episodio, evitando di raccontarlo? Si ha l'impressione che qui Pietro non abbia resistito alla tentazione di manipolare l'unzione in chiave mistica. Di fronte alla disapprovazione di vari apostoli, al vedere quello spreco (Giovanni però dice che fu solo Giuda a protestare), Gesù risponde dicendo cose del tutto insensate: 1) dare il ricavato di quel profumo ai poveri, una volta venduto sul mercato, sarebbe stata certamente un'azione giusta, ma siccome i "poveri" li avrebbero sempre avuti con loro, il fatto di versarlo sulla sua persona - destinata a morire di lì a pochi giorni - non sarebbe stato meno meritevole; 2) con quel profumo la donna aveva anticipato l'unzione del suo corpo per la sepoltura, in quanto la sua morte era imminente.
Da un lato quindi il Gesù marciano sostiene che non vi sarà alcuna insurrezione antiromana, per cui il problema della povertà resterà irrisolto; dall'altro fa passare quella donna, del tutto anonima, per una straordinaria profetessa delle intenzioni redentive del Cristo. Due falsità in piena regola, che Giovanni, nel suo vangelo, si è sentito in dovere di rettificare, visto ch'egli stesso fu testimone oculare di quell'evento.
Maria, sorella di Lazzaro, versò il purissimo nardo sui piedi di Gesù (non sulla "testa", come dice Marco) per ringraziarlo d'aver accettato l'idea di compiere l'insurrezione armata, quella stessa insurrezione che avrebbe voluto compiere suo fratello. Forse il profumo apparteneva già al Cristo, in quanto i due già si conoscevano, e forse lei gliel'aveva riservato per il giorno della sua sepoltura. Ma il punto non è questo. Nel quarto vangelo l'autore lascia capire che la protesta di Giuda non era solo di tipo economico, ma anche politico, in quanto, a differenza di Maria, egli non credeva affatto imminente l'insurrezione, almeno non fino a quando non si fosse trovato nella capitale il consenso sufficiente per poterla fare. Dare per scontata una cosa del genere, per lui era una forma di imprudenza, una forzatura esagerata.
Giuda era un moderato, che probabilmente proveniva dagli ambienti progressisti del fariseismo; ambienti dai quali verranno fuori esponenti prestigiosi del fariseismo convertito al cristianesimo o di questo simpatizzante, come Paolo di Tarso, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea, Gamaliele... Marco invece toglie a Giuda qualunque caratteristica politica e lo trasforma in una persona altamente venale, disposto a tradire Gesù solo per denaro. Non si rende conto, così facendo, di quel che scrive. Infatti come avrebbe potuto Gesù, dotato di poteri sovrumani, scegliere tra i suoi più stretti collaboratori una persona del genere, al quale affidare addirittura la gestione della cassa comune! In questo vangelo sembra addirittura che l'abbia scelto apposta, proprio per essere tradito!
III
Per come Marco racconta l'ultima pasqua di Gesù, dobbiamo dire che siamo in piena fiction, anzi, in una specie di rappresentazione teatrale in cui ognuno deve svolgere la propria parte, ben definita, senza sfumature di grigio.
Gesù si preoccupa di svolgere a puntino un rito religioso65, quando, per tutto il vangelo, non l'ha mai fatto. Predispone magicamente dove trovare l'uomo66 che metterà a loro disposizione "una grande sala ammobiliata e pronta" (14,15); fa questo esattamente come in precedenza, prima di entrare a Gerusalemme, quando aveva predisposto dove e come trovare un puledro su cui sarebbe salito. Poi a cena afferma, con sicurezza e improvvisamente, che uno di loro l'avrebbe tradito, mettendoli - potremmo aggiungere noi - in un imbarazzo insensato alla vigilia dell'insurrezione; e addirittura precisa, senza però fare nomi, che l'avrebbe tradito uno che intinge67 con lui nel piatto (14,20), quindi a lui fisicamente molto vicino, tant'è che nel quarto vangelo (13,26) i redattori scrivono che gli diede un boccone di pane intinto. Non è quindi da escludere che l'organizzatore di quella serata sia stato lo stesso Giuda, che certamente conosceva bene Gerusalemme, tanto quanto i fratelli Zebedeo.
Marco fa passare Gesù per una divinità che accetta d'essere tradita. Infatti il versetto preposto a spiegare questa scena fantastica è il 21: "Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui68, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!".
Cerchiamo ora di capire l'evidente incongruenza. Secondo Marco Gesù "doveva morire", poiché così era stato stabilito da Dio-padre. Tuttavia, anche se il tradimento ha ovviamente favorito questo destino, non necessariamente egli doveva morire in tale maniera. Ancora però non è chiaro. Se "doveva morire", perché ha aspettato d'essere tradito? Una volta entrato a Gerusalemme, non poteva farsi catturare? Non poteva rinunciare alla protezione della folla? o ai discepoli armati? Li aveva fatti armare perché altrimenti non l'avrebbero seguito? Ma allora perché non entrare da solo nella capitale? In questo modo avrebbe fatto risparmiare a Giuda l'azione vergognosa del tradimento.
Tutte le volte che in politica o in campo militare si parla di tradimento, è perché la persona tradita non voleva esserlo, non voleva essere catturata, non voleva essere costretta a dire o fare cose contro la propria volontà o non voleva essere messa in condizione di far rischiare la vita ai propri compagni o colleghi o amici o parenti o sottoposti. La risposta di Marco sembra essere la seguente: secondo la volontà del Padre Gesù doveva morire, ma, per non far sembrare questa morte un suicidio (agli occhi degli uomini), si doveva incolpare qualcuno a tutti i costi (in tal caso l'apostolo Giuda e, per estensione, le autorità giudaiche).
Marco, alias Pietro, vuol far capire varie cose con questo suo ragionamento: l'insurrezione antiromana è fallita per colpa dei Giudei, non dei Galilei, e non perché i Romani fossero troppo forti; se essa non è stata fatta dopo la morte del Cristo, il motivo va cercato nell'attesa del suo ritorno glorioso, legittimata dalla tomba vuota; l'assenza dell'imminente parusia trionfale ha fatto pensare che sulla Terra non fosse possibile realizzare un regno di liberazione; se un uomo straordinario come Gesù, capace addirittura di risorgere, non è riuscito a compiere la rivoluzione, allora vuol dire che la sua morte era "necessaria", voluta da Dio; ma allora anche il tradimento di Giuda rientra nella prescienza divina (essendo di natura divina, Gesù non poteva essere colto alla sprovvista: lo indica anche il fatto d'aver anticipato per tre volte le modalità della sua fine); siccome però le autorità giudaiche non hanno accettato di pentirsi per ciò che hanno fatto, i cristiani rompono definitivamente i rapporti col giudaismo e cercano un compromesso col mondo romano, che non viene più visto come un nemico politico, ma solo come un rivale sul piano religioso. Quindi, in sostanza, mentre prima era il movimento nazareno che vedeva le autorità giudaiche colluse politicamente con Roma, ora è l'intera chiesa cristiana che cerca col medesimo potere un rapporto reciprocamente vantaggioso.
Non dimentichiamo che Marco scrive dopo che Paolo aveva sviluppato il concetto petrino di "morte necessaria", trasferendolo sul piano ontoteologico. Per Pietro la morte è stata, in qualche modo, inevitabile, in quanto, se è vera l'idea di "resurrezione", allora non si può pensare che una persona divino-umana non avrebbe potuto evitare la propria morte violenta e trionfare sui propri nemici. Se aveva accettato di morire, era stato soltanto per far capire che gli uomini, da soli, in forza della propria autonoma volontà, non sono in grado di liberarsi da alcunché di negativo (in primis la schiavitù, l'oppressione sociale e nazionale, ecc.): essi hanno sempre bisogno di un aiuto superiore.69 Ovviamente per Pietro questo aiuto avrebbe dovuto essere imminente.
Paolo invece mette in rapporto tale impotenza umana al peccato originale: gli uomini non possono autoliberarsi proprio perché, all'inizio della loro storia, hanno compiuto una colpa che li ha definitivamente debilitati, i cui effetti principali sono la morte e l'incapacità d'essere coerenti, cioè se stessi, in quanto si fa non ciò che si vuole ma ciò che non si vuole. Gesù sarebbe morto e risorto per riscattarli da questa maledizione agli occhi di Dio. Paolo ha ancora in mente un Dio veterotestamentario, che ha bisogno di un sacrificio umano per placare la sua collera e giungere al perdono. In tal caso, per poter salvare l'intero genere umano, ha avuto bisogno del sacrificio "fisico" del figlio, per il quale la stessa creazione dell'universo e quindi del genere umano, era stata possibile. Il riscatto è avvenuto in quanto il figlio ha dovuto accettare, sul piano etico, umiliazioni indegne per una divinità. Il suo grandissimo amore per gli uomini li ha definitivamente redenti agli occhi di Dio, che non potrà più pentirsi d'aver creato la specie umana, come ai tempi di Noè. Il riscatto però, finché esisterà questo mondo, sarà unicamente "spirituale", non materiale. Sarà una specie di "caparre religiosa": gli uomini, individualmente, otterranno il saldo solo dopo la morte e, come genere, solo alla fine dei tempi. Questa la teologia politica regressiva, rinunciataria, di Paolo, in linea con quella di Pietro. Ecco perché si deve parlare di teologia petro-paolina quale vera fondatrice del cristianesimo.
IV
La parte finale della pericope sull'ultima cena continua a conservare l'aspetto surreale deciso sin dall'inizio. Sembra di assistere a uno psicodramma. È come se gli attori (i Dodici) fossero convinti di stare a mangiare non con una persona reale, ma col suo fantasma. Il quale, da un lato, afferma - come se fosse una persona dotata di preveggenza - che di sicuro qualcuno di loro lo tradirà; dall'altro però inscena una cerimonia religiosa (che poi verrà chiamata "eucaristia") come se fosse già morto e risorto, in quanto quel "sacramento" doveva servire per ricordare una tragedia già avvenuta (infatti viene anche detto "memoriale").
Il misticismo sembra purificarsi al massimo. Si celebra la Pasqua ebraica e la si trasforma in Pasqua cristiana, in cui l'agnello sacrificale è lo stesso Gesù Cristo, il quale appunto dice, parlando del pane: "Questo è il mio corpo", e del sangue: "Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti" (14,22 ss.).70 Praticamente i Dodici avrebbero assistito a una sorta di rito cannibalico simbolizzato dal pane-corpo e dal vino-sangue. Non sarebbero stati loro a uccidere l'agnello-animale privo di difetti, bensì l'agnello-Gesù si sarebbe offerto spontaneamente, si sarebbe autoimmolato nella propria purezza.
In un primo momento, quindi, Gesù avrebbe detto, con sicurezza matematica, che qualcuno l'avrebbe tradito (e lui sapeva chi), cioè non si sarebbe limitato a dire che in quel momento così delicato dovevano restare assolutamente uniti, evitando iniziative personali, eseguendo gli ordini alla lettera, ma avrebbe proprio detto che tutto sarebbe finito male, anche se non per loro, ma soltanto per lui.
Poi fa capire loro che, a ricordo della sconfitta politica (inevitabile, poiché su questa Terra nessuna liberazione è possibile, almeno non per i meriti degli uomini), avrebbero dovuto, d'ora in poi, celebrare un sacramento (che è un simbolo religioso), le cui modalità di esecuzione le ha stabilite lui stesso: un sacramento dell'impotenza, in memoria dell'unico dio-umano in grado di rendere definitivamente felici gli uomini soltanto nell'aldilà, mentre qui sulla Terra può offrire loro soltanto un anticipo, una caparra, attraverso appunto la resurrezione.
L'autoimmolazione è una sorta di patto politico: Cristo resterà fedele agli uomini anche se il regno di Dio potrà essere realizzato soltanto nell'aldilà. Si noti quindi la sequenza cronologica dei fatti: 1) Gesù annuncia un tradimento sicuro, che viene peraltro a confermare la necessità di "dover morire", al fine di riscattare il genere umano al cospetto di un Dio che vorrebbe sterminarlo a causa delle sue colpe sempre più gravi, come fece anche con le città di Sodoma e Gomorra; 2) Gesù dà da mangiare il pane-corpo e da bere il vino-sangue a tutti gli apostoli (quindi incluso il traditore), facendo capire che, nonostante il tradimento e l'inevitabile crocifissione (conseguente appunto al tradimento, ma soprattutto alla volontà divina), essi devono ricordarsi ch'era stato previsto tutto, e che quindi la tragedia della morte violenta va relativizzata, anche perché lui, essendo un dio, di fatto non può morire, se non apparentemente, agli occhi degli uomini; 3) detto questo, Marco scrive che "dopo aver cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi" (14,26). Lì per lì gli apostoli non avevano capito nulla, ma al cospetto della tomba vuota i loro occhi improvvisamente si apriranno.
Una tale ricostruzione dei fatti è semplicemente pazzesca. Nessuno chiede a Gesù che cosa stia facendo, che significato abbia quel rito cannibalico, che per qualunque ebreo sarebbe stata una cosa assolutamente mostruosa, anche se è compiuta in maniera simbolica. Quale leader ebraico avrebbe mai potuto pensare di dare in pasto ai suoi discepoli il proprio corpo e il proprio sangue, seppur mediati dal pane e dal vino, convinto che quelli non gli avrebbero posto neppure una domanda? Quando gli esseni praticavano un rito analogo a questo, non avevano certo in mente alcuna antropofagia, alcun pasto totemico.71
Dunque gli apostoli si trasferiscono nella vallata del Cedron, al Getsemani72, dopo aver tranquillamente cantato l'Hallel, un inno ripreso dai Salmi 112-117. E qui ci si chiede: indubbiamente loro si fidavano di Gesù, ma davvero avevano capito tutto quello che lui, in quel momento, aveva detto e fatto? E l'avevano anche condiviso? Stando a quanto scrive Marco, pare non avessero capito nulla. Infatti, mentre erano nel Getsemani Gesù si sente in obbligo di preavvisarli, dicendo: "Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea" (14,26 ss.).
La frase del pastore e delle pecore è presa da Zc 13,7. Quando si leggono frasi del genere è sempre bene analizzarle nel loro contesto originario, poiché siamo abituati, dagli stessi evangelisti, a vedere interpretazioni del tutto inappropriate. Secondo il profeta Zaccaria il pastore che deve essere "percosso" è una persona spregevole, e le pecore che lo seguono sono come lui. È una persona che opprime il popolo e ha introdotto idoli pagani. Due terzi del popolo, di conseguenza, vanno sterminati, inclusi i profeti, a vantaggio dei "deboli".
Ora, che senso ha estrapolare dal suo contesto una frase di Zaccaria, attribuendole un significato opposto a quello originario? Possibile che gli evangelisti avessero bisogno di ricorrere a bassezze del genere, pur di sostenere l'idea strampalata della resurrezione di Gesù? Non sarebbe stato meglio se avessero semplicemente detto che i discepoli trovarono vuota la tomba, senza potersi spiegare che fine avesse fatto quel corpo appena inumato? In questa maniera si sarebbero risparmiati di sostituire la parola "insurrezione" con la parola "resurrezione", che se per gli apostoli, in quel momento, poteva anche avere un significato mistico propositivo, indubbiamente ne aveva anche uno politico regressivo, in quanto induceva a un'attesa passiva della parusia.
Il bello è che nel racconto marciano chi cerca di opporsi di più al Gesù della fede, al Cristo eucaristico, al dio-uomo che preannuncia la propria fine, giudicata ingloriosa dagli uomini, ma del tutto conforme alla volontà divina, è proprio Pietro! Qui, in un certo senso, si raggiunge il comico, se non fossimo in presenza di un'altra delle solite triviali falsificazioni. Pietro infatti viene fatto passare come il più coraggioso, come colui che avrebbe dato la propria vita per difendere quella di Gesù. Il più coraggioso perché s'era fatto avanti per primo a esibire una dichiarazione di assoluta fiducia e di totale abnegazione, anche se poi, di riflesso, tutti gli altri avevano ripetuto le medesime cose, come viene detto al v. 14,31. Quindi Marco fa capire chiaramente che nessuno era disposto ad accettare l'idea di un Cristo martirizzato per il bene dell'umanità. Chissà quindi cosa avevano capito durante l'ultima cena...
Tuttavia, se ci limitassimo a individuare l'abisso che separava il Cristo teologico dagli apostoli politici, daremmo di questi fatti leggendari una lettura superficiale. Qui non si deve mai dimenticare che dietro Marco c'è Pietro. Dunque, che senso ha che Pietro presenti se stesso in una luce così sconveniente per la sua fede cristiana? La risposta non è difficile. Se un politico come Pietro, disposto a compiere l'insurrezione armata, si è trovato, ad un certo punto, a elaborare il concetto di "resurrezione" per interpretare la tomba vuota, una ragione - penserà il lettore - doveva pur esserci. Non lo si può accusare di "tradimento"; non lo si può mettere sullo stesso piano di Giuda, proprio perché avrebbe dato la sua vita per difendere quella di Gesù.
Dunque Pietro è come se avesse detto: "Ho rinnegato Cristo perché non l'avevo capito, ma quando finalmente l'ho capito, ho detto ch'era risorto. Consideratemi pure un traditore sul piano politico, ma non su quello teologico". Ecco perché il Pietro politico si fa mettere alla berlina dal Cristo teologico: aveva bisogno di far vedere, contro chi sosteneva l'idea di un Cristo politico, ch'era migliore la sua idea di Cristo teologico. Quindi alla necessità di una insurrezione terrena si doveva opporre la necessità di una resurrezione ultraterrena.
V
La pericope relativa all'agonia di Gesù nel giardino o podere o frantoio per l'olio del Getsemani sembra che parli di un luogo diverso dal Monte degli Olivi, citato prima. Sembra che Gesù e gli apostoli vi siano andati due volte. Anche da queste piccole cose si comprende come i vangeli siano in realtà delle opere collettive, scritte - diremmo oggi - da Autori Vari, i cui nominativi sono rimasti del tutto ignoti. In questo, peraltro, sta anche la loro forza. Sono frutto di ampi compromessi tra varie comunità cristiane. Possono rimetterci lo stile e l'organicità interna, ma sicuramente ci guadagna la complessità del messaggio, la sua pretesa esaustività attorno ad alcuni temi di fondo, assolutamente imprescindibili.
Noi occidentali, così individualisti, così legati al diritto d'autore, queste cose stentiamo molto a capirle. Per noi la produzione intellettuale è quasi sempre finalizzata a un riscontro economico o a un riconoscimento pubblico. Viceversa, per gli autori dei vangeli un'opera letteraria voleva soltanto essere espressione dei convincimenti più profondi di varie comunità. Spesso - almeno agli inizi - la diffusione di questi testi era addirittura clandestina, in quanto si temevano travisamenti, incomprensioni da parte dei poteri dominanti o addirittura persecuzioni per il semplice fatto di possederli.
Ora, se tale pericope venisse tolta dal vangelo, la coerenza interna, quella oggettiva, rimarrebbe immutata. Cioè se fossimo passati da 14,31 a 14,43 nessun esegeta si sarebbe accorto che in mezzo mancava qualcosa. Questo fa subito pensare che il brano sia stato aggiunto per esaltare alcuni aspetti soggettivi del Cristo o degli apostoli, qualcosa riguardante la loro personalità. In effetti la pericope è tutta incentrata sul tema dell'angoscia esistenziale, quel sentimento che si prova prima che stia per accadere qualcosa di terribile, di assolutamente inevitabile e irreparabile. Chi ha scritto questo testo doveva per forza aver riflettuto sul tema petrino della "morte necessaria" e non poteva non essersi chiesto in che modo un dio fattosi uomo, sapendo in anticipo ch'era giunta la sua ora, avrebbe potuto affrontarla sul piano psicologico.
In effetti un dio che tutto prevede, può anche avere un atteggiamento di indifferenza nei confronti di ciò che sta per accadergli, poiché sa bene che comunque ne uscirà indenne, qualunque cosa gli succeda. Ma un uomo come può affrontare un momento del genere? Come può restare impassibile? La sua stessa vita rischia d'essere compromessa. Può anteporre la necessità di vivere all'ideale che vorrebbe assolutamente realizzare?
L'autore del testo deve per forza essersi chiesto se, per poter rappresentare Gesù poche ore prima dell'arresto, sarebbe stato meglio puntare di più sulla sua umanità o sulla sua divinità. La soluzione scelta è stata una via di mezzo, facendo fare la parte degli indifferenti, ignari del pericolo incombente, agli apostoli, che se la dormono beatamente. Il testo, quindi, nel proprio misticismo, diventa complesso, poiché l'autore vuol tener conto della natura ambivalente del Cristo divino-umano; il che, ovviamente, rende il racconto del tutto fantastico, pur avendo motivi struggenti e anche strazianti, che arrivano a toccare certi livelli di poeticità.
L'esordio sembra essere realistico, ma, come spesso succede nei vangeli, la finalità è completamente mistica: Gesù prende con sé la triade apostolica prediletta (Pietro, Giacomo e Giovanni) e dichiara essere "spaventato e angosciato" (14,33), per cui mostra d'aver bisogno di "pregare" (v. 32). Viene ripetuto che la sua anima era "oppressa da tristezza mortale" (v. 34). È terrorizzato come uomo e prega come un credente che si rivolge a Dio-padre. Ciò che chiede è di non morire: "pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui" (v. 35); "Padre, ogni cosa ti è possibile; allontana da me questo calice!" (v. 36). È il calice di una bevanda molto amara. In Is 51,17 è il calice dell'ira divina, la coppa della vertigine, che qui Gesù deve bere per non farne pagare le conseguenze agli uomini. È una bevanda mortale per lui, ma terapeutica per l'umanità.
Il redattore entra nella personalità umana del Cristo e, per la prima volta in questo vangelo, fa capire che tra il dio-figlio e il dio-padre poteva non esserci una unanimità di intenti. Qui si rischia di non comprendere più se l'idea di "morte necessaria" Gesù l'aveva condivisa come un'idea giusta in sé e per sé o se semplicemente l'aveva accettata per spirito di obbedienza. L'autore deve fare molta attenzione a ciò che scrive, poiché sta per smentire una delle tesi fondamentali di Pietro.
Senonché dalla potenziale eresia egli si salva dicendo che il Cristo, anche se per un momento può aver creduto che un sacrificio del genere fosse eccessivo, di fatto non ha mai pensato, neanche per un momento, ad opporsi alla volontà del Padre. Ecco perché mentre pregava, Gesù si è sentito di aggiungere (ha cioè sentito il dovere di farlo): "Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu" (v. 36). Una frase, questa, che potrebbe dare adito a mille equivoci. Infatti, se Gesù, come uomo, non vorrebbe morire, in che rapporto sta la sua umanità con la sua divinità?73 S'egli era davvero convinto che in quel momento fosse stato compiuto un tradimento e che la cattura fosse molto probabile, avrebbe anche potuto agire diversamente: p.es. fuggire anche da quel luogo o difendersi sino alla morte. Se fossimo dei mistici potremmo addirittura arrivare a dire che doveva utilizzare contro i suoi nemici i poteri sovrumani di cui disponeva. Non a caso nel vangelo di Matteo Gesù dice a Pietro: "Se volessi, potrei chiamare dodici legioni di angeli" (26,53). Una frase assurda, questa, poiché se anche avesse potuto, non avrebbe dovuto farlo, in quanto avrebbe violato, ipso facto, la libertà di coscienza degli uomini, che non può essere coartata da alcuna evidenza in grado di autoimporsi.
Interessante è l'idea, da parte del redattore, di far dire a Gesù, davanti agli apostoli che se la dormivano molto tranquillamente (e che quindi - si potrebbe arguire - di tutta questa agonia e delle parole dette da Gesù nulla potevano sapere): "Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole" (v. 38). La tentazione era appunto quella di reagire in maniera scomposta di fronte alla turba armata che li stava venendo a prendere.
L'uso della preghiera qui ha lo scopo di ridimensionare le pretese, le esigenze personali, quelle di tipo politico, legate alla materialità della vita. Gesù chiede a loro di "vegliare", per non cadere nella tentazione di poter ottenere giustizia su questa Terra. La preghiera infatti ha il compito di far rassegnare gli uomini al male (degli altri), non opponendo violenza a violenza. Ancora una volta il Gesù umano viene surclassato dal Cristo teologico, quello conforme all'ideologia petrina. Il quale Cristo giustifica la propria decisione autoimmolatoria, mostrando che gli apostoli si erano addormentati per ben tre volte, quando, nella realtà, dovevano aver provato la sua medesima angoscia.
In Mc 14,36 Gesù, mentre prega, pronuncia in aramaico la parola "Abbà", che vuol dire "Padre". È una parola molto rara nel N.T.: si trova anche in Gal 4,4-7 e Rm 8,14-17, che sono fonti per il vangelo marciano. L'esegeta Joachim Jeremias, nel suo libro Abba (ed. Paideia, Brescia 1968), è convinto che si tratti di una delle parole più vere pronunciate da Gesù (ipsissima vox). Dice questo perché i vangeli pongono la parola "Padre" sulla bocca di Gesù in riferimento a Dio non meno di 170 volte e a queste vanno aggiunte le altre 250 menzioni nel resto del Nuovo Testamento.
Ebbene, se c'è una parola che Gesù non può aver pronunciato è proprio quella: lo dimostra il fatto che nel primo vangelo la parola "Padre" (Patér) viene detta solo quattro volte, mentre negli altri vangeli molto di più. Considerando che il vangelo marciano è una mistificazione del Gesù storico, basata sulla teologia petro-paolina, si può facilmente supporre che Gesù non abbia mai pronunciato questa parola, proprio perché non lo si vede mai "pregare", se non in alcuni versetti chiaramente apologetici.
Di regola, nel suo modo di comportarsi, cioè per dire quel che vuole dire o per fare quel che vuol fare, egli mostra di non aver bisogno di credere o di far credere in alcuna entità o divinità superiore. Infatti, anche accettando per buona la tesi mistica secondo cui Gesù "faceva la volontà del Padre", sono piuttosto i suoi interlocutori che devono credere che tra la sua volontà e quella di Dio non vi è alcuna differenza.
Nel protovangelo Gesù chiama Dio col termine "Abbà" perché i cristiani han visto in lui la possibilità di ridurre al minimo la distanza, posta tradizionalmente dagli ebrei (monoteistici e aniconici), tra l'umanità e la divinità. L'unico modo per farlo, in campo mistico o teologico, era appunto quello di far rappresentare perfettamente l'immagine di Dio-padre dal proprio Figlio, di natura divino-umana. Vedendo il Figlio, i discepoli post-pasquali avrebbero dovuto vedere il Padre, sicché chi chiedeva di vedere direttamente il Padre (p.es. Filippo in Gv 14,8), era perché non credeva nel Figlio: questo nel IV vangelo è chiarissimo.
Ma il punto è un altro. Com'è venuto in mente alla comunità protocristiana di equiparare il Figlio al Padre, quando per Gesù l'ateismo era l'unico modo per affrontare la questione religiosa? Le due posizioni sembrano inconciliabili, ma in realtà lo sono solo apparentemente.
Dobbiamo anzitutto tener conto che il cristianesimo è nato come una "religione" che aveva il compito di mistificare l'istanza politica del Cristo, quindi l'idea di Dio non poteva essere negata. Il problema era come conciliare questa idea religiosa col fatto che Gesù si poneva in maniera ateistica, in quanto considerava se stesso una divinità e voleva che anche i suoi discepoli si considerassero come lui. Se Dio non esiste, tutti gli uomini sono delle divinità.
Ora, che cosa ha fatto la comunità cristiana per trasformare questo ateismo esplicito in un'altra cosa? Ha fatto in modo di far passare Gesù, agli occhi dei Giudei, non per un ateo che negava Dio, affermando solo la natura umana, ma per un ateo che negava Dio identificandosi in Lui. Un'identificazione del genere, che nei vangeli viene presentata come di sua stretta pertinenza, non poteva apparire, alla mentalità ebraica, che come una forma di blasfemia, una presunzione insopportabile.
Agli occhi dei Giudei si poteva essere condannati per blasfemia non soltanto quando si sosteneva l'inesistenza di Dio, ma anche quando, pur non negandone l'esistenza, si affermava, in autonomia, d'essere pienamente conformi alla sua volontà. Per un ebreo nessuno poteva esser sicuro di fare la volontà divina, neppure il sommo sacerdote, in quanto di fronte a Dio si è sempre colpevoli di qualcosa. Di qui la necessità di pregarlo, di fare offerte e sacrifici, di rispettare scrupolosamente riti e consuetudini, ecc.
Vedere un uomo che, con sicurezza, afferma di compiere la volontà divina e che addirittura proclama d'esserne il Figlio in via esclusiva e unilaterale, senza alcuna mediazione sacerdotale, era sufficiente, per un ebreo, per accusarlo di blasfemia e ritenerlo meritevole di morte.
Quindi, in un certo senso, si potrebbe dire che la comunità cristiana ha voluto conservare l'atteggiamento ateistico del Cristo, trasformandolo in chiave teologica, in maniera tale che fosse annullato l'impatto politico-eversivo.
VI (fonti)
Se davvero Giuda avesse tradito con un bacio sul volto di Gesù, Giovanni non avrebbe mancato di dirlo nel suo vangelo, visto che con Giuda non è mai tenero. Generalmente il bacio veniva considerato un simbolo di pace e di carità: era d’uso corrente tra maestro e discepolo. Qui invece Marco lo presenta come un gesto di somma ipocrisia, sulla funzione del quale Giuda si era messo preventivamente d'accordo con la turba armata. Non dimentichiamo che in questo vangelo egli tradisce per denaro, o comunque le autorità, per ringraziarlo, gliene offrono (senza che se ne precisi la quantità), e l'evangelista non dice che lui lo rifiutò. Niente di tutto ciò, invece, nel quarto vangelo, ove non si parla né di denaro né di bacio.
La circostanza della notte fonda è confermata da tutti i vangeli. Le differenze si fanno consistenti quando si tratta di catturare Gesù. In Giovanni le guardie sono romane e giudaiche e vogliono prendere proprio lui, anche se, per poterlo catturare, sono disposte a tutto. Non possono mancare il bersaglio, altrimenti il giorno dopo per loro potrebbe anche essere la fine. Viceversa in Marco le guardie sono solo giudaiche, inviate dal Sinedrio (14,43). I Romani non devono apparire subito come dei protagonisti attivi: essi sono soltanto vittime inconsapevoli della perfidia giudaica, che al momento opportuno saprà raggirarli con grande maestria.
Il buio e la presenza dei molti alberi rendevano difficile la cattura di Gesù: le torce e le lanterne non erano sufficienti. La differenza tra la versione di Marco e quella di Giovanni sta proprio in questo, che in Giovanni è Gesù stesso, accortosi della netta sproporzione tra le forze in campo, che si fa avanti proponendo un patto: lasciare andare gli apostoli in cambio della sua spontanea consegna; non vi sarebbe stato alcuno spargimento di sangue. La turba armata accettò. Anche Giovanni, ovviamente, deve constatare la presenza di Giuda, in quanto l'apostolo conosceva bene il luogo del rifugio, ma evita di dire ch'egli fu così ipocrita da escogitare un bacio per far riconoscere Gesù alle guardie.
Marco invece lo dipinge così volgarmente perché lo vuole abbassare il più possibile, togliendo qualunque motivazione politica al suo gesto; sicché l'apostolo finisce col tradire per interessi o ragioni del tutto personali, da considerarsi di livello molto basso. Il che rende del tutto inspiegabile come mai un soggetto del genere fosse presente nel gruppo molto ristretto dei Dodici, e come mai gli fosse stata affidata la gestione della cassa comune e soprattutto come mai fosse stato incaricato da Gesù di compiere un'azione molto importante proprio nella notte decisiva per l'insurrezione.
Del vantaggio del buio doveva essersi accorto anche Pietro, che infatti estrasse subito la spada cercando di far fuori una delle guardie; senza però riuscirvi, poiché quello si scansò in tempo, rimettendoci solo un orecchio. Il gesto scriteriato dell'apostolo, con cui avrebbe potuto far ammazzare tutti i suoi compagni, fu - secondo il quarto vangelo, che indica persino il nome della guardia colpita - compiuto da Pietro, ma Marco, seguito a ruota da Matteo e Luca, evita di dirlo.
Perché questa autocensura da parte del cronista? Aveva già scritto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù: di peggio c'era solo il tradimento di Giuda. Eppure la reticenza, a ben guardare, è necessaria, poiché Pietro aveva dichiarato che avrebbe difeso Gesù anche a costo di rimetterci la vita. Invece con quella reticenza il lettore può pensare che Pietro, dicendo, in precedenza, che avrebbe fatto di tutto per salvare il suo maestro, aveva voluto fare soltanto lo smargiasso, ma che, di fatto, non possedeva i mezzi concreti per restare coerente col suo proposito. Qui, se venisse presentato con una spada in mano, il rinnegamento della strategia del Cristo, dopo la crocifissione, sarebbe apparso ancora più contraddittorio.
Negare di conoscerlo, poiché si teme d'essere catturati insieme a lui, ci poteva stare: era un'azione umana, seppur vile. Ma rinnegarlo ancora dopo morto, rifiutando la strategia eversiva, da parte di uno che fino a pochi giorni prima andava in giro armato, sarebbe stata una contraddizione eccessiva, un tradimento analogo a quello di Giuda, se non peggiore. Lo stesso Gesù dichiara alle guardie d'essere disarmato e che avrebbe potuto essere catturato facilmente i giorni precedenti, mentre insegnava pubblicamente al Tempio. Il Gesù di Marco vuol essere buonista ad oltranza, assolutamente non violento, fatalista nei riguardi del progetto tragico che su di lui ha riservato Dio-padre. Si consegna senza reagire proprio per adempiere le Scritture (14,49). Pietro, che vuole apparire suo diretto successore, non poteva essere completamente diverso da lui. Ecco perché il suo nome non appare.
Tutti gli apostoli fuggirono (poi, vedremo, meno uno, e qui è facile indovinare chi). L'unico che, stranamente, le guardie cercarono di catturare fu un giovane che seguiva Gesù, coperto soltanto con un lenzuolo.74 Lo afferrarono, ma egli, lasciato andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo (14,51 s.). In questa immagine alcuni esegeti hanno pensato di intravedere lo stesso Marco, il quale avrebbe lasciato una sorta di "firma" di autenticità della sua opera, ma è dubbio che un ragazzino potesse essere presente in quel frangente.
(torna su)14) I due processi farsa
I (Davanti al Sinedrio)
Il processo di Gesù davanti a Caifa, descritto da Marco (14,53 ss.), è una parodia non solo surreale, ma, nel proprio marcato antisemitismo, anche vergognosa. E di questa cosa lui pensa che nessuno avrebbe potuto smentirlo, in quanto l'unico testimone, tra gli apostoli, l'unico che, dopo aver fatto finta di fuggire, decise di tornare indietro e di seguire le guardie che avevano appena catturato Gesù, fu, nel suo vangelo, proprio Pietro!
Viceversa, il quarto vangelo spiega bene che Pietro non fu testimone di nulla, né dell'udienza davanti all'ex sommo sacerdote Anania (cui poté assistere, in qualche maniera, il solo Giovanni), né di quella davanti al sommo sacerdote Caifa (neppure Giovanni lo poté, avendo conoscenze solo presso Anania). E l'udienza presso Anania non fu affatto così melodrammatica come quella descritta da Marco davanti al Sinedrio; anzi fu piuttosto breve, in quanto Gesù non disse quasi nulla; e non fu affatto violenta, a parte un ceffone che una guardia gli diede, avendo interpretato una sua risposta al pontefice come offensiva.75
Marco, insomma, si è inventato tutto. E ha pensato di farlo proprio mostrando che l'unico testimone era stato Pietro, per cui nessuno avrebbe potuto contraddirlo. Già il suo esordio è inverosimile: si riunirono "tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi" (v. 53), cioè praticamente tutto il Sinedrio (come viene detto al v. 55), di notte (cosa vietata)76, pronto a giudicare nell'imminenza della Pasqua (altra cosa vietata), nella casa privata di Caifa (cosa del tutto assurda)77.
Pietro addirittura è potuto entrare da solo nel cortile della casa privata di Caifa, e starsene tranquillamente seduto, accanto alle stesse guardie che poche ore prima l'avevano visto tagliare l'orecchio al servo del sommo sacerdote: tutti si scaldavano attorno a un fuoco. A dir il vero anche in Giovanni può fare questo, ma nel cortile dell'ex sommo sacerdote Anania e con la protezione dello stesso Giovanni, che conosceva la custode e addirittura il nome del servo suddetto: Malco. È evidente, già da queste premesse, che Pietro vuole scaricare tutte le colpe della fallita insurrezione (di cui però non può parlare, avendo trasformato il suo Cristo da politico a teologico) sulle autorità giudaiche, quelle stesse autorità a cui, negli Atti degli apostoli (2,38 ss.), chiederà di pentirsi, al fine di poter stabilire un compromesso religioso tra cristianesimo e giudaismo.
In particolare Pietro vuole scaricare la responsabilità ultima, quella principale, su Caifa, mostrando che tutti gli altri sinedriti dipendevano da lui. Cioè vuol far vedere che lo scontro in atto non era tra Palestina e Roma, ma tra il Sinedrio e Cristo, quindi tra due diverse teologie politiche, di cui quella nazarena rappresentava gli ideali dei Galilei. Vi è quindi una sorta di personalizzazione dello scontro teologico-politico, in cui lo stesso Pietro, che si sente diretto successore di Gesù, avverte Caifa come il suo principale nemico. In questa maniera può evitare di dire che, rispetto all'imperatore romano e al prefetto Pilato che in Giudea lo rappresentava, Caifa era una figura minore, che non avrebbe neanche potuto ricoprire quel ruolo senza il consenso dell'imperatore.
Marco, alias Pietro, ci tiene a mostrare che Gesù era assolutamente innocente di tutto, per cui tutte le accuse dei sinedriti erano false e in contrasto tra loro. Una di queste viene riportata per canzonare gli stessi Giudei: "Noi l'abbiamo udito mentre diceva: Io demolirò questo Tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani d'uomo" (v. 58).78
I sinedriti vengono messi alla berlina perché, secondo Marco, interpretavano le parole di Gesù alla lettera, come se Gesù fosse stato una sorta di mago o di stregone, senza riuscire a capire ch'egli si riferiva ai tre giorni della propria resurrezione. In realtà Gesù quelle parole non le pronunciò mai, perché non avrebbero avuto alcun senso: a lui non interessava affatto compiere una riforma di tipo religioso, ma semplicemente estromettere la casta sacerdotale dal Tempio, la quale, essendo collusa coi Romani a motivo dei propri traffici commerciali, distoglieva le masse dall'esigenza di compiere l'insurrezione nazionale. Interpretare poi i tre giorni in riferimento alla propria resurrezione, è pura fantascienza. Peraltro il Tempio, sul piano etico, era già distrutto dalla corruzione, per cui non aveva bisogno di aspettare alcunché per demolirlo e rifarlo.
Si noti un'altra cosa ancora: l'accusa che gli rivolgono implica, come conseguenza logica, che l'epurazione del Tempio non può essere stata compiuta subito dopo l'ingresso messianico. Infatti gli accusatori stanno parlando di cose avvenute nel passato: stanno dicendo che lo si è "udito", non "visto all'opera" (14,58). Inoltre Marco non solo afferma che su questo le testimonianze non erano concordi (v. 59), ma anche che "testimoniavano falsamente contro di lui" (v. 57). Eppure tale testimonianza relativa al Tempio - se si accetta l'idea di un Cristo teologico - avrebbe anche potuto essere vera, proprio perché non è molto diversa da ciò che Gesù pronuncia nel quarto vangelo: "Demolite questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere!" (2,19). Una frase ch'egli però avrebbe detto all'inizio della sua carriera politica, non alla fine, quando ancora pensava che si dovesse anzitutto eliminare il potere della casta sacerdotale per opporsi ai Romani, mentre con l'ingresso messianico era evidente che tale casta avrebbe perso tutto il proprio potere se non avesse avuto l'appoggio dei Romani. Questa seconda cosa però Marco, alias Pietro, non poteva dirla, ecco perché è stato costretto a posticipare il momento dell'epurazione del Tempio, la quale viene fatta passare per una iniziativa di tipo etico-religioso, priva di risvolti politici.
Tuttavia la parte più inverosimile è l'ultima, quando Caifa chiede a Gesù: "Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?" (v. 61). Non c'è una parola sensata in questa domanda. Cristo è una parola greca che in aramaico vuol dire "messia": tutti gli ebrei aspettavano un messia per liberarsi dei Romani. Non avrebbe avuto alcuna giustificazione condannarlo a morte solo per questo.79 Semmai si sarebbe potuto discutere sulla strategia da adottare, ma in tal caso non avrebbe avuto alcun senso procedere all'arresto. Poiché invece vi era stata l'esigenza di catturarlo, le autorità dovevano saper bene ch'egli, entrando in maniera così vistosa nella capitale, si proponeva come messia politico e quindi necessariamente in alternativa al loro potere corrotto. Dunque, sotto questo aspetto, la domanda (di natura politica) era del tutto retorica. Chiunque sapeva bene ch'egli si proponeva come messia e nessuno, nella pericope, formula accuse in questo senso per dichiararlo reo di morte, anche se i sadducei, gli scribi e gli anziani sanno che se egli diventa messia, per il loro potere e i loro privilegi è finita.
La seconda accusa di Caifa è invece di tipo teologico. Vuole sentirsi dire da Gesù che è "Figlio del Benedetto"80; cioè in sostanza gli sta chiedendo se pensa d'essere una persona non esattamente umana, o di avere una natura divina o semi-divina. Il nesso messia-Figlio di Dio, del tutto estraneo alla mentalità giudaica, è stato inventato da Marco sulla scia della teologia petro-paolina. Al massimo si poteva accettare il nesso di messia-figlio di Davide. Dirsi "figli di Dio" era troppo esagerato, a meno che non lo si intendesse in forma traslata o metaforica, nel senso che tutti i "buoni credenti" lo sono, o che lo sono tutti gli esseri umani in generale.
Qui invece è come se Caifa avesse preteso di sentirsi dire da Gesù che l'unico vero Figlio di Dio era lui stesso. Il che è assurdo. Il concetto di Gesù come Figlio unigenito di Dio, in via assolutamente esclusiva, appartiene a Paolo: neppure Pietro l'aveva. E tanto meno sarebbe potuto venire in mente a Caifa, per il quale la distanza tra Jahvè e gli uomini era abbastanza netta, come, d'altra parte, per tutti gli ebrei.
E poi l'unico che poteva dirsi "figlio di Dio" (sempre in maniera metaforica) era proprio il re d'Israele, colui che fosse stato in grado di liberare la nazione dai suoi nemici. In tal caso però avrebbe avuto bisogno di un riconoscimento sacerdotale, proprio per rendersi conto che doveva comunque restare, nel suo comportamento, sotto il giudizio divino, di cui il sommo sacerdote si faceva garante e interprete.
Quindi nel contesto dell'udienza presso Caifa, un'autodichiarazione da parte di Gesù, d'essere nel contempo messia e figlio di Dio non avrebbe comportato, in sé e per sé, una sentenza irrevocabile di morte, in quanto avrebbe potuto essere confermata dal sommo sacerdote e tutto sarebbe finito lì. Nessuno poteva dirsi messia e figlio di Dio senza il consenso delle autorità costituite, le quali, comunque, in quel momento, quei titoli non li davano a nessuno, essendo esse profondamente colluse con Roma.81
La sentenza di morte viene emessa da Caifa e confermata da tutto il Sinedrio82, quando Gesù fa capire che il titolo di "Figlio del Benedetto" non andava interpretato metaforicamente ma alla lettera. "Sì, lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo, seduto alla destra della Potenza, venire sulle nubi del cielo" (v. 62).83 In tale maniera, piuttosto assurda, Gesù avrebbe dichiarato la propria esclusiva divinità. Se c'era anche solo una possibilità che Caifa non consegnasse Gesù a Pilato, con questa affermazione la si rendeva del tutto vana. In ogni caso Caifa non aveva alcuna intenzione di tenere Gesù agli arresti, tant'è che lo consegna a Pilato all'alba del giorno dopo (Gv 18,28).
Marco non si rende conto di ciò che scrive, proprio perché appare del tutto succube dell'interpretazione petrina. Infatti, se davvero Gesù si fosse espresso così, inevitabilmente, per un ebreo qualunque, avrebbe meritato di morire. Non c'era bisogno del Sinedrio per condannarlo. Chi pretendeva di farsi "Figlio di Dio" in via esclusiva poteva essere considerato un povero mentecatto da emarginare. Ma chi pretendeva il medesimo titolo compiendo guarigioni straordinarie, o comunque acquisendo vasti consensi popolari in forza della propria predicazione, andava considerato molto pericoloso, in quanto scardinava uno dei pilastri fondamentali della teologia giudaica, secondo cui solo Dio è Dio e nessun altro. Dirsi "Figlio di Dio" in maniera letterale e unilaterale, era come bestemmiare, cioè era come, per un ebreo, fare professione di ateismo, in quanto venivano disconosciute le peculiari caratteristiche della divinità.84
Marco, alias Pietro, vuol far passare qui lo scontro tra Gesù e Caifa come uno scontro tra due teologie opposte, in cui in una Dio è totalmente irrappresentabile, mentre nell'altra può essere rappresentato solo dal Cristo, che ha anche natura umana. Senonché tale scontro è frutto di una duplice falsificazione: la prima è che Pietro maturò l'idea di attribuire una natura divina a Gesù soltanto dopo la scoperta della tomba vuota, per cui Gesù, davanti a Caifa, non poteva certo parlare in quel modo85; in secondo luogo Gesù era ateo, cioè riteneva - come scrive Giovanni (10,33) - che tutti gli uomini fossero dèi.
In Marco sono rovesciati i termini della questione, nel senso che se davvero Caifa avesse voluto condannare Gesù, non avrebbe potuto farlo davanti alla pretesa di autodefinirsi "figlio di Dio" in via esclusiva (che nessun ebreo avrebbe mai potuto avere), ma davanti alla pretesa di dichiararsi "ateo".86 E comunque la vera condanna non si basò tanto su questioni di tipo teologico, quanto piuttosto su questioni di tipo politico. Gesù avrebbe voluto compiere un'insurrezione contro il potere romano e contro quello giudaico collaborazionista. Fatto questo, ognuno sarebbe stato libero di credere nel dio che voleva e dove gli pareva, come già aveva detto chiaramente alla samaritana presso il pozzo di Giacobbe (Gv 4,21).
II (Rinnegamento di Pietro)
Il triplice rinnegamento di Pietro è confermato da Giovanni, ma certamente non nel modo in cui l'ha descritto Marco. Non foss'altro che per una ragione: se Pietro fosse stato riconosciuto come un seguace di Gesù, nel cortile del sommo sacerdote Caifa, non l'avrebbe passata liscia, a dispetto di tutti gli spergiuri e le imprecazioni con cui cercava di dimostrare la sua totale estraneità alla causa del movimento nazareno.
Poi vi sono altri particolari curiosi che meritano d'essere ricordati: in Giovanni la portinaia pone una semplice domanda a Pietro, supponendo che, quale compagno di Giovanni, fosse un discepolo di Gesù. Di fronte a lei Pietro nega senza motivo, in quanto avrebbe dovuto fidarsi della protezione di Giovanni, altrimenti questi non l'avrebbe fatto entrare nel cortile dell'ex sommo sacerdote Anania. In Marco invece la serva ha un atteggiamento immediatamente accusatorio e Pietro, temendo per la sua vita, nega con decisione. Ma come potesse la donna sapere che Pietro "era con Gesù Nazareno" (14,67), resta un mistero. Marco scrive che "lo guardò bene in viso", come se lei stessa fosse andata con le guardie armate a catturare Gesù e a battagliare con gli apostoli nascosti nel Getsemani! Qui è evidente che Pietro voleva prendersi tutto il merito d'aver seguito Gesù e le guardie armate da solo e con molto coraggio e di aver potuto assistere in prima persona al processo giudaico. Così facendo, mente sapendo di mentire. Non solo infatti odia i Giudei, ma mostra di avvertire Giovanni come una presenza scomoda, da mettere in cattiva luce o da censurare del tutto.
In entrambi i vangeli uno dei rinnegamenti avviene a motivo del fatto che dalla sua parlata galilaica le guardie vicino a lui suppongono che anch'egli fosse un seguace di Gesù. Solo che nel vangelo di Marco tale rinnegamento viene messo al terzo e ultimo posto, in quanto i primi due sono causati dall'insistenza della serva. In Giovanni invece il terzo rinnegamento avviene di fronte a un parente di quel Malco ch'egli aveva cercato di uccidere spaccandogli la testa con la spada (un gesto che s'era risolto con la mozzatura dell'orecchio). Ora, siccome Pietro, nel protovangelo del suo discepolo, vuole apparire disarmato (esattamente come Gesù), era impossibile inserire nella pericope l'ultimo testimone d'accusa, il quale ovviamente offriva la prova più schiacciante.87
Ma la differenza principale tra i due racconti non sta in questi particolari. In Giovanni il canto del gallo appare in maniera piuttosto casuale; sembra, più che altro, una semplice indicazione cronologica. Dal momento dell'arresto al momento in cui Gesù fu consegnato a Pilato probabilmente erano passate, stando al suo racconto, al massimo sei-sette ore. Quella dovette essere una notte molto concitata. In Marco invece il canto del gallo viene usato per mostrare che Gesù aveva una natura divina, in quanto l'autore gli aveva già fatto prevedere, mentre erano nel Getsemani, che il terzo rinnegamento sarebbe avvenuto in concomitanza del duplice canto del gallo (14,30).88
Di fronte a una preveggenza del genere89, Pietro non può che inchinarsi. Il peso del suo rinnegamento viene di molto ridimensionato, anzi viene usato come controprova della natura divina del Cristo, nei cui confronti ogni uomo non può che sentirsi colpevole, mancante di qualcosa. Cioè in Marco si ha la netta impressione che le testimonianze degli accusatori contro Pietro siano servite a quest'ultimo per dimostrare che Gesù era davvero il figlio di Dio.
III (Davanti a Pilato)
La pericope relativa al processo di Gesù davanti a Pilato (15,1 ss.)90 è una delle più complesse di tutto il vangelo marciano, in quanto, se in quella del processo davanti a Caifa l'autore ha voluto scaricare tutte le responsabilità della sua condanna a morte sul Sinedrio, ora deve fare in modo di ridurre il più possibile le responsabilità del funzionario romano, onde permettere ai cristiani, che seguono la teologia politica petro-paolina, di stabilire un compromesso istituzionale con gli imperatori e religioso col mondo pagano: sulla base del primo si riconosceva il valore politico all'autorità imperiale ma non quello religioso; sulla base del secondo ci si limitava a professare l'idea di un Dio fatto uomo che dopo morto era risorto, il cui regno veniva posto nei cieli.
Marco, alias Pietro, si deve cioè porre l'obiettivo di dimostrare che, se fosse dipeso da Pilato, Cristo non sarebbe stato condannato, ma siccome egli aveva a che fare con una popolazione molto difficile da gestire, e soprattutto con delle autorità giudaiche caparbiamente ostili a Gesù, si risolse ad accettare, per quieto vivere o per opportunismo politico, una decisione sgradita, che in altre situazioni non avrebbe mai preso, anche perché giuridicamente priva di alcun fondamento.
Marco vuol essere chiaro sin dall'inizio: la decisione di consegnare Gesù a Pilato fu presa, unanimemente, dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, dagli scribi e quindi da tutto il Sinedrio (15,1). Tutti costoro tennero consiglio, legarono Gesù e lo consegnarono a Pilato. Più antisemita di così Marco non potrebbe essere: si ha addirittura l'impressione ch'egli parli di una seconda seduta del Sinedrio, il quale però - stando all'evangelista - non aveva il potere di emettere sentenze di morte. Basterebbe questo per capire come il racconto andrà a finire.
Forse le cose sarebbero potute andare diversamente se non vi fosse stata unanimità negli intenti, ma, viste queste premesse, come potrà Pilato non dare soddisfazione alle loro richieste? Potrà rischiare di compromettere il proprio potere per i diritti di un solo uomo, privo peraltro della cittadinanza romana?
Le autorità giudaiche lo accusavano di molte cose - dice Marco, senza però precisarle -, ma soprattutto di una, l'unica che a Pilato sarebbe dovuta interessare più di ogni altra: Gesù pretendeva di essere o di diventare il Re dei Giudei. Lo stesso Pilato glielo chiede per avere la conferma e Gesù, laconico, risponde: "Tu lo dici" (v. 2). Una risposta ambigua, che poteva voler dire anche il contrario, e cioè: "Lo dici tu, non io". Oppure poteva voler dire: "Dipende cosa intendi. Affinché ti possa rispondere, devi prima spiegare il significato delle parole che usi". Quelle tre parole sono le uniche che Gesù dice in tutta la pericope. Marco infatti scrive che Pilato si meravigliava del suo silenzio (v. 5).91 Avendo come suo compito anche quello di giudicare, non era abituato a vedere l'accusato rinunciare alla difesa.
Perché Marco non lo fa parlare? Il motivo è molto semplice: Gesù è già stato condannato a morte e ha già accettato supinamente il verdetto al fine di adempiere alla volontà del Padre. Infatti aveva detto: "Vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza, venire sulle nubi del cielo" (14,62). Qualunque altra cosa dica a Pilato sarebbe inutile; anzi, dal punto di vista redazionale si rischierebbe di mettere in difficoltà il procuratore, nei confronti del quale è sufficiente dire che "i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia" (v. 10), cioè senza una vera motivazione politica, ma solo per ragioni di tipo teologico (o clericale), che a un procuratore romano non avrebbero dovuto interessare, se non molto indirettamente, per i risvolti politici che potevano avere.
Ma qui quali risvolti politici potevano esserci? Pilato sa già che glielo avevano consegnato per "invidia", al punto che deve chiedere conferma a Gesù se davvero egli si qualifichi come "re d'Israele". Le due cose però - a ben guardare - non stanno molto in piedi: se Pilato era convinto che gliel'avessero consegnato per "invidia", cioè per questioni meramente religiose, non poteva non sapere che l'accusa politica di voler diventare "re dei Giudei" era falsa, o comunque andava interpretata in maniera simbolica, tale per cui il dominio di Roma non avrebbe avuto alcun motivo per sentirsi minacciato: un "re-filosofo o teologo", capace di belle parole, di un sano comportamento etico, privo di spada o di organizzazione politica, che paura avrebbe mai potuto fare alle legioni romane?
Il Pilato di Marco è più che convinto dell'innocenza politica di Gesù; anzi forse lo vorrebbe come alleato contro le stesse autorità giudaiche, che in quel momento fanno mostra, per convenienza, di stare dalla parte di Cesare, ma che in altri momenti tramano contro. Quando propone lo scambio tra lui e Barabba, egli è convinto - stando alla ricostruzione marciana - che la popolazione avrebbe chiesto di liberare Gesù, proprio perché egli lo riteneva innocente.
Al v. 6 viene detto che ad ogni festa di Pasqua "Pilato liberava loro un carcerato, quello che la folla domandava". Di tale usanza non si sa nulla in altre fonti. Il versetto però resta importante, poiché per la prima volta Marco chiama in causa anche la "folla" di Gerusalemme, ch'egli vuole considerare compartecipe, anzi corresponsabile della condanna a morte di Gesù, a dispetto dell'ingresso trionfale nella capitale.
È probabile che l'usanza di liberare qualcuno durante la Pasqua non sia vera, ma ciò non esclude che Pilato sia ricorso a tale stratagemma per far ricadere sulla popolazione, e non su di sé, la decisione di condannare Gesù. Barabba (il cui nome, come noto, non ha alcun significato, in quanto vuol semplicemente dire "figlio del padre") non era uno qualunque. Marco lo descrive così: "Vi era allora in prigione un tale, chiamato Barabba, insieme ad alcuni ribelli [rivoltosi], i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta [sommossa o sedizione]" (v. 7). Si tratta, senza dubbio, di un prigioniero politico (patriota, zelota, sicario o terrorista non importa).
Marco lascia capire che Pilato propone lo scambio dei due detenuti nella convinzione che la folla avrebbe chiesto la liberazione di quello ritenuto più popolare o più innocente. Cioè, secondo l'evangelista, Pilato approfitta della richiesta di un'amnistia da parte della folla per proporre la grazia a favore di Gesù, sgusciando così da un caso scottante; senonché la sua manovra verrà sventata dai sommi sacerdoti (v. 11).
Nella realtà deve essere accaduto proprio il contrario: conoscendo la popolarità di Gesù e l'intenzione di fare un'insurrezione armata contro Roma e il Tempio, Pilato deve aver proposto di liberare uno che riteneva meno pericoloso e che sicuramente avrebbe potuto arrestare di nuovo. Sa bene che quello che ha messo in piedi è un processo politico e non giuridico e che se, da un lato, è per lui troppo rischioso lasciar libero uno come Gesù; dall'altro non può assumersi l'intera responsabilità di farlo fuori senza un consenso popolare. Per decidere di mandare al patibolo Barabba e i suoi complici non aveva avuto bisogno di ricorrere a questo escamotage. Questo però fa pensare che tra lui e Caifa doveva esserci un accordo preliminare, altrimenti non si spiega la presenza della coorte romana (Gv 18,3) nel Getsemani al momento della cattura.
Marco però vuol salvare la faccia a Pilato. Sin dall'inizio ha voluto far vedere ch'egli non sapeva nulla di Gesù e che quindi non aveva motivo di perseguirlo, di accusarlo di qualcosa. Il verdetto finale però non può prenderlo né da solo né con l'avallo delle autorità. Non vuol rischiare che scoppi un tumulto in quei giorni di grande affluenza di persone nella capitale. Ha bisogno di un ampio consenso popolare. E qui ci si chiede: dov'era il movimento nazareno? Dov'era la folla che aveva osannato Gesù con i rami d'ulivo in mano e coi mantelli stesi per terra mentre lui faceva il suo ingresso trionfale? Sembra che tutti i seguaci si siano volatilizzati. Eppure nel vangelo di Giovanni è scritto che a Pilato non bastò affatto lo scambio di prigionieri: dovette provvedere anche alla fustigazione prima di decidersi per la condanna a morte.
Qui invece la fustigazione viene data come se fosse una procedura inerente alla crocifissione. Ma non era affatto così. Di regola le due cose erano in alternativa, e comunque mai si riduceva un condannato quasi a morire, avendogli dato più di 120 colpi sul nudo corpo, prima di crocifiggerlo. Pilato usò la flagellazione come seconda arma dopo lo scambio di Gesù con Barabba. Peraltro, se davvero lo riteneva innocente, gli avrebbe risparmiato la fustigazione e non avrebbe permesso gli atteggiamenti di scherno da parte dei militari.92 Una volta ridotto in uno stato pietoso, difficilmente chi aveva creduto in lui, ne avrebbe chiesta la liberazione. Quindi è del tutto fuori luogo l'idea che Pilato, convinto dell'inconsistenza delle accuse a carico dell'imputato, s'illuse di accontentare con la fustigazione quanti chiedevano a gran voce per Gesù una punizione esemplare, proprio al fine di risparmiargli la condanna capitale.
In Marco il versetto decisivo è l'11: "I capi dei sacerdoti incitarono [istigarono] la folla a chiedere che liberasse Barabba". Cioè riescono a convincere la folla che Barabba offriva maggiori garanzie di Gesù contro Roma. Questo, tutto sommato, è abbastanza realistico. La popolazione sa bene che le autorità giudaiche (non tutte, ovviamente, ma una larga parte) sono colluse con Roma; essa può anche aver pensato, per un momento, che Gesù fosse in grado di compiere qualcosa di risolutivo contro Roma e il Sinedrio. Tuttavia, vedendo ch'egli non aveva intenzione di compiere un veloce colpo di stato, bensì una ponderata rivoluzione di popolo, può anche averlo ritenuto meno efficace di Barabba, che aveva avuto il coraggio di eliminare un romano e che forse aveva fatto altre cose eversive. Di qui l'autoinganno, indotto dalla prepotenza dei sacerdoti. "Se loro stessi sono convinti che per combattere Roma ci vogliono degli omicidi, forse significa che stanno cambiando atteggiamento: dunque perché non dar loro fiducia?" - così può aver pensato la folla, che spesso ragiona in maniera istintiva, sottovalutando le conseguenze delle proprie decisioni.
Nel momento stesso in cui la folla chiede di liberare Barabba, il gioco è fatto. A Pilato Marco fa fare la parte del "buonista", del giudice imparziale. "Che farò dunque di colui che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Crocifiggilo! Pilato disse loro: Ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: Crocifiggilo!" (vv. 12-14).93
Perché questa pantomima? Semplicemente perché se avesse liberato Barabba, non sarebbe stato obbligato a crocifiggere Gesù. Visto che lo considerava innocente in tutto e per tutto, poteva sanzionarlo con una punizione meno cruenta. I Romani non negavano mai la possibilità di un ravvedimento a un uomo accusato di qualcosa e comunque sapevano distinguere, loro ch'erano maestri del diritto, tra reato e reato.
Ma perché la folla non si accontenta della liberazione di Barabba? Anche qui il motivo è molto semplice: con i suoi metodi democratici Gesù non offriva garanzie di successo. Risultato di questa concezione della politica basata più sulla forza che sul consenso libero, spontaneo e ragionato? La catastrofe d'Israele. Lui che chiedeva un'adesione di massa al suo progetto di liberazione, lo aveva ottenuto contro se stesso, ma chi ci aveva rimesso di più? Riuscirà la popolazione a liberarsi dei Romani grazie a Barabba e alle autorità che l'avevano sostenuto? No. Riuscirà a farlo grazie alla nuova rivolta scoppiata nel 66? Neppure. E in quella scoppiata nel 132? Meno ancora. Eliminando Gesù si erano autocondannati alla sconfitta.
E il movimento nazareno? gli apostoli? che fine avevano fatto? Qui è l'ironia della storia che ha la meglio. In questa pericope l'antisemitismo è molto forte, soprattutto là dove non si fa alcuna distinzione tra i capi politico-religiosi e neppure tra i partiti e i movimenti popolari. Marco, alias Pietro, è terribile nel condannare, senza appello, tutti i Giudei. Al massimo avrebbe perdonato Pilato se questi avesse ammesso d'essersi comportato meschinamente, d'aver agito per viltà.
E tuttavia, quando vedrà la tomba vuota, cosa penserà Pietro? Davvero Gesù doveva essere liberato? Se la tomba è vuota, allora vuol dire ch'era risorto; ma se è risorto, era una specie di dio, che avrebbe anche potuto non morire; quindi egli ha "voluto" morire, ma se ha voluto così, perché dobbiamo preoccuparci di fare l'insurrezione armata?
IV (La crocifissione)
La pericope sulla crocifissione (15,21 ss.), pur essendo molto lunga, rispetto agli standard di Marco, non contiene affermazioni molto significative. Il picco dell'intensità è già stato raggiunto col processo davanti a Pilato. Nella descrizione dei singoli episodi si nota una certa freddezza, un certo distacco. Marco sembra non voler concedere nulla all'emotività, al patetismo. Semmai concede molto all'immaginazione e s'inventa cose inverosimili.
Al v. 21 non spiega il motivo (la spossatezza a causa della fustigazione) per cui Gesù non aveva le forze per portare sino al Golgota il patibulum cui il picchetto dei militari l'aveva legato. Di qui la necessità di prendere un uomo a caso che passava di lì per aiutarlo. Strano che Marco ne riporti il nome, Simone di Cirene, e che sia anche in grado di dire ch'era padre di Alessandro e di Rufo: dettagli del tutto insignificanti nel contesto. È probabile che costoro siano diventati cristiani e forse dovevano essere conosciuti dalla comunità di Roma. Un certo Rufo viene citato in Rm 16,13, ma non si sa se sia la stessa persona. Forse tutti questi nomi sono stati messi in chiave polemica, perché più vicini al mondo pagano che giudaico: Cirene è una città della costa nord-africana (Cirenaica), anche se quel Simone doveva essere un ebreo.94
Al v. 23 Marco dice che, prima di crocifiggere Gesù, gli offrirono del vino mescolato con mirra, per intontirlo, ma non ne prese. Questo vino drogato, in genere, le donne lo davano ai condannati a morte per lenire i dolori del supplizio, ma evidentemente Gesù voleva essere cosciente sino all'ultimo, tant'è che nella ricostruzione del quarto vangelo poté pronunciare ancora delle parole significative.
Al v. 24 viene detto che il picchetto dei militari si divise le sue vesti95, ma Giovanni aggiunge che, siccome la tunica era senza cuciture, se la giocarono ai dadi. Stando alla Sindone, Gesù fu inchiodato ch'era completamente nudo.
Ai vv. 25 e 34 vengono riportate l'ora dell'impalamento e quella del decesso: un tempo molto breve, spiegabile solo in considerazione del fatto che con la flagellazione, i chiodi nei polsi e nei piedi, la corona di spine sul capo, Gesù doveva aver perso molto sangue. Lo si voleva morto ad ogni costo.
Al v. 26 viene riportata l'iscrizione indicante il motivo della condanna, appesa in cima allo stipes: "Il re dei Giudei". Essa era in tre lingue (latino, greco e aramaico) - dice il vangelo di Giovanni, il quale aggiunge anche la scritta: "Gesù Nazareno". Lo stesso Giovanni precisa inoltre che le autorità giudaiche volevano che Pilato facesse scrivere non "Il re dei Giudei", bensì "Io sono il re dei Giudei". Pilato però si rifiutò di cambiare l'iscrizione: cosa che, d'altra parte, non gli sarebbe convenuto. Strano che Marco non riporti questi dettagli: ciò fa pensare che Pietro non fosse presente al momento dell'esecuzione, e che poté raccontare qualcosa a Marco sulla base di ciò che le donne avevano visto (Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il Minore e di Ioses, e Salome, che forse era la madre dei fratelli Zebedeo).
Al v. 27 viene detto che con lui impalarono anche due "briganti", cioè due patrioti, probabilmente i compagni zeloti di Barabba, dei quali non si dice che furono frustati o che subirono un trattamento analogo a quello di Gesù, tant'è che per farli morire in fretta, a causa della festività pasquale, e seppellirli in una fossa comune, dovettero spezzar loro le gambe. Alcune traduzioni riportano la parola "ladroni", che sicuramente però non ha senso in rapporto alla crocifissione. Di sicuro comunque chi ha aggiunto il v. 28, omesso dai migliori codici ("Fu annoverato tra gli iniqui"), ha usato la parola greca anomos (senza legge) in chiave etica, non politica, pensando di poter fare, maldestramente, un collegamento con Is 53,12, ove si parla di "malfattori" nel senso di "criminali".
Si noti, peraltro, come tutto il cap. 53 di Isaia contenga già, in nuce, la teologia petro-paolina relativa all'idea di un servo sofferente, che non oppone resistenza ai maltrattamenti subiti e che dà la propria vita in riscatto per molti, prendendosi le colpe degli altri. I cristiani hanno semplicemente aggiunto che tale servo era di natura divina, per cui il sacrificio, che avrebbe tranquillamente potuto evitare, redime l'umanità intera e non solo la popolazione d'Israele. Questo per dire che la teologia petro-paolina è soltanto una sintesi religiosa tra paganesimo ed ebraismo.
A partire dal v. 29 fino al 39 Marco dà sfogo al proprio antisemitismo e scrive cose del tutto inventate, delle quali neppure una viene riportata nel vangelo di Giovanni, che pur nei confronti dei Giudei è sempre molto duro.
Solo al v. 40 farà capire che la fonte di tutto ciò che ha scritto dal v. 29 al 39 era costituita dalla testimonianza di varie donne, i cui nomi sono già stati detti in precedenza, più molte altre ch'erano salite con lui a Gerusalemme: esse "lo seguivano e lo servivano da quando egli era in Galilea". Un cospicuo numero di donne, di cui nel vangelo marciano si sa poco e nulla.
Stando dunque a quella decina di versetti assurdi, molti Giudei (tra cui i capi dei sacerdoti con gli scribi) avrebbero continuato a schernire Gesù anche ai piedi della croce, invitandolo a scendere per dimostrare ch'era davvero messia e re d'Israele. Lo insultavano tutti, inclusi i due zeloti al suo fianco.
Alle tre del pomeriggio Gesù grida a gran voce una frase in aramaico: "Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" (v. 34). È la citazione del Salmo 21,2, dove però si parla di Dio non di Elia. Quindi non si capisce perché Marco faccia dire alle persone lì presenti: "Chiama Elia!", "Aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere" (vv. 35-36). Elia o Dio avrebbe dovuto toglierlo dalla croce? Chi pronuncia queste frasi? Sembra la stessa persona che gli dà da bere con una spugna posta in cima a una canna, ma questa persona, nel vangelo di Giovanni, era uno dei soldati romani, che sicuramente non aveva capito l'aramaico di Gesù e che, se anche l'avesse capito, non avrebbe potuto intendere il significato di quella frase, anche perché a nessuno sarebbe potuto venire in mente che qualcuno dal cielo poteva scendere per liberarlo.
Marco ha voluto caricare la morte di Gesù di un indegno pathos antisemitico. Parla di "tenebre" minacciose su tutta la nazione da mezzogiorno alle tre; fa dire al centurione romano una frase che per lui non avrebbe potuto avere alcun senso e che però nel suo vangelo fa da spartiacque tra cristianesimo di origine galilaico-pagana e giudaismo: "Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!" (v. 39); infine s'inventa una frase simbolica con cui legittima la fine del primato storico d'Israele nel proprio rapporto con la divinità: "Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo" (v. 38). Era la tenda che separava l'area esterna da quella interna del Santo dei Santi (Es 26,31 s.).
Da notare che Marco non cita mai, tra le donne, la madre di Gesù, come invece fa Giovanni, il quale ricorda anche Maria di Cleopa, sorella della madre di Gesù, anche se stranamente non cita Salome, che – stando a Matteo – era la sua stessa madre.
Giovanni peraltro fa dire a Gesù una frase che è stata oggetto di varie interpretazioni esegetiche: "Donna, ecco tuo figlio!" (19,26). E da quel momento l'apostolo Giovanni "la prese in casa sua" (v. 27). La stranezza sta nel fatto che Maria, pur essendo evidentemente già vedova, aveva non pochi figli che potevano assisterla nella sua vecchiaia. Dunque Gesù aveva scelto Giovanni perché era celibe? O perché era il suo discepolo prediletto? Ma allora ai piedi della croce vi era anche Giovanni? Uno degli apostoli che avrebbe dovuto compiere l'insurrezione armata? A fianco di tutti i sacerdoti e degli scribi che schernivano Gesù?
A dir il vero nel quarto vangelo non risulta la presenza di tutte queste persone ciniche e volgari ai piedi della croce. Non viene neppure detto che i due zeloti insultavano Gesù. Semmai viene detta una cosa che potrebbe anche essere interpretata in maniera sconcertante. Se Gesù decise di affidare la madre a Giovanni, chi avrebbe dovuto sostituirlo nella guida del movimento nazareno? Chi avrebbe dovuto proseguire la strategia dell'insurrezione armata? Pietro o Giovanni? Come mai nel quarto vangelo (21,15 ss.) il Gesù risorto deve chiedere per ben tre volte a Pietro se lo amava davvero?
(torna su) - (Sulla figura di Barabba vedi anche questo testo)La pericope marciana sulla sepoltura di Gesù (15,42 ss.) appare, stranamente, più realistica di quella di Giovanni. In entrambi i vangeli l'artefice ne fu Giuseppe di Arimatea, "illustre membro del Consiglio [cioè del Tribunale ebraico o Sinedrio], anche lui in attesa del regno di Dio" (v. 43). Giovanni però aggiunge ch'era un discepolo occulto di Gesù, in quanto temeva i Giudei (19,38). È comunque la prima volta che Marco ammette che tra i membri del Sinedrio vi era almeno una voce discorde.
Perché Giuseppe chiede il corpo di Gesù a Pilato? Perché in occasione della Pasqua non si potevano tenere dei crocifissi intorno a Gerusalemme. Che Giuseppe abbia preso l'iniziativa spontaneamente o che sia stato mandato dal Sinedrio, è irrilevante. Marco lo definisce un uomo "coraggioso", in quanto Pilato avrebbe potuto sospettare anche di lui. Il che fa pensare che avesse agito autonomamente. Giovanni però evita di qualificarlo così, sia perché l'aveva già definito "discepolo occulto" (come Nicodemo), sia perché Pilato non avrebbe avuto motivo di non concedergli la salma (non era certo il tipo da temere un culto post-mortem). Infatti si limitò a sincerarsi, attraverso il centurione, che Gesù fosse morto davvero e si meravigliò che ci avesse messo così poco tempo (generalmente infatti occorrevano un paio di giorni). Giovanni spiega che uno dei soldati, per verificare l'effettivo decesso, gli penetrò nel costato la punta di una lancia (19,34). Racconta questo come se l'avesse visto di persona, e la Sindone ha confermato le sue parole.
Nel racconto di Giovanni è stato aggiunto il v. 20,39, ove si parla di Nicodemo, altro membro del Sinedrio, che avrebbe contribuito a seppellire Gesù con "una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre". Il versetto è stato interpolato per far vedere che tra le autorità giudaiche che stimavano Gesù e che probabilmente diventarono cristiane o filo-cristiane, dopo la sua morte, non vi era solo Giuseppe d'Arimatea.
Qui il racconto giovanneo ha subìto varie manipolazioni. Già è assurda una mistura di profumi così spropositata: circa 32,7 chili! Ma è del tutto inventata anche l'inumazione con gli oli previsti per le sepolture di rito e i "panni di lino con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i Giudei" (19,40). Non perché queste cose non si usassero, ma perché la sepoltura fu molto affrettata, in quanto non si voleva trasgredire il precetto che impediva il contatto coi cadaveri nell'imminenza della Pasqua: una sepoltura regolare avrebbe richiesto varie ore, e in quel momento, secondo il computo ebraico di contarle, stava arrivando il sabato. Questa cosa è ampiamente confermata da Giovanni in altri passi. Piuttosto appare abbastanza singolare vedere questi personaggi ebraici, amici o discepoli del Cristo, che si preoccupano di rispettare le formalità della legge giudaica davanti alla salma di un condannato a morte che avrebbe potuto liberarli dall'oppressione romana.
Ma proseguiamo. Marco scrive che Giuseppe "comprò un lenzuolo" in cui avvolse il corpo di Gesù, che depose "in una tomba scavata nella roccia; poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro" (15,46). Il sepolcro doveva essere suo, perché costoso e mai utilizzato; il lenzuolo invece dovette comprarlo e, stando alla Sindone, era proprio uno di quelli che si usava per avvolgere i cadaveri. Tutta l'operazione, dallo schiodamento alla sepoltura, avrà richiesto un paio d'ore. Il corpo non era stato minimamente lavato e il lenzuolo, che lo avvolgeva completamente, era stato fissato con dei legacci o fasce.
Marco conclude la pericope dicendo che "Maria Maddalena e Maria madre di Joses stavano a guardare il luogo dov'era stato messo" (v. 47). Il motivo viene spiegato più avanti: avevano intenzione di completare la sepoltura il giorno dopo. Nel vangelo di Giovanni i versetti riguardanti Nicodemo e la regolarità della sepoltura, secondo la prassi giudaica, sono stati messi da qualcuno che si dovette scandalizzare per la fretta con cui lo si era inumato. E doveva anche aver capito che non aveva alcun senso, come viene scritto nei Sinottici, mandare le donne da sole a completare la sepoltura con oli profumati quando quella pietra pesante che ostruiva l'ingresso non sarebbero mai riuscite a spostarla.
(torna su)16) La scomparsa del corpo (fonti)
Il finale del vangelo di Marco ha un che di comico. Anzitutto non si spiega perché le donne abbiano comprato gli aromi "passato il sabato" (16,1) e poi abbiano deciso di usarli il giorno dopo. Il sabato finiva di pomeriggio, alle 18, cioè al calar del sole: non avevano bisogno di aspettare un'altra mezza giornata. Invece così è passata alla tradizione cristiana l'assurda idea, perché indimostrata, secondo cui Gesù è risorto dopo tre giorni, quando in realtà - se ciò fosse vero - avrebbe potuto farlo lo stesso venerdì notte (che per gli ebrei era già sabato). Peraltro nella Sindone non vi è alcuna traccia di decomposizione del cadavere, e dopo tre giorni qualcosa avrebbe anche potuto esserci, soprattutto in un corpo grondante di sangue. E comunque le profezie fatte dire a Gesù, che parlano di tre giorni si smentiscono da sole, visto che lo stesso Marco (15,42) indica ch'egli morì di venerdì pomeriggio e che le donne trovarono il sepolcro vuoto il giorno dopo del sabato, senza poter ovviamente sapere il momento preciso in cui era stato aperto.96
Alle donne viene proibito di far qualcosa di sabato (incluso l'acquisto dei profumi), nonostante che il Cristo - stando al vangelo di Marco - non l'avesse mai rispettato quando faceva le proprie guarigioni. E vengono mandate a fare una cosa che non avrebbero mai potuto fare senza l'aiuto degli uomini. Lo stesso Marco se ne rende conto ed è costretto a farle dire: "Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro?" (16,3). Questa è una situazione che presenta aspetti tragicomici. Peraltro le donne non inumavano cadaveri di sesso maschile e meno che mai sarebbero potute entrare in quella tomba senza la presenza del legittimo proprietario. È dunque evidente che la comunità cristiana si è vergognata di non aver potuto procedere a una sepoltura regolare per timore delle regole giudaiche.
Il quarto vangelo evita queste amenità, e non perché la sepoltura fosse stata regolare, quanto perché la tomba vuota fu scoperta casualmente dalla Maddalena e da un'altra donna di cui non viene riportato il nome, ma probabilmente era Maria di Cleopa. Giovanni non spiega perché fossero andate là (curiosità femminile? la Maddalena aveva un debole per Gesù?), ma di sicuro in questo vangelo non si comportano come se in città non fosse presente alcun discepolo di Gesù; anzi, dopo aver visto che il corpo di Gesù era scomparso, si recano subito da Pietro e Giovanni per avvisarli.
Vediamo ora il racconto di Marco, che, al solito, deve presentare le cose con dei particolari mistici. Le donne constatano che la pietra era già rotolata. "Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate" (16,5). E quello, in tutta tranquillità, le rassicura dicendo: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto97, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro ch'egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura" (vv. 5-8). E qui finisce il protovangelo, restando in linea con la precedente comicità!
Il giovanotto etereo parla come se la resurrezione di un cadavere fosse la cosa più naturale di questo mondo. Si permette persino di prendere in giro le donne con delle domande che, secondo lui, dovrebbero apparire retoriche: "Perché tremate?". Cioè "Non lo sapevate che doveva risorgere? Non ve l'aveva forse detto più volte?".
Quando poi dice: "Egli vi precede in Galilea; lì lo vedrete, come vi ha detto", occorre andare al v. 14,28 per capire il significato di questa frase, dove appunto è scritto: "Dopo che sarò resuscitato, vi precederò in Galilea". Dalla quale Galilea però non avrebbero ricominciato con l'idea di liberazione politico-nazionale, ma con quella di redenzione teologico-universale, anteponendo nettamente la Galilea alla Giudea e poi, dopo il 70, il mondo romano all'intera Palestina.
La resurrezione, in Marco, viene fatta passare per una cosa naturalissima, che solo per la loro poca fede le donne non avevano capito. Cioè Gesù non è risorto perché le donne hanno trovato la tomba vuota (nella pericope Pietro non va neppure a verificare di persona), ma è risorto perché era "Figlio di Dio", era di natura divino-umana. Le donne possono anche non aver raccontato nulla a nessuno, ma per un discepolo credente non c'è bisogno di constatare che la tomba è vuota.
Siamo nella più pura fantascienza. A questo punto vien quasi voglia di porsi alcune domande che qualche credente potrà giudicare impertinenti, o qualche esegeta laico assai poco razionali: 1) sicuro che il corpo non sia stato trafugato da Pietro per far credere al movimento nazareno ch'era risorto? 2) Sicuro che non sia stato trafugato dai Giudei per impedire che quella tomba venisse trasformata in un luogo di culto in una città ove era ammessa una sola religione?98
Soprattutto però ci si dovrebbe porre un'altra domanda: se il corpo fosse rimasto nella tomba, si sarebbe fatta l'insurrezione? Se proprio Gesù doveva "risorgere", perché dotato di qualche aspetto a noi sconosciuto, non poteva aspettare che i discepoli facessero prima l'insurrezione armata? O forse non ha potuto aspettare perché il corpo si sarebbe putrefatto e a lui premeva conservarlo il più possibile integro? E poi perché risorgere facendo vedere di aver bisogno di aprire la porta dell'ingresso? Un corpo risorto non è in grado di attraversare i muri? Ma perché non portarsi via anche la Sindone? Perché era un oggetto materiale? Su quest'ultima domanda possiamo ipotizzare una risposta che farà sussultare sia gli atei che i credenti: quello è l'unico vero memoriale del Cristo, l'unico vero documento di tutto il Nuovo Testamento, l'unico in grado di smentire, con sicurezza, le falsità dei vangeli.
Nel vangelo di Giovanni la Maddalena e l'altra donna sono convinte che il corpo di Gesù sia stato trafugato da qualcuno. Pietro e Giovanni corrono a vedere coi loro occhi se quanto dicono è vero. Appena entrati dentro, trovano per terra i legacci che tenevano unito il lenzuolo funebre, mentre questo era ripiegato da una parte. Entrambi non possono non essersi chiesti che senso avesse trafugare un cadavere nudo senza lasciarlo avvolto nel suo lenzuolo. Poi, aprendo quest'ultimo, si saranno accorti che conteneva un'immagine poco chiara, in senso fisico-materiale, e anche poco comprensibile sul piano logico.
Si saranno guardati in faccia e cosa si saranno detti? Basta un po' di fantasia per immaginarlo: Giovanni avrà detto che lì dentro era successo qualcosa di strano; Pietro invece azzardò una propria lettura dei fatti: se il cadavere non è stato trafugato da nessuno, allora è risorto, e se è risorto, è meglio aspettare che Gesù ritorni, perché sicuramente lo farà in maniera trionfale. Siccome poi, tra gli Undici, passò la linea di Pietro, si rinunciò a compiere l'insurrezione armata e si aspettò invano il ritorno di Gesù, almeno finché non arrivò Paolo di Tarso, il quale cominciò a dire che la parusia sarebbe avvenuta il giorno del giudizio universale, cioè alla fine dei tempi e della storia. Ecco che poi Pietro dirà, nella sua seconda lettera, in maniera piuttosto sconsolata: "Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro..." (3,8 ss.).
*
Insomma è netta l'impressione che sia Marco che Pietro non credessero più in una parusia imminente del Cristo ben prima della stesura di questo vangelo.
Con la sua sconcertante conclusione l'evangelista è come se avesse detto che, siccome le donne non raccontarono niente a nessuno, gli apostoli continuarono ad attendere Gesù a Gerusalemme, senza capire che lui era tornato in Galilea e che non aveva intenzione di compiere alcuna insurrezione antiromana, in quanto - si può presumere dai toni antisemitici del testo - i Giudei non se la meritavano. Tant'è che se davvero l'avesse voluta fare, il giovane nel sepolcro avrebbe dovuto dire che li aspettava a Betania o nel Cenacolo o sul Getsemani.
Far credere ch'era tornato in Galilea, cosa voleva dire? Che avrebbero fatto l'insurrezione senza i Giudei? O che non l'avrebbero fatta per niente? Se il vangelo non fosse stato una "biografia", si poteva pensare alla prima soluzione. Senonché il compito del secondo finale è stato appunto quello di chiarire che dovevano rinunciare definitivamente all'idea di parusia immediata e trionfale.
Altra cosa davvero curiosa è che Marco addebita alla paura delle donne il motivo per cui non hanno potuto rivederlo in Galilea. Che senso ha una conclusione del genere? Sembra addirittura che Marco consideri la scoperta della tomba vuota del tutto irrilevante ai fini della fede nella resurrezione. Infatti le donne non l'acquisiscono. Sicché non sarà per merito loro che Pietro e gli altri apostoli l'acquisiranno.
Tuttavia, se questo è vero, bisogna dire che in questo vangelo è presente un kerygma di molto anteriore alla sua stesura, e probabilmente era tutto di derivazione paolina. Paolo infatti non è per nulla interessato alla tomba vuota: per lui Gesù doveva risorgere per riconciliare Dio con una umanità votata al male in seguito al peccato originale; nel senso che se non ci fosse stato il sacrificio del Figlio, l'umanità sarebbe stata abbandonata se stessa e si sarebbe autodistrutta o l'avrebbe annientata lo stesso Dio come ai tempi di Noè.
Tale vangelo, quindi, non vuole affatto dare la speranza di una parusia, ma è stato scritto proprio perché la speranza era andata delusa. È stato scritto su un morto che non ritorna. Esprime una delusione cocente, in quanto l'idea (petrina) che la resurrezione andasse collegata con la parusia, si era rivelata completamente sbagliata. Chi ha redatto questa amara conclusione, relativa a una sconfitta politica, non aveva neppure in mente l'idea consolatoria di ascensione, che infatti appare nel secondo finale, inserito dopo la catastrofe del 70: con questa idea si razionalizza, una volta per tutte, il motivo per cui non va compiuta alcuna insurrezione.
Questo finale posticcio sembra essere preso dal IV vangelo, salvo il fatto che viene ricordato che la Maddalena era un'ex-indemoniata. Il che fa pensare a una certa rivalità tra la teologia petro-paolina e la posizione della Maddalena, probabilmente più vicina a quella giovannea.
Vi sono inoltre riferimenti alla pericope lucana sui discepoli di Emmaus: sia questi che la donna avvisano gli apostoli che Gesù era risorto, e anche se quelli, inizialmente, non vogliono crederci, alla fine si rassegnano. Attenzione però: non è che non volessero credere all'idea di resurrezione (come insinua il testo), ma è che non volevano accettare l'idea di dover rinunciare ad associare la resurrezione alla parusia.
Cioè mentre nel primo finale essi, rimasti delusi per la mancata parusia, avevano deciso di abbandonare Israele a se stessa; nel secondo finale invece si convincono d'aver creduto per troppo tempo a un'idea sbagliata. La concezione teologico-politica del Cristo doveva essere superata da una meramente teologica.
Infatti il Cristo in persona comunica loro un nuovo messaggio, quello di andare a predicare al mondo che lui ha vinto la morte. Israele è perduta per sempre, ma il regno di Dio può essere anticipato attraverso le guarigioni, gli esorcismi e i miracoli.
(torna su)16.1) Post scriptum 1
È curioso notare come le due donne (Maria di Màgdala e Salome) che si trovano al sepolcro vuoto del Cristo siano le stesse che nel cosiddetto "Vangelo segreto di Marco", ritrovato nel 1958 dallo studioso Morton Smith, vengono incontrate da Gesù a Betania (in Perea, non quella nei pressi di Gerusalemme)99, dove lui compie, controvoglia, la resurrezione di Lazzaro. Con questa differenza, che al sepolcro era presente anche Maria madre di Giacomo il Minore, mentre nel vangelo "segreto" a Betania la terza donna presente è la madre di Gesù (che però in Mc 6,3 viene definita madre di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone, fratelli di Gesù).
Marco le presenta, in questo vangelo segreto, in maniera, come al solito, mistificata, in quanto le fa apparire come avversarie di Gesù. Esse attendevano un messia davidico, cioè vincente, e in questo si sentivano tradite dall'immagine di messia sofferente che Gesù voleva dare di sé. Poi però si pentono di non averlo capito e decidono di seguirlo nell'ingresso trionfale a Gerusalemme. È quindi probabile che nella realtà esse furono incontrate da Gesù proprio per ricevere disposizioni su come organizzare il suddetto ingresso.
Nel vangelo definitivo di Marco, se quello "segreto" è autentico, non appaiono a Gerico (o a Betania) perché probabilmente la mistificazione non era stata sufficientemente credibile. Il fatto stesso che alla fine del vangelo vengano presentate come tre sciocche intenzionate a fare una cosa che non avrebbero potuto fare in alcun modo senza l'aiuto degli uomini, cioè aprire il sepolcro; e il fatto che quando lo trovano aperto dimostrino di non aver fede nell'idea di resurrezione, fa sospettare che tra loro e Pietro vi fossero opposte concezioni politiche.
D'altra parte anche nel vangelo di Giovanni Maria Maddalena, che delle tre donne doveva essere la più importante, viene fatta passare per una che non credeva nell'idea di resurrezione, bensì in quella di "trafugamento del cadavere". L'incontro con Gesù, scambiato per l'"ortolano", va probabilmente interpretato come una forma di rassegnazione da parte della donna nei confronti dell'idea dominante della resurrezione, che escludeva quella di insurrezione nazionale.
Peraltro, sempre nella suddetta versione "segreta" di Marco, la Maddalena e Maria di Betania, sorella di Lazzaro, coincidono chiaramente, mentre Lazzaro viene definito "il discepolo che Gesù amava" per impedire che tale definizione potesse essere applicata all'apostolo Giovanni.
Inutile qui ricordare che Maria di Betania e la prostituta di Lc 7,37 ss. compiono la stessa azione (ungere Gesù con olio profumato); e che, sempre secondo Lc 8,2, la Maddalena, che pur finanziava i Dodici, insieme a Susanna e Giovanna, fu esorcizzata da Gesù perché posseduta da sette demoni. Un qualche problema di incompatibilità tra la teologia petro-paolina e le idee politiche di queste donne doveva senz'altro esserci.
(torna su)16.2) Post scriptum 2
I suddetti “tre giorni” di sepoltura, canonici per la Chiesa cristiana, sono del tutto inventati. Basta leggersi Giovanni per capirlo.
Gv 19,42: Seppellirono Gesù in tutta fretta il venerdì pomeriggio, che secondo il computo ebraico diventava già sabato dopo le 18.
Gv 20,1: Il giorno dopo (poi qualcuno ha precisato: “il giorno dopo del sabato”, facendo credere che questo giorno fosse “domenica”, secondo il modo latino di contare le ore e i giorni), Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Cioè Maria, in realtà, si era recata al sepolcro non la domenica mattina, ma il sabato mattina, quando ancora era buio, poche ore dopo che Gesù stato sepolto.
I motivi apologetici dei cristiani, di farlo risorgere non il giorno dopo della morte (o meglio: nella stessa notte in cui era morto), ma finito il precetto festivo del sabato, quindi al mattino presto del terzo giorno, stavano nel fatto che per i cristiani la domenica (l'ottavo giorno, quello appunto della resurrezione del dominus=signore) doveva sostituire il settimo, quello del riposo dopo la creazione.
Matteo (12,39) e Luca (11,29 ss) aggiungeranno, misticamente, l'analogia con Giona, rimasto nella bocca della balena per un tempo identico.
La cosa più ridicola è stata quella di far vedere che le donne andavano a imbalsamare Gesù dopo tre giorni, quando nel racconto della morte di Lazzaro, Marta dice a Gesù che dopo quattro giorni il cadavere (in quell'afosa Giudea) era già in decomposizione. Donne che non avrebbero potuto rimuovere il masso che chiudeva la tomba... Donne che non avrebbero mai potuto ungere e profumare un corpo maschile...
Per il resto va detto che non sta scritto da nessuna parte dell'Antico Testamento che il messia sarebbe morto in croce e risorto il terzo giorno. Faceva parte tuttavia di una certa tradizione ebraica quello di considerare il “terzo giorno” come il giorno del “riscatto”, non solo in riferimento all'esempio di Giona (2,1) nel ventre della balena, ma anche sulla base di quello che aveva scritto Osea (6,1): “Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza”.
La questione del “terzo giorno”, già presente in 1Cor 15,3-4, viene ripetuta per ben tre volte nelle profezie fatte pronunciare dallo stesso Cristo nel primo vangelo (8,31; 9,31; 10,34). E, considerando che Marco scriveva per cristiani di origine romana, è impossibile non vedere, in questo, un'allusione alla domenica latina (dies solis), dedicata alla divinità del Sol Invictus, che poi con Costantino diverrà giorno festivo e che con Teodosio, nel 383, verrà appunto rinominata dies dominicus.
(torna su)Una cosa straordinaria del vangelo di Marco (imitato, in questo, dagli altri evangelisti) è la mole considerevole di guarigioni miracolose e di prodigi compiuti da Gesù, raccontati, peraltro, con una buona dose di particolari che li rendono addirittura verosimili. Tale peculiarità la si è scoperta solo agli inizi del Novecento, in quanto si era sempre pensato che, proprio per questo motivo, fosse un vangelo di molto inferiore a quello più teologico di Matteo o a quello più dichiaratamente universalistico di Luca, per non parlare di quello ontoteologico di Giovanni.
Bisogna ammettere che in ciò vi è qualcosa di paradossale, poiché, se davvero Gesù avesse fatto tutte quelle cose sovrumane, resta inspiegabile il motivo per cui fosse soggetto a così grande ostilità. Generalmente si odia un guaritore quando passa per un impostore, cioè quando sfrutta la credulità popolare per arricchirsi. Qui però abbiamo un terapeuta che compie guarigioni a titolo gratuito e che addirittura chiede di non divulgare quanto gli riesce di fare. Una strategia, questa, analoga a quella che nello stesso vangelo passa sotto il nome di "segreto messianico" (inventato da Marco per togliere al Cristo qualunque caratterizzazione politica).100
In sostanza viene da pensare che l'odio nei confronti del Cristo dovesse avere altre motivazioni, che però nei racconti miracolistici non appaiono, se non in limitati casi: p.es. quando esse vengono compiute di sabato, a prescindere dal fatto che il malato fosse o no in pericolo di vita. Sembra addirittura che lo strumento delle terapie miracolose sia stato usato da Marco per nascondere qualcosa di molto umano e naturale, di cui egli non può dir nulla, in quanto verrebbe a contraddire l'impianto fondamentale della teologia petro-paolina, cui lui fa riferimento.
Nelle guarigioni del Cristo vi è comunque troppa autonomia da parte del terapeuta per non pensare a una qualche forma di "ateismo". Di questo lo stesso Marco sembra non rendersi ben conto. Infatti, facendole, Gesù non chiede di "credere in Dio", cioè a un'entità esterna. Chiede sì la fede, ma in generale (come forma di speranza per un cambiamento delle cose), o come fiducia in se stessi o in colui che guarisce. È una fede che potrebbe anche portare a credere in "Gesù come Dio", il quale però in vari racconti lascia capire che ogni uomo, potenzialmente, potrebbe fare le stesse cose che fa lui, se solo avesse fede in se stesso.
Sappiamo anche, da Samuel Brandon, che il vangelo di Marco andrebbe definito con la parola "tendenzioso", in quanto mira a spoliticizzare il Cristo. Non è quindi da escludere che dietro i prodigi e gli eventi miracolosi si nascondano fatti politici eversivi (generalmente anti-romani) o comunque questioni meramente umane, di tipo etico, che gli evangelisti non hanno potuto raccontare proprio perché la teologia petro-paolina voleva presentarsi come un'esperienza di fede che cercava con l'impero romano un compromesso dignitoso, un'alleanza pacifica: i cristiani avrebbero rispettato lo schiavismo e il potere del principato a condizione di non essere costretti a praticare culti pagani e di non dover riconoscere l'imperatore come una "figura divina".
Questo è tutto vero, ma resta il fatto che se Gesù non ha compiuto alcun prodigio, i vangeli non possono essere stati scritti che molto tempo dopo la sua morte, quando ormai nessuno avrebbe potuto considerarli un'impostura patentata. E ci chiediamo se mezzo secolo possa essere considerato un tempo sufficiente. Infatti sarebbe bastato anche un solo testimone per smontarli, e non è possibile pensare che tutti i testimoni siano stati impossibilitati a parlare a causa della catastrofe del 70.
I vangeli quindi andrebbero tutti post-datati, o almeno i loro autori ufficiali andrebbero considerati come puramente fittizi, dietro i quali si celano varie comunità cristiane anonime che hanno aggiunto ai testi originari dei racconti tra loro indipendenti, modificando eventualmente quegli stessi testi. I vangeli infatti sono un'opera collettiva: da tempo su questo non vi è alcun dubbio.
Certamente potremmo anche considerare la catastrofe del 70 come uno spartiacque decisivo per stabilire la verità dei fatti. Cioè si potrebbe dire che dopo quella data nessuno sarebbe stato in grado di smentire dei racconti fantastici sulla vita di Gesù, in quanto la prima generazione di cristiani o di nazareni era praticamente scomparsa e in maniera piuttosto violenta.
La cosa strana però è che il quarto vangelo, scritto per ultimo, presenta aspetti che solo un testimone oculare avrebbe potuto descrivere. Eppure i Sinottici non ne tengono conto, anzi sembrano essere stati scritti proprio contro la versione giovannea dei fatti. Peraltro l'autore, o meglio gli autori del quarto vangelo riportano un'altra serie di guarigioni miracolose, diverse da quelle dei Sinottici. Chi li obbligava a farlo, visto che sul piano teologico non dicono molto di più di quanto si può leggere in tutto il resto? È quindi possibile presumere o che il redattore di questi racconti prodigiosi non sia stato Giovanni, bensì un suo manipolatore, anch'egli condizionato dalla teologia petro-paolina, oppure che qualcosa di vero debba esserci, seppure a livelli minimi.
Due cose possiamo qui considerare evidenti: 1) quando si arriva a credere nella teoria della resurrezione, è poi difficile impedire al Cristo di compiere qualunque azione sovrumana; 2) se il Cristo si fosse imposto coi suoi prodigi, la fede degli uomini non avrebbe avuto alcun valore. Il rapporto tra lui e gli interlocutori doveva essere alla pari, da uomo a uomo e non da dio e uomo. Questa cosa i cristiani fanno fatica a capirla, proprio perché per loro i prodigi straordinari di Gesù sono una prova evidente della sua divinità. Sicché quando leggono i vangeli, amano interpretarli alla lettera.
E sono evidenti altre due cose: 1) se si fanno compiere dei prodigi straordinari a un terapeuta ebreo come Gesù, e si mostrano gli interlocutori ebrei come lui (non i postulanti ovviamente) del tutto indifferenti a tali prodigi, cioè non disposti ad ascoltare le parole di chi li compie, si cade inevitabilmente nell'antisemitismo; 2) è assurdo sostenere che in virtù di tali prodigi Gesù potesse pretendere d'essere considerato di "natura divina". Se poteva apparire una cosa assurda associare miracoli a messianicità, sarebbe stato ancora peggio associare miracoli a divinità: come a nessun messia è mai stato chiesto di compiere miracoli, così nessun miracolo è in grado di dimostrare alcunché.
Sotto questo aspetto lo scetticismo di molti ebrei era più che giustificato. Infatti anche gli impostori possono compiere miracoli; anzi, in genere se ne servono per meglio imporsi politicamente. Lo fanno anche oggi, seppur non in senso terapeutico, ma in senso economico, quando dicono di voler dare il lavoro a tutti, di voler ridurre il debito pubblico e di aumentare il prodotto interno lordo; oppure in senso militare, quando i generali dicono che la guerra sarà breve e indolore. Chi pretende di fare il guaritore strepitoso, si limita, in genere, a gestire una comunità di gente plagiata, se non addirittura invasata.
Quindi l'unica cosa che si può pensare è che le guarigioni compiute da Gesù dovevano essere alla portata di ogni uomo, previa una specifica preparazione, in virtù della quale si potessero potenziare le proprie capacità; oppure si può pensare che i malati avessero dei problemi somatici dovuti a cause psichiche. In tal caso si dovrebbe parlare di psicoterapia e quindi non di guarigione miracolosa, benché in determinati casi possa sembrare un miracolo che un disturbo fisico scompaia dopo un risanamento interiore, spirituale o emotivo. D'altra parte quante malattie sono frutto di stress, autosuggestione, manie depressive, ecc.? Chi riesce a uscire dal tunnel in cui si è cacciato, magari con l'aiuto di qualcuno, può ritrovare in se stesso le forze per ricominciare.
Supponiamo quindi che Gesù avesse compiuto qualche guarigione psicosomatica: cosa avrebbe potuto impedire a un evangelista, abbacinato dall'idea di resurrezione, di far compiere al Cristo prodigi di ben altra portata (come p.es. camminare sulle acque, moltiplicare pani e pesci, resuscitare dei morti, risanare i lebbrosi con un dito, ordinare a un paralitico di alzarsi dalla sua barella, guarire a distanza...)? Nulla, se non l'onestà personale, che però gli evangelisti non avevano, in quanto pensavano che nessuno sarebbe stato in grado di smentirli.
(torna su)Visto che il titolo di questo libro è Pescatori di favole, vogliamo cimentarci anche noi a scrivere una sorta di parabola per le persone ingenue, disposte a credere in cose fantastiche e che, nonostante ciò, non sarebbero disposte a compiere cose che vanno al di là del buon senso. La parabola la vogliamo intitolare L'idea di morte e di resurrezione.
È probabile che i miti pagani in cui si parla di "resurrezione" siano più antichi di quel che non si creda. Il paganesimo è legato allo schiavismo, e quindi può essere fatto risalire ad almeno seimila anni fa. Tuttavia il paganesimo, per poter giustificare lo schiavismo, aveva bisogno di rifarsi, seppur in maniera distorta o strumentale, alle religioni precedenti, cioè all'animismo e al totemismo.
Queste religioni vengono dette "naturalistiche" semplicemente perché fanno dei fenomeni naturali o degli animali le loro "divinità". Gli esseri umani si sentivano parte della natura, la rispettavano e, se erano costretti a uccidere degli animali per sopravvivere, lo facevano con un certo senso di colpa, poiché si rendevano conto di non essere molto diversi da loro.
La natura era percepita come un tutto unico, e quando qualcuno del villaggio moriva, si dava per scontato di poterlo, un giorno, rivedere. L'aldilà non era immaginato molto diverso dalla vita terrena. Nelle tombe si mettevano le armi usate quando si andava a caccia, ma anche il cibo, i monili, i vestiti, gli attrezzi da lavoro... Il concetto di "morte", in un certo senso, non esisteva. La morte non era che un momento di passaggio da una condizione di vita a un'altra. Per molte popolazioni persino la nascita non era che una forma di "rinascita" da parte di una sostanza eterea, invisibile, che nella nostra cultura occidentale abbiamo chiamato col nome di "anima".
Ora, quando finì il comunismo primitivo e si passò alle prime forme di schiavismo, statale o privato, cominciarono a sorgere quei miti che dovevano legittimare la transizione. I miti pagani in cui si parla di morte e resurrezione non sono pochi. Qual è la loro caratteristica? Quella principale è che a morire e risorgere sono solo gli dèi. I comuni mortali muoiono soltanto, oppure la loro anima va a vivere in un posto orrendo, pieno di solitudine e disperazione.
I miti pagani erano falsi e bugiardi, poiché dovevano giustificare il potere monarchico e aristocratico. Tuttavia riflettevano una credenza che un tempo era stata popolare: quella che la morte è solo un momento di passaggio. Gli dèi non possono morire, anche se vengono uccisi da altri dèi, o detronizzati del loro potere.
Si noti cosa dice il mito ebraico della creazione, là dove Dio mette sull'avviso la coppia che viveva nell'Eden: "Non mangiate dell'albero della conoscenza, altrimenti morirete". Come poteva morire un essere umano fatto a "immagine e somiglianza" di Dio? Evidentemente non potevano intendere quella parola in senso fisico. Morire voleva dire, in realtà, "morire dentro", cioè nello spirito. Era soltanto l'idea di qualcosa di terribile, di angoscioso, di disperato.
Chi aveva creato l'essere umano, voleva che arrivasse alla conoscenza completa delle cose, ma in maniera graduale, rispettando i tempi di una crescita normale, naturale. In questa maniera non sarebbe mai morto, né nel fisico né nello spirito. Invece, siccome venne meno ai propri impegni, l'uomo cominciò a morire dentro, e chi l'aveva creato pensò di ridurgli il tempo della vita fisica, terrena. Infatti, non avrebbe avuto senso far vivere per troppo tempo chi soffriva terribilmente nell'anima per la colpa compiuta e che si trovava a vivere un'esistenza sempre meno umana, sempre meno conforme a natura.
Gli uomini avevano sicuramente la percezione del tempo che passava, ma non attribuivano alla morte fisica un motivo di angoscia. Sapevano di dover morire a causa della colpa originaria, ma non ritenevano che la morte fosse la fine di tutto. Sapevano bene di essere destinati a esistere.
Fu solo con la nascita dello schiavismo e del paganesimo che si cominciò a pensare alla morte come a una disgrazia d'incalcolabile portata, che nessun uomo di potere avrebbe mai voluto affrontare. Gli antichi Egizi arrivarono a pensare che almeno i faraoni e le persone facoltose, che potevano permettersi un proprio sepolcro, avrebbero potuto continuare a esistere nell'aldilà. Per tutti gli altri il destino sarebbe stato incerto: bastava che il cuore pesasse anche solo un grammo più di una piuma che si moriva per sempre. L'Ade, il Tartaro, gli Inferi... sono luoghi orribili, in cui non esistono piaceri di alcun tipo. Era quasi meglio pensare che dopo la morte non vi fosse più nulla o che la liberazione coincidesse con il pieno annullamento di sé.
Gli ebrei, al tempo dei Maccabei, non scartavano a priori l'idea che, dopo morti, vi fosse qualcosa di positivo, di meritevole d'essere vissuto, soprattutto per chi avesse dimostrato di aver fede. Anche nel mondo islamico si pensava che l'aldilà fosse qualcosa alla portata di tutti, e che i frutti del paradiso se li sarebbero potuti godere quanti se li fossero meritati sulla Terra. I Vichinghi chiamavano Valhalla il luogo nel cielo, dove gli eroi, condotti dalle valchirie (donne a cavallo), sono accolti nella splendida residenza del dio Odino, restando in attesa della grande battaglia finale che dovranno combattere, tutti insieme, contro il male.
Proprio nel mondo ebraico apparve, duemila anni fa, un uomo chiamato Gesù. Voleva liberare la Palestina dai Romani e togliere il potere alla casta sacerdotale corrotta, che gestiva il Tempio di Gerusalemme. Ma non vi riuscì, in quanto fu tradito. Messo a morte, il suo corpo fu deposto in una tomba scavata nella roccia, appoggiato su una lastra di pietra, avvolto in un lungo lenzuolo, tenuto unito con dei lacci. Il corpo era ancora tutto sporco del sangue della fustigazione e della crocifissione, in quanto la sepoltura, per motivi di purità legale, era stata molto affrettata.
Il giorno dopo però due donne si accorsero che la pietra rotolante che ostruiva l'ingresso della tomba era stata spostata, sicché si poteva entrare dentro. Cosa videro? Videro che il corpo era scomparso. Pensarono ch'era stato trafugato da qualcuno. Andarono ad avvisare gli unici due apostoli presenti nella capitale giudaica: Pietro e Giovanni, che si preoccuparono di vedere coi loro occhi quanto era accaduto. Presero atto che le donne avevano ragione, ma videro anche due cose molto strane: i legacci che tenevano unito il lenzuolo erano per terra, mentre il lenzuolo era piegato e riposto da una parte.
La domanda che si posero fu questa: "Che senso ha rubare un cadavere senza quel lenzuolo?". Uno dei due discepoli, Pietro, cominciò a dire che Gesù era "risorto"; l'altro invece preferì limitarsi a pensare ch'era misteriosamente scomparso. Attesero un po' di tempo, sperando che Gesù si rifacesse vivo, ma invano. Non avevano però molto tempo per attenderlo. Infatti, siccome Gesù era andato a Gerusalemme per compiere la liberazione della Palestina, si doveva decidere in fretta.
A questo punto la domanda che s'imponeva era un'altra: "Si fa lo stesso la rivoluzione o vi si rinuncia?". Giovanni era per la prima soluzione. Pietro invece escogitò una via di mezzo: disse che se Gesù era risorto, non poteva che tornare, e questa volta l'avrebbe fatto in maniera trionfale. Ma Gesù non ricomparve più e l'insurrezione non si fece. Il movimento politico nazareno si trasformò in un movimento religioso cristiano, che cominciò a predicare che il Cristo era risorto proprio perché "unigenito figlio di Dio". E tutti vissero infelici e scontenti, sostenendo che solo nell'aldilà si può vincere questa terribile tristezza.
Cosa insegna questa parabola? Tante cose. La prima è la più elementare: se esiste un aldilà, chi ci vive non può interferire con le scelte che gli uomini devono prendere sulla Terra, poiché inevitabilmente le influenzerebbe, in un modo o nell'altro. Secondo: gli esseri umani devono cercare anzitutto di vivere bene su questa Terra, in maniera conforme a natura, senza riporre nell'aldilà la soddisfazione dei loro desideri. Terzo: Gesù era un uomo come gli altri; non ha mai compiuto nulla che potesse far pensare che fosse un dio; dunque se è scomparso in maniera strana, lasciando la propria impronta sul lenzuolo che lo avvolgeva, forse aveva qualcosa in più di un semplice essere umano, ma noi non possiamo sapere cosa, né ci deve interessare. Quarto: se Gesù, dopo essere scomparso, ha continuato a vivere in qualche altra parte dell'infinito universo, questo può indurci soltanto a pensare che il nostro destino non sarà molto diverso dal suo. Nel senso che se, ad un certo punto, eravamo arrivati a non credere più d'essere eterni, ora abbiamo la prova che lo siamo davvero.
Siamo destinati a esistere, che lo si voglia o no. E dobbiamo dimostrare d'essere davvero umani su questa Terra, rispettando le esigenze di vivibilità della natura. Dunque le idee di "morte" e di "resurrezione" non hanno alcun senso: sono fuorvianti e, in fondo, mistificanti. Se nessuno può morire definitivamente, nessuno può risorgere. Tutti continueremo ad esistere in un'altra dimensione, con nuove possibilità di scelta.
(torna su)1 Di recente, rispetto a Brandon, sono state pubblicate altre opere significative che meriterebbero d'essere lette, preventivamente, in quanto si situano sulla stessa linea di Brandon, ne siano o meno consapevoli i loro autori: D. Donnini, L. Cascioli, D. T. Unterbrink, P. F. Zarcone, G. Tranfo..., che tendono a "ripoliticizzare", in un modo o nell'altro, la figura di Gesù o, quanto meno, l'ambiente in cui egli ha vissuto. Si raccomanda anche la lettura del famoso testo di K. Kautsky e di quello, ancora più famoso, di F. Belo.
2 Ci si riferisce, con quella del 66-73, al periodo che va da Nerone a Vespasiano e Tito, suo figlio: la guerra si concluse con la distruzione del secondo Tempio di Gerusalemme; con quella del 115-117, al periodo di Traiano: essa fu chiamata anche "guerra di Kitos" e interessò le città della diaspora ebraica; infine con quella del 132-135, al periodo di Adriano: la rivolta fu sostenuta da Simone Bar Kokhba e interessò parte del territorio palestinese. Fino a Costantino i Giudei non poterono più rientrare a Gerusalemme.
3 Il termine ευ-αγγέλιον è simile, sul piano meramente lessicale, alla "buona notizia" di carattere profano della grecità, anche se qui si vuol far passare Gesù come annunciatore e, insieme, oggetto del messaggio. Non è stato però Marco a inventare questo termine sul piano religioso, bensì Paolo di Tarso.
4 Si noti come in questo vangelo l'autore faccia decorrere la natura divina del Cristo a partire non dalla sua nascita (come fanno Matteo e Luca) bensì dal suo battesimo (nel cui valore politico, peraltro, il quarto vangelo sostiene che Gesù non credesse affatto).
5 A dir il vero questo vangelo ha un lessico formato da 1.312 vocaboli su un totale di 11.216 parole, corrispondente all'11,69% del totale. Si tratta del più alto rapporto percentuale rispetto agli altri evangelisti. Luca nel suo vangelo utilizza 2.055 vocaboli su 19.490 parole, pari al 10,54%. Matteo impiega 1.691 vocaboli su 18.346 parole, pari al 9,21%. Il lessico più monotono e ripetitivo è quello dell'evangelista Giovanni, che pur appare, in molti capitoli, come il più teologico di tutti: 1.011 vocaboli su 15.641 parole, pari al 6,46%.
6 Il primo studioso che ha sostenuto la priorità di Marco rispetto a Matteo e Luca, è stato il filologo tedesco Karl Lachmann (1793-1851).
7 Si è stabilito che più del 95% di Marco appare o in Matteo o in Luca. Ciò che Marco non si trova in loro è: 4,26-29; 7,31-37; 8,22-26; 3,20; 9,49; 14,51.
8 Ci rendiamo conto che questa definizione di "protovangelo" può non piacere a quegli esegeti che ritengono il vangelo di Tommaso anteriore persino a quello di Marco, ma il nostro testo esula da tali diatribe. Noi possiamo soltanto dire che anche questo vangelo apocrifo non presenta caratteristiche tali da permettere un'interpretazione politica del messaggio di Gesù.
9 Persino tra gli esegeti confessionali va emergendo un tale ribaltamento di prospettiva: cfr i testi di M. Imperatori, E.A. Wuenschel, A.-M. Dubarle...
10 Il racconto marciano del battesimo di Gesù è del tutto leggendario, preso da passi veterotestamentari (p.es. Sal 2,7; Is 11,2; 42,1 ss.), ma anche da miti pagani (p.es. presso i Siro-fenici la colomba era simbolo della divinità protettrice, mentre presso gli Egizi aleggiava sulle teste dei faraoni). Si può anche sostenere che la pericope del battesimo, frutto di un compromesso tra cristiani e battisti, non può essere originaria di Marco, poiché questi, volendo dimostrare che Gesù era "Figlio di Dio", avrebbe avvertito come un controsenso farlo battezzare da uno che predicava un rito di penitenza per i propri peccati (benché Marco faccia dire a Gesù, rivolto al giovane ricco, che l'unico a essere "buono" è Dio). Peraltro Pietro non associa neppure la resurrezione del Cristo a una esclusiva, letterale, figliolanza divina, la cui natura sarebbe consustanziale a quella di Dio-padre (come invece appare nel brano del battesimo e in quello della trasfigurazione): ci vorrà Paolo per operare una torsione intellettuale del genere.
11 "Il tempo è compiuto!" è frase che proclamavano i sacerdoti al tempo del re assiro Assurbanipal (668-626 a.C.), celebrato quale salvatore e figlio di dio. Anche nella predicazione di Zarathustra si parla di un imminente "regno di dio". Era pure un motto del partito zelota, che ovviamente lo intendeva in senso "terreno", non "celeste", da acquisirsi anche con la "forza", come risulta, d'altra parte, in Mt 11,12.
12 Nel libro di Ezechiele il titolo di "Figlio dell'uomo" viene usato da Dio più di 90 volte quando si rivolge al profeta: in Ez 2,1 indica un singolo individuo del genere umano; infatti la maggioranza delle traduzioni bibliche lo rende semplicemente con "uomo". Invece in Sal 8,5, 146,3 e Ger 49,18 49,33 indica l'umanità nel suo complesso (comprendendo indirettamente anche la persona che parla). In Sal 144,3 indica "il figlio dell'uomo mortale". In Dn 7,13 indica un uomo comune che è portato sulle nubi del cielo davanti all'Antico dei giorni. Anche Buddha lo usava.
13 I pubblicani erano funzionari incaricati di esigere le tasse (in Galilea a favore di Erode Antipa) e i diritti di dogana.
14 Dodici è un numero magico: nella mitologia greca gli dèi principali del monte Olimpo sono dodici come dodici sono le "fatiche" di Eracle (Ercole) e il numero dei Titani e delle Titanidi. Anche Buddha aveva dodici discepoli. Generalmente veniva considerato il più sacro tra i numeri, insieme al tre e al sette: indicava infatti la ricomposizione della totalità originaria, la discesa in Terra di un modello cosmico di pienezza e di armonia, la conclusione di un ciclo compiuto, il simbolo della prova iniziatica fondamentale (fisica e mistica), che permette di passare da un piano ordinario a un piano superiore, sacro. In molte culture antiche i riti iniziatici si facevano all'età di dodici anni, dopo di che si entrava nell'età adulta (ne parla anche Lc 2,41-47). Dodici erano anche le tribù di Israele, ridotte a due al tempo di Gesù. Nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, le ceste riempite con gli avanzi sono dodici. Nell'Apocalisse di Giovanni la donna vestita di sole ha sul capo una corona di dodici stelle (12,1); i vegliardi che attorniano il trono di Dio sono 24 (4,4); la Gerusalemme celeste ha dodici porte (21,12.21); i redenti della Terra sono un multiplo di dodici: 144.000 (7,4; 14,1.3).
15 Questi nomi da battaglia (lo stesso "Pietro" lo era) venivano generalmente dati ai militanti impegnati in politica e servivano anche per favorire la clandestinità.
16 Il passo di Is 6,9-10, che qui viene citato, annunciava l’insuccesso del profeta, la cui predicazione doveva aggravare il peccato del popolo indurito. Praticamente Marco, alias Pietro, guardando il popolo dall'alto, sta già anticipando che la sconfitta politica del Cristo fu dovuta anche all'atteggiamento incoerente o non sufficientemente determinato da parte del popolo.
17 Il racconto della tempesta sedata è una riscrittura del racconto veterotestamentario della vicenda di Giona (cfr. Gn 1), con la differenza che Giona viene gettato in mare, finendo nel ventre della balena, mentre Gesù resterà nella tomba per tre giorni (in realtà per poche ore). Già il salmista aveva gridato a Dio: "Svegliati, perché dormi Signore?" (cfr. Sal 43,24).
18 Si noti peraltro che l'appellativo con cui lo definisce è un'espressione frequente nell'A.T., usata dai pagani per indicare la divinità suprema (Zeus, Giove).
19 Il primo esegeta ad aver affrontato la questione del "segreto messianico" è stato William Wrede nel 1901, il quale, pur non avendo capito nulla dell'argomento, in quanto identificava “messianicità e figliolanza divina”, attribuendo a Gesù una consapevolezza assurda (mistica), aveva intuito che i vangeli sono opere di fede, non narrazioni storiche.
20 Si poteva mettere anche "carpentiere", in quanto il termine greco può indicare un operaio che lavora il legno, la pietra o il metallo. Questo è l'unico passo nel N.T. dove si precisa il mestiere di Gesù.
21 Naturalmente non pochi esegeti cattolici sostengono che, secondo l'usanza semitica, quando si parla di fratello e sorella non s'intendono solo i figli degli stessi genitori, ma anche cugini, nipoti e fratellastri (cfr. Gen 13,8; 14,16; 29,15; Lv 10,4). Quindi Giacomo e Giuseppe (o Joses) potrebbero essere stati figli di un'altra Maria (cfr. Mt 27,56; Mc 15,40.47), e naturalmente questo significa che anche Giacomo, Giuda e Simone non sarebbero gli apostoli che portano lo stesso nome. Di fatto però il vangelo venne scritto in greco non in aramaico, e in greco si fa sempre molta differenza tra le parole.
22 Il semita Matteo la riporta perché Giovanni era una figura giudaica, l'ultimo dei profeti veterotestamentari, secondo la teologia cristiana. Il pagano Luca invece, non avendo agganci con la Palestina e rivolgendosi a un pubblico esclusivamente ellenico, vi si astiene; come pure l'apostolo Giovanni, ma per un motivo diverso: probabilmente egli riteneva che il periodo più significativo del Battista fosse stato quello antecedente alla prigionia, quando aveva avuto la possibilità di allearsi col Cristo e l'aveva rifiutata.
23 A dir il vero è presente un certo messianismo anche tra gli esseni, ma in genere gli esegeti lo ritengono inferiore a quello del Battista, il quale, più che vivere l'escatologia in un deserto, aveva preferito rivolgersi direttamente alla popolazione scegliendo come luogo d'incontro il Giordano.
24 Dagli esseni i cristiani non prendono solo i due sacramenti del battesimo e dell'eucaristia (ovviamente senza l'equiparazione, in quest'ultimo, del vino col sangue, che è di derivazione pagana), ma anche la dottrina della predestinazione, della giustificazione attraverso la fede, della comunione dei beni, della venuta imminente del regno di Dio, del giudizio universale e altro ancora (p.es. la critica dell'ipocrisia farisaica, della corruzione della casta sacerdotale del Tempio e persino l'interpretazione strumentale delle profezie veterotestamentarie). Forse è per questo motivo che gli esseni non vengono mai ricordati nel Nuovo Testamento, benché si possa dare per scontato che il Precursore venisse da quegli ambienti.
25 Un denaro rappresentava la paga giornaliera di lavoro di un bracciante.
26 Si noti come questo episodio, trasformato misticamente, finisca col richiamare la vicenda del popolo affamato nel deserto e sfamato da Dio (cfr. Es 16,12). E richiama anche il miracolo di Eliseo: "Ne mangeranno e ne avanzerà anche" (cfr. 2Re 4,43), a testimonianza che i vangeli, quando vogliono mistificare le cose, non hanno scrupoli a servirsi anche dell'Antico Testamento.
27 Altri grandi personaggi sono stati fatti camminare sulle acque: Asclepio, Serapide, Eracle e Buddha. Nell'A.T. Giosuè ed Elia (Gs 3,7 ss.; 2Re 2,8). Le leggende su Buddha assomigliano molto a quelle più fantasiose dei vangeli: anche a lui si attribuiscono guarigioni di malati, di ciechi e sordi e di storpi che camminano. Asclepio, compiendo guarigioni miracolose, aveva trasformato il Tempio di Epidauro in una meta di pellegrinaggio.
28 Nella letteratura pagana dell'India Vimalakirti, grazie al suo potere miracolistico, sfamò una folla con poco cibo, moltiplicandolo in quantità sufficiente. Ma storie del genere si trovano anche in 1Re 17,11 ss e 2Re 4,42 ss.
29 I maestri farisei, nati nel periodo dei Maccabei (II sec. a.C.), avevano ampliato le prescrizioni di Lv 11-16 (che proibivano qualsiasi contatto con cose dichiarate impure) con delle tradizioni orali che imponevano il lavaggio rituale delle mani prima del pasto, tradizioni che evidentemente il popolo spesso ignorava (cfr. Gv 7,49). D'altra parte anche tra i farisei quelli che provenivano dalla scuola del rabbi Hillel erano assai diversi da quelli, molto più rigoristi, della scuola del rabbi Shammai.
30 Marco però non dice che non erano obbligati a versare subito la somma, in quanto potevano differirla per anni. Il che però non toglie l'ipocrisia del gesto, ovviamente nel caso in cui i genitori fossero in stato di bisogno.
31 Da Betsaida (vicino al lago di Genezareth), Gesù sale verso i confini settentrionali d'Israele, ai piedi del monte Ermon, nel territorio governato da Filippo, figlio di Erode il Grande. Questi ricostruì la città di Paneas (poi Baniyas), chiamandola Cesarea, in onore di Tiberio Cesare, e aggiungendo "di Filippo" per distinguerla da Cesarea marittima. Siccome siamo a metà del racconto evangelico di Mc, e la questione dell'identità di Gesù (problema posto a partire da 6,14) deve trovare soluzione, tale localizzazione geografica non è puramente letteraria, ma diventa profetica, cioè Pietro riconoscerà in Gesù il Cristo proprio ai confini con il mondo pagano, quasi a prefigurare la sua strada per Roma, dove andrà a completare la sua "confessione teologica", prima della quale però ci dovrà essere, in questo vangelo, la testimonianza del Dio-padre nella trasfigurazione del Figlio e quella del centurione ai piedi della croce.
32 Gli esegeti sanno bene che tale promessa di Gesù è stata variamente interpretata nel corso dei secoli: 1) si è adempiuta nella trasfigurazione che seguirà immediatamente, come sostengono i Padri in genere, fino ai grandi Scolastici; 2) si è adempiuta con la distruzione di Gerusalemme nel 70, secondo parecchi moderni; 3) si è adempiuta nella resurrezione e nella pentecoste, dando l'avvio alla fondazione della Chiesa, avvenuta con grandi prodigi, secondo il pensiero di Gregorio Magno e di qualche moderno. Difficile credere in queste interpretazioni mistiche. Ciò a testimonianza che quando si affrontano i vangeli in maniera laica, si rischia di perdere del tempo prezioso a leggere i commenti precedenti fatti da esegeti più o meno confessionali.
33 Si noti come questo verbo, "gustare", possiede un uso metaforico noto anche nella versione biblica dei LXX (cfr. Sal 33,9), però solo nel N. T. viene applicato alla morte. Il che fa del cristianesimo una religione il cui misticismo può anche sconfinare nella follia.
34 Da notare che la traduzione letterale del verbo greco μετεμορφώθη non è "trasfigurato" ma "metamorfizzato", che è lo stesso verbo tecnico usato per indicare i cambiamenti degli dèi nella mitologia pagana. Luca infatti evita di usarlo per i suoi lettori cristiano-pagani di origine greca, che avrebbero potuto paragonare Gesù a una delle loro divinità.
35 Secondo gli ebrei Elia non è morto ma è stato rapito in cielo (2Re 2,11-12), e ritornerà (Mal 3,23). Quanto a Mosè, nessuno ha mai saputo dove fosse la sua tomba (Dt 34,6), perciò, secondo l'ebraismo, può tornare. Entrambi poi avrebbero incontrato Dio sul monte Sinai (1Re 19,2.8-14; Es 19,16-20,17).
36 In tale pericope è la prima volta che Marco fa chiamare Gesù (in questo caso da Bartimeo) con l'appellativo di "Figlio di Davide", che Gesù sostanzialmente rifiutava non perché troppo caratterizzato politicamente, quanto perché lo era in senso teologico-politico e in riferimento a modalità autoritarie di gestione del potere. L'evangelista è sempre spaventato all'idea di politicizzare il Cristo. Infatti egli non ha riportato nessuna genealogia e non ha ricordato Betlemme, la città di Davide. Qui Bartimeo torna a vederci semplicemente perché, quando vede Gesù di fronte a sé, lo chiama "Rabbunì", che significava "Mio grande", un titolo che si dava a maestri o persone particolarmente dotte o istruite. Tale importante pericope la riprenderemo più avanti.
37 Suicidi di massa, d'altra parte, avvengono anche oggi in ambiti religiosi. Nel 1978, in Guyana, nella setta Tempio del popolo di Jim Jones. Nel 1993 a Waco (Texas) nella setta davidiana di David Koresh. A partire dal 1994 ripetuti suicidi collettivi hanno riguardato la setta dell'Ordine del Tempio Solare, in Svizzera, in Canada e in Francia. Nel 1997 nel Ranch Santa Fe, di San Diego (California), nella setta Heaven’s Gate (Higher Source). Nel 2000 in Uganda circa 800 adepti di una setta apocalittica ugandese, di matrice cattolica, chiamata "I dieci comandamenti di Dio", si sono dati fuoco dopo aver cantato e suonato per molte ore nella loro chiesa, a sud est di Kampala.
38 Si noti come anche nell'apocrifo Vangelo di Giuda si parli della stessa cosa. Infatti il tradimento sarebbe stato un incarico espresso segretamente da Gesù, per la sua futura gloria celeste, all'apostolo Giuda, discepolo prediletto, anche se per quello che ha fatto sarebbe stato disprezzato dagli uomini. Una tesi assurda, però consequenziale all'impostazione marciana.
39 Il libello del ripudio o di divorzio, privo di motivazioni, era un atto scritto necessario per salvaguardare la donna dall'accusa di adulterio. Il marito non aveva diritto di divorziare soltanto se aveva disonorato una vergine (Dt 22,29) o se aveva ingiustamente incolpato la propria casta moglie (Dt 22,19). La moglie poteva, secondo il Talmud, richiedere il divorzio per motivi fisici o morali. Tuttavia il rilascio di un attestato di ripudio da parte della moglie era impensabile nell’ambiente genuinamente giudaico.
40 Notiamo che qui Gesù fa riferimento a un "comando" di Mosè, mentre i farisei parlavano di "permesso" (v. 4); in Mt 19,7-8 succede invece l'inverso.
41 Una rigidità del genere la si ritrova anche nella teologia della chiesa romana, la quale però non ha potuto fare a meno di concedere la prassi dell'annullamento del matrimonio, a prescindere dal sesso del richiedente. In presenza della legge civile sul divorzio, la chiesa ha infatti dovuto aumentare la casistica in cui è possibile chiedere l'annullamento, onde impedire un drastico calo di celebrazioni religiose del rito.
42 Questo personaggio fantasioso viene generalmente identificato come il giovane ricco, sulla base di Mt 19,20, ma né Marco né Luca (che lo chiama "capo", 18,18) ne precisano l'età; la risposta del v. 20 (…dalla mia giovinezza) induce a pensare a un uomo adulto, benché il suo ingenuo idealismo faccia credere il contrario.
43 Si noti come per la prima volta nel vangelo di Marco viene posta a Gesù una domanda riguardo alla vita eterna e come, nonostante questo, Gesù faccia capire che nessuno, per meriti propri, è in grado di ottenerla, tanto meno i ricchi.
44 Pilato verrà destituito dall'imperatore Caligola proprio a causa delle violenze perpetrate a danno dei Samaritani, durante la rivolta sul monte Garizim.
45 Alcuni esegeti han fatto notare come, a differenza di Matteo e Luca, Marco metta molto in evidenza le debolezze degli apostoli proprio per giustificare meglio la loro incapacità a proseguire la strategia eversiva dopo la crocifissione di Gesù.
46 Alcuni esegeti han pensato che la richiesta dei fratelli Zebedeo di sedere alla destra e sinistra di Gesù, stia ad indicare la loro morte, avvenuta prima di quella di Pietro. Giacomo, in effetti, morì nel 44 (Atti 12,2), e forse Giovanni morì insieme all'altro Giacomo, fratello di Gesù, nel 62, ma di questo non vi è alcuna certezza e personalmente lo escludiamo, per quanto sia appurato che il vescovo Giovanni di Efeso sia stato confuso da Papia di Ierapoli con l'evangelista, e anche che le lettere di Giovanni siano state scritte non dall'apostolo bensì da Giovanni il Presbitero.
47 Si noti peraltro che Marco cita la città di Gerico (10,46) come snodo per l'ingresso messianico, senza far compiere assolutamente nulla a Gesù. Non pochi esegeti han pensato che dal vangelo sia stato rimosso qualcosa di politicamente scomodo.
48 Il profeta Isaia (11,1 ss.), p.es., attendeva il Salvatore proveniente dal "tronco di Iesse", cioè dalla stirpe di Davide, quindi un re. Cosa che viene confermata nelle genealogie di Matteo e Luca, per quanto all'interno di una cornice mistica, di redenzione universale, e non politico-nazionalistica contro i nemici di origine pagana o influenzati dal paganesimo, come invece si auspicava nell'Antico Testamento.
49 Betfage è stata forse menzionata perché in aramaico vuol dire "casa dei fichi non maturi", quel frutto, simbolo di Israele, che di lì a poco Gesù maledirà senza scampo.
50 Si noti che il v. 11,3, in cui Marco scrive che Gesù pretendeva il puledro d'asina in quanto "Il Signore", pone un'esplicita identificazione divina della sua persona. Infatti quell'appellativo, con l'articolo, viene riservato, nell'A.T. greco (versione dei LXX), esclusivamente a Jahvè.
51 Nell'A.T. le offerte fatte a Dio (primizie dei raccolti e del bestiame) dovevano essere perfettamente integre: se era un animale, non doveva aver mai portato il giogo (cfr. Nm 19,2 e Dt 21,3). Il puledro quindi fa parte dell'offerta che Gesù fa di se stesso come agnello immolato, entrando nel Tempio.
52 In Marco Gesù compie la profezia di Zac 9,9 s.: "(Gerusalemme), ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti". Anche solo il pesante comportamento di scherno da parte dei soldati romani durante la "passione" smentisce che la guarnigione ebbe l'impressione di un ingresso con finalità pacifiche.
53 È singolare tutto questo interesse di Marco per il Battista, quando nel quarto vangelo Pietro non viene mai citato nei racconti riguardanti il Precursore.
54 Oltre ai pedaggi, le dogane e altre tasse, le provincie romane dovevano versare all'impero il tributo, ch'era uguale per tutti: soltanto i vecchi e i bambini ne erano esenti.
55 Si noti peraltro l'assurdità di mostrare a Gesù una moneta romana, il denarius (la paga giornaliera di lavoro di un bracciante), mentre egli si trovava ancora nel Tempio (Mc 11,27): il fatto stesso che in quell'area i farisei avessero portato una moneta del genere rappresentava un oltraggio alla legge divina (cfr. Es 20,4).
56 I sadducei appartenevano alle classi superiori del sacerdozio e non ammettevano la fede nella risurrezione, argomento apparso due secoli prima con Daniele (cfr. Dn 12,1-3). I farisei invece l'ammettevano, come risulta da At 23,8, anche sulla base di alcuni brani di Ezechiele (18,20; 37,3). Nella risposta data da Gesù Marco non ha potuto citare Daniele o altri testi (cfr. 2Mac 7,9.14; Is 25,8; 26,19), in quanto i sadducei riconoscevano solamente il Pentateuco come Scrittura. Da notare che nei vangeli non vengono riportati questi precedenti veterotestamentari proprio perché si vuol far vedere la resurrezione come una caratteristica esclusiva del Cristo.
57 Queste cose il mondo laico le ha imparate dal cristianesimo, anche se i credenti le hanno rivestite di un involucro religioso, facendo sì che la relazione fondante sia quella tra uomo e dio o quella tra santo e peccatore. Nel quarto vangelo si arriverà persino a dire, in forma estrema, ai limiti dell'irrazionalismo, che "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici" (15,13).
58 Il racconto dell'obolo della vedova si ritrova anche nella letteratura buddistica mahayana.
59 Qui si sta parlando della sala grandiosa costruita da Erode nella parte settentrionale dell'atrio delle donne. Vi erano 13 recipienti per il denaro o cassette per le offerte, che, per la forma a imbuto ristretta verso l’alto (per impedire furti), erano dette "trombe"; sette di esse servivano per ricevere le imposte stabilite, cinque per le offerte destinate a uno scopo specifico e una per le offerte spontanee comuni. Dal momento che i sacerdoti controllavano le offerte, non era raro che questi schernissero pubblicamente le offerte di poco conto, per cui tutti i presenti mostravano molto interesse all'offerta dei doni, e questa per i benestanti era una buona occasione per mettersi in mostra (cfr. Mt 6,2).
60 Al tempo di Gesù questa collina, vicina a Gerusalemme, da cui è separata dalla valle del Cedron, era ricoperta da un bosco di ulivi, e aveva già una sua storia nella tradizione ebraica: qui si svolse la cosiddetta "Passione di Davide" (2Sam 15,30); qui il profeta Ezechiele fa riposare la gloria di Dio prima di partire per Babilonia (Ez 11,23); qui il profeta Zaccaria vi colloca il giudizio finale (Zac 14,4).
61 La ricostruzione del Tempio era iniziata sotto Erode il Grande verso il 20 a.C., e fu completata circa sette anni prima della sua distruzione ad opera dei Romani, nel 70 d.C.
62 Se ne parla in Dn 9,27; 11,31; 12,11 e in 1Mac 1,54; 6,7.
63 Si noti come su questo aspetto permanga forte ancora oggi la differenza tra chiesa ortodossa, che pensa se stessa come se fosse un ente spirituale, proiettato verso il futuro escatologico, e chiesa romana, interessata invece a un concreto potere temporale nel presente.
64 Il nardo era fatto – secondo Plinio il Vecchio – con le radici e le foglie di una pianta della famiglia delle valerianacee che cresce sui fianchi dell’Himalaya. Era molto costoso. Trecento denari corrispondevano alla paga di circa 300 giorni di un contadino.
65 Secondo le prescrizioni di Dt 16,6 la pasqua doveva essere consumata la sera in ricordo della notte di liberazione dall'Egitto.
66 Qualche esegeta ha sottolineato che parlare di un uomo che portava una sola brocca per l'acqua è una cosa molto strana, in quanto se ne portavano sempre due per non dover fare due viaggi.
67 Da notare però che nella cena pasquale tutti intingono dal piatto comune che contiene una salsa di frutta.
68 Non esiste nessun testo dell'A.T. che parli esplicitamente del tradimento del Figlio dell’uomo. Marco in realtà forza l'interpretazione di Is 53,8 e Sal 40,10.
69 Ci si chiede, a questo punto, come avrebbe potuto Pietro fare considerazioni del genere se non avesse avuto a disposizione una tomba vuota. Non è stato certamente un caso che nel vangelo di Matteo i redattori abbiano deciso di far controllare ad alcune guardie l'accesso al sepolcro di Gesù: dovevano in qualche modo rispondere all'accusa che il trafugamento del corpo era stato operato dagli stessi discepoli.
70 Difficile non vedere qui un'influenza della teologia paolina, di molto superiore a quella petrina.
71 Qualche esegeta è arrivato addirittura a proporre di tradurre la parola "corpo" con la parola "cadavere", poiché in greco ci starebbe, tant'è che una antichissima versione siriaca del vangelo l'ha fatto. D'altra parte, stando a Gv 6,51-58, che pur non prevede alcuna "eucaristia" nel corso dell'ultima cena, si dovrebbe usare la parola "carne" in riferimento al corpo di Cristo. In ogni caso sembra che gli evangelisti non avessero la minima cognizione della Kasherut, cioè di tutte quelle minuziose prescrizioni su quali tipi di carne si possono mangiare e su come vanno macellate.
72 Non viene detto che Giuda era assente, quando invece doveva esserlo per forza, altrimenti tale spostamento sarebbe incomprensibile. In Gv 13,27 è infatti chiarissimo che Gesù gli aveva ordinato di compiere una missione molto importante in un tempo molto ridotto.
73 Si badi che in questi versetti Dio potrebbe anche non esistere, in quanto potrebbe corrispondere semplicemente all'ideale che un uomo qualunque si prefigura o s'immagina, di fronte al quale si chiede fino a che punto sia giusto sacrificarsi.
74 Curiosamente qui Marco usa in greco la stessa parola che più avanti userà per indicare la Sindone, forse per mostrare le due differenti modalità di fronte alla morte: paura e rassicurazione.
75 Nell'udienza davanti a Caifa, dopo la sentenza capitale, Gesù viene sottoposto a varie vessazioni inaudite per un consesso come il Sinedrio. "Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: Indovina. I servi intanto lo percuotevano" (14,65). In genere si velava la faccia a quelli che dovevano essere impiccati (cfr. Est 7,8). Nel quarto vangelo un trattamento del genere lo subisce ad opera dei soldati romani e senza alcun riferimento mistico circa la possibilità di poter indovinare, a volto coperto, chi poteva averlo colpito.
76 Persino Luca (22,66-71), che pur non sa nulla delle usanze giudaiche, è stato costretto a scrivere che la condanna a morte da parte dell'intero Sinedrio non sarebbe mai potuta avvenire di notte.
77 Qui gli esegeti cattolici spesso si trovano piuttosto imbarazzati, in quanto vorrebbero sostenere che la riunione si tenne a casa di Caifa e non nella sala di convegno del Sinedrio, al Tempio, per dare un carattere privato all'interrogatorio, quando però la sentenza di morte, nella versione di Marco, ebbe un tono molto solenne.
78 Qui l'evangelista sembra voglia approfittare persino del fatto che, se solo si fosse seguita alla lettera la procedura giudiziaria giudaica, avrebbero dovuto liberare Gesù, in quanto la legge esigeva almeno due testimoni concordi perché l'accusa fosse riconosciuta valida (Dt 17,6; 19,15). P.es., nella storia di Susanna è appunto il disaccordo tra i due testimoni che permette di assolvere l'accusata (Dn 13,52-60).
79 L'eroe dell'ultima rivolta ebraica contro l'imperatore Adriano, Simon Bar Kokheba ("figlio della stella"), si era autoproclamato messia nel 132, poi principe d'Israele e infine re di Giudea. Siccome combatteva per la conservazione del mondo nativo tradizionale, ivi compresa la sua teocrazia sacerdotale, il Rabbi Akiva, il settimo sapiente più citato della Mishnah, non ebbe alcuna difficoltà a riconoscerlo. Furono entrambi uccisi dai Romani, ma dopo la sconfitta di quella ribellione, i rabbini ebrei fecero piombare la damnatio memoriae solo su Bar Kokheba, che per disprezzo arrivarono a chiamare "Bar Koseba", cioè "figlio della menzogna".
80 Con l'articolo davanti al nome, "il Benedetto" diventa un modo di dire tipicamente ebraico, per evitare di pronunciare il nome di Dio. Come nome di persona è usato solo qui nel N.T.
81 Inutile quindi dire – come fanno taluni esegeti – che Caifa era ostile ai Romani in quanto non riconosceva all'imperatore la pretesa "divinità". Se per i Romani la religione aveva davvero un forte potere eversivo, avrebbero cercato di distruggere la Palestina molto tempo prima del 70. Vi è anche chi attribuisce al solo Pilato la sentenza di morte nei confronti del Cristo, esonerando Caifa da ogni responsabilità politica, in quanto il Sinedrio non aveva la necessaria autonomia per emettere sentenze del genere. Ma sono considerazioni che non tengono conto del fatto che la strategia di Gesù non era solo contro Roma ma anche contro la casta sacerdotale del Tempio. Non è possibile, quando si denuncia l'antisemitismo dei vangeli, arrivare a giustificare completamente l'operato delle autorità giudaiche. Se queste, col solo potere giudiziario, non politico, avessero avuto il potere di ucciderlo, l'avrebbero fatto tranquillamente. Peraltro con Stefano (come detto negli Atti degli apostoli) lo fecero, o comunque non fecero nulla per impedirlo, né processarono chi l'aveva linciato o chi addirittura aveva permesso esplicitamente di farlo, cioè Saulo di Tarso.
82 Secondo Lc 23,51 la decisione non fu unanime, in quanto Giuseppe d'Arimatea non vi aderì. Ma se davvero fosse giusta la versione marciana, sarebbe stato impossibile non essere d'accordo con Caifa.
83 È la stessa espressione già detta in 13,26.
84 Il titolo di "figlio di dio" era più che altro di origine pagana: non a caso lo si trova in riferimento a Pitagora, Platone, Augusto, Apollonio di Tiana... Quest'ultimo, addirittura, filosofo neo-pitagorico di Tarso e contemporaneo di Gesù, operava esorcismi, guariva paralitici, ciechi, ossessi, ha risuscitato una fanciulla, ha placato una tempesta marina e, alla fine, è risorto e asceso al cielo. Anche l'imperatore Vespasiano – secondo Tacito – guarì un paralitico e restituì la vista a un cieco, spalmando sugli occhi un miscuglio di saliva e polvere. Lo stesso Marco (9,38) sostiene che anche i nemici di Gesù operavano miracoli (in Mc 3,22 gli scribi riconducono al demonio i miracoli di Gesù, ma non li negano).
85 Cristo non avrebbe mai potuto parlare in una maniera così mistica, quale quella riportata dai vangeli, poiché se l'avesse fatto, nessuno sarebbe stato in grado di capirlo: il che avrebbe anche potuto essere interpretato come una forma di presa in giro di persone ignoranti, che nulla sanno dei misteri divini, della vita ultraterrena e altre amenità del genere.
86 Sulla base della stessa accusa fu condannato Socrate, ma non è da escludere che Platone celi il vero motivo della condanna, quello politico.
87 Stranamente però neppure nel quarto vangelo, di fronte alla testimonianza del parente di Malco, si assiste a una reazione adeguata da parte delle guardie. Infatti, se in Marco le guardie potevano pensare che Pietro, nonostante la sua parlata galilaica e le testimonianze a suo carico, potesse anche dire il vero, in Giovanni avrebbero fatto fatica a crederlo. Quindi nel quarto vangelo deve per forza essere accaduto qualcosa che si è preferito non riportare. Il fatto stesso che l'apostolo Giovanni fosse noto negli ambienti dell'ex sommo sacerdote Anania ha indotto non pochi esegeti a sospettare qualcosa intorno alla sua persona, ammesso ch'egli fosse il cosiddetto "discepolo prediletto" di Gesù.
88 Anche su questo gallo vi sono state una ridda di interpretazioni esegetiche, in quanto era proibito, per motivi di purità sacerdotale, l'allevamento di gallinacei a Gerusalemme. I sacerdoti poi non potevano allevarli in nessuna parte d'Israele. Questo tuttavia non esclude che qualcuno potesse tenerlo come una sorta di orologio biologico per indicare l'arrivo del mattino.
89 Si ricordi che nel Gesù di Marco la preveggenza è totale, salvo quella relativa alla fine dei tempi, di esclusiva spettanza di Dio-padre. A ciò Pietro è stato costretto in quanto doveva trovare una giustificazione alla mancata parusia trionfale, che pur egli aveva assicurato come imminente al movimento nazareno, onde dissuaderlo dal compiere l'insurrezione.
90 Il processo si svolge nel Pretorio, nella collina occidentale dove aveva sede l'antico palazzo di Erode il Grande.
91 Si noti come la domanda "Non rispondi nulla?" è la stessa già posta dal sommo sacerdote Caifa (Mc 14,60), e qui è impossibile non vedere come Marco insista nell'identificare Gesù col "servo sofferente" di Isaia 53,7.
92 La corona di spine, la veste di porpora e l'omaggio in ginocchio erano propri della dignità regale.
93 In Palestina, dopo la morte di Erode il Grande, furono crocifissi duemila ribelli per ordine del legato romano Varo. Nell'anno 7 Giuda il Galileo subì la stessa sorte per aver provocato un movimento di opposizione ai Romani (cfr. At 3,37). Curioso il fatto che Marco metta in bocca alla folla il verbo "crocifiggere" all'attivo per sottolineare la responsabilità di Pilato, mentre in Mt 27,22 il verbo è al passivo: "Sia crocifisso", che scarica sulla folla le conseguenze del gesto.
94 Alcuni esegeti lo ritengono nativo di Kyrenia, nell’isola di Cipro, da cui proviene anche Barnaba, zio di Marco.
95 Le cose che appartenevano ai condannati toccavano di diritto ai soldati incaricati dell'esecuzione; ma Marco è molto più interessato al compimento del Salmo 21,19.
96 Per capire i tre giorni bisogna in realtà rifarsi ai miti pagani di Mitra, Dioniso, Attis, Osiride, Tammuz, ecc.
97 Si noti – ma ciò può apparire una sciocchezza a un'esegesi laica – come il significato delle parole cambi se si scrive "è risorto" invece che "è stato risorto"; in questo secondo caso si tende ad attribuire l'azione a Dio, mentre nel primo caso Dio potrebbe anche non esistere. Lutero, in tedesco, non tradusse neppure la parola "risorto" (ἐγείρω); si limitò a scrivere: "Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso; non è qui. Questo è il luogo dove l'avevano deposto!".
98 La prima tesi è stata sostenuta, per la prima volta, da H. S. Reimarus; la seconda da Charles Freeman.
99 C'è chi pensa fosse Gerico, in quanto Mc 10,46 fa entrare Gesù in questa città senza fargli compiere o dire niente. Ed è a partire da Gerico che inizia il viaggio verso la capitale, mentre nel quarto vangelo è a partire da Betania di Giudea.
100 A dir il vero si può anche capire che il Cristo chiedesse ai discepoli di non avvalorare l'idea ch'egli potesse essere un messia secondo la tradizione ebraica, per la quale non si doveva fare alcuna differenza tra contenuto politico e religioso del messaggio di liberazione e per la quale il messia doveva essere uno di tendenza monarchica, grande come Davide e Salomone. Tuttavia non è credibile ch'egli chiedesse di non avvalorare alcuna idea di liberazione politico-nazionale, come risulta dal vangelo marciano. Semplicemente questa idea andava realizzata democraticamente, con la partecipazione dell'intero popolo d'Israele, a prescindere dall'atteggiamento nei confronti della fede religiosa. Il primo esegeta ad aver affrontato la questione del "segreto messianico" è stato W. Wrede all'inizio del secolo XX.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube