- "Per la conoscenza delle mentalità
di una società è indispensabile uno studio preliminare delle
istituzioni scolastiche, delle loro strutture, dei metodi, delle nozioni
che intendono trasmettere, delle loro attrezzature, del loro inserimento
nella società, di ciò che le lega agli altri nodi, familiari,
militari, religiosi, politici" [nota
1].
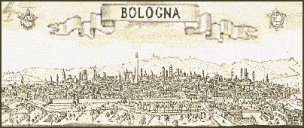
- L'affermazione di Georges Duby appare
assolutamente vera anche nel caso di Bologna, infatti lo studio della vita
degli studenti contribuisce a descrivere non solo una mentalità
sociale, in funzione delle risultanze ideologiche e professionali determinate
dal processo insegnamento/apprendimento, ma persino un significativo spaccato
di vita cittadina.
- Tale spaccato, a prescindere dai possibili
stereotipi, chiarisce particolari aspetti della quotidianità o della
"eccezionalità" riferibili anche all'esistenza del cittadino
comune: l'emergenza alloggi, gli affitti da pagare, i danni provocati dai
fittavoli, gli stupri, i rapimenti, le violenze, le spese da affrontare
giorno dopo giorno e diverse problematiche d'intolleranza, generate dallo
stretto confronto tra abitudini locali e "altre" usanze.
- Ricostruire le vicende di un gruppo,
nel nostro caso gli studenti, o leggere il momento focale di una singola
esistenza, può fornire la chiave di accesso ad una forma d'indagine
microstorica che accoglie tra i suoi "reperti" anche sentimenti
e comportamenti umani.
- Le testimonianze esaminabili sono
fornite prevalentemente da chartularia (atti notarili tratti dai memoralia
communis), epistole, cronache, statuti, monumenti scultorei e spazi architettonici.
Si tratta di fonti che lasciano trasparire anche il dato evenemenziale
e perciò non sono esenti dal rischio d'indeterminazione che caratterizza
l'affiorare dei temi narrativi.
- Un importante documento di stampo
letterario, relativo alla vita degli studenti, è costituito da una
cronaca in versi di un anonimo poeta bergamasco, maestro di grammatica,
redatta tra il 1162 e il 1166, che descrive l'incontro (1155) di Federico
Barbarossa con i rappresentanti della città di Bologna.
- Tra costoro figurano anche dottori
e studenti, a proposito dei quali il sovrano mostra vivo interesse: "Domanda
infatti come siano trattati in città, per qual ragione essa piaccia
più di qualsiasi altra e se i cittadini siano spiacevoli in qualche
atteggiamento, se siano fedeli e senza inganno alla promessa data, se li
considerino cari, se rispettino i diritti di ospitalità. Rispondendo
a queste cose un dotto maestro descrive le abitudini e la vita felice degli
studenti: Noi - dice- abitiamo, o grande re, in questa terra ricca e molto
idonea a chi studia. Da varie parti del mondo, confluisce qui una folla
desiderosa d'apprendere; vi portiamo talenti d'oro e d'argento, monete,
tessuti e vesti. Alloggiamo nel centro della città, in case, adatte
alle nostre esigenze. Compriamo ciò che serve a tutti a giusto prezzo,
eccetto l'acqua che è considerata bene comune. Notte e giorno manteniamo
la mente intenta agli studi. E questa ci sembra una dolce fatica, per tutto
il tempo in cui siamo qui" [nota
2].
- L'unica lamentela riguarda la consuetudine
della cosiddetta "rappresaglia", che consente a un cittadino
bolognese, danneggiato da uno straniero, di rivalersi su un qualsiasi altro
connazionale residente in città. Si tratta di una palese ingiustizia,
che il Barbarossa emenda tre anni più tardi mediante il provvedimento
conosciuto come Autentica Habita: "Con questa legge generale e valevole
per sempre, abbiamo stabilito che da adesso in poi non si ritrovi alcuno
tanto audace da presumere di offendere in qualche modo gli scolari, e da
imporre loro un debito per causa di qualcuno della medesima provincia,
cosa accaduta, come sentimmo dire, a ragione di una perversa consuetudine"
[nota 3].
- I documenti comprovano assai bene
che, dal tempo della dieta di Roncaglia in poi, la collettività
dello Studio, l'istituzione didattica composta da docenti e discenti, era
ormai diventata una forza di fatto interagente con le strutture sociali
cittadine.
- Il processo di adattamento urbanistico
in funzione delle esigenze di residenza degli studenti dovette plasmarsi
in modo progressivo e sistematico proprio a partire dal XII secolo. Agli
ultimi decenni di quello stesso secolo si fa risalire infatti il fenomeno
di costituzione delle Universitates scholarium [nota 4],
ossia delle confraternite o corporazioni di studenti Citramontani e Ultramontani.
|
 |
- Peraltro le soluzioni architettoniche
elaborate a Bologna sembrano esaltare la gestione ottimale degli spazi
collettivi: i portici, ad esempio, furono polivalenti luoghi di aggregazione
e scambi commerciali, perfettamente al riparo dalle intemperie e dal luto
maleodorante delle strade.
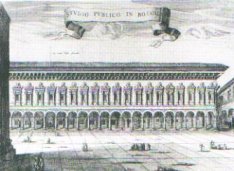 |
- Prima della costruzione dell'Archiginnasio,
quale sede accentrata dello Studium universitario, la zona degli
studi era ubicata nel settore meridionale di Bologna, riconoscibile in
base alle emergenze ecclesiastiche e ai poli culturali di San Francesco,
San Petronio, San Domenico e San Procolo.
|
- Le lezioni e le dispute cominciavano
alla mattina, al suono della campana di S. Pietro, detta la "scolara"
e si protraevano sino alle 19.00. L'anno scolastico iniziava il 10 ottobre
e proseguiva fino al termine di agosto [nota
5]. Oltre al mese di settembre, gli studenti usufruivano di giorni
di vacanza mensili, delle domeniche e delle sacre festività. Dobbiamo
immaginare attività di studio, approfondimento e ricerca svolte
secondo dinamiche di operatività collettiva. Pertanto le modalità
di insegnamento/apprendimento erano improntate ad un modello comunicativo
fortemente discostato rispetto alla identificazione del ruolo del ricercatore
e dello studioso solitario.
- Un attento spoglio degli atti della
curia del podestà ha consentito di censire la presenza degli studenti
a Bologna, tra il 1280 e il 1350, anche in rapporto alla loro provenienza,
come si rileva dal prospetto sotto riportato [nota
6].
| Citramontani |
|
Ultramontani |
|
Piemonte
Liguria
Lombardia
Emilia
Toscana
Sardegna
Umbria
Romagna
Veneto
Friuli
Lazio
Marche
Italia Meridionale
Sicilia
Citramontani |
50
35
48
68
230
1
53
28
24
7
35
46
16
22
663 |
Francesi
Provenzali
Borgognoni
Normanni
Inglesi
Scozzesi
Catalani
Spagnoli
Polacchi
Ungheresi
Tedeschi
Boemi
Ultramontani |
11
13
9
4
13
2
12
14
5
16
68
11
178 |
NOTE
1. GEORGES DUBY, L'histoire et
ses méthodes, Parigi 1961.
2. Per la fonte corrispondente in
lingua latina clicca
qui.
3. Per la fonte corrispondente in
lingua latina clicca
qui.
4. In età medievale, la parola
Universitas non è assimilabile allo specifico significato
odierno del termine università, ma designa ogni associazione di
uomini finalizzata a difendere interessi comuni.
5. Statuti delle Università
e dei collegi dello Studio bolognese, a cura di C.Malagola, Bologna,
Zanichelli 1888.
6. Per verificare la completa elaborazione
dei dati stessi, si consulti il saggio di ANTONIO IVAN PINI, Discere
turba volens. Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello
studio alla metà del '300, in Studi e memorie per la storia
dell'Università di Bologna, vol. VII, Bologna, presso Istituto
per la Storia dell'Università, 1988.

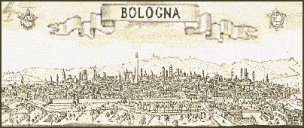

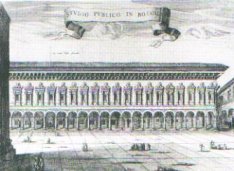
![]()