TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
JACQUES DERRIDA - IL PENSIERO
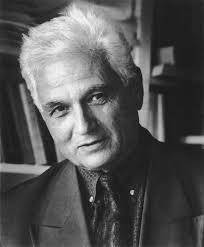
A cura di Diego Fusaro
Scrivere, significa ritrarsi... dalla scrittura. Arenarsi lontano dal proprio linguaggio, emanciparsi o sconcertarlo, lasciarlo procedere solo e privo di ogni scorta. Lasciare la parola... lasciarla parlare da sola, il che essa può fare solo nello scritto."
PREMESSA
Un rilievo particolare va fatto sulla "scrittura" di Derrida, poiché essa è essenziale per il suo discorso filosofico. La produzione di questo pensatore (si calcola che sino a oggi consti di circa 70 libri e di uno sterminato numero di saggi, per la maggior parte tradotti m moltissime lingue) è quanto mai varia e veramente inusuale per un filosofo, spaziando m campi estremamente eterogenei e misurandosi allo stesso modo con testi filosofici e letterari (Hegel, Husserl, Heidegger, Nietzsche, Mallarmé, Blanchot, Baudelaire Celan ecc).
Ancor più sorprendente è il carattere specificamente testuale di tali scritti, cioè la loro strutturazione e la loro "materialità". Derrida stesso, riferendosi ai rapporti di reciproco rimando intercorrente tra i suoi testi, parla di "strana geometria " o di "labirinto" (in "Posizioni"). Il loro carattere innovativo sfiora lo sperimentalismo in testi come "Envois", il cui carattere epistolare è indissociabile dal "contenuto", o "Tympan" (in "Margini della filosofia") e "Glas", la cui struttura interna non si presta ad una lettura tradizionale: essi si presentano infatti come un innesto di brani che generano un testo ibrido, "mostruoso", al punto che non si sa più qual è il testo principale e quale il commento o la nota. Una tale strutturazione interna ha lo scopo di mettere in discussione quella "linearità del significante" che costituisce uno degli assiomi principali dello strutturalismo e che risulta strettamente connessa alla scrittura alfabetica e alla concezione occidentale del tempo come successione di istanti-presenti. Derrida è anzi uno dei filosofi più attenti a forme di comunicazione multimediale, che coniugano cioè diversi mezzi espressivi e comunicativi (parola, immagine, accorgimenti tipografici), che si svolgono su più livelli e che sono inseparabili dal medium stesso.
Il suo decostruzionismo incrina quella priorità dell'intelligibile sul sensibile che tradizionalmente si è espressa come secondarietà o addirittura inessenzialità dello scritturale e del materiale. Più che un certo voler-dire (senso, significato o contenuto) è infatti il come i testi funzionano e sono fatti il tema principale della decostruzione. Così, in La farmacia di Platone, egli mette in luce la contraddizione insita nello stesso pensiero di Platone: questi, infatti, da un lato condanna la scrittura, ma dall'altro lato definisce il pensiero come una forma di scrittura nell'anima.
BREVE INTRODUZIONE A DERRIDA
E' certamente uno dei filosofi più interessanti del nostro secolo: con Heidegger, Husserl e Lacan, ha contribuito ad una completa rivisitazione dei concetti e delle categorie proprie della filosofia classica occidentale. Alle sue opere, più recentemente, si sono ispirati o in qualche modo possono considerarsi vicini, quei pensatori particolarmente interessati al rapporto fra telematica e precarietà del soggetto. Abbagnano ha scritto che "al centro del progetto filosofico di Derrida troviamo l'idea di una decostruzione della metafisica della presenza che ha caratterizzato la tradizione filosofica occidentale".
Secondo Derrida, infatti, il carattere fondamentale della filosofia occidentale è il logocentrismo o fonocentrismo, fondato sulla metafisica della presenza, nel senso indicato dall'ultimo Heidegger. A questa tesi, tuttavia, Derrida arriva partendo dall'analisi del rapporto fra la parola o logos, inteso come voce, e la scrittura, anche alla luce del mito raccontato nel "Fedro" di Platone. A suo avviso, nella tradizione occidentale la voce gode di un primato in virtù del fatto che essa è percepita e vissuta come qualcosa di presente e di immediatamente evidente: nella parola parlata è sempre immanente il logos. La scrittura, invece, è caratterizzata dall'assenza totale del soggetto, che l'ha prodotta: il testo scritto gode ormai di vita propria. Compito della grammatologia, dove "gramma" è assunto nel senso originario di lettera scritta dell'alfabeto, è di mirare alla comprensione del linguaggio a partire dal modello della scrittura, non dal logos. La forma scritta, sottraendo il testo al suo contesto di origine e rendendolo disponibile al di là del suo tempo, ne garantisce la sua decifrabilità e leggibilità illimitata.
Su questa base si rende possibile quella che Derrida chiama la différance, un termine da lui coniato che include i due significati cristallizzati nel verbo "differire". In un primo senso, esso implica che il segno è differente da ciò di cui prende il posto e, quindi, che tra il testo e l'essere a cui esso rinvia c'è sempre una differenza, uno scarto che non può mai essere definitivamente colmato, ma lascia sempre soltanto tracce, da cui si diparte la molteplicità delle letture e delle interpretazioni. Ma, in un secondo senso, "differire" significa anche rinviare, rimandare e, quindi, mettere una distanza tra noi e la cosa o parola assente nel testo: ciò vuol dire uscire dal primato della presenza, che caratterizza il logocentrismo.
La "différance" equivale ad un accadere indipendente dai soggetti che parlano e che ascoltano, è un evento nel senso heideggeriano. Essa è agli antipodi della identità e della presenza: per questo, nei testi la verità non è originaria né unitaria né mai totalmente data, ma si trova come disseminata.
E' possibile, dal momento che inevitabilmente siamo entro il linguaggio costruito dalla ragione, andare oltre il logocentrismo e la metafisica della presenza? Secondo Derrida questa strada è percorribile non costruendo nuove teorie, incentrate sulla violenza del logos che pretende di essere cogente e definitivo, ma adottando una diversa strategia di lettura dei testi, che egli chiama decostruzione e che ha avuto notevole influenza anche sulla critica letteraria, soprattutto nordamericana.
Derrida non definisce né analizza articolatamente che cosa significhi decostruzione, ma lo mostra in atto nelle letture a cui sottopone testi della tradizione filosofica o letteraria. In generale, si può dire che la decostruzione sia la messa in opera della "différance" nella lettura dei testi, ossia l'atto di compiere il processo inverso rispetto a quello che ha portato alla costruzione del testo, smontandolo e rovesciandone le gerarchie di significato, che la metafisica della presenza tende a privilegiare, trattando le opere di filosofia come opere di letteratura e viceversa, giocando sulle opposizioni, sui rimandi, sulle somiglianze casuali, su ciò che sta ai margini nel testo, in modo da sottrarsi al desiderio della definitezza. La decostruzione, più che una pratica teorizzabile e ripetibile, è qualcosa di simile all'esecuzione artistica. Attraverso la decostruzione è, secondo Derrida, possibile che si aprano varchi attraverso i quali intravedere ciò che viene dopo il compimento della nostra epoca, ossia al di là dell'epoca della metafisica.
Derrida ha ripreso il pensiero di Heidegger risolvendo nello strutturalismo le sue riflessioni su due temi:
- Il rapporto tra svelarsi e velarsi dell'Essere
- Il rapporto tra destinarsi dell'Essere e linguaggio.
Lo strutturalismo linguistico ha capito che il linguaggio, il discorso è fatto dalle differenze nel loro sistema di rapporti (che ha dei contenuti ma questo fatto è secondario in quanto i contenuti sono un aspetto del sistema, l'aspetto variabile: non ci sono discorsi sulla verità): per lo strutturalismo c'è il ripetersi infinito dei linguaggi e delle differenze, non una verità delle frasi. Heidegger ha capito che il linguaggio ed il discorso, soprattutto quello poetico, è la "casa" del destinarsi dell'essere all'uomo; essere che però decide se svelarsi o no nelle varie epoche.
Derrida sostiene invece che tra l'Essere e il linguaggio c'è, come abbiamo visto, un rapporto di "différance" (Derrida scrive differance: la scrittura corretta del termine francese è difference: la pronuncia dei due termini è la medesima, anche se si scrivono in modo diverso). L'essere si "differanza" nel linguaggio, l'Essere si media nel linguaggio, si aliena però nel linguaggio, diventa altro da sé, si rende presente ma assente nello stesso tempo, diventa segno, diventa traccia. La verità si trasforma in traccia, si contamina, si intacca nel linguaggio che è segno, si dà nel linguaggio ma nega di essere quello che è il linguaggio stesso. Non c'è dunque nessun linguaggio privilegiato; quello poetico è equivalente a quello filosofico concettuale anche se è più vivo e meno preciso.
In tutti e due i casi non si può dire che il linguaggio ti faccia "arrivare" alla verità e nemmeno che nel linguaggio ci sia il darsi delle verità e dell'essere; ci sono solo tracce della verità, c'è la "differance" dell'essere nelle tracce di sé. La verità (essere) è differantesi-differente nel-dal linguaggio. Si sa ciò che il linguaggio dice ma la verità, l'essere è il non detto del linguaggio. L'essere non si destina all'uomo nel linguaggio, ma si "differanza" nel linguaggio, e ciò di cui il linguaggio è "traccia" e solo traccia; traccia non è "niente" - come dice lo strutturalismo - ma non è nemmeno la cosa, l'Essere, la presenza.
Ma cosa esiste allora? Esiste il parlare, il creare rapporti tra gli uomini e il comunicare con il sistema delle comunicazioni; questo parlare però non contiene l'Essere, ma solo le sue tracce. La "grammatica" del testo scritto è il luogo dove "si aliena" l'Essere: non la "voce" in cui è meno evidente il "farsi differanza" dell'Essere: ma la "grafia", il "segno scritto", la "scrittura", dove questo "farsi altro" è più "evidente".
Derrida usa il termine "differance" perché privilegia la scrittura sulla parola e soltanto scrivendo questa parola si riesce a capire il suo significato. La verità-l'essere non è nel "testo scritto" ma è "tra le righe", "nell'interlinea" del testo scritto, nel "non detto" del testo scritto di cui il testo è la "traccia". Forse, dice Derrida con un altro paragone, noi abbiamo non l'Essere, ma il suo "simulacro", una statua dell'essere, una "parvenza" dell'essere.
In questa situazione, il lavoro del filosofo è far capire che esiste questo "qualcosa" che è "fra le righe" del testo, capire che è "differance" non "Identità", che è traccia dell'Essere e non presenza. Il compito del filosofo sarà quello allora di "decostruire" i testi, cioè smontarli, metterli in crisi, contraddirli. Chi compie quest'opera permette al lettore di capire che in esso non c'è l'essere, ma l'essere è oltre il testo, che nel testo ci sono solo le sue "tracce".
In questo modo il filosofo giunge, attraverso il suo lavoro di decostruzione, anche a forme di potere che stanno sotto a certi discorsi fatti passare per veri: decostruire è anche chiedersi: chi dice una cosa del genere? Da chi è fatto il discorso che stiamo leggendo? Con che scopo fa questo discorso? A chi giova questo discorso? Decostruire un discorso, "glossarlo", "scrivere nei suoi margini" un commento che lo demolisce, farne la "parodia" è mettere in crisi la sua pretesa di essere luogo della verità e nello stesso tempo smascherare chi usa questo testo per il suo potere: questo è per Derrida fare filosofia.
In questo modo si capisce che il vero modo in cui si aderisce alla verità è quello del "colpo di dadi"; quello in cui a caso scegli la tua opinione, decidi che in quel testo c'è l'essere (la verità): ma così facendo conferisci a quel testo un valore veritativo che esso non ha (e il filosofo ha il compito di dimostrartelo). Il colpo di dadi, la decisione senza motivo, avviene perché non si è perfettamente coscienti che la verità è nello "spazio vuoto", che è in mezzo a "indecidibili" opposti. E' così o cosà? Dentro o fuori? Prima o dopo? La risposta è "né l'uno né l'altro", ma lo spazio che è tra l'uno e l'altro, la "sbarra" che divide l'opposizione (quando scrivo dentro/fuori metto tra la parola "dentro" e la parola "fuori" una "sbarra" trasversale: la risposta è in "quella sbarra"), l'interlinea, l'indecidibile, il qualcosa che non sopporta la decisione.
Derrida cerca una via media tra nichilismo e ontologia, fra strutturalismo e metafisica della presenza e lo fa nella direzione della decostruzione del discorso basato sul testo scritto. E' in fondo una forma di "apofantismo" (posizione per cui la verità non può essere detta. Forse la verità si coglie ma non si può dire. E' una forma di "scetticismo", seppure molto "raffinato").
Per una confutazione ("decostruzione") di questo pensiero si può adoperare, "raffinandole", le consuete obiezioni per gli scetticismi: anche il dire che l'Essere "si aliena" ("si differanza") ed è "indecidibile", costituisce un'"affermazione" che implica un'istanza veritativa; anche tematizzare la "differanza" è un "colpo di dadi"? Anche affermare il "colpo di dadi" come il "vero" modo di tematizzare il venire-dell'-uomo-all'-essere (verità) è frutto di un "colpo di dadi"? Queste domande pongono lo scettico "post-heideggeriano" di fronte alla "necessità del pratico", che è l'istanza ultima anche del "paradosso" di Aristotele ("quando dici che non vuoi filosofare, stai filosofando"): è inevitabile "agire" (anche quando questo agire è costituito dal "decostruire" i discorsi che mascherano interessi di potere) e nel "volere" di questo "agire" è implicito un "affermarne" la "bontà-verità", è implicita - in altri termini - un'"istanza metafisica": a questo non si sottrae, nonostante non lo metta a tema, neppure il neo-scetticismo di Derrida.
Il "colpo di dadi" dice l'atto dell'uomo libero in ordine al verificarsi del "dire è": ma lo dice in corrispondenza a un non-cogliere l'Essere, a un non-darsi a sufficienza dell'Essere (e ciò è la sostanza della "differance"): siamo alla denuncia di una presunta persistente sopravvalutazione paradossale dell'atto del soggetto di fronte alla persistente mancanza di realtà del darsi-dell'-Essere: il soggetto "pretende" di colmare la "sufficienza" di un essere che "non-si-dà-sufficientemente". Ma questa concezione è presentata come "vera", e non come "non-sufficientemente-dantesi".
Anche il modo con cui Derrida mette in relazione concetto e metafora potrebbe essere ripreso e indagato, in direzione dell'enucleazione dello "statuto simbolico" del "darsi-della-verità" in Gesù Cristo: Gesù è un "simbolo", cioè una "storia" con un "nocciolo-profondità" da mettere a tema (ermeneuticamente) "concettualmente" ma che non esaurisce il concetto: l'incontro con la "res" (referenza, aspetto oggettivo, istanza metafisica) avviene anche nella "metafora", in modo più vivo e ricco, e viene irrigidita e cristallizzata nel concetto, che precisa ma impoverisce.
L'essere - secondo Derrida - è stato da sempre considerato come pienamente attingibile grazie al linguaggio, mediante il quale la verità viene trasmessa da soggettività individuale ad una comunità, il che equivale ad oggettivare la verità stessa. Tuttavia, se la verità è evidenza intuitiva - ossia presenza di qualcosa davanti ad una coscienza presente a se stessa - debbono essere ridiscussi sia la struttura dell'esistente che quella della verità stessa. Quel che ora è - nella sua finitezza - ovvero il presente, è, in ultima analisi, un nulla differito e il nulla un essere differente.
In opposizione alla tradizione filosofica, che ha fondato la propria attività speculativa sull'assunto che esistono coppie concettuali che si risolvono dialetticamente, Derrida propone un'inversione di tale logica: il divenire precede l'essere e il nulla, e solo grazie alla differenziazione possono ri-costruirsi nuove soggettività. La de-costruzione, staccate dalle mode che ne hanno fatto un metodo di interpretazione, diventa per Derrida il progetto di un "nuovo, nuovissimo illuminismo ", la costante preoccupazione per l'altro verso e per cui dobbiamo coltivare un'etica dell'ospitalità, ovvero l'apertura verso un avvenire che accade senza essere atteso, ad un dialogo che procede dal rispetto e che pone il tema della differenza come punto imprescindibile di partenza per un incontro fra gli uomini: "come se lo straniero fosse innanzi tutto colui che pone la prima domanda, o colui al quale si rivolge la prima domanda (...); pertanto lo straniero, ponendo la prima domanda, mi mette in questione ".
Ecco il punto cruciale, secondo Derrida, del tema dello straniero, di "colui che viene da fuori", che "parla una strana lingua", che produce inquietudine e sospetto. "Lo straniero è in primo luogo straniero rispetto alla lingua giuridica nella quale sono formulati il dovere d'ospitalità, il diritto d'asilo, i limiti, le norme, i codici di polizia eccetera ". Il tema dello straniero per Derrida diventa, non solo metaforicamente, l'emblema di un'interrogazione che la società, ciascuna società, rivolge a se stessa: "come se lo straniero fosse la questione stessa dell'essere in questione". Grazie allo straniero la società non può fare a meno di interrogarsi sulla propria cultura, sulla lingua e le istituzioni giuridiche in vigore, in definitiva sul modo con cui attua una legge dell'ospitalità, "coinvolgendo l'ethos in generale". E del resto la parola latina "hostis" significa "ospite" ma anche "nemico". La costellazione semantica, nel suo ambiguo oscillare tra termini opposti (oste, ostile, ospizio, osteggiare...), sembra costituire la trama della nostra identità.
Ma c'è anche un secondo aspetto, non meno significativo: le ampie meditazioni di Derrida sulla sepoltura, sul nome, sulla memoria, sulla follia che abita il linguaggio, l'esilio e la soglia, "sono altrettanti segnali rivolti alla domanda del luogo, che invita il soggetto a riconoscere d'essere per prima cosa un ospite". Svolgendo quella che chiama "il teatro invisibile dell'ospitalità", il filosofo ripercorre alcuni tratti dell'elaborazione di Lévinas, in particolare quelli in cui afferma che "il soggetto è un ospite" o che "il soggetto è un ostaggio". La tesi centrale di Derrida è che vi è un'impossibile convivenza, una sorta di lacerazione tra "l'ospitalità incondizionata che va al di là del diritto, del dovere o addirittura della politica" e "l'ospitalità circoscritta dal diritto e dal dovere". In altri termini: "dando per buona l'ospitalità incondizionata, come dar luogo a un diritto, a un diritto determinato, limitato e delimitabile, in una parola calcolabile?". Il problema dell'ospitalità, conclude l'autore, "è sovrapponibile al problema etico".
L'AVVENIMENTO DELLA SCRITTURA
Il modello di testo che propone Derrida non è più omogeneo e padroneggiabile dall'autore che lo ha scritto, ma piuttosto strutturato in modo plurale e differenziale, pensabile come un tessuto di tracce e rinvii che ne fanno una manifestazione eventuale, un punto in perpetua trasformazione di un originario movimento di scrittura che impedisce qualsiasi sua riduzione ad una semplice forma di presenza. In realtà il proposito di Derrida sarà proprio quello di mostrare come ogni possibilità di presenza, di pienezza, di significato appartenga da sempre al movimento della significazione, ovvero a quell'"apertura della prima esteriorità in generale" che lega costitutivamente ogni presenza alla non-presenza dell'altro, ogni vita alla morte, ogni dentro ad un fuori.
Per comprendere correttamente la sua prospettiva non si dovranno però intendere tali termini all'interno di semplici strutture oppositive, che li ricomprenderebbero all'interno di una logica dell'identità, quanto piuttosto si dovrà tentare di pensarli come coppie che si sollevano da quel fondo, da quella "riserva" costituita dal modo di accadere della traccia (che è già doppia, mai semplicemente se stessa, sempre eccedente, rinviante ad altro), dal quel gioco che si crea tra i segni di un testo e che corrisponde al lavoro attivo e supplementare della dif-ferenza, ovvero alla legge strutturale anonima, eccentrica e nascosta che è sottintesa ad ogni movimento significante.
Al fine di ritrovare tale funzionamento autonomo dell'operazione testuale, Derrida propone così una pratica di lettura che, invece di proteggere i testi e di riconfermarli nella chiusura secolare da cui è nata la metafisica logocentrica e fonocentrica, li percorra sotterraneamente per aprirli dall'interno, guardando attraverso quella fessura che tali limitazioni, nonostante tutto, lasciano intravedere. L'intero progetto della Grammatologia può essere letto come un tentativo di decostruzione di quelle figure concettuali della metafisica occidentale che, formatesi in un preciso momento storico ed organizzatesi tutte attorno alla centralità di determinati nomi e forme verbali (quali ad esempio prossimità, immediatezza, voce, essere...), hanno assunto nel tempo una consistenza e una solidità tali da apparire come innocenti descrizioni linguistiche di strutture naturali ed eterne.
Il testo, in particolare, si apre con l'annuncio di un movimento del linguaggio appena percettibile, quello del "significante del significante", della lingua come scrittura, per cui essa, da semplice ed inconsistente doppio, "comincerebbe a debordare l'estensione del linguaggio", a comprenderlo e a contaminare con la sua esteriorità ogni possibilità in generale di significato: "L'avvenimento della scrittura è l'avvenimento del gioco; il gioco oggi si riconsegna a se stesso, cancellando il limite a partire dal quale si è creduto di poter regolare la circolazione dei segni, e trascinando con sé tutti i significati rassicuranti, costringendo alla resa tutte le piazzeforti, tutti i rifugi del fuori-gioco che vegliavano sul campo del linguaggio".
Tale avvenimento significa innanzitutto l'inizio della delimitazione dell'epoca metafisica, dominata dal privilegio della phonè, ovvero da un sistema linguistico che crede nella trasparenza e nella naturalità della sostanza fonica, nella vicinanza della voce alla presenza piena, e che da tale illusione produce l'idea di un senso esistente anteriormente, che non ha bisogno del significante per essere ciò che è, che può "aver luogo", nella sua intelligibilità, prima della sua "caduta" fuori, della sua trascrizione verbale e sensibile.
In tale struttura logocentrica la scrittura (come evidentemente appare nell'ideale della scrittura fonetica) scadeva al ruolo di tecnica rappresentativa, di strumento pratico per la traduzione di una parola piena e pienamente presente a sé e al suo significato. L'operazione di Derrida tenterà di mostrare invece come non solo tale concetto di scrittura abbia una portata storicamente limitata all'epoca della nostra cultura onto-teologica, ma che costituisca anzi la condizione stessa della possibilità dell'apparire e del mantenersi di tale epoca, "che si avvicinerebbe ora a ciò che è propriamente il suo esaurimento".
Esempio illuminante che testimonia questo stato dei fatti è quella che Derrida chiama "la morte della civiltà del libro": l'idea del libro è infatti quella di un luogo che riunisce in una presenza simultanea la totalità del significante, che può essere tale solo a patto che gli preesista una totalità di significato ("il libro della natura" o di Dio) che ne regoli così la sua iscrizione; è con tale operazione di "protezione enciclopedica" che l'epoca logocentrica si è opposta all'"energia dirompente, aforistica della scrittura", si è garantita cioè la possibilità della sua stessa sopravvivenza. "Ma se il Libro fosse solo, in tutti i sensi dell'espressione, un'epoca dell'essere... se la forma del libro non dovesse più essere il modello del senso?", solo in tal modo potrebbe farsi strada la possibilità di un illeggibilità radicale, originaria, non più in relazione ad una leggibilità perduta o non trovata, ma anteriore alla stessa epoca del libro.
L'annuncio della distruzione del libro rientra nel più ampio proclama della "morte della parola", della scomparsa "del primo significante", del privilegio dell'espressione orale come luogo di produzione dei primi simboli "in prossimità assoluta con l'essere", nelle vicinanze immediate con un senso interamente leggibile, e che permette di preservarlo dal movimento corrosivo ed ambiguo del processo della significazione.
Il modello di questo logos puro e naturale è contemporaneo all'epoca teologica, "il segno e la divinità hanno lo stesso luogo e tempo di nascita": come il verbo divino è parola assoluta di una soggettività creatrice infinita, che crea le cose solo nominandole, così il linguaggio della metafisica, anche se espresso tramite un soggetto umano e finito, disponendo della voce come significante puro, è ancora pensabile in un rapporto immediato con il senso. Quando poi, al momento dei grandi razionalismi del XVII secolo, si costituirà l'idea di una soggettività come presenza assoluta a sé, come coscienza intuitiva che avviene nell'evidenza di sé, tale logos corrisponderà alla voce interiore della coscienza che intende se stessa, all'espressione spontanea della propria verità ed interiorità che non trae dal di fuori nulla, e che fonda perciò la possibilità di un'esperienza originaria di un significato che si produce in un'ideale cancellazione del significante: "nella chiusura di quest'esperienza la parola è vissuta come l'unità elementare e indecomponibile del significato e della voce, del concetto e di una sostanza d'espressione trasparente".
Di contro a questa parola se-dicente, ad un "logos che crede di essere padre di se stesso", parola della vita (interiore) che sfugge al movimento del segno, la scrittura appare sempre seconda, istituita, "lettera morta e portatrice di morte", scrittura "del di fuori", perversa ed artificiosa, esiliata nell'esteriorità del corpo e delle passioni, ovvero in quel luogo ove si sono emarginate tutte le minacce all'unità del senso.
Sulla scorta del pensiero nietzscheano, Derrida vede invece nella scrittura (e nella lettura) un'operazione "originaria" nei confronti del senso (il che non vuol dire, per semplice inversione, "che il significante sia ora fondamentale o primo"), il rischio permanente che minaccia di "spezzare il nome", di immobilizzare nella ripetizione della lettera la creazione spirituale nella parola, di interrompere con uno sdoppiamento l'unità privilegiata e immediata del suono e del senso nella voce.
Benché infatti l'intenzione dichiarata dell'ideale di scrittura fonetica sia evidentemente quella di proteggere "l'integrità del "sistema interno" della lingua" dall'esteriorità della notazione, dal pericolo della raffigurazione, di fatto succede che essa da sempre non vi riesca: "quel modello particolare che è la scrittura fonetica non esiste; mai una pratica è fedele in modo puro al suo principio". Il fuori, ciò che dovrebbe rappresentare l'accidentale, l'inessenziale rispetto al dentro, alla logica interna ed interiore della parola, viene in realtà spesso analizzato con accenti che tradiscono una paura ingiustificabile verso ciò che dovrebbe solamente aggiungersi in modo esteriore ad una lingua inalterabile ed indipendente nella sua essenza.
Il "vestito" della parola si trasforma così in travestimento, intrattenendo un rapporto con la sostanza che ri-copre, "che è tutto meno che di semplice esteriorità", producendo piuttosto una serie di ambigui e al tempo stesso seducenti effetti di "inversione e perversione" tra immagine e cosa, tra grafia e parola, tra significante del significante e significante del significato: "in questo gioco della rappresentazione, il punto d'origine diventa inafferrabile"; la "perversione" di questo rincorrersi di rimandi risiede proprio nell'allontanare indefinitamente la possibilità di risalire chiaramente alla fonte e nel lasciar invece apparire solo l'avvicendarsi dei rinvii di specchi che sdoppiano in se stessi ciò che riflettono, facendo perdere la semplicità e la singolarità della sorgente.
Il punto è che per Derrida "l'usurpazione ci rimanda necessariamente a una profonda possibilità d'essenza", mettendoci ormai nella situazione di intravedere come tale operazione di inversione e di disseminazione non appartenga solo alla scrittura, non colga indebitamente, pervertendolo, l'ordine "naturale" di un linguaggio puro ed innocente, ma costituisca il modo di accadere proprio di ogni significanza: "la scrittura non è segno di segno, salvo dire questo, il che sarebbe più profondamente vero, di ogni segno".
Una volta preso atto di quella che Saussure denomina l'"arbitrarietà del segno", dell'istituirsi immotivato e convenzionale di uno spazio di iscrizione e distribuzione di differenze regolato da leggi autonome, si dovrebbe ormai essere nelle condizioni di escludere ogni possibile gerarchia o privilegio tra ordini di significanti. Superata la nozione di segno come immagine, come figura legata da rapporti di somiglianza con ciò che rappresenta, e quindi chiarito il funzionamento della lingua e della scrittura facendo riferimento alla capacità autonoma di sostenersi propria dei sistemi di segni, dovremmo ora esser nelle condizioni storiche di ammettere la "possibilità di un sistema totale di segni", in cui il collegamento tra significanti non è più modellato sul legame lineare che univa il suono al senso, ma avviene attraverso una "rete pluridimensionale" di rimandi, e lo apre così ad essere investito da ogni direzione possibile di ogni possibile senso.
Da qui il ricorso di Derrida alla nozione di traccia istituita per decostruire il concetto logocentrico di segno, e per offrirci un punto di vista non più fonocentrico entro cui elaborare un modo per concepire l'accadere della scrittura. La traccia è in primo luogo immotivata, il che non significa che sia in balia dell'uso dei singoli soggetti parlanti, ma semplicemente che non ha "nella realtà alcun 'aggancio naturale' col significato", ovvero che non è vincolata da alcun legame che, in maniera necessaria, sicura, univoca, le assicuri un unico modo di rinviare ad una presenza unitaria. Essa rappresenta la possibilità dell'annunciarsi del "totalmente altro" come tale, cioè dell'accadere, in ciò che non è esso stesso, di qualcosa il cui modo di esistere è "senza alcuna semplicità, alcuna identità..".
La differenza, infatti, per apparire come tale, non può mai presentarsi in maniera piena, ma solo nella dissimulazione del suo "come tale", ovvero attraverso una struttura di rimando in cui si segna il rapporto all'altro non disponendosi nella presenza del significato, ma piuttosto nel differimento, ovvero nel modo proprio della traccia.
In questo movimento del differire, la peculiarità del significante è quello di prodursi incessantemente come struttura di rinvio, di distrarsi continuamente da sé, di non essere mai prossimo, vicino, nella pienezza di sé. "Ciò che inaugura il movimento della significazione è ciò che ne rende impossibile l'interruzione. La cosa stessa è un segno": per Derrida una volta inaugurata la possibilità del senso, esiste solo il differimento dei segni, ovvero il gioco di rinvio di strutture doppie che funzionano solo in una rete di infinite potenzialità di significazioni, mai nella semplicità dell'evidenza intuitiva, nell'esperienza fenomenologica della forma pura della presenza.
Una volta chiarito da Saussure come la condizione del "valore linguistico", ovvero del potere di significazione del segno, risieda nel suo carattere differenziale, nel suo apparire solo entro una struttura di opposizioni, e superato a partire proprio da questa stessa direzione il pregiudizio fonocentrico, Derrida può suggerire, attraverso la nozione strategica di traccia, l'ipotesi di un linguaggio che sia sempre stato nelle condizioni della scrittura, segno di segno e mai parola piena. Ed è in tale scrittura totale (o archiscrittura) che si dovrà vedere la possibilità generale di ogni movimento di significazione, di ogni articolazione differenziale tra i segni e di ogni rapporto all'altro.
D'altra parte, il pensiero della traccia come "origine assoluta del senso", come "dif-ferenza che apre l'apparire e la significazione", ma che è essa stessa già da sempre in posizione di traccia, mai semplice presenza di senso, equivale anche al dire che non c'è alcuna origine assoluta del senso, alcun fondo anteriore, esistente solo come presenza piena e sottratto alla condizione del rinvio ad un passato, ad un qui-da-sempre, che la traccia ritiene sempre in sé: "lo strano movimento della traccia annuncia tanto quanto ricorda".
Non potendo perciò ricorrere a concetti metafisici organizzati tutti sulla semplicità e sull'omogeneità della presenza, si mostra come l'accadere della struttura della traccia non potrà prestarsi ad alcuna descrizione scientifica e positiva, a meno di tradirne la sua radicale passività, il suo rapporto costitutivo ad un passato assoluto che non potrà mai essere restituito all'evidenza della presenza.
Un altro modello utile ad illustrare l'accadere decentrato di un linguaggio non più dominato dal privilegio della voce è per Derrida quello offerto dalla "scrittura teatrale", visiva, immaginifica dei sogni: la parola, infatti, riveste nella sintassi onirica un ruolo paritetico agli altri elementi della messa in scena, ridiventando un gesto, un segno corporeo che non fa più da semplice tramite per un concetto, ma che si impone come una forma dotata di una fisicità che può avere un volume, effetti seduttivi ed emanazioni sensibili.
Tale scrittura psichica, più simile ad una geroglifica che ad una fonetica, è scrittura originale, primaria, irriducibile nel suo funzionamento a subordinata e posteriore trasposizione di una parola viva e piena, comportando aspetti ideogrammatici, pittografici, pluridimensionali e visivi che nella linearità della parola orale, della "catena parlata", tendono ad appiattirsi, fino a scomparire.
Anche dalla radicalizzazione di questo modello, dal decentramento rispetto alla metafisica della presenza in cui è ancora immerso, per Derrida si offre indirettamente la possibilità di attingere al senso di ogni scrittura in generale come a quello di un movimento della traccia, che, pur operando con elementi comunque codificati (lungo il corso di una storia individuale e collettiva), è costitutivamente cancellazione di sé, non permette di essere avvicinata da alcun codice di lettura che la esaurisca.
Ogni segno, verbale o non-verbale, può funzionare infatti a diversi livelli, entrando in configurazioni che non sono "prescritte" da una sua essenza, ma che scaturiscono dal gioco incessante della differenza, dal suo essere preso in una rete pluridimensionale di rimandi percorribile in direzioni non prestabilite.
I segni così appaiono articolati come degli "indovinelli figurati", come dei rebus mai leggibili a partire da una chiave interpretativa universale; così come avviene per colui che sogna, ogni esperienza inconscia "inventa la propria grammatica", "produce i propri significanti", introducendo nelle sue operazioni un "residuo puramente idiomatico", un "corpo verbale" che inaugura ogni volta una nuova significanza e limita così definitivamente ogni possibilità di traduzione. Essendo quindi la materialità, il corpo dell'espressione verbale a lavorare ed agire nel sogno, ad imporsi e a non lasciarsi attraversare o trascurare a favore del significato (come avviene invece nel discorso cosciente), appare chiaro come qualsiasi sua traduzione completa sia impossibile, dovendo ogni passaggio ad un altro significante lasciar cadere proprio il corpo all'opera.
Messe in relazione al soggetto parlante, la passività della traccia e la sua struttura differenziale ci rimandano all'incoscienza fondamentale del linguaggio, al radicamento della parola cosciente nella lingua che la eccede e la costituisce; ma per evitare il semplice rovesciamento di una metafisica della soggettività in una speculare "metafisica della scrittura", Derrida sottolinea che "Costituendolo e dislocandolo ad un tempo, la scrittura è altro dal soggetto, in qualsiasi senso lo si intenda. Essa non potrà mai essere pensata sotto al sua categoria; in qualsiasi modo modificata, sia essa affetta in modo cosciente o inconscio, essa sarà legata, per tutto il filo della sua storia, alla sostanzialità di una presenza impassibile sotto gli accidenti, o all' identità del proprio nella presenza del rapporto a sé".
Per descrivere la situazione di un soggetto che è consegnato a un linguaggio che continuamente lo disperde è esemplare, a questo proposito, per Derrida la figura del poeta, l'"uomo della parola e della scrittura" per eccellenza. Egli è al tempo stesso il soggetto del libro, la sua sostanza e il suo padrone, e il suo oggetto, suo servitore e tema. Mentre il libro è articolato dalla voce del poeta, il poeta si trova ad essere modificato e letteralmente generato dallo stesso poema di egli cui è il padre, ma che producendosi si spezza e si piega su se stesso, diventando soggetto in sé e per sé: "la scrittura si scrive, ma insieme si immerge nella propria rappresentazione".
In questa situazione, l'unica esperienza di libertà a cui il poeta può accedere, la sua "saggezza" consiste tutta nell'attraversare la sua passione, ovvero nel "tradurre in autonomia l'obbedienza alla legge della parola", nel non lasciarsi sopraffare, abbassare a semplice servitore del libro. L'unica forma di libertà a cui può accedere un uomo che appartiene radicalmente, visceralmente ad un tradizione linguistica, sarà allora quella che passa attraverso il riconoscimento dell'essenzialità, della costitutività dei propri legami; tale "identificazione" però, per essere emancipante, non può implicare la chiusura, la semplice delimitazione di uno spazio a cui si deve appartenere in maniera esclusiva, quanto piuttosto costituire l'esperienza di un radicamento ad un "laggiù", ad un "oltre-memoria", ad un altrove che non è solo un passato assoluto, che è già da sempre stato (e non è una semplice forma modificata del presente, un presente-passato), irrimediabilmente perduto, ma anche l'apertura della possibilità di un' avventura a-venire, di una traversata dei segni sempre lontana da qualsiasi forma di prossimità e vicinanza, da qualsiasi viaggio dalla meta prestabilita e sicura.
Il fatto che la scrittura sia radicalmente seconda, ripetizione della lettera, e non voce originaria che accade in prossimità del senso, occultamento dell'origine più che suo svelamento, innesta costitutivamente nella sua struttura di significazione la differenza, la negatività e la morte; d'altra parte solo quest'assenza apre lo spazio alla libertà del poeta, alla possibilità di un'operazione di inscrizione e di interrogazione che deve "assumere le parole su di sé" e affidarsi al movimento delle tracce, trasformandolo "nell'uomo che scruta perché non si riesce più ad udire la voce nell'immediata vicinanza del giardino".
Perduta la speranza di un'esperienza immediata della verità, il poeta si deve affidare al lavoro "fuori del giardino", alla traversata infinita in un deserto senza strade prefissate, senza un fine prestabilito, la cui unica eventualità è la possibilità di scorgere miraggi. Partecipe di un movimento animato da un'assenza, il poeta non solo si troverà così a scrivere in un'assenza, ma a diventare soggetto all'assenza, che "tenta di produrre se stessa nel libro e si perde dicendosi; essa sa di perdersi e di essere perduta e in questa misura resta intatta e inaccessibile". Assenza di luogo quindi, e, soprattutto, assenza dello scrittore: "Scrivere, significa ritrarsi... dalla scrittura. Arenarsi lontano dal proprio linguaggio, emanciparsi o sconcertarlo, lasciarlo procedere solo e privo di ogni scorta. Lasciare la parola... lasciarla parlare da sola, il che essa può fare solo nello scritto". Così ogni scrittore, scrivendo, sacrifica la propria esistenza alla parola; ma questo stesso atto è anche consacrazione dell'esistenza per mezzo della parola.
L'ambiguità essenziale che sta tra le significazioni, l'assenza che non si lascia inscrivere dalla lettera, irriducibile dall'ordine del discorso o della logica dell'identità, è per Derrida originariamente necessaria al senso. Pretendere di dire il silenzio che "sottintende" il linguaggio, di riempire il simbolismo vuoto che marca il tempo morto in ogni testo, significa infatti non aver compreso e conosciuto il linguaggio, "il fatto che esso è la rottura stessa della totalità", non avere avuto esperienza che ciò che la lettera dice è nell'"involgersi su di sé del linguaggio", che è nel vuoto che il linguaggio ottiene la possibilità di essere significante.
Più che sostenuto dal contenuto discorsivo, infatti, è nella cesura, nell'interruzione - tra le lettere, le parole, le frasi, i libri - nella discontinuità e nell'inattualità, che il sorgere delle significazioni trova uno spazio di manifestazione, in cui esse vivono grazie alla "morte che si aggira tra le lettere". Se "una poesia corre sempre il rischio di non avere senso e non avrebbe alcun valore senza questo rischio", e se la scrittura procede aforisticamente, per frammenti, per lapsus, ciò non accade in virtù di una semplice scelta stilistica o per dichiarare uno scacco, ma perché solo questa può essere la "forma dello scritto", di un movimento che insegue e proviene da un'assenza, da una rottura, da un pensiero su un essere che non è né si manifesta mai esso stesso, non è mai presente, in questo momento, fuori della differenza.
Derrida, per evidenziare il "movimento di emancipazione" del segno sia rispetto al soggetto parlante che e al contesto, e quindi anche rispetto alla situazione ideale di presenza della voce, introduce il termine spaziatura; la scrittura, prestandosi alla possibilità di marcare il "tempo morto", disponendo di un simbolismo vuoto (di pause, di punteggiatura, di bianchi...), segna il rapporto originario che lega ogni linguaggio alla morte: "la spaziatura come scrittura è il divenir-assente e il divenir-inconscio del soggetto".
È infatti in ogni spaziatura silenziosa o non esclusivamente fonica delle significazioni, in ogni spazio non fonetico, che sono possibili concatenazioni e coabitazioni che non obbediscono più alla linearità del tempo logico, del tempo della coscienza e della "rappresentazione verbale". In quanto rapporto del soggetto alla sua morte, il "movimento di deriva" che costituisce ogni scrittura corrisponde, in ritorno, alla costituzione stessa della soggettività, come desiderio di una presenza piena a sé.
L'organizzazione della vita si effettua così a tutti i livelli secondo un'"economia della morte", un lavoro di strutturazione e messa in forma dell'esistenza, del presente vivente ad opera di un'assenza originaria. D'altra parte il nome "scrittura" è, segna il gioco di due assenze, funziona cioè coprendo, occultando propriamente, ovvero in modo dissimulato, due posti vuoti: quello del signatario, del soggetto della scrittura, e quello del referente; di assenze cioè che, escludendo la pensabilità e la possibilità di un significato, interiore o mondano, sprovvisto di significante, "forano il linguaggio", lo costruiscono come una rete di rimandi nel vuoto, aperta, che accade nella discontinuità e nella ritenzione della non-presenza.
"La traccia affetta la totalità del segno nelle sue due facce", contamina tutto il linguaggio con la sua struttura di presenza-assenza, di doppio movimento di "protensione e ritenzione": solo nel concatenarsi di differenze è possibile ora l'apparire del senso, solo in quella scrittura che fugge qualsiasi situazione di stasi o di presenza assoluta, che eccede qualsiasi domanda d'essenza, e che, eppure, "non è nulla", non è inesistente o insensata, ma ha comunque una qualche forma di esistenza (che non è quella della semplice presenza) e permette una qualche forma di senso (che non è quello pieno, sostanziale ed assoluto della metafisica), "non è ancora del tutto un segno [separato dalla forza] ma non è più una cosa [che si oppone al segno]".
La traccia non è più così né il significante di un significato (non c'è più possibilità di manifestarsi di un senso fuori del significante), ma neppure l'unico significato di un significante senza significato, di un significante che non ha altra funzione se non quella di significare un altro significante; "...questa differenza non è niente, è il furtivo", un'erosione "essenziale e insieme fugace" che accade alla "maniera del ladro", che "svuota sempre la parola nella sottrazione di sé", la potenzialità espropriante del linguaggio che ruba in fretta le parole che il soggetto crede di avere trovato, "molto in fretta, perché deve scivolare invisibilmente nel nulla che mi separa dalle mie parole, e trafugarmele prima ancora che io le abbia trovate, perché, avendole trovate, io abbia la certezza di esserne già sempre stato spogliato".
Ogni parola, da quando è parola, è infatti "originariamente ripetuta", istantaneamente sottratta, "senza mai essere tolta", a colui che parla e che se ne crede padrone; e tale sottrazione si produce come un enigma, come una parola che nasconde la sua origine e il suo senso, che non dice mai da dove viene o dove va "perché non lo sa", perché questa ignoranza, quest'assenza del suo proprio soggetto le è costitutiva. Allora quello che si chiama il "soggetto parlante" non è più "quello stesso e quello solo che parla": facendo esperienza della parola, si scopre da sempre in una situazione di irriducibile secondarietà, di espropriazione radicale rispetto al luogo organizzato del linguaggio in cui ogni tentativo di collocazione è vano perché il posto è sempre mancante; "è la differenza che si insinua, come mia morte, tra me e me".
Riconoscere l'autonomia del significante, la sua sovrapersonalità e necessità rispetto all'intenzione del soggetto parlante, coincide perciò da questo punto di vista col pensarlo nella sua storicità, ammettere la "stratificazione e potenzializzazione" storica del senso, che, come sistema storico, cioè "aperto da qualche lato", deborda ogni struttura centrata, e continuamente è sull'orlo di smembrarsi, di farsi "costellazione in un sistema". Ogni atto di parola, ed ogni atto di scrittura, diviene così un atto di lettura in un campo storico e culturale da cui si devono attingere le parole e le regole; ciò fa di ogni parola qualcosa di rubato, rubato alla lingua ed anche a se stessa, essendole già da sempre sottratta la proprietà e l'iniziativa, ed apre in ogni atto linguistico un foro, spalanca una porta attraverso cui la parola è sempre sottratta perché è sempre aperta: "essa non è mai propria al suo autore o al suo destinatario e fa parte della sua natura non seguire mai il percorso che conduce da un soggetto proprio ad un soggetto proprio".
LA TESTUALITA' GENERALE
Concepito come un insieme di sostituzioni e di rinvii per i quali non è possibile alcun approdo ad una presenzialità ultimativa (un fondamento o un'origine che non siano a loro volta presi nel gioco differenziale), cioè come scrittura, il testo della metafisica assume i caratteri di ciò che Derrida chiama "testualità generale". La testualità generale è la conseguenza, in sede linguistico-semantica, dell'affermazione nietzscheana della "morte di Dio": essa comporta la cancellazione del significato e del significante trascendentali (come ancora per l'ermeneutica del primo Heidegger poteva essere l'essere), il loro "sprofondamento" ("mise-en-abìmè") o la loro "messa in disparte" ("mise a l'écart"), cancellazione che Derrida accompagna con un atteggiamento che ricorda non a caso quello del nichilismo compiuto e dell'oblio attivo:
"Non vi sarebbe alcun nome unico, foss'anche il nome dell'essere. Ed occorre pensarlo senza nostalgia, cioè fuori dal mito della lingua puramente materna o puramente paterna, della patria perduta del pensiero. Occorre al contrario affermarlo, nel senso in cui Nietzsche mette l'affermazione in gioco, con un certo riso e con un certo passo di danza" ("La différance").
L'elisione del significato trascendentale è intesa come rapporto con un nulla: e se "non c'è nulla fuori del testo" ad arrestare il rinvio, il testo non è che una deriva di sensi, vale a dire disseminazione. Il vocabolo "disseminazione" è assunto da Derrida mettendo consapevolmente in comunicazione due termini tra cui non c'è etimologicamente alcuna parentela: "sema" e "semen". Ma proprio questo "slittamento" e questa "collusione puramente esteriore", questa esplicita "devianza dal voler-dire", fanno del termine "disseminazione" una parola particolarmente adatta a significare quella dispersione del senso ("sema") che, come nel caso della semente ("semen"), è sempre inscritta in ogni aspettativa di fruttificazione.
La disseminazione non è quindi la polisemia: mentre la polisemia è sempre in qualche modo irreggimentabile, controllabile (diremmo: ubbidisce a un qualche "principio di realtà"), la disseminazione non è mai riconducibile all'ordine, si abbandona a un "principio di piacere" dispersivo che ha un rapporto necessario con il godimento e con la pulsione di morte. Nella sua mancanza di un principio ordinatore, la disseminazione configura il testo (e qui la differenza tra "linguaggio" o "scrittura" e "realtà" viene completamente a cadere) come una serie di innesti, ibridazioni, formazioni "mostruose", che costituiscono una contestazione quanto mai radicale di due assunti della razionalità metafisica:
- quello dell'identità e dell'identificazione, della possibilità di "definire", operazione rassicurante che tende a difendere dall'alterità, a rimuoverla. In Spettri di Marx Derrida assimila la stessa ontologia al bisogno di identificazione (a tutti i livelli, da quello logico a quello politico), di purezza contro ogni forma di contaminazione, come difesa dall'evenienza dell'altro, il che si configura come un lavoro del lutto mai finito, e in particolare come difesa dalla sua possibilità di ritorno. L'identità si costituisce a prezzo di un'esclusione. Si tratta di un orizzonte - quello di una "ontologia" del fantasma (in francese "revenant") - che Derrida chiama hantologie, termine formato sul francese "hanter", che significa principalmente "ossessionare" (una casa "hantée par les fantomes" è una casa abitata dai fantasmi): la hantologie non è altro che la stessa grammatologia. Si capisce bene come, lungi dall'essere "rassicurante", una tale hantologie sia invece inevitabilmente perturbante: il riferimento al saggio di Freud Il perturbante - in cui Freud analizza quel particolare fenomeno per cui in una situazione familiare si prova improvvisamente e inspiegabilmente una sensazione di "estraneità" e che ha molto a che fare con l'ossessione fantasmatica - è in Derrida esplicito;
- quello della "linearità del significante, principio fondamentale dello strutturalismo, con cui viene sancito il rapporto di interdipendenza tra la scrittura fonetica e una certa concezione della temporalità come successione lineare, discreta, di istanti. Il testo come ibrido si presta invece a una lettura molteplice, su vari livelli e in più direzioni (possibilità che Derrida riscontra ad esempio nella scrittura ideografica, che non è fonetica), perché non assoggettabile a un centro unico, a una direzione principale, a un significato egemone. Si tratta di una concezione che, nella sua forma radicale - spesso praticata da Derrida come possibilità di leggere un testo in più modi diversi (sempre in Spettri di Marx, la non identificabilità ultima del senso fa sì che esso sia sempre più d'uno) - ha portato a una deriva interpretativa non priva di problematicità.
I presupposti strutturalisti - antifenomenologici e antiermeneutici - di questo discorso sono chiari: lo strutturalismo ha inteso il processo di significazione come funzione del sistema, e quindi come indipendente dall'intenzionalità di un soggetto o di una "coscienza", come un processo impersonale e quasi meccanico. La testualità generale come disseminazione è quindi il risultato di una doppia breccia che la decostruzione opera nella tradizione filosofica: contro l'idea fenomenologico-ermeneutica della coscienza come luogo in cui il senso trova il suo aggancio, o la sua possibilità di riattivazione, al di là di ogni possibile perdita (e ciò, abbiamo visto, è conseguenza della critica derridiana al logocentrismo), e contro l'idea strutturalista che fa del sistema un principio ordinatore in cui la differenzialità è allo stesso tempo comunque condizione di identificazione (di definizione, di istituzione di un limite), conseguenza, questa, dell'inserimento nelle nervature apollinee dello strutturalismo di una forza dionisiaca allergica a qualsiasi forma. Alcune affermazioni di Derrida consentono però di circoscrivere la deriva interpretativa della decostruzione: come scrive ad esempio in Firma evento contesto, "in questa tipologia, la categoria di intenzione non scomparirà, essa avrà il suo posto, ma da questo posto, essa non potrà più comandare tutta la scena e tutto il sistema dell'enunciazione".
Non si tratterebbe dunque tanto della semplice eliminazione di un termine o di una funzione che nella storia della metafisica ha giocato un ruolo fondamentale (anzi Derrida mette in guardia contro il carattere semplicistico di una tale operazione), ma di negare ad esso una tale fondamentalità, un ruolo egemonico, trascendentale, vale a dire astorico.
Se il conflitto fra Dioniso e Apollo non può essere risolto attraverso un rapporto di subordinazione o di rimozione è perché esso è la storia stessa, e cioè, in un senso paradossale perché ossimorico, la condizione trascendentale della storia: "la divergenza, la differenza tra Dioniso e Apollo, tra lo slancio e la struttura non si cancella nella storia, poiché essa non è nella storia. È anch'essa, in un senso insolito, una struttura originaria: l'apertura della storia, la storicità stessa" ("Forza e significazione").
Questo passaggio ci permette alfine di individuare il punto in cui il gioco differenziale, il tessuto di rinvii che caratterizza la testualità generale, assume una connotazione storica, riportando in primo piano il senso temporale della nozione di différance. La storia è una rete di rinvii, di invii, di destinazioni (è evidente la risonanza dell'associazione heideggeriana tra Geschichte, storia, e Geschick, invio o destino), ma, conformemente al carattere non unitario, ma ibrido, frutto di una serie di innesti senza corpo principale, della testualità generale, in tale concezione della storia non è possibile ravvisare alcun "telos" fondamentale, alcun destino (come la heideggeriana "storia dell'essere"), concezione che sottolinea una volta di più uno dei caratteri più marcatamente postmoderni della filosofia di Derrida: "se la posta (tecnica, posizione, metafisica) si annuncia al 'primo invio', allora non vi è più LA metafisica ecc. [...] e nemmeno L'invio, ma degli invii senza destinazione. Poiché ordinare le diverse epoche, soste, determinazioni, insomma tutta la storia dell'essere, a una destinazione dell'essere, è forse l'illusione postale più inaudita. Non c'è nemmeno la posta o l'invio, ci sono le poste e gli invii. […] In breve, non appena vi è, vi è différance [...]; e vi è ordinamento postale, relais, ritardo, anticipazione, destinazione, dispositivo telecomunicante, possibilità e quindi necessità fatale di dirottamento ecc. " ("Envois").
Questa concezione della storia rappresenta una sorta di iperbolizzazione delle due assenze strutturali della scrittura: assenza del destinatore (mittente) e assenza del destinatario (ricevente). La storia è davvero quel testo generale il cui senso non è mai definitivamente dipendente da una coscienza, poiché una coscienza non può mai dominarla: se la scrittura ha una dimensione imprescindibilmente testamentaria, è perché nessuna coscienza vivente le può mai sopravvivere, salvaguardandone il senso, secondo una pretesa che, come abbiamo visto, appare piuttosto come un tentativo di rimozione e che agiva nella condanna socratico-platonica, e idealistica in generale, della scrittura.
DIFFERENZA, TRACCIA E SUPPLEMENTO
Nell'analisi genealogica della filosofìa socratico-platonica, condotta in La farmacia di Platone, Derrida mostra un'attitudine tipicamente nietzscheana. Ma l'emergenza del tema della scrittura sposta l'attenzione verso un ambito tematico più propriamente psicanalitico: la messa in luce di uno schema familiare, al fondo della cosiddetta metafisica della presenza - schema in cui il logos occupa la posizione del padre - si avvale di tutto un armamentario interpretativo in cui concetti psicanalitici come "rimozione", "castrazione", "sublimazione", "pulsione di morte", "coazione" ecc. giocano un ruolo di primo piano.
L'analisi stessa del testo è condotta come un tentativo di individuazione di atti mancati, lapsus, mascheramenti, sintomi e brecce che la decostruzione sfrutta per inserirsi in sistemi che a prima vista - diremmo, nei loro "meccanismi di difesa" - appaiono solidi e inattaccabili. Di questa deriva psicanalitica Derrida aveva dato una chiara anticipazione già in La voce e il fenomeno, scrivendo: "ed è proprio intorno al privilegio dell'adesso, dall'adesso, che si svolge, in ultima istanza, questo dibattito, che non può somigliare a nessun altro, tra la filosofia, che è sempre filosofia della presenza, e un pensiero della non-presenza, che non è forzatamente il suo contrario, né necessariamente una meditazione dell'assenza negativa, anzi, una teoria della non-presenza come inconscio " (La voce e il fenomeno).
Questa teoria della non-presenza è riassunta nel concetto di "traccia". La traccia (e qui Derrida riprende la definizione di Emmanuel Lévinas) è "un passato che non è mai stato presente", cioè la dimensione di un'alterità che non si è mai presentata né potrà mai presentarsi, che Derrida non esita ad assimilare alla nozione psicoanalitica di inconscio: "con l'alterità dell'"inconscio" abbiamo a che fare non con degli orizzonti di presenti modificati - passati o a venire - ma con un "passato" che non è mai stato presente e che non lo sarà mai, il cui "avvenire" non sarà mai la produzione o la riproduzione nella forma della presenza. Il concetto di traccia è dunque incommensurabile con quello di ritenzione, di divenir-passato di ciò che è stato presente. Non si può pensare la traccia - e dunque la différance - a partire dal presente, o dalla presenza del presente" (La diffèrance).
Come la nozione freudiana di inconscio, il concetto di traccia assume una funzione antifenomenologica, nel senso che costituisce un ordine di alterità per definizione irrappresentabile, o rappresentabile soltanto attraverso un insieme di sostituzioni: "e per descriverle, per leggere le tracce delle tracce "inconsce" (non c'è traccia "cosciente"), il linguaggio della presenza o dell'assenza, il discorso metafisico della fenomenologia è inadeguato ".
Ed è infatti proprio questo l'esito principale consentito dalla nozione di traccia: quello di far intendere l'ordine del senso - della coscienza, della presenza, e di tutto il sistema concettuale da esse regolato, cioè l'insieme stesso della metafisica - come un ordine supplementare, radicalizzando con ciò quella che, secondo una tale metafisica, era una condizione limitata alla semplice scrittura. Vale a dire che l'impresentabilità della traccia tende a far leggere ogni presentazione o rappresentazione come ciò che sta al posto della traccia "originaria", la sostituisce, ne è insomma la scrittura, così come la coscienza, in un testo famoso in cui Freud la paragona ad un notes magico e che Derrida discute in La scrittura e la differenza, è la traccia "visibile" dell'inconscio.
Questa "logica del supplemento" è ovviamente impensabile all'interno della logica (Della grammatologia): il supplemento supplisce una mancanza, una non-presenza, nel senso che rappresenta il momento di una strutturazione non preceduta da nulla, ma a partire dalla quale qualcosa "appare". "Il supplemento viene al posto di un cedimento, di un non-significato o di un non-rappresentato, di una non-presenza. Non c'è nessun presente prima di esso, è quindi preceduto solo da se stesso, cioè da un altro supplemento. Il supplemento è sempre il supplemento di un supplemento".
Una tale "logica del supplemento" o della traccia (supplementarità originaria) è quindi il "concetto fondamentale" di una nuova scienza (se essa fosse possibile), che Derrida chiama "grammatologia": la grammatologia fa dell'essere dell'ontologia - di "ciò che c'è" - la traccia di ciò che "non c'è", che non si presenta né può mai presentarsi; la grammatologia costituisce in breve l'introduzione, all'interno dell'ontologia da sempre dominata dal principio di identità, di una differenzialità originaria, di uno scarto, di una cesura, che Derrida riassume nella nozione di différance.
Una comprensione della nozione derridiana di différance - argomento di una famosa conferenza tenuta il 27 gennaio 1968 e poi compresa in Margini - non può che partire dal suo statuto di "scrittura", dal modo in cui la parola stessa viene scritta, prima e piuttosto che dal suo contenuto "concettuale": la sua "concettualità" è anzi tutta nella sua scritturalità. La différance è anzitutto quel "lavoro" silenzioso che la scrittura opera al di là di ogni possibile concettualizzazione. Il termine francese usato da Derrida è volutamente scritto con la "o" anziché con la "e", come sarebbe la sua forma corretta (différence). Questa "violenza grafica" non ha conseguenze fonetiche percepibili, e perciò intelligibili: con ciò Derrida intende segnare uno scarto dal fono-logocentrismo, ovvero dal privilegio del logos nel sistema concettuale dell'Occidente, di cui è diretta conseguenza - o addirittura causa - l'uso della scrittura fonetica.
Privilegio del logos significa: a) privilegio del concettuale, del soprasensibile; b) solidarietà sistematica tra il concettuale (lo spirituale) e il fonetico (la voce, l'ascolto ecc.); e) centralità della coscienza nella fondazione della verità in quanto garante della prossimità tra il significante e il significato; d) condanna della scrittura in quanto possibilità di sviamento dalla verità, perché svincolata o pur sempre svincolabile dalla presenza di una coscienza; e) concezione della verità come rapporto a un'origine riattivabile; f) determinazione di questa origine come "presenza".
Con il suo lavoro "silenzioso", la différance segna uno scarto rispetto a tutti questi punti, non però nella forma di una "opposizione", bensì di un'alterità eccentrica rispetto al sistema oppositivo su cui si regola il logocentrismo. Questa eccentricità è quella di un'alterità non riconducibile all'identità, o meglio di un "luogo" altro come può essere l'inconscio o la "materia".
Si tratta di una collocazione che Derrida definisce come "la voce media" (né... né...), e che nella parola stessa différance è espressa dalla terminazione -ance, propria di parole che, formate sul participio presente, restano sospese tra l'attivo e il passivo. Ma insieme al suo senso grammaticale, è il senso logico della terminazione media che qui importa: essa corrisponde alla forma indecidibile del "né... né...", del tertium datur con cui è scardinata la razionalità metafìsica, fondata sui princìpi di non contraddizione e del terzo escluso.
L'indecidibile è la "logica" stessa del decostruzionismo, un'alogica che anziché scegliere tra due elementi opposti, appartenenti, per la loro stessa solidarietà sistematica, a un medesimo ordine concettuale, tende a farli collidere o a intrecciarli in maniera chiasmatica: il chiasma è la "x", figura dell'incognita e della barratura dell'indecidibile.
Da questo punto di vista la decostruzione è atetica, non approda cioè a nessuna tesi. La decostruzione della metafisica della presenza non può essere più radicale: non potendosi esprimere nella forma del discorso letico e apofantico "S è P", la decostruzione, attraverso l'indecidibile, si richiama a forme di discorso tradizionalmente non apofantiche: quelle, come vedremo, dell'invocazione, del giuramento, dell'invito, del ringraziamento, del perdono e finanche della preghiera.
Nella sua medietà, la provenienza terminologica dal participio del verbo différer allude al doppio significato, a un tempo sincronico e diacronico, di différance:
- sincronico: la différance è da questo punto di vista una radicalizzazione (e perciò anche una decostruzione) di quel gioco sincronico delle differenze in cui lo strutturalismo saussuriano faceva consistere il significato. "Nella lingua non ci sono termini positivi, ma solo differenze", scriveva Saussure: è dal rapporto sincronico tra i vari termini, nel loro gioco differenziale, che si genera l'identità di un significato (è noto l'esempio di Saussure della lettera "t", che può essere scritta in mille modi diversi ma l'importante è che "non si confonda", cioè si differenzi dalle altre lettere);
- diacronico: la différance indica il movimento di "differimento" temporale (ritardo o anticipazione) che disloca continuamente l'origine in un altrove, in un luogo e in un tempo "altri". Anche qui abbiamo a che fare con una radicalizzazione, quella della "differenza ontologica" heideggeriana, che si risolve iperbolicamente, e dunque paradossalmente, nella sua cancellazione: il senso ultimo (il significato trascendentale) non è "riappropriabile", la differenza resta "assoluta", e perciò cancellata (Derrida si richiama al proposito al concetto hegeliano di "differenza", nella Scienza della Logica).
Questo espacement (semento in sé privo di significato, ma condizione del significato: Derrida ricorda la funzione della spaziatura nella scrittura) indica quindi allo stesso tempo un differimento temporale e spaziale: ciò che è percepibile, intelligibile, cosciente ecc. non è che traccia di questo movimento, traccia della différance. In tal modo Derrida capovolge il sistema logocentrico, facendo del logos la traccia di un'origine perduta e portando in primo piano questo sistema di tracce in quanto scrittura.
La scrittura è la traccia di un'origine assente, differenzialità pura, traccia che ha cancellato la sua origine come la ricerca della verità in Nietzsche; così la ricerca dell'origine giunge qui a un esito nichilistico, quello di risolvere o dissolvere il fondamento nel gioco dei rimandi senza termine ultimo. E, questa, quella nozione di "testualità generale" cui il decostruzionismo di Derrida è approdato e che ha avuto ampi sviluppi soprattutto in sede di critica letteraria.
COS'E' LA DECOSTRUZIONE?
Definire la decostruzione è impresa che va immediatamente incontro a una radicale e inesorabile stroncatura da parte dello stesso Derrida: come scrive a un amico giapponese, "ogni frase del tipo 'la decostruzione è X' o 'la decostruzione non è X' è a priori priva di pertinenza, è a dir poco falsa. Lei sa che fra i principali obiettivi di ciò che nei miei testi si chiama 'decostruzione' è proprio la delimitazione dell'onto-logica e anzitutto dell'indicativo presente della terza persona: S è P" ("Pacific Deconstruction", "Lettera a un amico giapponese").
Un tale avvertimento critico, lungi dal voler impedire ogni pro-posizione teorica a proposito della decostruzione, ha piuttosto lo scopo di attirare l'attenzione, mettendoli crudamente in luce, sui temi e le frontiere contro cui essa è impegnata: temi e frontiere che solo riduttivisticamente possono essere detti teorici, ma che sono sempre nel loro fondo soprattutto etici e politici.
Se, come ha scritto, suo malgrado giustamente, Hilary Putnam (in Rinnovare la filosofia) "criticare il decostruzionsmo è come cercare di fare a pugni con la nebbia", ciò è dovuto forse al fatto che finché si pretende di condurre questa lotta sul piano puramente teorico, non si può che mancare il bersaglio.
La decostruzione è infatti soprattutto una pratica, e una pratica di scrittura, nel senso che, per ragioni che vedremo meglio, affida alla scrittura una dimensione performativa che sarebbe irriducibile alla constatività teoretica, la funzione della scrittura, repressa nella metafisica occidentale, sarebbe infatti proprio quella di delimitare, attraverso il suo potenziale sovversivo, la pretesa di dominio della teoreticità. Ciò di cui ne va nella decostruzione è, dice Derrida, la delimitazione dell'onto-logica di una certa concezione dell'essere e di una certa logica ad essa coessenziale che si esprimono nell'interpretazione tradizionale - metafisica - della terza persona dell'indicativo presente, della copula "è". Si tratta di un problema eminentemente metafisico che Derrida assume da Heidegger e che consiste nel generale privilegio accordato nella metafisica occidentale alle nozioni di "presenza" e di presente.
Il termine decostruzione può anzi essere considerato come la fortunata traduzione del tedesco Destruktion, con cui Heidegger, nel par. 6 di Essere e Tempo indicava il compito preliminare, richiesto dall'indagine sul senso dell'essere nei confronti della storia della metafisica ereditata. Che la logica, a partire dal suo fondatore Aristotele, si costruisca su un indiscusso privilegio della forma enunciativa alla terza persona dell'indicativo - il discorso apofantico - è un dato del tutto evidente. Che tale privilegio abbia come sua giustificazione metafisica la dottrina della sostanza e una certa concezione dell'essere e del linguaggio dominata dalla dottrina delle categorie, è altrettanto evidente, al punto da costituire un dato della nostra tradizione culturale talmente costante da confondersi con l'ovvietà se non proprio con la naturalità.
Ciò che Derrida contesta - con un'analisi genealogica e smascherante degna di maestri del sospetto come Nietzsche, Marx e Freud - è invece proprio tale ovvietà, mostrandone il carattere storico, fondato cioè su una decisione che, in quanto tale, è più etico-politica che teorica. Tale analisi è condotta in riferimento soprattutto a Platone in La farmacia di Platone e a Husserl in La voce e il fenomeno.
Platone rappresenta in un certo senso il luogo originario di una tale decisione, mentre la fenomenologia husserliana ne costituisce la forma compiuta, essendo essa, per Derrida, "il progetto metafisico stesso nel suo compimento storico e nella purezza solamente restaurata della sua origine" (La voce e il fenomeno).
Metafisica della presenza è il privilegio che le nozioni di "presenza" e di presente assumono nella definizione di tutti i concepì fondamentali della metafisica - esse anzi esprimono la nozione stessa di "fondamento". In base a questo privilegio si struttura tutta una sene di coppie oppositive che improntano la concettualità metafisica - originano/derivato, modello/copia, immediato (evidenza)/mediato (ripetizione) verità/inganno ecc.
Il mito di Teuth, esposto nel Fedro platonico, fa vedere come queste coppie oppositive agiscano nel delineare lo statuto della filosofia che ha dominato la nostra cultura, cui è coessenziale la condanna della scrittura. Teuth è il dio della scrittura, ma la sua invenzione viene considerata un veleno, qualcosa di dannoso per la verità e per la conoscenza, non essendo che copia di copia (come ogni arte per Platone): pertanto essa non può che esporre alla perdita del senso, non può che allontanare dalla verità. Si nota in ciò l'eredità socratica - Socrate non scrisse nulla, per fedeltà alla forma dialogica, e perciò è il vero filosofo -, ma quel che Derrida tende a mettere particolarmente in luce è il nucleo etico che si cela in questa decisione epistemica: si tratta dell'imperativo socratico del "conosci te stesso". Quel che il privilegio della presenza cela nel suo fondo è l'identificazione del sapere - e del bene - con la coscienza, con la presenza a sé. Tutto ciò che allontana da tale presenza a sé (l'arte, la copia, il mito, e dunque la scrittura, che "ripete senza sapere") è errore, erranza, male.
Ma, nota Derrida, non è la conoscenza di sé a dettare l'imperativo del conosci te stesso: esso è dato in una iscrizione, il "delphikón gramma", il quale prescrive - e dunque precede - ciò che si pretende porre a fondamento. La sistematica concettuale qui analizzata si ritrova fortemente riaffermata, ad avviso di Derrida, nella difesa husserliana del principio dei princìpi, quello, cartesiano, e dell'evidenza del cogito, assunto come fondamento della filosofia in quanto scienza rigorosa, episteme; con esso si pone, e perciò eventualmente anche cade, la possibilità di ogni riduzione, di ogni epoche, la possibilità stessa, cioè, della fenomenologia.
È perciò fondamentale che la fenomenologia possa realizzare tale riduzione, evitando il più possibile l'inserimento di un elemento estraneo (del "mondo") all'interno della descrizione fenomenologica stessa. Ne va qui, insomma, dell'ambiguo rapporto che Husserl ha sempre intrattenuto con il linguaggio, e con ogni forma di tecnicizzazione, a un tempo valorizzato nelle sue possibilità espressive e svalorizzato nel suo carattere di dissimulazione, sovrastrutturale, obiettivante.
Nelle Ricerche logiche una tale ambiguità viene regolata attraverso la distinzione tra uno strato linguistico puramente espressivo, che garantirebbe la coincidenza di significato e segno, vale a dire la presenzialità del voler-dire (così Derrida traduce il termine tedesco Bedeutung, "significato", per sottolinearne la dipendenza dall'intenzionalità) alla coscienza, e uno strato meramente indicativo, rivolto cioè a quella "trascendenza" (il mondo) che le riduzioni dovrebbero mettere tra parentesi, onde consentire quella piena immanenza della coscienza a sé che è l'elemento stesso dell'evidenza fenomenologica.
Attraverso una discussione serrata, di cui Derrida aveva già dato prova nella sua Introduzione a 'L'origine della geometria' di Husserl, che è emblematica di quel movimento di "gira-volta", come lo definisce Derrida stesso, che la decostruzione attua o scopre nei testi della tradizione metafisica, la distinzione husserliana viene minata in base ai presupposti stessi della fenomenologia, e in particolare in base alle riflessioni svolte nelle lezioni sulla coscienza interna del tempo. Qui Husserl sostiene che il presente stesso (l'adesso nella sua puntualità) si compone continuamente e inevitabilmente con un non-presente, così come ogni percezione con una non-percezione. E allora, se non è possibile che il presente si dia in una forma assoluta, viene minata la possibilità stessa di una presenzialità a sé priva di rinvio, di indicatività (la vita solitaria dell'anima, il platonico "monologo dell'anima con se stessa"), e quindi la possibilità di una presenzialità di fatto e di principio epochizzabile. Col che verrebbe a cadere, allora, la possibilità stessa dell'evidenza, dell'intuizione ("noesis") senza intelletto ("dianoia"), della fenomenologia pura.
Con l'esposizione di questi nuclei problematici non siamo però ancora giunti a delineare a fondo quella sistematica concettuale che Derrida chiama "logocentrismo", e che è un'ulteriore, consequenziale definizione della "metafisica della presenza". Il logocentrismo è la tendenza, rilevabile all'interno di tale metafisica, a identificare presenzialità e logos (discorso parlato, vivo, cosciente), cosicché è il logos ad assumere una posizione centrale, fondatrice, originaria. Più propriamente, come scrive Derrida, il logocentrismo è il desiderio stesso di un centro, di un fondamento, su cui si costruisce il "bisogno di verità" della metafisica.
La vicenda della scrittura ha messo in luce come questa posizione centrale sia occupata dalla coscienza, e cioè dalla voce ("phoné"). La voce infatti è la coscienza, poiché garantisce la completa trasparenza dell'elemento espressivo, il suo immediato svanire nell'immediatezza del voler-dire, evitando quel che Platone paventava nella scrittura ("figlio bastardo e parricida"), e cioè la perdita del senso e l'incapacità di "difendersi" o, peggio, la possibilità di rivoltarsi contro il "padre-logos" (La farmacia di Platone). Che la metafisica sia sorta entro un orizzonte culturale che si avvale di una scrittura fonetica è un dato storico non secondario, poiché solo una scrittura fonetica avrebbe potuto consentire il sorgere di una concettualità in cui opposizioni come senso/lettera, spirito/materia, intelligibile/sensibile, verità/errore fossero sovrapponibili con quella voce/scrittura.
Ma tutti i tentativi di relegare la scrittura a una funzione secondaria, accessoria e subordinata non sarebbero altro che tentativi di difesa dalla sua potenziale carica sovversiva, eversiva; che insomma nella vicenda della scrittura operi una sorta di "rimozione" è provato secondo Derrida dal fatto che, in realtà, una scrittura totalmente fonetica non esiste, poiché anche nella scrittura fonetica si danno elementi significanti non fonetizzabili: la punteggiatura, le spaziature, le virgolettature, i corsivi ecc. La decostruzione sfrutta il potenziale sovversivo - o quantomeno dislocante - di questi elementi scritti ma non dicibili, poiché essi consentono di operare differenze di senso inaudite, che segnano uno scarto rispetto al dominio fonologocentrico: ne vedremo un esempio - possiamo dire l'esempio - nel caso della scrittura del termine différance.
LA DEMOCRAZIA A VENIRE
Dalla seconda metà degli anni Ottanta del Novecento l'interesse di Derrida si è sempre più spostato verso temi etici e politici, ancora una volta affrontandoli in maniera poco tradizionale, cioè con uno stile in cui poco spazio è lasciato alla "teoria" e che può essere inteso solo alla luce dei presupposti fondamentali della decostruzione.
Gli anni Ottanta costituiscono un periodo di particolare vivacità a livello filosofìco-politico, poiché in essi si sviluppa quel dibattito tra moderno e postmoderno che coinvolge anche il decostruzionismo, e il cui avvio è segnato dal discorso di Jürgen Habermas, "Il moderno: un progetto incompiuto", pronunciato nel 1980 in occasione del conferimento del premio Adorno.
Secondo la tesi di Habermas, il postmoderno sarebbe contraddistinto dalla rinuncia all'ideale emancipativo della modernità, le cui radici si trovano nel razionalismo illuminista, ripiegando verso una forma ambigua di neoconservatorismo, che caratterizzerebbe soprattutto la filosofia francese contemporanea e i cui ispiratori sarebbero principalmente Nietzsche e Heidegger.
Come si è detto, la curvatura politica è, come afferma lo stesso Derrida, assolutamente inscindibile dalla pratica decostruttiva: questo perché ogni struttura oppositiva (originario/derivato, modello/copia ecc.) che la decostruzione tende a scardinare non si presenta mai come una mera contrapposizione di termini, collocati su uno stesso piano e quindi con una stessa dignità assiologica, ma costituisce l'instaurazione di una forma di dominio dell'uno sull'altro, di subordinazione.
D'altra parte non si dà una condizione del pensiero che non sia al tempo stesso interconnessa con momenti istituzionali, che si tratta di comprendere e di disarticolare: l'impegno di Derrida nel GREPH (Groupe de recherches sur l'enseignement philosophique) per contestare la riforma Haby-Giscard, mirante a eliminare l'insegnamento della filosofia nelle scuole francesi a partire dal 1981, o nel College Intemational de Philosophie, un'istituzione volutamente atipica, è a tal riguardo significativo (alla riflessione sulle implicazioni filosofiche delle istituzioni e istituzionali del lavoro filosofico Derrida ha dedicato un libro che costituisce anche un importante documento di questi suoi impegni, Du droit à la philosopbie, 1990).
Addirittura nella stessa nozione di différance è possibile rintracciare in nuce il potenziale etico-politico della decostruzione, attenta a denunciare ogni sistema di potere e di repressione dell'alterità attraverso un'azione sovversiva: "[la différance] non governa su nulla, non regna su nulla e non esercita da nessuna parte alcuna autorità. Non si annuncia con una maiuscola. Non solo non vi è un regno della différance, ma essa istiga alla sovversione di ogni regno" (La différance).
La maniera con cui la différance contesta le forme del dominio è la sua stessa natura atetica e indecidibile: l'indecidibilità teorica è nel decostruzionismo il punto in cui si accumula la sua carica sovversiva, poiché, anziché occultarlo, apre davvero lo spazio della decisione, mostrando come ogni risoluzione dell'indecisione non sia frutto di una constatività teoretica, ma di una performatività, di un atto istitutivo, tetico.
Secondo Derrida, alla base di ogni legittimazione non c'è mai una semplice descrizione, una constatazione, un fatto (come ad esempio la natura, a fondamento dei diritti umani), ma sempre un atto di decisione, una scelta performativa (il riferimento è alla teoria di Austin degli "atti linguistici"): ogni legittimazione istituzionale non può non implicare una filosofia.
L'esplicitazione di un nucleo performativo all'interno di atti che si pretendono constativi è un passaggio importante, poiché non è che la messa in evidenza, da un altro punto di vista, del limite intrinseco della constatività pura, e cioè del privilegio logico della forma enunciativa.
Sempre più, come si è anticipato, il linguaggio di Derrida si discosta dalla forma apofantica per assumere, non solo come proprio tema di indagine, ma anche come proprio medium espressivo, forme non apofantiche come invocazioni, giuramenti, imperativi, esortazioni, ringraziamenti ecc. Ne è prova l'espressione in cui Derrida concentra tutto un insieme di "concetti" e che ritorna sempre più spesso nei suoi ultimi scritti, e cioè "Viens!". "Viens!" è un'invocazione, l'invocazione rivolta a un "tu", e quindi assolutamente non inscrivibile nella logica apofantica, che privilegia la terza persona. Questo "tu" è l'altro, il quale può solo essere lasciato venire. "Viens!" significa un'apertura all'altro al di là di qualsiasi calcolo, programmazione, riassimilazione, prima di ogni identificazione e presentificazione.
Polemizzando con la nozione heideggeriana di Ereignis come implicante ancora un tentativo di appropriazione (eignen), Derrida scriveva già nella conferenza sulla Différance: "se la donazione di presenza è proprietà dell'ereignen [...], la différance non è un processo di propriazione in un senso quale che sia. Essa non è ne la posizione (appropriazione) né la negazione (espropriazione), ma l'altro". L'altro sfugge a ogni tentativo di appropriazione, è lo straniero che si invita a venire, e per il quale Derrida auspica una politica dell'ospitalità.
Insieme all'analisi dei fenomeni di identificazione nazionale, la riflessione sul tema dell'ospitalità costituisce uno dei momenti principali della speculazione politica di Derrida. Gramma costitutivo di questa riflessione è la coppia amico/nemico, e cioè ospitalità/ostilità. Derrida nota - appoggiandosi su riferimenti linguistici e sulla storia delle istituzioni - la parentela tra i termini hostis (straniero o nemico) e hospes (ospite, invitato), che ha dato origine a rapporti chiasmatici, a contaminazioni, a veri e propri intrecci tra l'essere ospite e l'essere straniero, l'essere amico e l'essere nemico (soprattutto in Politiche dell'amicizia), in cui etica e politica si oppongono e si associano continuamente.
Ma il pensiero a cui Derrida impronta maggiormente questa sua riflessione è quello di Emmanuel Lévinas. Nel confronto con Emmanuel Lévinas - a cui Derrida riconosce, seppure con una certa presa di distanza, un debito particolare - il rapporto etica-politica emerge in tutta la sua problematicità. Tale rapporto non può più essere inteso come mera antecedenza dell'etica sulla politica, nella misura in cui l'etica stessa è ecceduta da un evento, l'evento politico, che accade - viene - prima ancora che un'etica sia pronta a recepirlo. In questo capovolgimento è possibile forse vedere la ripresa di un tema heideggeriano - quello del dato che precede ogni orizzonte di trascendentalità - rispetto alla problematica fenomenologica dell'intenzionalità: prima di ogni "coscienza di", e quindi di ogni accoglienza (Lévinas, sottraendola all'orizzonte riflessivo husserliano, aveva definito l'intenzionalità come "accoglienza del volto, ospitalità e non tematizzazione"), un dato è lì - c'è o accade -, chiedendo di essere "ricevuto", "accolto". Si tratta del passare dell'altro che, scrive Derrida, "ha già superato la soglia, non attendendo né invito né ospitalità né accoglienza". La sua visita "eccede ogni relazione dialogica da ospite a ospite. [...] La sua effrazione traumatizzante deve aver preceduto ciò che normalmente chiamiamo ospitalità, precedendo persino, sebbene esse già appaiono sconvolgenti e pervertibili, le leggi dell'ospitalità" (Addio a Emmanuel Lévinas).
L'antecedenza del dato è, per Derrida, quella di una visitazione che viene senza preavviso, evento politico che precede e che anzi chiama a un'etica e, soprattutto, a un diritto dell'accoglienza, oggi sempre più urgente per il moltiplicarsi delle effrazioni di quelle soglie che sono i confini tra gli Stati, e di cui è emblema la vicenda politica stessa dello Stato di Israele.
Una tale visitazione non solo è destinata a sconvolgere - o a decostruire - la definizione attuale del politico, ma anche quella del soggetto: esso, scrive Derrida, è infatti già ospite, anzi ostaggio, perché a sua volta accolto nel luogo in cui abita, perché già da sempre, e inevitabilmente, "emigrato, esiliato, straniero" nel luogo stesso in cui dimora.
La politica dell'ospitalità - che Derrida proclama con particolare attenzione ai fenomeni contemporanei di attraversamento delle frontiere, da quelli "normali" dovuti alla cosiddetta "globalizzazione" o a emigrazioni fisiologiche a quelli "eccezionali" dovuti a movimenti di profughi, a spostamenti o deportazioni etniche, di cui le vicende di fine Novecento hanno offerto numerosissimi esempi (dal Ruanda al Kosovo) - sarebbe così il fondamento di una "democrazia a venire" che non intende chiudersi sullo stato di fatto delle democrazie occidentali, ma che vuole dischiuderle appunto sull'avvenire, su un futuro che - come è esplicito nel concetto di "traccia", nel quale Derrida sintetizza quel che per lui è il rapporto con l'alterità - non è né sarà mai presente: non a caso la nozione di "traccia" è mutuata da Emmanuel Lévinas, la cui riflessione etica è tutta centrata su una fenomenologia dell'altro. È questo del resto uno dei tratti più marcatamente ebraici del pensiero derridiano, che hanno un peso importante nella sua concezione politica: il problema dell'alterità inappropriabile, a partire da cui soltanto è possibile pensare una politica e ogni forma di relazione etica (come l'amicizia), conferisce al discorso di Derrida i toni del messianismo, o meglio, come lui stesso lo definisce in Spettri di Marx, di un deserto messianico, un messianismo desolante perché non ha alcuna Terra promessa, alcun luogo, in cui acquietarsi. Poiché, se una democrazia a-venire vuole davvero rispettare l'alterità dell'altro, non può mai preventivamente identificarlo, non può mai dire "che cosa" esso sia, non può pretendere di sapere che cosa avverrà, non può anticiparlo, può solo accoglierlo come si accoglie un ospite inaspettato: "senza questa desolazione, se proprio si potesse contare su quel che viene, la speranza non sarebbe che il calcolo di un programma. Se ne avrebbe la prospettiva, ma non si attenderebbe più nulla ne nessuno. Il diritto senza la giustizia".
IL DECOSTRUZIONISMO
Il panorama culturale e le componenti che agiscono sulla formazione di Jacques Derrida sono genericamente quelle della Nietzsche-Renaissance degli anni Sessanta del Novecento. Le indagini genealogiche nietzscheane costituiscono in quegli anni la chiave con cui il cosiddetto "poststrutturalismo" giunge a incrinare il carattere apollineo del formalismo strutturalista: l'indagine genetica - o meglio energetica - tende a leggere ogni costituzione di forma non già come sincronicità strutturale, ma come differenzialità dinamica, economica, effetto di determinati rapporti di forze.
Come nelle indagini foucaultiane, ogni struttura rappresenta sempre una forma di dominio che si tratta di smascherare e di scuotere nelle sue fondamenta. Princìpi che nello strutturalismo assumono una funzione eminentemente ordinatrice - la differenzialità sistemica, il principio della linearità del significante, la distinzione significato/significante - vengono così nel poststrutturalismo, e in particolare nel decostruzionismo derridiano, "distorti", diventando piuttosto princìpi entropici, di disordine, di disorganizzazione, di liberazione del desiderio dalle repressioni del "sistema".
Insieme a Nietzsche, è dagli altri due tradizionali maestri del sospetto, Marx e Freud, che la filosofia di Derrida riceve infatti la sua impronta. Marx, al quale Derrida ha dedicato lo scritto Spettri di Marx, agisce nella componente politica che Derrida ritiene sempre indissociabile dall'operazione decostruttiva e smascherante, mentre Freud costituisce un termine di riferimento cui Derrida si richiama in momenti nevralgici della sua elaborazione teorica, come a proposito dei "concetti" di différance o di traccia: la figura di Freud è nel discorso di Derrida giocata soprattutto in contrappunto a un'altra sua fondamentale matrice, la fenomenologia di Husserl.
Husserl costituisce il primo banco di prova della decostruzione: a lui, oltre al "mémoire" Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, sono dedicati due tra i primi libri pubblicati da Derrida, l'Introduzione a 'L'origine della geometria' di Husserl, del 1962, e La voce e il fenomeno, del 1967, di cui Derrida dice che "è forse il saggio a cui tengo di più" (Posizioni).
Il rapporto di Derrida con la fenomenologia è fortemente influenzato da componenti psicoanalitiche: la decostruzione è una fenomenologia, non di ciò che si presenta, di ciò che c'è, bensì di ciò che non si presenta né può mai presentarsi, una fenomenologia cioè della traccia, di ciò che non c'è, di ciò - ripetendo qui la definizione che Derrida da della traccia in La différance - che si cancella nel momento stesso della sua iscrizione.
Se la decostruzione è fenomenologica, lo è paradossalmente contro la fenomenologia: il suo scopo non è l'epochè attuata in nome e in vista del senso, ma l'epochè del senso, la messa tra parentesi del senso per aprire sull'orizzonte della sua costituzione, su un certo non-senso, ossia l'inconscio.
Una tale presa di distanza dalla fenomenologia costituisce un momento interpretativo utile per comprendere anche il rapporto di Derrida con Heidegger e con l'ermeneutica. Indubbiamente, se l'indagine heideggeriana - ed ermeneutica in generale - è intesa come un tentativo di ricostruzione di un senso perduto, la decostruzione non è ermeneutica; se però si svolge fino in fondo - come pare fare Derrida - la difficoltà da Heidegger stesso evidenziata, e da Gadamer portata a chiarezza teorica, insita in ogni progetto ermeneutico di tipo ricostruttivo, la decostruzione, per quanto lateralmente, può anche essere intesa come una sorta di nichilismo ermeneutico o ermeneutica nichilista.
I testi di Derrida appaiono spesso come commenti ad altri testi, filosofici o letterari, linguistici, antropologici o politici, il cui scopo non è la ricostruzione del loro senso, bensì l'evidenziazione delle loro pieghe autodestrutturanti. A Heidegger Derrida riconosce esplicitamente il merito di aver ispirato il suo progetto filosofico (innumerevoli sono i testi a lui dedicati: Ousia e grammè, Dello spirito, Differenza sessuale-differenza ontologica, La mano di Heidegger, ecc.): "nessuno dei miei tentativi sarebbe [...] stato possibile senza l'apertura delle domande heideggeriane" (Posizioni).
Il debito più importante nei confronti di Heidegger consisterebbe in quella critica alla metafisica della presenza che costituisce l'orientamento costante della decostruzione e di cui Heidegger avrebbe consentito l'apertura con le indagini svolte in Essere e Tempo. Se la decostruzione ha una carica sovversiva veramente radicale, che sola spiega l'orientamento così marcatamente etico-politico e il particolare linguaggio che essa ha assunto soprattutto in tempi recenti (a fine Novecento Derrida non parla quasi più di différance, traccia, grammatologia, concetti che hanno giocato un ruolo primario nell'elaborazione dei suoi testi tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta), è solo alla luce della critica heideggeriana alla metafisica della presenza. Essa comporta una serie di conseguenze paradossali, da Derrida esplicitamente assunte: da quella del carattere necessariamente avventuroso del pensiero che cerca di svincolarsi da tale metafisica (ovvero dalle sue presupposizioni logiche e gnoseologiche: dal principio di identità a quello dell'evidenza, dall'esigenza della fondazione al primato dell'ideale), alla tematizzazione cosciente e coerente dell'impossibilità teorica di una tale uscita.
Il carattere paradossale della decostruzione costituisce una connotazione che ha da più parti suggerito un accostamento con le avanguardie artistiche, e in particolare con il dadaismo. La decostruzione non vuole comunque essere, nell'intento di Derrida, uno tra i tanti discorsi apocalittici sulla fine, e in particolare sulla fine della filosofia, quanto piuttosto un tentativo di delimitazione del discorso filosofico, che ha molto in comune, in effetti, con il programma dadaista: essa si pone al limite del discorso filosofico, limite "a partire dal quale la filosofia è diventata possibile e si è determinata come episteme funzionante all'interno di un sistema di costrizioni fondamentali, di opposizioni concettuali al di fuori delle quali essa diventa impraticabile" (Posizioni).
Non stupisce quindi come lo stile volutamente asistematico e spesso distante dal modo tradizionale dell'argomentazione filosofica (si pensi a testi soprattutto degli anni Settanta come La verità in pittura, La disseminazione, Glas - che ha fatto quasi gridare allo scandalo - o Envois), il linguaggio fortemente idiomatico e l'uso, spesso ironico, della citazione, siano elementi non secondari, diremmo anzi intrinseci al procedere decostruttivo, il quale si configura esplicitamente come una commistione di linguaggi (filosofico, psicoanalitico, fenomenologico, politico) tra cui è difficile individuare quello dominante. Siamo in presenza di un insieme di tratti che hanno fatto di Derrida - sia in senso positivo sia in senso negativo - uno dei maggiori esponenti di quella che è stata definita condizione postmoderna.
SPECULARE SU FREUD
Speculare su "Freud" è la traduzione della seconda parte di un'opera apparsa nel 1980 (Parigi, Flammarion) con il titolo di La carte postale. De Freud à Socrate et au-delà, di cui era già apparsa la traduzione italiana della terza parte (La lettera rubata, Milano 1975) dedicata a Jacques Lacan e alla sua lettura di The Purloined Letter, "La lettera rubata", il celeberrimo racconto di Edgar Allan Poe.
Altro riferimento, questa volta legato all'occasione accademica: Speculare è la parte pubblicata di un seminario sull'argomento La vita la morte che Derrida tenne nel 1975 all'École des Hautes Études di Parigi, dedicato principalmente a Nietzsche ma allargato a Freud, a Heidegger, alla storia e all'epistemologia delle moderne scienze della vita, durante il quale Derrida intraprese un percorso in tre tempi e tre circoli, l'ultimo dei quali, appunto, è quello disegnato attorno a Freud e al testo forse più difficile ed oscuro che il padre della psicoanalisi ha lasciato in eredità: Al di là del principio di piacere.
Il testo su Freud occupa un posto importante sia nell'ampia produzione del filosofo francese sia, più in generale, nella pratica testuale di un incrocio tra filosofia e psicoanalisi. In Derrida i riferimenti alla psicoanalisi sono innumerevoli e disseminati; tuttavia pare opportuno leggere Speculare accanto a Freud e la scena della scrittura, saggio contenuto in La scrittura e la differenza, e a Mal d'archivio. Un'impressione freudiana, che sono due momenti in cui Derrida assume Freud come "oggetto" di indagine e mette in opera una sorta di riscrittura della psicoanalisi all'interno del discorso della filosofia.
Questa operazione è tutto meno che neutra; anzi, essa è un modo per istituire delle "corrispondenze" (sia nel senso di missive, di invii, addirittura di cartoline postali sia nel senso di relazioni logiche) tra due grandi della nostra epoca che non si sono mai letti: Freud, appunto, e Heidegger. Ma se Freud e Heidegger si sono ignorati, ci dice Derrida, noi non possiamo non leggere l'uno assieme all'altro e cercare di articolare un discorso che tenga conto degli apporti, separati ma talvolta sorprendentemente convergenti, della psicoanalisi e di una certa filosofia. "Si ha qui una corrispondenza fra due autori che, secondo le apparenze e i criteri comuni, non si sono mai letti e tanto meno incontrati. Freud e Heidegger, Heidegger e Freud. Ci muoviamo nello spazio circoscritto e orientato da questa corrispondenza storica (…)".
Vicinanza e lontananza dell'uno rispetto all'altro (e viceversa) come se entrambi, ciascuno a suo modo, avesse pensato quella che Derrida chiama un'economia della morte, la legge che lega la vita e la morte. In questo senso, "…l'analitica esistenziale del Da-sein è inseparabile da un'analisi dell'al-lontanamento e della prossimità che non risulterebbe così estranea a quella del fort/da".
Infatti Speculare è una lettura (ma anche una scrittura) della scena in cui ha luogo il momento più denso della narrazione di Freud nell'Al di là del principio di piacere: l'esempio del gioco del rocchetto in cui il piccolo nipote, Ernst, si cimenta. Il gioco di avvicinamento e di allontanamento, di fort/da, in cui la posta - ipotizza Freud - è il controllo dell'angoscia prodotta dalla perdita dell'oggetto (il rocchetto che simbolizza la madre), è un gioco che si raddoppia nell'osservazione e nella scrittura di questa esperienza. Derrida mostra come le descrizioni di Freud, e il tentativo di avanzare una tesi che possa spiegare come questo gioco sia in rapporto all'al di là del principio di piacere, siano già scritte nella scena del rocchetto, secondo un legame di supplementarità che unisce la descrizione del gioco e la formulazione della tesi. Una scena è sempre inscritta nell'altra e viceversa, e mai l'una è del tutto riducibile all'altra.
In un passo-chiave della sua analisi Derrida dice: "Ammettiamo che Freud scriva. Scrive di scrivere, descrive ciò che descrive, il che è anche ciò che fa, fa ciò che descrive, ossia ciò che Ernst fa: fort/da, con il suo rocchetto". Se Ernst gioca al fort/da con il suo rocchetto, lanciandolo al di là del lettino e facendolo sparire, per poi trarlo a sé, facendolo ricomparire, Freud sembra fare altrettanto con la stesura de L'al di là. Il che porta Derrida a enunciare una sorta di legge che regola il rapporto tra il fort/da e la scrittura: "La scena del fort/da, quale che sia il suo contenuto esemplare, sta già da sempre scrivendo, in rapporto differito, la scena della propria descrizione. La scrittura di un fort/da è sempre un fort/da (…)".
Qual è l'effetto sulla scrittura del testo, del movimento del fort/da che è sempre un movimento che fa i conti, cioè che in definitiva "specula" con la morte? In che cosa lo riconosciamo, seguendo Derrida? L'effetto è quella che Derrida chiama l' atesi", cioè l'impossibilità di avanzare, da parte di Freud. "Avanzare" sia in senso di avanzare una tesi sul rapporto tra il principio di piacere e la pulsione di morte (ricordiamo come il saggio prenda le mosse proprio dall'esigenza di spiegare alcuni fenomeni di ripetizione di esperienze traumatiche, il che avrebbe contraddetto il principio di piacere), sia, e soprattutto, "avanzare" nel senso di procedere al di là, al di là del principio di piacere, verso la morte e il suo principio.
Ogni tentativo di procedere oltre ("facciamo ancora un passo…", "ein Schritt weiter", ripete Freud in continuazione a ogni ripresa di capitolo) è uno scacco, fino alla paralisi, fino alla necessità della ripetizione che lega ogni allontanamento a un riavvicinamento. Movimento che lascia sul posto, per così dire, che non fa avanzare di un passo la scrittura di Freud, secondo un "ritmo differenziale" che mette in scena, nella scrittura, l'oscillazione tra la vita e la morte.
Testi di J. Derrida
- La scrittura e la differenza, Einaudi
- Lo spergiuro. Il tempo dei rinnegati, 2013, Castelvecchi
- Luoghi dell'indicibile, 2012, Rubbettino
- Helene Cixous, per la vita, 2012, Marietti
- «Il faut bien manager». O il calcolo del soggetto, 2011, Mimesis
- Spiegare Ponge. Colloquio con Gérard Farasse, 2011, Mimesis
- Gli occhi della lingua, 2011, Mimesis
- Nietzsche e la macchina. Intervista con Richard Beardsworth, 2010, Mimesis
- La bestia e il sovrano. Vol. 1: (2001-2002), 2009, Jaca Book
- La bestia e il sovrano. Vol. 2: (2002-2003), 2010, Jaca Book
- Avances, 2010, Mimesis
- Dello spirito: Heidegger e la questione, 2010, SE
- Al di là delle apparenze. L'altro è segreto perché è altro, 2010, Mimesis
- Firmatoponge, 2010, Mimesis
- La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, 2010, Jaca Book
- Psyché. Invenzioni dell'altro. Vol. 1, 2008, Jaca Book
- Psyché. Invenzioni dell'altro. Vol. 2, 2009, Jaca Book
- Derridabase. Circonfessione, (con Bennington Geoffrey), 2008, Lithos
- Adesso l'architettura, 2008, Libri Scheiwiller
- Incondizionalità o sovranità. L'università alle frontiere dell'Europa, 2008, Mimesis
- Marx & sons. Politica, spettralità, decostruzione, 2008, Mimesis
- La farmacia di Platone, 2007, Jaca Book
- Toccare, Jean-Luc Nancy, 2007, Marietti
- Ciò che resta del fuoco. Testo francese a fronte, 2007, SE
- Il tempo degli addii, 2006, Mimesis
- Et cetera. (And so on, und so weiter, et ainsi de suite, etc.), 2006, Castelvecchi
- Glas. Testo italiano e francese, 2006, Bompiani
- Breve storia della menzogna. Prolegomeni, 2006, Castelvecchi
- «... Soprattutto: niente giornalisti!». Quel che il Signore disse ad Abramo, 2006, Castelvecchi
- Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo!, 2005, Cronopio
- Abramo, l'altro, 2005, Cronopio
- Economimesis. Politiche del bello, 2005, Jaca Book
- Ogni volta unica, la fine del mondo, 2005, Jaca Book
- Antonin Artaud. Forsennare il soggettile, 2005, Abscondita
- Perdonare, 2004, Cortina Raffaello
- Sulla parola. Istantanee filosofiche, 2004, Nottetempo
- Quale domani? (con Roudinesco Elisabeth), 2004, Bollati Boringhieri
- Il monolinguismo dell'altro o la protesi d'origine, 2004, Cortina Raffaello
- Ulisse grammofono. Due parole per Joyce, 2004, Il Nuovo Melangolo
- Memorie di cieco. L'autoritratto e altre rovine, 2003, Abscondita
- Stati canaglia, 2003, Cortina Raffaello
- Il diritto alla filosofia dal punto di vista cosmopolitico, 2003, Il Nuovo Melangolo
- Forza di legge. Il «Fondamento mistico dell'autorità», 2003, Bollati Boringhieri
- Donare la morte, Derrida Jacques, 2002, Jaca Book
- Società e discorso. L'etica della comunicazione in Karl Otto Apel e Jacques Derrida. Con un inedito di Jacques Derrida: I limiti del consenso (con Dal Bo Federico), 2002, Mimesis
- L'università senza condizione, (con Rovatti P. Aldo), 2002, Cortina Raffaello
- Camilla Adami. Catalogo della mostra (Milano, aprile-maggio). Ediz. italiana e francese, 2001, Mazzotta
- Interpretazioni in guerra. Kant. L'ebreo, il tedesco, 2001, Cronopio
- Paraggi. Studi su Maurice Blanchot, 2000, Jaca Book
- Speculare su «Freud», 2000, Cortina Raffaello
- Ecografie della televisione, (con Stiegler Bernard), 1997, Cortina Raffaello
- Limited inc., 1997, Cortina Raffaello
- Margini della filosofia, 1997, Einaudi
- Donare il tempo. La moneta falsa, 1996, Cortina Raffaello
- Mal d'archivio. Un'impressione freudiana, 1996, Filema
- Politiche dell'amicizia, 1995, Cortina Raffaello
- Essere giusti con Freud. La storia della follia nell'età della psicoanalisi, 1994, Cortina Raffaello
- Gli spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, 1994, Cortina Raffaello
- Otobiographies. L'insegnamento di Nietzsche e la politica del nome proprio, 1993, Il Poligrafo
- L'archeologia del frivolo. Saggio su Condillac, 1992, Dedalo
- I problemi della genesi nella filosofia di Husserl, 1992, Jaca Book
- Sproni. Gli stili di Nietzsche, 1991, Adelphi
- Il fattore della verità, 1978, Adelphi
- L'animale che dunque sono, 2006, Jaca Book
- Aporie, 2004, Bompiani
- Il sogno di Benjamin, 2003, Bompiani
- Come non essere postmoderni. Post, neo e altri ismi, 2002, Medusa Edizioni
- Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione, 1999, Ombre Corte
- Il gusto del segreto, (con Ferraris Maurizio), 1997, Laterza
- Saggio sull'autobiografia. Memorie per Paul De Man, 1995, Jaca Book
- Ritorno da Mosca. Omaggio a Jacques Derrida, 1993, Guerini e Associati
Download
- Derrida & Co.: la differenza compatibile (pdf-zip)
- Kafka e Derrida: l’origine della legge (pdf-zip)
- Derrida e Lacan: un incontro mancato? (pdf-zip)
- Derrida e Deleuze (pdf-zip)
- Derrida e il pensiero del vivente (pdf-zip)
- Lettera a un amico giapponese (pdf-zip)
- Tempo e Traccia in Derrida (pdf-zip)
- Derrida e Merleau-Ponty (pdf-zip)
- Derrida e lo strutturalismo (pdf-zip)
- Derrida e la decostruzione dell'ebraismo (pdf-zip)
- Economia e teo-logia negativa in Derrida (pdf-zip)
- Cartesio e l’indebolimento binario in rapporto a Derrida (pdf-zip)
- Derrida e l'esperienza dell'impossibile (pdf-zip)
- Derrida e il decostruzionismo (pdf-zip)
- Tre tesi di Derrida su come "decostruire" la costruzione terroristica (pdf-zip)
- Odifreddi intervista Derrida (pdf-zip)
- Derrida, la voce e il fenomeno (pdf-zip)
- La scrittura e l’intenzionalità non presente a se stessa (pdf-zip)
- Tracce del “religioso” nella scrittura di Derrida (pdf-zip)
- L'essere fuori luogo secondo Derrida (pdf-zip)
- Nazismo e decostruzione: come Jean-Pierre Faye demolisce Derrida (pdf-zip)
- Derrida e la questione dello sguardo (pdf-zip)
- Il nome a venire. La questione della nominazione a partire da Jacques Derrida (pdf-zip)
- Introduzione a Derrida (pdf-zip)
- Scrittura filosofica e pratica di decostruzione (pdf-zip)
- Gli animali di Jacques Derrida (pdf-zip)
- Modalità di lettura-scrittura in Derrida (pdf-zip)
- Il tema della scrittura nell'opera di Jacques Derrida (pdf-zip)
- Derrida e la fenomenologia (pdf-zip)
- L’animale che dunque sono (pdf-zip)
- Ricostruire Derrida (pdf-zip)
- Scrittura: la genesi del significato (pdf-zip)
- Sulle tracce di Derrida. I fantasmi materialisti esigono memoria (pdf-zip)
- Derrida filosofo politico (pdf-zip)
- Della grammatologia (pdf-zip)