TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
MARSILIO DA PADOVA (1270-1342)
I - II
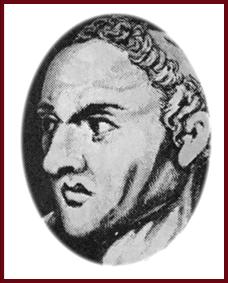
Occorre riferirsi qui subito, con evidenza, a quello che forse è l’esempio massimo di moderna laicità, nella cultura trecentesca, l’opera di Marsilio da Padova Defensor pacis, dedicata all’imperatore Lodovico, che sopravanzava molto quella politica di frate Guglielmo d’Ockam.
Il laico Marsilio, averroista italiano, ghibellino, medico e giurista, maestro delle arti e temporaneo rettore dell’università di Parigi, era espressione della civiltà comunale italiana. La sua avversione all’imperialismo papale, catastrofico per l’unità e la pace in Italia, originava – come l’ostilità dantesca – dalla situazione storica italiana. Da qui il titolo Defensor pacis, che esprime la preoccupazione politica dominante dell’autore, confermata dall’indicazione tematica dell’esordio dell’opera: la “tranquillità” civile nella città e nello stato.
Altrettanto dichiarata dall‘inizio è l’ispirazione diretta alla Politica aristotelica, per cui probabilmente valse la collaborazione all’opera di Jean de Jaudun, maggiore averroista francese. E’ assai strana seppure non insolita la disparità rispetto all’opinione corrente degli studiosi, che si riscontra nel vol. IV e aggiunto dei fratelli Carlyle, così inutilmente insistenti nel negare alle tesi del Defensor pacis un carattere di modernità “rivoluzionaria”, che l’autore non presumeva e nessuno credo gli abbia attribuito.
I Carlyle si riferivano in retrospettiva ai notevoli e pure contraddittori aspetti di secolarizzazione desacralizzante, che affioravano nelle discussioni dei giureconsulti franco-inglesi, a difesa dell’autonomia dell’imperium, col ritorno alle fonti del diritto romano. E citavano quell’Egidio Colonna (Romano) autore fra i secoli XIII-XIV delle citate opere come il De regimine principum e il De ecclesiae potestate, sbilanciate verso il sovra-potere pontificio.
Ma più in particolare citavano il De legibus dell’inglese Bracton, per la sua valorizzazione della priorità della legge, fondata non solo sulla volontà del principe, coadiuvato dai suoi maggiorenti, ma pure sull’approvazione della comunità, il populus fonte nominale del diritto romano (vol. III, pp. 56ss., 89ss.).
E’ superfluo dire che gli essenziali aspetti di novità “laica” e “democratica” erano ricondotti (sempre dai Carlyle) allo studio bolognese di giurisprudenza romana, rifondato da Irnerio nell’XI secolo, cioè ai princìpi del diritto romano, che erano espressione eminentissima di ben altra civiltà politica da quella anche tardo-medioevale. Ma che addirittura li esibiscano come “princìpi tradizionali” nella teoria e perfino nella prassi medioevale, cioè nella civiltà feudale e teocratica cristiana, è assurdamente mistificatorio e contraddetto dallo sviluppo della loro stessa opera (vol. III, pp. 409ss.; vol. IV, pp. 11ss., 45ss.).
Se si riferissero al tardo affermarsi della civiltà comunale e del sistema rappresentativo, dovrebbe essere precisato ma non lo è e anzi, con tipica astrazione dalla violenza di contrasto degli eventi storici europei, si tende a fare apparire quelle difficili conquiste come espressione “caratteristica” del Medioevo, mentre ne erano conflittualmente l’uscita liberatoria.
Il Defensor pacis – ripeto, legato alla premoderna civiltà cittadina dei comuni –, è apparso in ovvio senso relativo così “moderno” anticipatore della società futura, giacché nessuno dei testi coevi appare così radicalmente “secolare” come il Defensor pacis.
Quasi in deliberato contrasto, un altro studioso inglese, Harold J. Laski, professore di scienze politiche a Londra, valutava così altamente l’apporto teorico di Marsilio, “l’esponente di gran lunga più brillante della vera controversia con Roma”, da scrivere: “Le concezioni, che queste tesi gigantesche implicano, adombrano quasi ogni punto della moderna filosofia politica. La sostituzione del popolo al sovrano quale vera fonte del potere, l’insistenza sulla tolleranza religiosa, la riduzione del clero da una gerarchia che domina la vita degli uomini a un ministero al servizio dei medesimi, tutto questo, esposto nei minimi particolari, costituisce una profezia così audace da non avere uguali nella storia del pensiero umano” (Il pensiero politico del tardo medioevo, in Storia del mondo medievale, vol. VII, pp. 892-93).
L. de Lagarde intitolava il vol. II della sua opera Naissance de l’ésprit etique au declin du Moyen-âge (1934): Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l’État laïque. E’ al contrario al limite dell’insensato l’interpretazione di un altro francese, Marcel Prélot, che in una sua sintesi opinabile di Storia del pensiero politico (1970, tr.it. Mondadori 1975), scrive che Marsilio avrebbe teorizzato lo “stato totalitario” (p. 161), il cui modello totalitario, strutturale e metodologico, può scorgersi solo nell’autoritarismo poliziesco dei sacri imperi e delle burocrazie ecclesiastiche.
E’ invece apprezzabile che pure lo “spiritualista cristiano” F. Battaglia (già autore di un Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medioevo, Le Monnier 1928) abbia riconosciuto che Marsilio svolse un nuovo “principio laico”, spinto “con tutta la coerenza possibile fino a scuotere le basi della visione della vita propria dei secoli di mezzo” (Il pensiero politico medievale, in Nuove questioni di storia medioevale, Marzorati 1964, p. 523). In tale prospettiva pure un altro storico americano del pensiero politico, George H. Sabine (Storia delle dottrine politiche, 1937, 1949, tr.it. Comunità 1953, p. 232), lo definiva “aristotelico averroista”.
Marsilio teorizzava la fondazione “aristotelica” cioè mondana e razionale, civile e laica dello stato, in cui la religione è inserita come cosa estranea, affidata a una classe speciale, il clero pari a ogni altra classe sociale, la cui funzione è di insegnare le “verità” irrazionali, le cose che secondo la Scrittura si devono credere, fare o non fare, per la salvezza oltremondana, e per evitare il male (Defensor pacis, I, VI,8, mia parafrasi breve dalla antologia di A. Sabetti, Liguori 1966, che integra lo studio su Marsilio da Padova, Liguori 1964; la traduzione integrale dell’opera è di C. Vasoli, 2^ UTET, 1975).
E’ un rovesciamento poderoso, non solo rispetto all’intero Medioevo, ma alla intera storia del cristianesimo ecclesiale pontificio alleato dell’impero, dalle origini costantiniane. Diceva bene Sabine che tale separazione drastica, fra l’altro anti-tomistica, fra ragione e fede, è “l’antenata diretta dello scetticismo religioso” e, nelle sue conseguenze, si risolve in un "secolarismo anticristiano e antireligioso insieme” (p. 236). Di fatto solo con questa opera si ha una sortita concettuale e culturale dal Medioevo cristiano.
Marsilio era perfettamente conscio della “ardua impresa” che si era assunto, dovendo sfidare e contrastare “la persecuzione del potere violento del vescovo romano e dei suoi complici” (II, II 1). Il Defensor pacis fa distinta analogamente dalla legge “divina” la legge umana, quale prodotto esclusivamente umano e “comandamento” della “totalità dei cittadini” (universitas civium), o della sua parte prevalente elettiva o assembleare: questa legge è “civilmente vantaggiosa”, diretta solo al vantaggio comune, in cui consiste la “giustizia civile” (I, XI,1), che quindi ha una sanzione giuridica, coercitiva e penale, solo umana, legislativa e cioè giuridica.
Il centro protagonistico dello stato laico di Marsilio è il legislator, “causa prima efficiente della legge”, che s’identifica sempre con l’universalità dei cittadini o con la sua rappresentanza, che istituisce la pars principans governante, il monarca o comunque l’organo che governa, che comanda e decide, avendo potere coercitivo, ma sempre per mandato dei “popoli” (I, XII,3). Non poteva ancora riferirsi al potere legislativo, ma a quello di governo della comunità politica autonoma – come scriveva Sabine –, “secondo un concetto comune alla città-stato” (p. 237): io direi in un’ottica democratica comunale, che d’altra parte implica pure il potere di legiferare. In questo senso è superflua perché scontata la discussione di McIllwain su questo cap. XII del trattato, “probabilmente il più interessante e importante di tutto il libro” (pp. 371ss.). Ma è lo stesso studioso che, rigettando le interpretazioni troppo modernizzanti, ne riconosce la “modernità” storica (p. 377).
Quanto al secondo Discorso di attacco virulento ai privilegi del potere ecclesiastico, si è accennato come la riduzione sia la più estrema del secolo, nella giusta esigenza di applicare i medesimi princìpi politici, enunciati finora per la comunità civile, alla chiesa cattolica concepita anch’essa, come era in origine, unicamente quale comunità, precisamente come civium fidelium universitas, ovvero “popolo cristiano”, che si identifica con la comunità civile.
Se la chiesa nel suo costituirsi come regnum, con governo monarchico, esercita nel suo interno i poteri previsti dal suo ordinamento, è indubitabile che la comunità cristiana, e pure la gerarchia ecclesiastica, fatta da e di uomini, essendo una comunità politica sottostà alle leggi, al governo civile, ai suoi obblighi e alle sue sanzioni penali, assorbendo e vanificando così la legislazione canonica.
Marsilio anzi civilizza tutto l’apparato ecclesiastico, dai poteri penali (scomuniche ecc.) alle proprietà in concessione, perfino agli obblighi legali delle funzioni religiose, senza parlare del diritto pubblico di destituire ogni autorità ecclesiastica, incluso il papa. Notava Sabine: “L’idea che la filosofia politica difendesse la libertà religiosa è totalmente errata. I despoti nazionali del periodo della Riforma, nella illegalità della loro posizione, raramente giunsero agli estremi che la sua teoria giustificherebbe, e la cui conclusione sarebbe la soggezione assoluta della religione al potere civile” (p. 240).
La dottrina del Defensor pacis era comunque una destituzione globale della pretesa plenitudo potestatis, di ogni potere ecclesiastico che non sia “spirituale”. Una utopia irrealizzabile, come si è constatato nelle compromissioni politiche dei secoli moderni, proprio perché la costituzione gerarchica risponde puramente a esigenze mondane di potere politico, non a esigenze “spirituali” seriamente sostenibili.
Sabine scriveva che questo preparava la Riforma futura, ma per me aveva torto, perché la Riforma protestante comunque sembrava muovere da esigenze mistico-religiose, mentre la destituzione di Marsilio lui stesso la caratterizza come tendenziale agnosticismo laico.
In questo senso, dopo avere censurato McIllwain, mi piace riportare sue parole conclusive di ampio riconoscimento della sua opera, che una volta tanto ritengo pienamente condivisibili. “Il grande significato del Defensor pacis sta nel fatto che in esso per la prima volta lo stato secolare pretende una uguaglianza pratica che può essere ottenuta soltanto attraverso una superiorità teorica. I papisti estremi avevano trattato per qualche tempo lo stato come un ufficio subordinato della chiesa: il Defensor pacis è il primo libro che rovesci il procedimento e che consideri la chiesa come un ufficio dello stato, in tutte le questioni di interesse terreno. Il Defensor pacis è il primo libro, in tutta la lunga controversia, che neghi al clero qualsiasi autorità coercitiva, spirituale o temporale, diretta o indiretta. Perciò deve essere considerato come una vera pietra miliare, non soltanto nella storia della lotta tra chiesa e stato, ma nello sviluppo complessivo del pensiero politico” (p. 387).
Purtroppo questo era un livello e modello dottrinale, quasi estremo e quindi utopico in epoca, sollecitato e motivato dalle controversie politiche anti-ecclesiastiche, che nella realtà si scontrava con la cultura dogmatica dominante, con l’ordine del mondo imposto nella coercizione teo-politica ecclesiale. Nei cui confronti non l’uomo generico, ma l’intellettuale pensante e scrivente, guadagnava a fatica e spesso con incoerenza e fallimento la propria autonomia di mente e di coscienza, la propria autentica “dignità” umana.
Con tipica visione storico-erudita Garin, notoriamente benemerito degli studi su Umanesimo e Rinascimento, su cui ha prodotto molti libri, perlopiù raccolte di studi specifici, constatava e a un tempo sollecitava ancora un apprezzamento “positivo” sia del Medioevo che del Rinascimento, superando la contrapposizione ottocentesca (anche di Burckhardt), protratta fino nel 900. E citava Hauser quasi come modulo di giudizio consensuale: “il Medioevo è probabilmente morto per avere realizzato col Rinascimento la maggior parte dei suoi sogni” (cit. in Umanesimo e Rinascimento, op. cit., p. 358). Che è una battuta priva di senso, se non si precisa di quale “medioevo” si parla, pure nell’affermazione bilanciata che “le due età si implicano e si escludono reciprocamente” (ivi).
Io concordo nel senso dell’impegno di storicizzare ogni età, fuori o dentro le partizioni artificiose ma irrinunciabili di cui si è indotti a abusare. Lo ripeto, Medioevo Umanesimo e Rinascimento non sono che nomi, come gli dèi tutti, personificazioni sfruttate come indispensabili al discorso storico, ma in sé vuote, cioè da riempire di dati di fatto storici. Nel flusso continuo della storia umana, in perpetuo mutamento, è ovvio che si osservino successioni di fenomeni, in evoluzione o involuzione secondo i punti di vista ideo-culturali assunti dallo storico.
Il Medioevo millenario è un lungo scenario di eventi economico-politici, di poteri istituzionali auto-conservativi, di interessi in conflitto con altri che vi si oppongono in competizione incessante, con enorme spargimento di sangue; è una storia di protagonisti diversissimi, di fatti culturali in sviluppo, che modificano ogni momento la fisionomia epocale.
Nel Medioevo gli imperi si succedono, la sola spettrale permanenza “divina” è quella imperiale ben più temibile, possessiva e totalitaria della chiesa romana. Ma nello stesso Medioevo lo sviluppo italiano e poi europeo delle città, l’acquisto contrastato e il difficile mantenimento delle autonomie politiche, è una conquista civile e perciò “umanistica” primaria e prioritaria, che cioè precedette di secoli le poche acquisizioni innovative o espressioni eterodosse di inibiti intellettuali organici della chiesa cattolica, o dei “laici” cittadini controllati sempre dal potere ecclesiastico. Pure il nostro sondaggio rapido, che seguirà, lo conferma: poterono molto più, in senso oppositivo “riformatore”, i vari moti ereticali interni (se così può dirsi) alla chiesa, fino al gioachimismo più fantasioso.
E’ bene poi ribadire – V. Rossi aveva ragione – che il vero “umanesimo” si formava e si realizzava fuori, col risveglio della vita reale cittadina, con lo sviluppo delle libertà comunali, in cui l’“umanità” dei rapporti inter-individuali e di gruppo si affermava nel vigore dei suoi stessi conflitti, con la formazione e la crescita economico-politica e giuridica di una nuova “borghesia” laica mercantile e professionale. Che si espandeva dalle campagne nelle città, in senso antifeudale e anti-autoritario, quindi anche anti-ecclesiastico (Pirenne, Le città del Medioevo cit., capp. VII-VIII), con lo sviluppo di una libera economia produttiva proto-capitalistica, di scambio monetario ecc. (v. J. Rossiand, in L’uomo medievale cit., pp. 168ss.).
E’ questo l’autentico “umanesimo” tardo-medioevale, che coincise con la nascita e la diffusione delle lingue “volgari” e delle letterature profane, poesia erotica stilizzata, ma anche la prosa “realistica” delle “croniche” ecc., in cui la “umanità” della vita cittadina è ritratta e testimoniata quasi al vivo.
Che altro “umanesimo” si vuole oltre questo, che non necessitava di modelli classici, di “ritorni” filosofici, ma prorompeva nella vita reale delle città e delle campagne? Mentre i poeti stilnovizzavano le loro immagini femminili, allegoriche o “reali”, mentre gli intellettuali dotti dissertavano come Dante stesso sull’Amore e sulla Filosofia, la “umanità” della vita reale si agitava fuori e intorno travolgente.
Dante stesso, umanissima vittima, travagliata e sconfitta, esiliato e quasi mendicante nelle corti italiane, scrive il suo grande e dis-umano “poema sacro”, sovraccarico del mondo reale in cui vive, ma stipato nelle sue costrittive strutture giudiziali. Strutture radicalmente alienanti rispetto alla propria stessa “umanità”, per la visione mito-teologica che riconsacra poeticamente, idealmente, misticamente, remote dalla “umanità” dell’uomo reale. L’“umanesimo cristiano” è infatti, né altro può essere, che una rappresentazione perpetuata dell’“uomo medioevale”. L’umanesimo “umanistico” (“rinascimentale”) trae risalto e significato storico, nella misura in cui se ne pone contro o comunque ne esorbita per “laicità” e radicalità culturale.
L’Umanesimo insomma non consiste soltanto delle tecniche filologiche degli studia humanitatis, ma più generalmente, globalmente involge la faticosa riemersione della “cultura dell’uomo”, a tutti i livelli socio-economici e antropo-culturali.
In questa prospettiva sono da rifiutare arcate storiche indiscriminanti come quella millenaria “europea” proposta da Paul Renucci, che pure era uno storico “laico”, non confessionale, in L’aventure de l’humanisme européen au Moyen-Age (IV-XIV siècle) (Paris 1953), che identificava proprio con “Le sort de la culture classique au cours du moyen-âge”, e nella seguente pretesa “Renaissance médiévale”. Si noti infatti che una “Renaissance” qui Renucci l’attribuiva già a Teodorico (per Boezio e Cassiodoro, funzionari imperiali), e ovviamente ai gloriosi carolingi, sempre nell’ottica di una “cultura antica” in regressione e declino quasi mortale, che tuttavia “rinascerebbe” sempre, pure nei secoli più oscuri.
Ma si consideri che anche l’impegno dichiarato di Renucci era giustamente di contrastare se non sottrarre il tardo monopolio italiano dell’Umanesimo e del Rinascimento, suffragato da Burckhardt, opponendogli un fenomeno europeo (sottinteso in prevalenza francese), di “rinascita” umanistica. E ci piace che ne identifichi i valori con la “cultura antica” (classica), e coi suoi ritorni prima rari e sporadici, poi crescenti e più diffusi nella cultura medioevale.
Ci piace che qui dica d’intendere per umanesimo “la volontà di afferrare l’intera storia del pensiero e dell’arte per mobilitarla laicisticamente al servizio dell’uomo, considerato il più perfettibile degli esseri e il solo capace d’intendere, d’improntare l’universo” (p. 9).
Ma quanto si concilia tale prospettiva dell’uomo, che qui s’identifica con la “cultura antica”, e con le pretese “rinascite” medioevali: che cosa “rinasce” (e in realtà sopravvive, più o meno) nella corte di Teodorico e in quella di Carlo Magno? Ma pure in seguito, proprio in quella prospettiva, è sufficiente la ricognizione dei testi classici, magari solo quelli neoplatonici, già acquisiti e cristianizzati da Agostino, a configurare una “rinascita” definibile umanistica, nel senso antropo-culturale anzidetto?
Lo abbiamo visto nel nostro non breve percorso teo-filosofico medioevale: in cui la mistificata “continuità” non è al più che una continua o discontinua assimilazione trasformante, una “conversione” stravolgente dei valori umanistici classici. Si va dal Platone patristico, allievo di Mosè e nunzio di Cristo, all’aristotelismo cattolicizzato nella teologia sistematica del santo Tomaso: è questo l’umanesimo cristiano che può vantare la cultura medioevale europea?
Ma finanche il cosiddetto “averroismo latino” di Sigieri e lo stesso pensiero di Averroè, si è visto come trapeli in contesti teologici pur sempre istituzionali, e con quali torsioni, correzioni e ritrattazioni, con quali rischi e conseguenze personali. No, una più rigorosa visione “umanistica” è obbligata al rigetto di tali diffuse dilatazioni prospettiche, dettate da interessi politici diversi confessionali e laici, ma di scarso esito significante.
La “rinascita medioevale” è un lento processo fatto di limitati e pure minimi episodi, prodotti fra difficoltà enormi, inibizioni e repressioni ecclesiastiche sempre più tracotanti, sicché anche l’humanitas dei nostri maggiori poeti e dotti trecenteschi va limitata ragionevolmente. Ricordo il trittico coevo di volumi editi da “Belles Lettres” (1952-54), nella collana “Les classiques de l’humanisme”, Dante disciple et juge du mond latin dello stesso Renucci; Dante Minerve et Apollon di I. Batard, e Dante humaniste di Renaudet: complessivamente una amplificazione spropositata di 1500 pagine!
Lo storico Renaudet, nelle sue 550 pp. di Dante humaniste, distingueva un primo e un secondo umanismo di Dante: il breve umanesimo “laico” del Convivio, e quello teologico e mistico dilagante della Commedia, caratterizzato subito come “umanesimo cristiano”, che consistette nei limiti ampi della cultura classica di Dante.
Renaudet si poneva lui stesso preventivamente il problema del preteso humanisme chrétien, riassunto riduttivamente in una éthique de la noblesse humaine, che sarebbe “rivolta insieme allo studio e all’azione”, e riconoscerebbe, esalterebbe “la grandezza del genio umano, la potenza delle sue creazioni, e opporrebbe la sua forza alla “forza bruta della natura inanimata”.
L’essenziale sarebbe “lo sforzo dell’individuo per sviluppare in se stesso, mediante una disciplina severa e metodica, tutte le potenzialità umane, per non lasciare nulla di ciò che accresce e magnifica l’essere umano” (p. 17). Questa formulazione, che non a caso si appella subito dopo al Faust goethiano, è quanto mai ambigua appunto nel suo faustismo individualistico e superomistico della grandeur, nella nostra visione storico-umanistica nella più larga accezione etico-civile, non è l’umanesimo storico nemmeno rinascimentale, come vedremo.
E’ di grande rilievo che lo studio diretto, allora filologicamente possibile, dei testi letterari e filosofici greco-romani permettesse di conoscere la originaria humanitas naturalistica classica, perduta nelle mistificate “trascendenze” ecclesiali cattoliche. Renaudet scriveva cautamente che “essi attribuivano ai testi antichi nei quali si esprime il pensiero greco-romano la virtù di rendere gli uomini più umani conoscendosi meglio”. E però ammetteva lui stesso che “l’antichità” indeterminata, ma da intendersi “classica”, considerata globalmente nella sua cultura storico-filosofica, “non aveva mai cessato di operare nel senso e nello spirito dell’umanesimo”.
Gli intellettuali rappresentativi del rinascimento italiano ritennero – continuava Renaudet, che assecondiamo per consenso – di riprendere, dopo la lunga interruzione medioevale, l’impegno della conoscenza del mondo e della natura umana, carentissimi nel Medioevo, sul quale era fondata l’antica “educazione dell’uomo e del cittadino”, e da cui sembra si aspettassero – diceva – “la riforma intellettuale e morale della moderna cristianità” (p. 18).
Renaudet sosteneva che questo presuppone “un atto di fede nella potenza dello spirito umano, e più ancora un atto di fede nella bontà e virtù della natura umana”, opposta al tetro pessimismo cristiano ecclesiale dell’uomo peccatore, del mondo diabolico, della natura umana corrotta e dannata, che l’ecclesia divina è preposta a “salvare”, delegata dai suoi numi, nel suo ordine “soprannatuale” necessario al suo potere.
Il comico è che per tale infame concezione Renaudet rimandi al citato Esprit de la philosophie médiévale di Gilson, storico militante cattolico, e precisamente al capitolo “L’ottimismo cristiano”, ottimismo ecclesiastico s’intende. Qui si leggeva a chiare lettere che “il pessimismo cristiano sarebbe così la negazione stessa dell’umanesimo”. Anche i promotori della Riforma, a cominciare dagli anatemi di Lutero, pur sempre cristiani, erano ostili all’umanesimo sospetto di “paganesimo”, per la sua fiducia nella potenza della ragione e nella bontà della natura” (Gilson, tr.cit., p. 11). E giustamente citava l’infelice contrasto fra Lutero e Erasmo, di cui diremo più ampiamente poi.
Sono i temi fondamentali della nostra costruzione, che vediamo pienamente confermati in questa incipiente “età moderna”, la cui cultura nascente, non già “rinascente”, si produceva in opposizione e possibile cancellazione delle “soprannature” omicide ecclesiali, strumentali al suo potere mondano. Quanto e come, con quali sofferenze e rischi personali, quegli intellettuali vi riuscivano, è altro discorso da circostanziare in singoli casi, e non mancheremo di farlo.
Senonché qui lo storico della Sorbona, il laico Renaudet, tornava a sfoderare il suo mistificante “umanesimo cristiano” che, per una sorta di prodigio metafisico, di arcana coincidentia oppositorum, già dai primi secoli procederebbe insieme dalla cultura antica, avversata e combattuta come “pagana”, ma riscattata dal vangelo: si eleverebbe così “dalla scienza e dalla saggezza greche”, da quella bassura “alla santità degli apostoli”. Come non esserne edificati?
Qui è lo storico corrivo a riasserire, capovolgendo quanto detto prima da un punto di vista laico-umanistico, le falsificanti tesi ecclesiastiche cristiane, da Giustino a Ambrogio e Agostino fino a Tommaso, sostenendo che “la chiesa cristiana si mostrò attenta dalle origini a trarre partito da ciò che l’antichità aveva saputo del mondo e dell’uomo”, che quindi “fra la credenza cristiana e la ragione greca si era compiuta una riconciliazione necessaria” (p. 21). Nemmeno sfiorata l’ipotesi di una appropriazione per la propria qualificazione culturale e per la “conversione”, per una cristianizzazione che appare stravolgente, pro-prio nella prospettiva umanistica prima riassunta inequivocabilmente.
Si moltiplicano qui a conforto le citazioni più incongrue, sempre facendo fede a Gilson, col massimo semplicismo senza controllo, così mettendo insieme Agostino arcinoto “umanista” trinitario della “Città di Dio”, il monaco Alcuino patrono retorizzato della “rinascita carolingia”, e perfino i due irriducibili nemici Bernardo e Abelardo affratellati, i mistici Riccardo e Ugo da san Vittore, la “scuola di Chartres” e il monaco Giovanni di Salisbury.
Con indiscriminazione totale, del tutto acriticamente, lo storico sorbonico su tali esempi celebrava un autentico “trionfo dell’umanesimo cristiano” medioevale (p. 22), tra una “Rinascenza” e l’altra di quella orrenda storia ecclesiale. Un Renaudet apologista cattolico poteva scrivere qui che santo Tommaso avrebbe costruito, “a fronte dell’averroismo anticristiano e antiumanista, un aristotelismo insieme umanista e cristiano” (p. 23).
L’altro sostegno sicuro dello storico militante, dopo e con Gilson, era l’abate H. Bremond, per raccoglierne una esaltazione dell’“umanesimo devoto”, che nei secoli XVI-XVII, rappresentato dai mistici della Controriforma, porterà alla sublimazione il già fulgido “umanesimo cristiano”, con l’esaltazione psichiatrica della “grandezza della creatura umana”, di cui abbiamo fornito larghe prove nella ultima parte del vol. III.
Così vediamo che su tali basi equivoche, con tale confusione d’idee, lo storico francese fondava senza fondamento il suo monumento oratorio all’opinabile “umanesimo di Dante”, così viziato e in certa misura tradito, col classificarlo nella mistificante casella bremondiana dell’“umanesimo devoto”: è questo che avrebbe avuto “una magnifica affermazione già, indistintamente nell’opera filosofico-politica di Dante, nel Convivio e nella Monarchia, trionfando infine nella Commedia.
Il laico cristiano Renaudet non si accorgeva di dequalificarlo in quanto “umanesimo”, concorrendo alla tradizionale appropriazione clericale, che mostrificava quei valori “umanistici” classici, stravolgendoli nel loro esatto contrario, e peggio nei soliti mistificati ibridi falsamente conciliativi dell’inconciliabile, e solo compromissori o puramente retorici, con cui si decanta l’anti- e pseudo-umanesimo cattolico.
Si pensi che fra gli obbligati riferimenti cattolici di Renaudet c’è perfino un libro italiano di Rocco Montano (che se ne sarà lusingato), allora giovane allievo di Toffanin a Napoli, difensore e ripetitore, dell’umanesimo medioevale culminante nell’arci-umanesimo tomistico (Dante e il Rinascimento, guida 1942).
Il libro era tutta una rivendicazione polemica, dichiaratamente anti-laicistica e cattolica, della “profonda coscienza religiosa” (s’intende sempre cattolica) degli umanisti italiani, con un attacco alla tradizione laica degli studi da De Sanctis a Cassirer, a Garin e Russo ecc., a cui opponeva quella ortodossa cattolica di de Wulf, Gilson ecc.
Così Dante, dopo la “crisi giovanile”, si porrebbe “al centro fra il pensiero medievale e l’ideologia dell’umanesimo, sintesi impareggiabile del rinascimento duecentesco ed anticipazione, insieme, di quello cinquecentesco” (pp. 77ss.). Ecco il quadretto scolastico dell’assurdo storico e antistorico, in cui si profilava retoricamente, quasi caricaturata “l’immensa figura di Dante”, col consenso incredibile dello storico cristiano-sorbonico. Che su questi pilastri critici dieci anni dopo riaffermava, senza riserve critiche, come “dimostrate la legittimità dottrinale e la realtà storica di un umanesimo cristiano”, dal quale si annuncerebbe paradossalmente l’esprit de la Renaissance – si noti – “nel pieno trionfo della scolastica e della mistica”, in perfetta sintonia storico-culturale (p. 31). Così risplende l’umanesimo cristiano più devoto!
Tratto dal vol. IV di Gianni Grana
www.giannigrana.it - www.ateismodigiannigrana.it
Fonti
- Marsilio da Padova, Il difensore della pace. Testo latino a fronte, 2001, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli; Defensor pacis. Antologia di passi scelti, 1966, Liguori
La critica
- Casini Giuseppe, La «Translatio imperii». Landolfo Colonna e Marsilio da Padova, 2005, Aracne
- Merlo Maurizio, Marsilio da Padova. Il pensiero della politica come grammatica del mutamento, 2004, Franco Angeli
- Maglio Gianfranco, Autonomia della città dell'uomo e religione in Marsilio da Padova, 2003, Gabrielli Editori
- Simonetta Stefano, Dal difensore della pace al Leviatano. Marsilio da Padova nell'Inghilterra del Seicento, 2000, Unicopli
- Omaggio Vincenzo, Marsilio da Padova. Diritto e politica nel «Defensor pacis», 1996, Editoriale Scientifica
- Cropsey Joseph; Strauss Leo, Storia della filosofia politica. Vol. 1: Da Tucilide a Marsilio da Padova, 1993, Il Nuovo Melangolo
- Battaglia Felice, Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medio Evo, 1987, CLUEB
- Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale (5-6). Marsilio da Padova nel settimo centenario della nascita. Atti del Convegno (Padova, 1980), 1979, Antenore
- Piaia Gregorio, Marsilio da Padova nella Riforma e nella Controriforma, 1977, Antenore
- Saggi e ricerche su Aristotele, Marsilio da Padova, M. Eckhart, Rosmini, Spaventa, Marty, Tilgher, Omodeo. Metafisica, fenomelogia ed estetica, 1971, Antenore
- Sabetti Alfredo, Marsilio da Padova e la filosofia politica del sec. XIV, 1964, Liguori