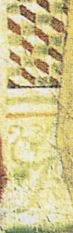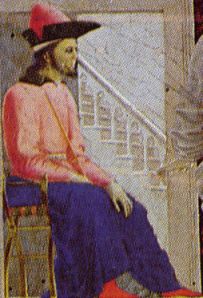PIERO DELLA FRANCESCA
LA FLAGELLAZIONE DI CRISTO
PREMESSA TECNICA DELL'OPERA

La "Flagellazione di Cristo" è una tempera su tavola di 59 x 81,5 cm, realizzata tra il 1444 e il 1469 dal pittore Piero della Francesca. Si trova presso la Galleria Nazionale delle Marche (ex Palazzo del duca Federico da Montefeltro), a Urbino. Quanto alla data oggi si tende a collocarla, prevalentemente, a ridosso della caduta di Costantinopoli (1459-60). Anche perché la struttura corinzia, la trabeazione, i rivestimenti marmorei dell'edificio, risentono fortemente dell'influenza albertiana e ciò non è riscontrabile nell’opera di alcun altro architetto rinascimentale prima del 1451.
![]()
L'opera è danneggiata da tre lunghe fenditure orizzontali e da alcune cadute di colore. A sinistra, alla base del trono, sul secondo gradino sotto il faldistorio su cui siede un personaggio con abiti alla “grecanica”, si legge, in caratteri epigrafici latini: OPUS PETRI DE BURGO S[AN]C[T]I SEPULCR[I]. Sansepolcro (provincia di Arezzo) era il suo borgo natale. In pratica è la sua firma (Petri sta per Piero).
A lungo ignorato il dipinto venne riscoperto, all’inizio dall’Ottocento, nella sacrestia del duomo di Urbino, da un tedesco, Johann David Passavant. Grazie alla lettura appassionata che ne fece, nel 1911, il critico Adolfo Venturi, da allora l'opera continua a essere la protagonista di una delle più lunghe e accanite dispute tra studiosi.
A destra, sotto i tre personaggi in primo piano, almeno fino al 1839, secondo il Passavant si leggeva la scritta Convenerunt in unum (molto probabilmente il titolo originale della tavola), tratto dal Salmo II, che fa parte del servizio del Venerdi santo, riferito alla Passione di Cristo: Adstiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eius.
Si può pensare alla tavola come fosse divisa in due aree rettangolari: da
sinistra alla colonna a metà piano, l'area in cui è rappresentata la
flagellazione e dalla colonna all'estremità destra, l'area occupata dai tre
personaggi in primo piano: le due aree stanno fra loro in un rapporto aureo,
pari al numero aureo 1,618. La sezione aurea (nota anche come rapporto aureo, numero aureo, costante di
Fidia e proporzione divina), indicata abitualmente con la lettera greca
![]() (phi), corrisponde al
numero:
(phi), corrisponde al
numero:
![]()
La luce proviene da due punti differenti, da sinistra e da destra, e illumina anche il riquadro del soffitto sotto cui è collocato il Cristo.
| Per evitare che la colonna, cui è legato il Cristo, si sovrapponesse, per un naturale effetto ottico, alla parete di fondo, il pittore ha posto sul capitello un idolo dorato, che ribadisce la centralità della colonna stessa. L'idolo d'oro è Helios, che nella mitologia greca veniva normalmente rappresentato alla guida del carro del sole, tirato da cavalli che andavano da est a ovest, permettendo così al dio di assistere ad ogni avvenimento del mondo. Helios (Elio) non solo sorvegliava costantemente l'operato degli uomini ma veniva invocato quale garante dei giuramenti. Il culto del dio sole fu importato a Roma dai Sabini, finché finì col confondersi con quello di Apollo, che aveva le stesse attribuzioni. Verso la fine dell'impero romano, il sole (Sol Invictus) in quanto tale, fu oggetto di un particolare culto da parte della famiglia degli Aureli, che se ne dicevano discendenti. In mezzo al foro di Costantinopoli si ergeva una colonna di porfido sormontata da una statua di Costantino somigliante proprio a un dio solare (Apollo-Helios). |
|
| Il fregio sul fondo della tavola, fra la
mano di Tommaso e la veste di Bessarione, sembra essere lo stesso che si ritrova nei
codici fatti miniare da Malatesta Novello di Cesena, e altri dettagli
celerebbero motivi araldici legati alla famiglia dei Malatesta. Ci si è chiesti
infatti se l’opera non
stata forse commissionata da Violante, sorella del defunto Oddantonio e del
nuovo duca Federico, nonché moglie di Domenico Novello Malatesta, signore di
Cesena, che l’avrebbe poi donata alla cattedrale di Urbino. Questo fregio ricorda alcune decorazioni del Tempio Malatestiano di Rimini:
|
|
|
| Queste scale invece sembrano un riferimento preciso alla
"scala di Pilato del Palazzo Lateranense di Roma: Precisa è anche la corrispondenza fra l'architettura ove è assiso Pilato e quella del palazzo di Salomone dove il sovrano riceve la regina di Saba negli affreschi di Arezzo. |
|
|
|
Qui Pilato assiste indifferente alla flagellazione, come Paleologo assiste indifferente alla caduta di Bisanzio. |
Molto dibattuta è stata l'identità sia delle tre figure in primo piano che di quella posta a sedere sullo sfondo. Fino all'ultima ricerca della Ronchey restavano sufficientemente attendibili due sole identificazioni: l'uomo sulla destra con il vestito di broccato, l'umanista e funzionario della curia romana Giovanni Bacci, nipote di un mercante di spezie; l'uomo seduto, in secondo piano, invece Giovanni VIII Paleologo (1425-48), penultimo imperatore di Bisanzio, che tentò per l'ultima volta la via delle trattative per l'unione delle chiese, al fine di procurarsi, a prezzo della sottomissione religiosa a Roma, l'aiuto dell'occidente contro i turchi, tante volte promesso ma mai concesso. |  I flagellatori non impongono nessun impeto ai loro gesti, come non c'è reazione emotiva da parte del Cristo. |
|
|
||
|
|
La Ronchey invece sostiene che i tre uomini in primo piano siano Bessarione, l’uomo con la barba (secondo la moda orientale), l’unico con la bocca socchiusa e la mano alzata, che parla per convincere e rassicurare i suoi interlocutori (si noti anche il lungo mantello ad ampie maniche, generalmente indossato da chi è in viaggio, con un copricapo che indica la sua carica di magistrato).. Accanto a lui, la figura di giovane biondo è quella, idealizzata, di Tommaso Paleologo, vestito di porpora ma a piedi scalzi (in attesa di riavere i calzari della sovranità bizantina e l’aiuto occidentale). All’estrema destra della tavola, infine, l’uomo dal prezioso vestito di broccato sarebbe Niccolò III d’Este, che accolse a Ferrara il concilio del 1438-39. |
|
| Il ruolo ufficiale e legale di Niccolò III d’Este (vestito con una ricca veste di broccato decorata con cardi dorati) è certificato dalla fascia rossa che scende dalla spalla destra, che è attributo cardinalizio o nobiliare. |
|
Giovanni Bacci, il committente dell’opera maggiore di Piero, Le storie della Croce di Arezzo, ricevette la carica di podestà di Cesena dal principe della città Malatesta Novello, nel 1461. E' molto probabile che proprio Giovanni Bacci sia stato il tramite, come a Rimini nel 1451, tra Piero e il principe cesenate che lo impiegò, forse, in una cappella della chiesa di S. Francesco o, più verosimilmente, nella chiesa che il Novello aveva voluto erigere, in suo onore, all’interno del convento di S. Caterina.
Straordinaria è la somiglianza tra il giovane biondo della Flagellazione e uno dei profeti del ciclo di Arezzo. Le stesse architetture sembrano richiamare quelle del Palazzo di Salomone nel medesimo Ciclo.

La posizione dei piedi del Cristo è la stessa di quella dei piedi di
Tommaso Paleologo.
Il portico è molto simile a quello dell’Alberti a San Pancrazio. Lo sfondo ricorderebbe elementi architettonici ferraresi ancora esistenti.
Gli studiosi che hanno esaminato con attenzione le proporzioni matematiche del quadro ritengono che il muro di marmo istoriato di disegni geometrici e incorniciato da fiori stilizzati che sta dietro al giovane biondo sia di inusuale grandezza: se misurato nei termini delle proporzioni relative del contesto architettonico, dovrebbe essere alto più di dodici metri. Il muro quindi è fuori prospettiva, non soggiace ad alcuna legge razionale e l’effetto visivo che produce serve a differenziare dalle due figure del mediatore greco e del signore occidentale il giovane biondo, la cui statura non appartiene ai parametri umani.
Sia il Cristo che il giovane biondo sono enfatizzati da caratteristiche sulle loro teste, la statua sulla colonna sopra di Cristo, un albero e il cielo aperto sopra il giovane. Che il giovane scalzo sia un morto e quindi una figura della resurrezione, non è mai stato messo in discussione (Buonconte da Montefeltro o Oddantonio da Montefeltro o Tommaso Paleologo o altri ancora a sfondo più mistico).