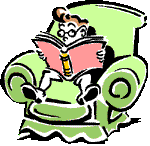|
|
IL DIRITTO ALLA
CULTURA
|
EVITARE CONFUSIONI 1-2-3-4-5-6-7-8-9
CULTURA E BUSINESS IN RETE SONO DUE COSE DIVERSE
Facendo seguito alla dichiarazione del responsabile dell’Uff. Arti Figurative della Siae (punto-informatico.it/p.aspx?id=1890523), vorrei qui proporre ulteriori spunti di riflessione di natura culturale e didattica.
Le domande cui vorrei cercare di rispondere sono le seguenti e spero che nella revisione della L. 633 si tenga conto delle risposte che ad esse si possono e si potranno dare a favore della libera fruizione della cultura digitale.
- Quali sono le condizioni per poter definire didattico o culturale un sito?
- Quali sono le condizioni per poter definire commerciale un sito didattico o culturale?
- Esistono delle condizioni che fanno restare didattico o culturale un sito pur in presenza di aspetti commerciali, come p.es. un circuito banner o gli ad-sense di Google?
La Siae in questo momento tiene un atteggiamento ambiguo: sa di non poter colpire indiscriminatamente i siti didattico-culturali che usano materiale protetto e tuttavia nelle sue tabelle è previsto un tariffario anche per questi siti; ecco che allora inizia a colpire siti come il mio che presentano alcuni aspetti commerciali (come i banner e gli ad-sense), dicendo che un sito del genere non può dirsi del tutto didattico o culturale.
In particolare evita di criminalizzare gli ad-sense, in quanto ormai tutti i siti li hanno, e punta il dito sui banner, che però nel mio caso sono posti a titolo gratuito o di scambio alla pari, e comunque anche se alcuni sono commerciali il reddito è prossimo allo zero, nel senso che con Google si guadagna sicuramente di più, essendo basato sul semplice cliccaggio di ip univoci.
Secondo me non ha senso pensare che la semplice presenza di banner o di ad-sense rendano di per sé commerciale un sito.
Quando si afferma che anche la tv private non obbligano al pagamento del canone, alimentandosi solo di pubblicità, e che pertanto un sito come homolaicus.com, avendo pubblicità, può essere equiparato a una televisione privata, per cui è giusto definire il suo webmaster un editore a tutti gli effetti, si compie una forzatura interpretativa difficilmente sostenibile davanti a un giudice.
Per una serie di ragioni:
- è vero che l’utente di una tv privata non paga direttamente il canone, ma è anche vero che lo paga indirettamente quando va ad acquistare gli stessi prodotti che vede reclamizzati, avendo essi prezzi di molto superiori a quelli non reclamizzati. Da me non esiste questa cosa.
- Sul piano televisivo il nostro paese è caratterizzato da un fondamentale duopolio, per cui le scelte dell’utente televisivo sono alquanto limitate. In rete invece i siti sono decine di milioni e nessuno è costretto a venire da me.
- L’uso del televisore rende di per sé inevitabile la fruizione dei canali televisivi, essendo trasmessi questi via etere. Viceversa l’uso del monitor, quando si è connessi, non obbliga a nulla. In rete occorre un’azione diretta del navigatore, che deve sapere dove andare, se non vuole perdersi. Non è automatica la fruizione di un determinato ipertesto, neanche facendo “zapping” con un motore di ricerca.
- Nelle tv private la pubblicità interferisce continuamente con la visione dei programmi. Nel sito homolaicus.com ciò non avviene mai. Cioè non appaiono mai delle popup che obbligano alla previa visione di uno spot pubblicitario, che generalmente avviene entro un certo lasso di tempo, o al cliccaggio sul medesimo spot prima di poter accedere alla fruizione dei contenuti culturali dell’ipertesto. Nessun ipertesto è mai stato da me vincolato alla visione o all’uso preliminare di un qualunque spot pubblicitario o, peggio, di qualsivoglia dialer.
Il fatto che accanto a un ipertesto appaiano gli ad-sense di Google o altre forme di pubblicità, non può di per sé voler dire che il sito è commerciale. Essendo libera e gratuita la visione di un ipertesto culturale, al punto che se ne permette persino il download e l’inserimento in altro sito, a condizione che si citi la fonte di provenienza (cosa che in dieci anni è sicuramente avvenuta più volte, tanto che non mi stupirei che coi miei materiali qualcuno ci abbia lucrato sopra), il sito è e deve continuare a essere considerato didattico e culturale.
I miei ipertesti non sono beni immateriali cedibili dietro corresponsione di qualcosa o fruibili soltanto con l’obbligo di sottostare a una qualsivoglia condizione. Essi peraltro vengono sempre offerti in maniera integrale e non dimostrativa.
E nel mio sito non si vendono quadri o opere d’arte. Se vendessi quadri e usassi ipertesti di qualità con immagini protette per poterli vendere meglio, allora forse si potrebbe anche pensare a un qualche interesse di lucro.
Viceversa l’atteggiamento di totale gratuità che ha sempre caratterizzato il mio sito esclude a priori qualunque scopo di lucro e chi sostiene il contrario renderà certamente conto di ciò che dice. Qui si può parlare – come più volte ho detto - di “incremento patrimoniale” solo a favore dell’artista trattato nell’ipertesto e quindi dei suoi eredi, i quali, grazie proprio ai miei ipertesti critici, vedranno aumentare le quotazioni delle loro opere.
Paradossalmente se avessi messo i miei ipertesti “incriminati” sotto password, come mi chiede la Siae, al fine di non pagarne i diritti d’autore, facendo essa più differenza tra area riservata e area pubblica che non tra sito didattico e sito commerciale, io avrei anche potuto decidere di farli vedere dietro riscossione di una certa somma.
Se mi fossi comportato così, la Siae, che ora vorrebbe punirmi per aver messo
in chiaro una cosa gratuita, da loro protetta, su quella stessa cosa, messa in
un’area riservata accessibile solo a pagamento, non avrebbe fatto nulla.
Il prossimo intervento sarà sugli aspetti tecnici dei formati digitali usati per
le immagini.
COL FORMATO JPEG SI PUO' DISTINGUERE UNA COPIA DALL'ORIGINALE?
Uno dei principali difetti nelle considerazioni dell’uff. Arti Figurative della Siae, riguardo a questa incresciosa vicenda inaugurata con l’attacco proditorio al sito homolaicus.com, sta proprio nella pretesa di applicare la legge sul diritto d’autore al concetto di “immagine digitale”, che nella fattispecie della stragrande maggioranza degli ipertesti didattici e culturali del web, si traduce nel cosiddetto “formato jpeg”.
Quello che a un semplice docente o webmaster appare evidente, di primo acchito, quando si accinge a fare qualcosa di didattico o di culturale utilizzando immagini di dipinti da reperire in rete, è proprio l’incredibile diversità di toni, colori e sfumature che si riscontra in riferimento a una medesima immagine. Generalmente infatti è impossibile sapere con esattezza, limitandosi alle fonti visive della rete, come fu effettivamente dipinto, nei suoi aspetti cromatici, un qualunque quadro da parte di un qualunque artista.
Per uno che si accinge a fare un ipertesto culturale, questo è sempre un problema serio da affrontare, così difficile da risolvere che il dubbio sulla reale efficacia interpretativa di ciò che s’è compiuto permane anche dopo aver realizzato il lavoro.
Un qualunque webmaster, minimamente onesto con se stesso, dovrebbe arrivare alla conclusione che quando sono in gioco i dipinti degli artisti è meglio escludere a priori, allo stato attuale della tecnologia, l’idea che un formato jpeg possa costituire “copia fedele di un originale”.
Ho trovato conferma in quella che per me era una semplice impressione, nell’analisi lucida che un consulente informatico e docente a contratto presso l'Università di Trieste, Tommaso Russo, mi ha fatto avere dopo aver periziato gli ipertesti cosiddetti “incriminati”.
Lui ha esaminato le immagini riproducenti l’opera intera dell’artista, dando per scontato che sulle porzioni d’immagini – checché ne dica la Siae – non si possano accampare diritti di sorta, all’ovvia condizione che si specifichi trattarsi appunto di particolari dell’originale.
Ed ecco alcune delle sue conclusioni, quanto mai illuminanti, riportate in forma molto succinta e facilmente comprensibile.
- tutte le 74 immagini jpeg segnalate dalla Siae erano di una risoluzione largamente inferiori allo standard VGA (640x480 px), con un campionamento spaziale e una quantizzazione neppure lontanamente paragonabili alle immagini che si ottengono con le migliori fotocamere digitali di alta gamma oggi in commercio (12,5 megapixel) e, tanto meno, a quelle che si ottengono con le migliori pellicole chimiche fotosensibili (936 megapixel);
- il contenuto informativo della miglior foto professionale ottenuta con pellicola chimica è superiore a quello della miglior foto digitale di un fattore stimabile a 75 per quanto riguarda la risoluzione, e di un valore difficilmente stimabile, ma sicuramente molto superiore ad 1, per la profondità cromatica. Con questi dati, un’immagine digitale di 640 x 480 pixel a 24 bit/pixel compressa jpeg ha un contenuto informativo inferiore allo 0,0047% della miglior fotografia su pellicola da cui possa essere stata ricavata;
- In base alla definizione di Shannon, l’informazione veicolabile da un messaggio (o contenuta in un file) è pari al numero di bit necessario a trasmetterlo. Il contenuto informativo di una foto digitale ripresa con le migliori apparecchiature digitali professionali oggi disponibili, risulta pari a 12 Megapixel x 42 bit/pixel = 504 Megabit. Mentre il contenuto informativo di un’immagine di risoluzione VGA visualizzabile su PC risulta pari a 640 x 480 pixel x 24 bit/pixel = 7,3 Megabit. Il contenuto informativo della seconda risulta essere quindi l’1,4% della prima;
- ma la “compressione con perdita” jpeg riduce ulteriormente questo contenuto informativo ad un valore medio di circa 50 KiloByte = 400 Kilobit, il che indicherebbe un contenuto informativo pari al 0,07% della migliore immagine digitale.
Il professor Russo dice in realtà molte più cose e ancora più interessanti, dal punto di vista tecnico, ma per me è importante la sua conclusione: sostenere che l’immagine jpeg di un dipinto, visualizzabile sullo schermo di un piccolo pc, possa costituire una copia dell’opera originale equivale a sostenere che l’indice di un libro sia una copia del libro stesso.
Ovvero che un tribunale dovrebbe dichiarare infondate le pretese SIAE: un'immagine Jpeg non può essere considerata riproduzione di un intero dipinto, ma solo un assemblaggio di riproduzioni di una minima percentuale di parti dello stesso, atto a dare un'idea grossolana della sua struttura, grafica e cromatica, e quindi liberamente pubblicabile ai sensi e per gli scopi dell'art. 70 delle Legge sul Diritto d'Autore ("diritto di citazione").
Questo dal punto di vista tecnico, poiché, prosegue l'egregio consulente, qui non si azzarda neppure un raffronto con il contenuto informativo delle opere originali, universalmente riconosciute come inimitabili, e di cui la miglior fotografia realizzabile resta soltanto un pallido fantasma.
Ma più in generale, nel caso di un dipinto, “copia” può essere soltanto un’imitazione, più o meno fedele, eseguita da un altro pittore con tecniche simili: “disegno, pittura o scultura che riproduce più o meno fedelmente un originale, talvolta a scopo di contraffazione, o a scopo di esercitazione o di diffusione” (De Mauro).
A questo punto è lecito porsi una semplice domanda: posto che una jpeg non è in grado di riprodurre adeguatamente alcunché, in quanto vi è una perdita secca di informazioni del tutto indipendente dalla volontà del webmaster, se questa approssimazione per difetto dovesse essere considerata una violazione della paternità morale dell’opera di un artista, tale violazione verrebbe forse scongiurata pagando i diritti d’autore su quell’opera?
Si noti peraltro che la giurisprudenza, pur essendo favorevole all’uso di una porzione d’immagine sulla base del diritto di citazione, secondo l’art. 70 della 633/1941, è contraria all’uso dell’immagine integrale, perché questa potrebbe distogliere l’utente dall’andare a vedere l’originale.
Ora, a parte il fatto che poter fare liberamente un ipertesto culturale su una parte del quadro e non sulla sua interezza è quanto meno ridicolo, se c’è una cosa priva di senso nei confronti del rapporto tra semplice jpeg e capolavoro artistico di un dipinto è proprio la convinzione che una jpeg integrale possa sostituire completamente un dipinto, come se fosse possibile la copia di un dipinto senza creare immediatamente un falso.
Chi realizza una jpeg dovrebbe essere punito non solo sul piano civile ma anche penale. Se si considera una jpeg copia fedele dell’originale, pagandone i diritti, si riceve dalla Siae il diritto di produrre un falso patentato.
Qui siamo in una situazione kafkiana. È talmente forte l’esigenza di tutelare delle rendite acquisite (che, si badi, non sono solo quelle degli artisti e dei loro eredi, ma anche quelle della stessa Siae), che non ci si rende conto che una jpeg integrale, avendo per sua natura lo scopo di produrre un effetto di curiosità intellettuale, è in grado di favorire proprio queste rendite. Dunque perché penalizzare ciò che in sostanza incrementa i diritti patrimoniali degli eredi, dei musei, delle gallerie d’arte e degli stessi dipinti presi in esame?