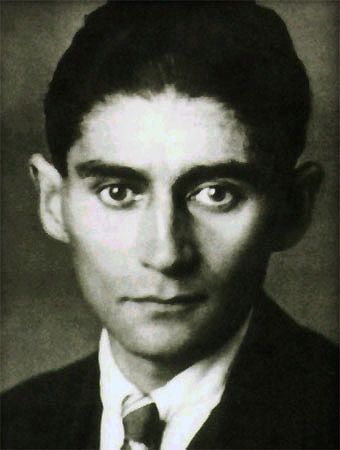
Franz Kafka (1883-1924)
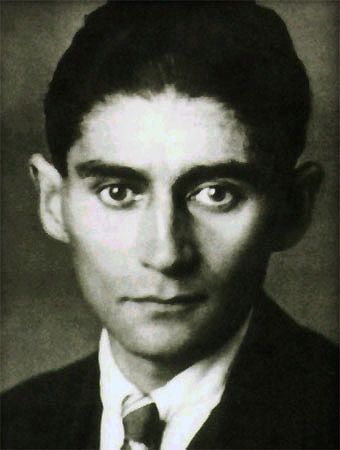
“Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure passabilmente. E anche se tento di risponderti per iscritto, il mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d’ostacolo la paura che ho di te e le conseguenze, sia perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria e il mio intelletto”.
Franz Kafka scrisse una lettera al padre (poi divenuta famosa) in cui cercava di spiegare la propria posizione nei confronti della sua autorità. E' improbabile che il padre Hermann, che aveva un emporio a Praga, potesse comprendere le argomentazioni del figlio. Ma è anche poco probabile che il figlio stesso riuscisse a comprenderle. Il fatto è che Franz Kafka andava alla ricerca di una ragione dell’autorità in genere. Ne era attratto, non tanto per arrivare a possederla, quanto per riuscire a conviverci bene e ad agire di conseguenza, ovvero ad agire con il placet del sistema di vita che, a questo punto, considerava ideale. Nei confronti della stessa religione, Kafka tenne un comportamento ambiguo, ma sostanzialmente votato ad una confidenza con la stessa, con i suoi valori esterni, non certo votato ad una sottomissione.
I suoi interessi per la mistica chassidica settecentesca appaiono caratterizzati da un fascino per la spiritualità che il movimento chassidico professava a difesa dell’ebraismo dell’est, in forte pericolo di caduta e quindi di dispersione di quello che era ritenuto un tesoro inestimabile – il dettato ebraico e i suoi significati spirituali reconditi – nonché un mezzo di coesione senza pari. Kafka preferiva i tratti, in qualche modo esoterici, della religione, quasi rifacendosi all’ermetismo di Ermete Trismegisto che era per una conoscenza divina (ovvero di tipo divino) senza intermediazioni, così come è, in fondo, per ogni forma spirituale pura.
Il timore del praghese – che conosciamo grazie all’amico Max Brod che salvò i suoi scritti e li fece pubblicare (Kafka pubblicò solo qualche racconto in vita e ordinò che alla sua morte i testi che aveva nel cassetto venissero distrutti) – era un timore profondo provocato da una sensibilità straordinaria, da un’angoscia esistenziale molto marcata.
Angoscia esistenziale
L’angoscia esistenziale veniva sollecitata da una vera e propria paura del vuoto, del nulla, a fronte di un’agitazione umana molto accentuata a fiduciosa di sé, quando non sicura.
La sicurezza del padre era il paradigma della sicurezza di un mondo che di fatto non si curava delle problematiche essenziali dell’esistenza. Kafka cercava di andare alla ricerca della sicurezza maggiore che sovrintendeva quella inferiore e voleva sentirsi considerato, accettato, da quella, non da questa.
I comportamenti umani inferiori, quelli cioè propri della vita di tutti i giorni – come un eseguire un programma – avevano troppa poca ragion d’essere se mancavano le motivazioni superiori.
Il fatto che i rapporti umani fossero impregnati di basso pragmatismo non deponeva a favore del nuovo protagonismo umano. Kafka – lo si nota alla perfezione nel “Castello” e nel “Processo”, con estremo pessimismo ne la “Metamorfosi” (sicuramente i suoi scritti maggiori) – vuole proporsi al sistema come un richiedente preoccupato dei metodi che il sistema stesso impiega e che sono ottusi rispetto all’ideale filosofico e alla vecchia morale religiosa che aspiravano, giustamente, al sublime.
La preoccupazione, insoddisfatta perché frutto di elaborazione mentale della realtà possibile, investita da quella reale, spinge Kafka al pessimismo, un pessimismo aggravato dalle sue condizioni di salute (una tubercolosi inguaribile): il praghese non ha la forza fisica per opporsi agli eventi che immagina sotto il peso della realtà (ovviamente trasfigurata a talento, ma come derivata da un’osservazione spietata) e, con dolore lacerante, mascherato da dolia, sopporta il rifiuto del “Castello” alla sua volontà, generosa, di entrarvi sperando di convincerlo a cambiare le regole del relativo funzionamento. Sopporta la condanna estrema che il “Processo” gli commina forse per la sua presunzione e quindi per la sua colpa di chiedere perché lo stiano condannando (una legge superiore, insondabile, ha deciso così: riecco l’autorità del padre basata sulla semplice forza fisica, addirittura legalizzata) e sopporta ancora l’annullamento brutale della sua persona ridotta a bestia immonda (per esplicita dichiarazione di inadeguatezza a vivere in quel mondo) ne la “Metamorfosi”.
Kafka eleva l’inadeguatezza personale a fatto universale: l’esistenza migliore, addirittura in senso assoluto, non sarebbe alla portata dell’uomo, sebbene vi aspiri. Questa valutazione è una salvezza personale, ma la stessa possiede un risvolto drammatico in quanto impedisce effettivamente il riscatto ideale.
La reazione di Kafka
A questo punto, il praghese diventa umile e vuole quasi essere colto in errore, secondo un semplice assioma: se penso all’assoluto, significa che esso esiste e magari può essere concretizzato, certo riflettendo altrimenti e certo agendo in un altro modo. Ecco perché accanto al passo esitante e all’incertezza programmatica, Kafka pone un obbiettivo: è un obbiettivo vago perché chi lo pensa non è sicuro di sé e questa non sicurezza di sé sorge da una sorta di impotenza riconosciuta e sofferta, ma poi irrimediabilmente ammessa quanto sommessamente negata un istante dopo. La speranza è quella di sentirsi dire che sta esagerando e che in fondo il ravvedimento umano è dietro la porta. Le virtù, compresa quella di creare un mondo ideale, moralmente e intellettualmente qualificato, superiore ai modelli precedenti, migliore dell’ordinamento religioso perché oggettivo, ebbene sono virtù che devono e in definitiva possono imporsi.
Kafka non l’ammette, ma vorrebbe farlo. E’ troppo realista e si macera per questo eccesso. E’ convinto di non poter essere capito perché lui stesso non sa spiegarsi a dovere in quanto sempre lui stesso non è in grado di spiegare quel che sente in sé.
L’uomo nell’ estrema elevazione personale è nella fase pionieristica, come è ovvio che sia, data la poca esperienza con la libertà vera, e Kafka carica su di sé, o avverte caricati su di è, i pochi sì, i molti ma e gli scoramenti del caso.
I sì sono virtuali e giacciono in solenni dichiarazioni di principio, racchiusi in scrigni preziosi ed esibiti a mo’ di abbellimento di un mondo – quello ferocemente materialista – che bellezze ancora proprio non ha. Non diventano esecutivi.
Dei suoi tentennamenti (con un’amarezza di fondo che denuncia il desiderio, in qualche modo circostanziato, di superarli) riempie le lettere che scrive specialmente a Felice Bauer (“Lettere a Felice”) con cui ebbe una relazione tormentata (Kafka odiava la carnalità, la riteneva degradante, e quasi sempre la evitò; era attratto dal matrimonio, ma aveva paura di un annullamento di sé, di un imborghesimento intollerabile)che scrive a Milena (“Lettere a Milena”) oltre a quella al padre, già accennata, e fondamentale per provare a comprenderlo.
Il praghese visse atrocemente la sua malattia e mancò dopo aver sofferto parecchio (non deglutiva più): fu una sorta di punizione, per così dire celeste, per la sua ricerca del cosiddetto indicibile e per la scoperta di sé e delle cose, secondo una logica di base migliorabile con le sole forze umane. O, meglio, una punizione, per così dire celeste, per essere arrivato solo vicino a tutto questo (impresa, in realtà, titanica).
Importantissimo l’inizio de “Il castello”:
Era sera tarda quando K. arrivò. Il paese era sprofondato nella neve. Il colle non si vedeva, nebbia e tenebre lo circondavano, non il più debole chiarore rivelava il grande castello. K. sostò a lungo sul ponte di legno che dalla strada maestra conduceva al paese e guardò su nel vuoto apparente.
Poi andò a cercare un alloggio per la notte; alla locanda erano ancora svegli, l'oste non aveva stanze libere ma, assai stupito e sconcertato da quel cliente tardivo, offrì di farlo dormire nella sala su un pagliericcio. K. fu d'accordo. Alcuni contadini sedevano ancora davanti alla loro birra, ma egli non volle parlare con nessuno, andò a prendersi da solo il pagliericcio in solaio e si coricò vicino alla stufa. Faceva caldo, i contadini erano silenziosi, egli li osservò ancora un poco con gli occhi stanchi, poi si addormentò. Ma non passò molto che fu svegliato. Un giovane in abito cittadino con un viso da attore, occhi sottili, sopracciglia folte, stava accanto a lui insieme all'oste. I contadini erano ancora lì, alcuni avevano girato la sedia per vedere e udire meglio. Il giovane si scusò molto gentilmente di aver svegliato K., si presentò come figlio del custode del castello, poi disse: «Questo paese appartiene al castello, chi vi abita o pernotta in certo modo abita e pernotta nel
castello. Nessuno può farlo senza il permesso del conte. Ma lei questo permesso non ce l'ha, o almeno non l'ha esibito».
K., che si era levato a sedere, si ravviò i capelli, guardò i due dal basso in alto e disse: «In che paese mi sono perso? C'è un castello qui?».
«Certo», disse lentamente il giovane, mentre qualcuno, qua e là, scuoteva la testa all'indirizzo di K., «il castello del conte Westwest».
«E ci vuole il permesso per passare qui la notte?», chiese K. come per convincersi di non aver magari sognato quello che gli era appena stato detto.
«Ci vuole il permesso», fu la risposta, e c'era molta presa in giro nei confronti di K. nel modo in cui il giovane tendendo il braccio chiese all'oste e ai clienti: «O forse non ci vuole il permesso?».
«Quand'è così dovrò procurarmelo», disse K. sbadigliando, e scostò la coperta come per alzarsi.«Già, ma da chi?», chiese il giovane.
«Dal signor conte», disse K., «non resta altro da fare».
«Adesso, a mezzanotte, andare dal conte a chiedere il permesso?», esclamò il giovane facendo un passo indietro.
«Non si può?», chiese K. con calma. «Allora perché mi ha svegliato?».
Questa volta però il giovane perse il controllo. «Che modi da vagabondo!», esclamò. «Esigo rispetto per le autorità comitali! L'ho svegliata per comunicarle che deve lasciare immediatamente il territorio del conte».«Finiamola con questa commedia», disse K. con voce stranamente bassa, si coricò e si tirò addosso la coperta. «Lei sta un po' esagerando, giovanotto, e domani riparleremo del suo comportamento. L'oste e quei signori sono testimoni, se di testimoni ho bisogno. Ma sappia intanto che sono l'agrimensore fatto venire dal signor conte. I miei aiutanti mi raggiungeranno domani in carrozza con gli strumenti. Io non ho voluto rinunciare a una passeggiata nella neve, ma purtroppo ho sbagliato strada più volte, e per questo sono arrivato così tardi. Che fosse troppo tardi per presentarmi al castello lo sapevo già da me senza che lei me lo insegnasse. Ecco perché mi sono accontentato di questa sistemazione per la notte, dove lei ha avuto la scortesia - per non dir peggio - di venirmi a disturbare. Con ciò considero esaurite le mie spiegazioni. Buona notte, signori». E K. si voltò verso la stufa. «Agrimensore?», chiese ancora alle sue spalle una voce esitante, poi fu completo silenzio. Ma il giovane si riprese presto e disse all'oste, in tono abbastanza smorzato da parere riguardoso del sonno di K. e abbastanza forte da essere da lui udito: «Mi informerò per telefono».
Dello stesso autore:
Testi di Kafka