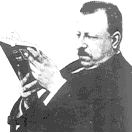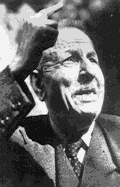LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
Benedetto Croce (1866-1952)
Dopo il terremoto di Casamicciola del 1883, Benedetto Croce si recò a Roma in casa di Silvio Spaventa, dove le sue letture collegiali dai romanzi romantico-gotici alle Mie Prigioni, da De Sanctis a Carducci, ebbero a confrontarsi con gli insegnamenti del Labriola, che gli restavano in mente con "pochi punti che fissavo sulla carta e che rimuginavo in mente al mattino nel destarmi".
|
Intanto dal 1886 al 1892 si esplica la fase della ricerca letteraria ed erudita nella Rivoluzione napoletana del '99 e nei Teatri della Napoli dal Rinascimento alla fine del Settecento. Ma la presenza del Labriola e della sua concezione materialistica della storia si fa ancora sentire nella ripresa della vocazione filosofica che si concretizza nei saggi del Materialismo storico ed economia marxistica. |
L’interesse per il De Sanctis riletto dopo il collegio rivive negli studi per l’estetica interrotti quando nel novembre del 1900 dovette coadiuvare il commissario straordinario di Napoli nell’amministrare le scuole del Comune. Finalmente l’Estetica vide la luce nel 1902, anno di fondazione della "Critica", nella quale rivista Croce curò la parte di storia letteraria.
Croce, Contributo alla critica di me stesso
Ma io non traccerò né confessioni, né ricordi, né memorie della mia vita.
Confessioni, ossia esame morale di me stesso, no, perché quanto stimo utile confessarsi in ogni istante, cioè procurare chiarezza a sé stessi nell'atto dell'operare, altrettanto mi pare inutile esercitare un giudizio universale sulla propria vita.
| Rimosso l'unico fine di riconoscersi degni o indegni del paradiso e del purgatorio, queste confessioni generali non vedo a che cosa servano, se non forse alla vanità dell'individuo: vanità, o che l'individuo si compiaccia dì sé medesimo, o che si accusi e condanni e gema, perché in ambo i casi egli si reputa cosa troppo più importante che in effetto non sia. |
|
Inoltre, quando si tenta di rispondere con iscrupolosa coscienza alla domanda se si sia stato buono o cattivo, si avverte presto di aver posto piede sopra un terreno infido; perché, nel pronunziare un giudizio di quella sorta, si pencola sempre nella duplice opposta vicenda dell'adularsi o del calunniarsi.
|
E tale impaccio nasce dalla ragione già assegnata: che l'individuo è poca cosa per sé, fuori del tutto, onde non solo gli altri ma esso stesso dimentica la maggior parte degli atti da lui compiuti e dei sentimenti che li mossero; e nello sforzo di raccoglierli e comporli come in un quadro, facile è che li colorisca alla luce del suo sentire presente, favorevolmente o sfavorevolmente disposto, formandone una immagine fantastica, che si confonde poi e si disfà innanzi ai dubbi dell'autocritica, sicché si resta in ultimo col non sapere quel che si debba propriamente pensare. |
E ricordi nemmeno, perché il passato mi riempie bensì di affetti e di malinconia, ma io non terrei lecito di mettere questi miei sentimenti sulla carta se non nel caso che mi presumessi poeta, ossia che quei sentimenti formassero centro di attrattiva del mio essere e oggetto delle mie migliori virtù spirituali.
E certamente il passato mi fa sovente sognare; ma di brevi e rapidi sogni, presto ricacciati indietro dalle necessità del mio lavoro, che non è di poeta.
Se dunque mi v'indugiassi, se dessi a quei ricordi, ai quali bastano i taciti colloqui interiori, forma di scritto o di discorso ad altri, ricadrei nel caso precedente delle vane e vanitose confessioni, e andrei incontro al meritato fastidio che suole suscitare chi pretenda interessare altrui ai casi propri, ossia alla propria transeunte individualità.
| E, infine, non memorie, perché le memorie sono cronache della nostra vita e di quella degli uomini coi quali abbiamo collaborato o che sono stati da noi osservati e conosciuti, e degli avvenimenti ai quali abbiamo partecipato; e si scrivono quando si reputa di poter serbare al posteri alcune importanti notizie che altrimenti andrebbero perdute. |
|
Ma la cronaca della mia vita, in ciò che può presentare di ricordevole, è tutta nella cronologia e nella bibliografia dei miei lavori letterari; e, non avendo partecipato né da attore né da testimone ad avvenimenti di altra sorta, non ho nulla o ben poco da dire sugli uomini da me conosciuti o sulle cose che ho viste.
Che cosa scriverò, dunque, se non scriverò né confessioni, né ricordi, né memorie? Mi proverò semplicemente ad abbozzare la critica, e perciò la storia di me stesso, ossia del lavoro che, come ogni altro individuo, ho contribuito al lavoro comune: la storia della mia "vocazione" o "missione". Delle quali parole ho già temperato quel che possono avere di altisonante, col notare che ogni uomo conferisce al lavoro comune, ogni uomo ha la propria vocazione o missione, e può farne la storia; quantunque certamente, se avessi atteso solo alle mie faccende private e al governo della famiglia, o, peggio, ad adempiere la poco degna missione del gaudente, non starei ora a prender la penna per raccontarmi.
Perché, insomma, io che ho composto tanti saggi critico-storici intorno a scrittori così contemporanei come remoti, procurando d'intendere di ciascuno il carattere e lo svolgimento e discernere quel che ciascuno aveva di proprio ed originale, non comporrò un saggio su me stesso? E' qui pronta la risposta: - Lascia che di te parlino gli altri. - E certamente lascio che ne parlino, quando lor piace; ma perché ne parlino con migliore informazione e maggiore esattezza, e magari con meglio istrutta severità, dirò loro anche quello che so dell'opera mia, persuaso che, nel dir questo, fornirò alcune osservazioni che assai probabilmente a loro sfuggirebbero o che ritroverebbero con difficoltà, quantunque senza dubbio a me ne sfuggiranno altre, che essi ben sapranno cogliere.
Commento a Contributo alla critica a me stesso di B. Croce
In queste pagine Croce esprime la sua opinione sui generi autobiografici. La sua non è una posizione teorica, ma è del tutto inserita nell’esperienza personale e nelle necessità della sua comunicazione intellettuale. In questo senso egli mostra di conoscere quanto da lui si aspetta il lettore.
L’idea di un’autobiografia di confessione viene del tutto esclusa in quanto egli nega per se stesso e per ogni uomo la possibilità che la vita sia sottoposta a un’inchiesta di ciò che è stato bene ed è stato male e quindi a un giudizio di buono e cattivo, prescindendo dal quadro complessivo della realtà in cui è inserita ogni esistenza.
Ogni atto, ogni voce del passato può quindi scolorirsi alla luce del presente, perché fuori dal contesto in cui sono stati vissuti. E nemmeno Benedetto Croce vuole che le sue pagine vadano sotto il titolo dei ricordi, in quanto i brevi e rapidi sogni del passato devono, sono presto ricacciati indietro dalle esigenze del suo lavoro che non è quello di poeta.
D’altra parte egli rifiuta di fare confluire le proprie riflessioni sotto il titolo di memorie ritenendo che esse non meritino tale collocazione di genere, perché il genere memorialistico s'interessa soprattutto di eventi collettivi, dei quali si presta testimonianza comunicando al lettore importanti notizia che altrimenti andrebbero perdute.
Uomo di libri e di studio, Benedetto Croce accetta di fornire la propria testimonianza soltanto come contributo alla critica del proprio pensiero. Riappare così nel nostro secolo la memoria filosofica nella dimessa discussione di ciò che si conosce, in favore dei contemporanei e dei posteri che abbiano la necessità di attraversare l’opera di don Benedetto valendosi della sua più sicura e avveduta guida.
Di nuovo il privato, salvo l’inserto delle tragiche circostanze della perdita della famiglia, viene riassorbito dalla glorificazione dell’opus letterario, del grande artigianato intellettuale al quale è dedicato il senso di un’esistenza che pure conobbe onori e pubblici e fu in qualche modo esemplare per i contemporanei che gli riconobbero l’antico ruolo di padre della patria repubblicana.
Croce Benedetto, Contributo alla critica di me stesso, 1989, Adelphi