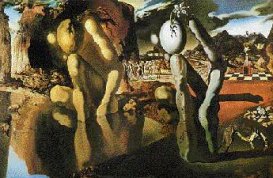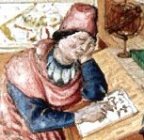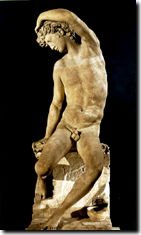LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
Autobiografismo versus Autobiografia
di Andrea Battistini
- Autobiografismo è la presenza generica del soggetto nella propria opera letteraria. In questo senso, qualsivoglia genere letterario può essere pervaso di autobiografismo, perché l'autore può parlare di se stesso perfino nei generi più impersonali e oggettivi.
- Autobiografia è invece un vero e proprio genere letterario con le sue costanti, le sue convenzioni, i suoi orizzonti di attesa, la sua genesi storica.
| Se si accetta ancora la definizione che ne diede Lejeune, che come tutte le definizioni è molto generale e quindi in parte riduttiva, ma serve in ogni caso a precisare meglio ciò di cui si intende parlare, possiamo prendere come punto di riferimento la concezione che fa dell'autobiografia un "racconto retrospettivo in prosa che una persona reale fa della propria esistenza, quando mette l'accento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della sua personalità". |
|
| Se adesso ripercorriamo la storia della letteratura italiana, e non solo italiana, alla luce di questa definizione, non abbiamo difficoltà a constatare che fino alla fine del XVII secolo le vere e proprie autobiografie sono scarsissime, del tutto eccezionali: tra le poche, si possono menzionare le Vite di Cellini, di Cardano e di Teresa d'Avila. Altri testi sono propriamente opere pervase di autobiografismo, ma non autobiografie in senso tecnico. |
|
A riprova sono sufficienti alcuni esempi scelti tra i più noti, tenendo in filigrana la definizione più restrittiva e pertinente di Lejeune. Nella Vita nuova di Dante tutto è in funzione di Beatrice, non dello scrittore. Il 'libello' non copre l'intera esistenza dell'autore ma sembra piuttosto una biografia o meglio una agiografia di Beatrice. Di Dante non si pone l'accento sulla storia della personalità, ma se ne seleziona solo l'attività di poeta, senza la considerazione di altri aspetti.
| Non diversamente il Secretum di Petrarca è un soliloquio, un insieme di riflessioni
senza costruzione diegetica, senza uno sguardo coerentemente retrospettivo, dalla nascita
al momento della scrittura. E ugualmente privi di sviluppi narrativi sono i Ricordi di Guicciardini, le cui massime gnomiche, universali, li fanno più assomigliare alla rapsodicità dei diari che alla continuità delle autobiografie, tanto più che la trasposizione dell'esperienza personale sul piano dei principi generali riduce o cancella la presenza della vita individuale dell'autore. |
|
Dalla fine del XVII secolo, dopo tanto tempo di scarsa e occasionale fortuna, si assiste invece allo sviluppo generalizzato dell'autobiografia, un genere praticato soprattutto dagli intellettuali, con taglio per dir così professionale, nel senso che parla della carriera dei loro studi, della professione, delle pubblicazioni, delle cariche conseguite.
|
In altri termini 'nasce', come pratica diffusa,
l'autobiografia, che diventa un genere codificato. Viene da chiedersi perché ciò avviene
proprio in questo periodo, quali fattori determinano o meglio concorrono a questa
diffusione, perché prima invece la sua frequentazione era tanto sporadica. D'altro canto la distinzione fatta al principio tra autobiografismo e autobiografia lascia intendere che era possibile scrivere di sé anche senza la diffusione di un genere specifico a ciò deputato. Esistevano dei surrogati, costituiti da generi letterari che privilegiavano la messa a fuoco del soggetto che scriveva ma senza avere tutte le caratteristiche dell'autobiografia. |
|
Per esempio, un atto autobiografico al quale facevano ricorso tutti i letterati che, vissuti tra il XVI e il XVII secolo, venivano associati a una o più accademie, consisteva nella scelta del nome di affiliato e dell''impresa'.
Tanto l'autoimposizione di un nom de plume quanto l'adozione di una sorta di stemma araldico che combinava un motto con un disegno simbolico erano due iniziative che racchiudevano una condotta di vita, un proposito assunto davanti alla comunità dell'accademia, una specie di secondo battesimo più motivato di quello che si riceveva alla nascita perché rispondente a un programma da perseguire.
Non possono però definirsi autobiografie poiché l'adozione di un nome e di un''impresa' manca di récìt, di uno sviluppo narrativo: nella sua staticità si tratta piuttosto di un autoritratto.
Tratto dal saggio, Genesi
e sviluppo dell'autobiografia moderna,
apparso nel "Supplement" a "The Italianist", n. 17/1997 (ed. J.
Lindon).