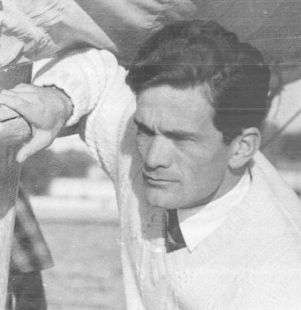PASOLINI UOMO ARTISTA
E INTELLETTUALE
La voce della coscienza critica
2.1. PASOLINI NARRATORE 1946-1961
E’ più amato e famoso come poeta (il maggiore poeta civile italiano contemporaneo, secondo Moravia), piuttosto che come narratore di romanzi e racconti. Ai suoi sono preferiti i romanzi e i racconti di un Moravia o un Calvino, solo per fare due nomi. Eppure anche la sua opera narrativa è un tassello indispensabile nella costruzione di quel mosaico che doveva essere la sua testimonianza globale.
Pur essendo conscio sin da piccolissimo della propria diversità sessuale, ebbe le prime esperienze omosessuali solo nel '44, a ventidue anni. Cominciò quindi a tenere una sorta di diario in cui confessava dolorosamente l'omoerotia, che non riuscì ad accettare mai del tutto, perché sentiva che veniva da fuori, cioè non era connaturale con la sua anima. Più tardi inizia a scrivere due romanzi, Atti impuri e Amado mio, nei quali "oggettiva" l'esperienza sessuale diversa, servendosi di due personaggi: Paolo (protagonista di Atti impuri, nel quale si riconosce pienamente) e Desiderio (protagonista invece di Amado mio, riflesso della parte oscura di sé - o, meglio, di tutti - una sorta di dandy frivolo e gaudente, a tratti geloso ed anche vendicativo).
Paolo (il cui carattere mansueto corrisponde alla psiche dell'Autore) dice di sé:
"la recente perdita della verginità di adolescente [...] mi aveva tolto molto del mio candore e della mia aspirazione alla bontà."(1)
E agli angeli che lo tormentano dichiara:
"Dio [...] se proprio mi vuole, si faccia temere in me, non nei suoi innocenti [...]. Tutto questo è stato scritto ad ogni modo a un solo fine: quello di ottenere un'autorizzazione. Io chiedevo a Dio di autorizzarmi a peccare!"(2)
Quanto a Desiderio, Pasolini scrive nella prefazione ai due romanzi, che era costretto a immergerlo "in un diluente «cattivo», vuol dire che ero obbligato a farlo e che era sotto questa luce che io dovevo apparire ai lettori di questo libro"(3)
Perché essere considerato peggiore di quel che era? Usava se stesso, la propria reputazione, per indurre il lettore a un "viaggio" nell'inconscio pieno di peccati, da illuminare appunto con la luce della coscienza, contro ogni dannosa rimozione. In quest'ottica possono essere spiegate anche le descrizioni minuziose di perversioni ed incesti, nel suo ultimo romanzo, incompiuto, Petrolio.
Al 1951 risale un progetto su un poema sul mare, in cui avrebbe dovuto mescolare una storia cosmologica del mare con vicende della propria infanzia. Scrisse qualche decina di pagine, in due opere incomplete, Coleo di Samo e Operetta marina. Riferiscono Walter Siti e Silvia De Laude nella notizia sui testi:
"da bambino Pasolini aveva chiamato "teta veleta" i suoi primi turbamenti sessuali; "Thetys", gli aveva detto Contini, in greco significa sesso; ed era, per di più, il nome dato dai geologi al mare triassico da cui si era formato il Mediterraneo. A tutto questo si aggiungeva l'identificazione fra l'emozione erotica e l'emozione legata, da bambino, alle fantasticherie marine."(4)
In realtà Contini aveva sbagliato perché "Thetys" in greco non significa "sesso".
Dice l'Autore friulano: "Noi veniamo dal mare, non dal cielo."(5)
Nell'Operetta marina spiega meglio che il cielo ci chiederebbe di sopprimere il "nostro vizio" e il nostro passato, mentre il mare ci permette non solo di "essere sempre, beatamente, indifferenziatamente noi stessi" ma di "essere anche quello che siamo stati, di effetto in causa, dunque, nel pieno, continuo calore della vita..."(6)
"questo mare appena creato non dalla volontà di Dio e non poetizzato dalla violentissima paratassi dei versetti biblici, ma da una meccanica che supera ogni espressione"(7)
Quello che conta non è tanto la cosa in sé (il mare) quanto l'espressione stessa, quindi la storia stratificata delle varie espressioni che "creano", in questo caso, la "vera storia del Mare".(8)
Nell'Operetta marina, apprendiamo, tra l'altro, nelle notizie sulla sua infanzia, che a causa della frequentazione con due ragazzette:
"i miei compagni si erano fatti una mia immagine di impube Don Giovanni"(9)
Sono, d'altra parte, anche le letture che egli fa, a dargli una idea di necessità della propria diversità (mentre gli altri suoi compagni seguiranno per lo più la via di una esistenza normale), da vivere per dare e darsi conoscenza:
"si vede che come nella materia tutti gli squilibri sono compensati, così nelle cose dello spirito, forse, esiste un tale equilibrio per cui una cosa non pensata o mal pensata, poniamo, da una gran quantità di spiriti, deve essere pensata e sofferta da una minoranza, ma con tanta intensità e fedeltà da compensare la sproporzione."(10)
Così scrive infatti all'amico Franco Farolfi, in una lettera del 1943. Raccogliendo tutti questi indizi, possiamo congetturare che il suo impegno culturale ed esistenziale nasce come "destino" se intendiamo dare a questo termine il senso di "destinazione" da parte della cultura (come stratificazione delle espressioni) che lo ha preceduto, conoscendo la quale egli si immette sulla sua via personale e atipica rispetto a una normalità, che pure poteva vivere fisicamente ma alla quale "deve" rinunciare.(11) Certamente questa mia congettura non coincide a pieno con altre espressioni che Pasolini riferisce sulla sua diversità, come qualcosa di predestinato, ma è possibile una sintesi se pensiamo che il destino non è coattivo, ma è come se lo fosse, in un animo generoso come quello di lui, che non poteva sottrarsi a questo suo "cammino" per sé e per gli altri.
Nel '49 fugge a Roma con la madre, dopo che è stato denunciato per corruzione di minorenni e atti osceni in luogo pubblico, ed espulso anche dal partito comunista. Di questo che fu il dramma della sua vita, c'è una trasfigurazione in un romanzo incompiuto di qualche anno dopo, dal titolo Il disprezzo della provincia. Qui non parla direttamente della sua disavventura, ma si sdoppia in due personaggi, entrambi letterati, ed anche impegnati in politica (uno come militante, l'altro simpatizzante). Essi, in quanto intellettuali liberi, sono osteggiati da tutti gli altri, che hanno preferito, per convenienza, sottomettersi a un qualsivoglia potere. Quando uno dei due cade per un fattaccio non ben precisato nel romanzo, è costretto, proprio come Pasolini, a fuggire via. Il vizio, tollerato e nascosto in tutta omertà solo se commesso da parte degli "integrati" (alla società di provincia, apparentemente pulita), è invece motivo di scandalo quando a cadere è uno che non si è piegato dinanzi ai potenti. I due intellettuali protagonisti sono consapevoli di rappresentare nei confronti del loro ambiente, ciò che erano gli ebrei durante la cattività babilonese: degli intoccabili.
Ragazzi di vita esce da Garzanti nel maggio 1955. L'autore è affascinato dalla vita dei borgatari romani, conosce molti sottoproletari che vivono di espedienti, spesso fanno i ladri o si prostituiscono. Nel romanzo narra le vicende del Riccetto e dei suoi compari, delle loro giornate gaie e lontanissime dalla morale borghese, almeno fino a quando il Riccetto non si fidanza e trova lavoro. Mentre da adolescente è persino capace di rischiare la vita tuffandosi in acqua per salvare una rondine in difficoltà, alla fine del romanzo, ormai uomo e reso disincantato dall'esperienza, e da tre anni di carcere, non si butta nel fiume per salvare un ragazzino che muore affogato. Un sottoproletariato allegro, dalla battuta salace, nell'alterità rispetto a un potere civile e religioso ad esso estraneo, quel potere che non garantisce equamente un posto di lavoro a tutti e quindi costringe indirettamente al crimine.
Il romanzo successivo sui borgatari esce nel 1959: Una vita violenta. Narra le vicende di Tommaso, giovane ladruncolo romano, che passa da una ingenua fede di estrema destra, a motivo del culto virile per Mussolini, che pure non gli impedisce, a volte, di guadagnarsi la pagnotta andando con i "frosci", alla scoperta, nuova per lui, di uomini disinteressati, militanti comunisti; conosce questi ultimi al sanatorio, dove è stato ricoverato per una forma non grave di tubercolosi, che però si aggrava repentinamente quando, per salvare una prostituta dalla inondazione che devasta le baracche, si dà il colpo di grazia: la mattina seguente sbocca sangue, lo ricoverano in ospedale ma, essendo ormai segnato, decide di voler morire a casa sua (non alle baracche, perché già da tempo si era trasferito alle case INA, vivendo un'altra scoperta: quella della superiore, a suo modo di vedere, mentalità degli studentelli piccolo-borghesi). Dopo una gioventù spesa in rapine, violenze varie e marchette, muore riscattato, al punto che i compagni comunisti intitolano a suo nome la sezione di Pietralata.
Sono gli anni '50, ancora, e Pasolini abiurerà in seguito a questo "ridicolo decennio", ridicolo per le speranze da lui stesso vissute in ordine a un riscatto collettivo dei sottoproletari all'ombra di una bandiera rossa, che invece negli anni successivi, con la mutazione antropologica degli italiani, i quali diventeranno tutti dei piccoli borghesi incapaci di qualunque azione disinteressata e attaccati al solo benessere materiale, sarà uno strumento retorico, usato a fini propagandistici da una sinistra che, accettando il consumismo, rinnegherà il pensiero autentico dei propri padri fondatori, quale fu, primo fra tutti, l'amato (da Pasolini) Gramsci.
C'era ancora (ma per poco tempo) un mondo incontaminato, nel mondo del neocapitalismo incipiente: l'oriente, con la sua civiltà non fondata sulla volontà di potenza, come invece qui da noi occidentali; la civiltà indiana, soprattutto, all'insegna della rassegnazione. Appartiene al 1960 un viaggio del nostro con Moravia ed Elsa Morante, in India appunto, il cui resoconto Pasolini (anche Moravia ne scriverà uno suo: Un'idea dell'India) pubblica a puntate sul "Giorno", e successivamente, nel 1962, nel volume L'odore dell'India. A causa della miseria, gli indiani poveri, cioè la maggioranza, non possono essere felici, eppure c'è in loro una forma di gioia, "quasi allegria: è tenerezza, è umiltà verso il mondo, è amore..."(12)
Un'India, quella che conoscono i nostri tre simpatici visitatori, quasi del tutto priva di volgarità, un popolo educato, mite persino alle fermate degli autobus, con ragazzini calmi anche quando chiedono l'elemosina (Pasolini aiuta uno di loro a trovare una sistemazione presso un religioso cattolico che non cercherà di indurre il ragazzo a convertirsi al cattolicesimo: la libertà religiosa degli indiani è proverbiale, e solo i musulmani hanno un carattere più austero a causa delle certezze date dal Corano). Durante questo viaggio il nostro conosce pure Madre Teresa di Calcutta, che gli appare un esempio di vera bontà, cioè bontà senza sentimentalismi, pazientemente pratica.
Si è detto: Pasolini anche autore di racconti. Inizialmente non può non scrivere della sua iniziazione alla omosessualità, quasi fosse una necessità non puramente corporale, ma altruistica. In un primo racconto l'Arcangelo dice al Santo per convincerlo a rinunciare alla sua purezza:
"Solo dopo il peccato e la vergogna ti potrai sentire veramente umile: solo allora ti sentirai di terra, e inutile, e triste e stretto agli altri uomini quasi ti affratellasse ad essi l'omertà di una medesima colpa."(13)
In altri racconti descrive le condizioni di miseria disumana in cui vivono i sottoproletari nei tuguri sparsi nella periferia romana, quasi campi di concentramento. In altri parla dei diletti viaggi nel Meridione d'Italia, dove si imbatte in giovani colti che sono la sua speranza, e in altri, fascisti, che pur simpatici quando si tratta di mangiare insieme o bere del vino, però gli provocano dolore al pensiero di quanto siano compromessi con il potere clerico-fascista, che ovviamente lo odia e provoca quegli stessi giovani a una sorta di linciaggio verso di lui. In altri ancora descrive le cene o gli incontri con gli amici letterati, insieme a lui "anime belle", disinteressate e anche sfruttate da editori e produttori cinematografici non sempre propensi a pagare il compenso come da contratto.
Scopriamo in altri racconti ancora, un Pasolini superstizioso, che crede all'oroscopo da rotocalco e alla jella.(14)
C'è il dolore infine per l'immagine distorta che danno di lui i rotocalchi, ma non solo di lui, pure di registi meno scandalosi come Fellini.(15)
Voglio concludere questa "puntata" del mio saggio, ricordando la stima che aveva Pasolini per Moravia, tanto che in un racconto scrisse:
"L'intelligenza è bontà e la bontà è intelligenza; se, per lui, posso parafrasare Keats."(16)
Non chiedetemi dove Keats abbia espresso questo concetto, perché non ne ho la più pallida idea!
(1) Pasolini Pier Paolo, Atti impuri, in Romanzi e racconti, volume primo 1946-1961, "I Meridiani", Mondadori, Milano, 2004, p. 14. (torna su)
(3) Prefazione ad "Atti impuri" e "Amado mio", in Romanzi e racconti, volume primo, cit., p. 271. (torna su)
(4) Siti Walter e De Laude Silvia (a cura di), Note e notizie sui testi, in Romanzi e racconti, volume primo, cit., p. 1676-7. (torna su)
(5) Coleo di Samo, in Romanzi e racconti, cit., p. 339. (torna su)
(6) Operetta marina, in Romanzi e racconti, p. 393. (torna su)
(7) Coleo di Samo, cit., p. 343. (torna su)
(9) Operetta marina, cit., p. 408. (torna su)
(10) Lettere 1940-1954 (a cura di Nico Naldini), Einaudi, Torino, 1986, p. 169. (torna su)
(11) Cfr. l'epigramma A un figlio non nato, ne La religione del mio tempo, soprattutto in una redazione non pubblicata in cui scrive, a proposito di un rapporto sessuale, a Roma, con una prostituta che era entrata furtivamente nella sua auto: "Quella povera puttana cosa mi riproponeva? / Oh, più nulla ormai: tuttavia mi creai un'ipotesi: / non ero più obbligato, ma potevo scegliere! / Non scelsi: continuai per la mia stupenda strada / di amore sfrenato e rinnovato mille volte / come un incubo che ogni cinque minuti si fa più dolce. / L'amore che non è amore ed è mille volte amore.", in Tutte le poesie, tomo primo, "I Meridiani", Mondadori, Milano, 2003, p. 1673 [i versi citati non sono stati pubblicati nella redazione definitiva che si trova a p. 1003]. (torna su)
(12) L'odore dell'India, in Romanzi e racconti, volume primo, cit., p. 1252-3. (torna su)
(13) Le piaghe illuminate, ivi, p. 1288. (torna su)
(14) "l'oroscopo [...] E' la mia unica superstizione: suffragata, naturalmente, da mille prove inconfutabili... e condivisa del resto da quasi tutti i miei amici..." ne La vigilia. Il 4 Ottobre, p. 1553; "17 e 31, i due numeri che mi portano jella." ne La lunga strada di sabbia, p. 1480. (torna su)
(15) cfr. La vigilia. Il 21 Ottobre, ivi, p. 1565-6. (torna su)