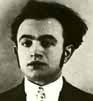IL ROMANZO DALLA CRISI DEL POSITIVISMO A "SOLARIA"
1. La crisi del positivismo (I - II)
|
Verso la fine del 1800, una serie di romanzi indica con chiarezza la crisi della filosofia positivista e della narrativa naturalista in Italia: 1889:
Il piacere di Gabriele D'Annunzio Queste opere formano ciò che, con Maria Corti (1), può essere considerato come un "campo di tensioni" (2). Per comprendere le 'tensioni' che caratterizzano il 'campo' costituito dai romanzi citati conviene accennare alla vicenda del positivismo italiano e ai suoi riflessi letterari. Il positivismo ha molto influenzato la cultura in Italia a partire dal 1870 e in particolare dopo la caduta della Destra storica (1876) (3). "Sulla base delle teorie positiviste gli intellettuali accolsero una concezione della storia e dell'evoluzione sociale che prospettava il progresso come un processo naturale verso una perfettibilità indefinita: era una concezione che permetteva alla borghesia ormai al potere di giustificare il proprio dominio e di guardare con ottimismo al processo storico in atto."(4). Sul piano culturale e letterario, accanto all'affermazione della Scuola storica (5), si impose la ricezione del naturalismo francese, che si chiamò verismo. Il verismo riprende dal naturalismo il canone poetico della impersonalità, cioè della imparzialità dello scrittore, il quale con metodo scientifico investiga la realtà, giacché vero significa oggettivo, e questo vuol dire che l'investigazione della realtà non deve essere influenzata dal punto di vista dello scrittore. In effetti, l'esigenza del vero si richiama ad un filone basilare del romanticismo italiano, un filone rappresentato da Alessandro Manzoni (6) e poi da vari narratori tardoromantici, tra i quali Emilio De Marchi (1851-1901) (7). Ma, soprattutto, il modo in cui i veristi recepirono le teorie del naturalismo va inquadrato nella specifica situazione storica, sociale ed economica italiana. Lo sviluppo industriale in Italia, in particolare a partire dal 1874, fu caratterizzato dal così detto "germanesimo economico" o "via prussiana" (8): si trattava di riformare l'economia "dall'alto e con il concorso determinante dello Stato, all'insegna del protezionismo e del rafforzamento del prestigio internazionale del paese" (Procacci [op. cit. 1975: p. 417]). Ne scaturì un doppio fenomeno.
La situazione fin qui tratteggiata si acuì quando nel 1887, alla morte di Depretis, divenne presidente del Consiglio Francesco Crispi. Questi impresse una svolta autoritaria in politica interna, e imperialistica in politica estera (9): già nel 1889 Crispi stipulò una convenzione militare con la Germania e riprese la politica coloniale in Africa, con la occupazione di Asmara e la proclamazione dell'Eritrea come colonia italiana. Ma proprio la politica coloniale segnò la fine del presidente del Consiglio: il 1. marzo 1896, dopo la sconfitta di Adua (15.000 soldati italiani furono annientati), Crispi si dimise definitivamente. (10) Seguirono quattro anni convulsi. Il nuovo presidente del Consiglio fu il marchese di Rudinì. Egli emanò un'amnistia a favore dei protagonisti del moto dei "Fasci siciliani" (cfr. 10), istituì un commissario civile per la Sicilia, "primo esperimento di decentramento regionale" (Ragionieri [op. cit. 1976: p. 1835]), e chiuse l'avventura coloniale voluta da Crispi. D'altra parte, il 1897 fu un anno di carestia e per di più gli Stati Uniti, impegnati nella guerra di Cuba, ridussero le esportazioni di grano. Fu necessario alzare il prezzo del pane, e ne seguirono tumulti popolari, non solo nelle campagne ma anche in città come Firenze, Napoli, Bari, ed infine, maggio 1898, a Milano, dove il generale Bava-Beccaris fece sparare con i cannoni sulla folla, causando a detta del governo 80 morti, secondo i giornali parecchie centinaia. Furono arrestati gli esponenti del Partito socialista, che aveva cominciato a riprendersi dopo le persecuzioni di Crispi, e furono soppressi non solo i giornali socialisti ma anche quelli cattolici. Il governo cercava di presentarsi come garante contro gli estremismi, socialisti e cattolici, mentre gli elementi conservatori cominciavano a provare nostalgia se non per Crispi, certo per un governo forte. Gradatamente vanno prendendo forma due schieramenti politici, "i fautori del governo forte" e i "difensori della libertà" (Procacci [op. cit. 1975: p. 449]). Fu l'intervento del re, Umberto I, a causare la caduta del governo e la formazione di un nuovo ministero: quello del generale Pelloux. La linea politica non cambiò: nel febbraio del 1899 Pelloux "presentò alla Camera un complesso di provvedimenti intesi a proibire lo sciopero nei servizi pubblici, a limitare la libertà di stampa e il diritto di riunione e di associazione, che, se approvati, avrebbero praticamente segnato la fine dello Stato liberale. La battaglia condotta dall'estrema sinistra, alla quale si aggiunse in un secondo tempo anche la sinistra costituzionale di Giolitti e di Zanardelli, fu memorabile" (ivi: p. 447) e determinò la caduta di Pelloux e la nascita del governo Saracco. Il 29 luglio 1900 in seguito ad un attentato anarchico perse la vita Umberto I al quale successe Vittorio Emanuele III. Seguì un periodo estremamente incerto, e quando, nel dicembre dello stesso anno, Saracco prima avallò lo scioglimento della Camera del lavoro di Genova e poi, dinanzi allo sciopero generale, senza incidenti e tumulti ma deciso e maturo, degli operai genovesi, fu costretto a revocare lo scioglimento della Camera del lavoro, fu chiara la necessità di una svolta. Il re diede l'incarico di formare un nuovo governo alla sinistra costituzionale. Cominciava nel 1901 l'età giolittiana. Questo profilo, pur molto sommario, può aiutare a spiegare quel 'campo di tensioni' di cui si diceva in apertura del presente paragrafo. Ma prima di tutto aiuta a spiegare le differenze fra verismo e naturalismo. La delusione e la sfiducia nei confronti dello stato unitario, la situazione delle classi povere ed emarginate dell'Italia meridionale, escluse dal 'benessere', il pessimismo e il fatalismo: tutto ciò caratterizza l'opera e l'ideologia del più grande scrittore verista, Giovanni Verga (1840-1922). Ciò che i veristi (11) recepiscono dal naturalismo non è tanto una visione del mondo caratterizzata dall' impegno sociale e dalla fiducia nella possibilità di aderire alla realtà per cambiarla, ma piuttosto un metodo di rappresentazione, neutrale, oggettiva, impersonale, della realtà. Tale realtà è considerata - nell'opera di Verga in modo esemplare - come immobile ed immutabile, e proprio tale immutabilità, fatta di rassegnato fatalismo, svolge certo una funzione critica nei confronti dello sviluppo industriale, ma senza che ciò significhi la proposta di un società alternativa, progressiva. Conviene leggere per intero una limpida pagina (Tateo/Valerio/Pappalardo [op. cit. 1985, vol. 3, tomo I: p. 696]) che sintetizza in modo preciso tale questione:
La tensione appare già qui, ed è - paradossalmente - la radice della grandezza dell'arte verghiana (12).
Ebbene, l'anno successivo all'ultima redazione di Giacinta, Capuana pubblica il romanzo Profumo. L'interesse del romanzo, e la tensione che esso crea con la narrativa verista, stanno nel fatto che il ruolo del metodo scientifico è marginale. Al centro della storia è ancora una volta un caso clinico, costituito dalla malattia nervosa di una donna, ma non è il metodo scientifico che permette un approccio al caso patologico, bensì l'attenzione ai fattori spirituali che 'spiegano' il caso. Sicché: "l'apparato scientifico, con le sue aride annotazioni, appare del tutto pleonastico rispetto all'idea conduttrice, riposta tutta nella soluzione spirituale del ‘caso clinico’" (Tateo/Valerio/Pappalardo [op. cit. 1985, vol. 3, tomo I: p. 707]). In effetti Profumo assume una posizione centrale nella produzione di Capuana: realizza artisticamente le istanze spiritualistiche che già in saggi come Spiritismo (1884) e Mondo occulto (1896), dello stesso autore, subentrano alle teorie naturalistiche, e annuncia quello che è considerato il capolavoro di Capuana, Il Marchese di Roccaverdina (1901), in cui "le sottili e compiaciute analisi psicologiche, di vago sapore scientifico, [..] finiscono con l'appesantire l'opera la quale però trova un motivo di riscattarsi nel clima quasi fiabesco, allucinato e di grande suggestione che avvolge la vicenda e i personaggi." (ivi) In conclusione: Profumo lascia intravedere la tensione fra la visione del mondo del positivismo e le nuove istanze spiritualistiche che cominciano a comparire nella cultura italiana del fine secolo. L'opera fondamentale di un altro autore verista di grande interesse, Federico De Roberto (1861-1927), è il romanzo I Vicerè (1894). I Vicerè non è solo il capolavoro di De Roberto, è anche uno dei romanzi più interessanti della letteratura italiana moderna (14). Si tratta di un romanzo storico ("che riduce al minimo, anzi quasi annulla l'effetto consueto di distanziamento prospettico dall'epoca in cui è situata la vicenda", Spinazzola [op. cit. 1990: p. 5]) in cui vengono narrate le vicende di una nobile famiglia siciliana (la famiglia degli Uzeda, principi di Francalanza, soprannominati appunto "Vicerè") dal periodo risorgimentale al periodo immediatamente successivo all'Unità. L'impianto narrativo è naturalistico (De Roberto fu amico e seguace di Capuana e di Verga), ma oggetto della rappresentazione scientifica è il mondo dei nobili, e non quello dei diseredati; inoltre il metodo scientifico viene applicato allo studio dell'evoluzione storica. L'interesse del romanzo sta nel fatto che ad esso, come ha notato molto bene Spinazzola, sono da affiancarsi I vecchi e i giovani (1913) di Pirandello e Il Gattopardo (1957) di Tomasi di Lampedusa: i tre romanzi offrono "una rappresentazione narrativa e una interpretazione saggistica di eventi connessi al passaggio della Sicilia dal regime assolutista al liberalismo borghese, per effetto dell'unificazione nazionale italiana" (Spinazzola [op. cit. 1990: p. 4]), ma tale rappresentazione - in varie maniere nelle tre opere - è caratterizzata dalla negatività, dalla sfiducia nel cambiamento storico e nel progresso. Consalvo, personaggio de I Vicerè, afferma alla fine del romanzo: "La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d'oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio universale non è né un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io, perché mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento [...]. Il nostro dovere, invece di spezzare le nuove leggi, mi pare quello di servircene!" (15) E proprio questo succede: la famiglia degli Uzeda si adatta al nuovo corso storico, e così facendo mantiene la propria egemonia, si serve delle nuove leggi. Proprio qui la 'tensione' che caratterizza il romanzo di De Roberto: il metodo storico per realizzare un romanzo 'antistorico', il metodo scientifico per negare il positivismo. "Il teleologismo positivista, con la sua persuasione che la razionalità scientifica avrebbe potuto grado a grado sanare tare e squilibri dell'esistenza consociata, non offre più alcun paradigma di certezze a De Roberto." (Spinazzola [op. cit. 1990: p. 13]) Profumo e I Vicerè rappresentano in modi diversi la crisi del positivismo, proprio in ambiente verista, e portano in piena luce quella contraddizione fra metodo scientifico 'positivo' e visione del mondo 'negativa' già presente in Verga. (1) Corti, Maria, in La semiotica letteraria italiana, Interviste con D'A. S. Avalle, M. Corti, C. Segre, U. Eco, E. Garroni, S. Agosti, M. Pagnini, A. Serpieri, A. Rossi, G. L. Beccaria, A. Buttitta, G. P. Caprettini, a cura di Marin Mincu, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 29-30; Corti, Maria, Principi della comunicazione letteraria, Bompiani, Milano 1976, pp. 19-22; Corti, Maria, Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Einaudi, Torino 1978, pp. 22-23 (torna su) (2) "[...] una società crea in determinati momenti una nuova ideologia, da cui nascono dei modelli sociali e di lettura del mondo; tali modelli, che sono delle strutture semiotiche, possono persistere più a lungo dell'ideologia che li ha creati e scontrarsi con una nuova ideologia nascente; si crea allora un processo semiotico conflittuale dentro la società e, di conseguenza, dentro la letteratura: conflitto fra il presente, che abbisogna di nuovi modelli strutturanti, e il passato che sovrasta coi suoi. Da questa non coincidenza temporale fra ideologie e modelli può nascere, anzi nasce un campo di tensioni, cioè la coesistenza di "diversi" in forte contrasto e il particolare e specifico modo di reagirvi di gruppi e movimenti letterari." (Maria Corti, in: La semiotica letteraria italiana. Interviste con D'A. S. Avalle, M. Corti, C. Segre, U. Eco, E. Garroni, S. Agosti, M. Pagnini, A. Serpieri, A. Rossi, G. L. Beccaria, A. Buttitta, G. P. Caprettini, a cura di Marin Mincu, Feltrinelli, Milano 1982, pp.29-30. (torna su) (3) Per "Destra storica" si intende la tendenza moderata del
movimento liberale: si tratta dei continuatori della politica di Camillo Benso,
conte di Cavour. Cavour, moderato, sostenitore della libertà imprenditoriale, e
al tempo stesso convinto democratico, morì nel giugno del 1861, pochi mesi dopo
la proclamazione del Regno d'Italia. I governi successivi ereditarono appunto le
idee di Cavour (ma non ne furono per nulla all'altezza, soprattutto perché non
furono capaci di affrontare i problemi sociali, in particolare nel sud del
paese), e rimasero al potere fino al 1876. Infatti, "con la presa di Roma il
ciclo eroico del Risorgimento si chiudeva definitivamente e l'attenzione
dell'opinione pubblica veniva ora naturalmente indotta a concentrarsi sui
problemi interni e della vita economica." (Procacci, Giuliano, Storia degli
italiani, Laterza, Roma-Bari (prima edizione: 1968).[1975: p. 404]). (4) Pirodda, Giovanni, Lineamenti di letteratura italiana. Storia - Correnti - Generi, Paravia, Torino 1982, p. 164. La vittoria prussiana nella battaglia di Sedan (1870), che aveva consentito al governo italiano di conquistare Roma (nel 1864 il governo italiano si era impegnato con la Francia di Napoleone III a garantire la integrità del territorio pontificio e aveva scelto Firenze quale capitale d'Italia, appunto come segno di rinuncia a Roma; dopo la sconfitta francese del 1870, l'Italia si sentì libera da tale accordo), favorì la penetrazione in Italia delle idee positiviste. Quando nel 1876 la direzione politica passò a Agostino Depretis e alla Sinistra storica, le idee positiviste accentuarono la reazione alla chiusura della chiesa cattolica che, fin dal 1864, con il Síllabo, aveva condannato il socialismo, le teorie liberali e ogni manifestazione del mondo moderno. (torna su) (5) Il "manifesto" del positivismo italiano è il saggio La filosofia positiva e il metodo storico (1866) di Pasquale Villari. Il "metodo sperimentale" nelle scienze naturali corrispondeva, secondo Villari, al "metodo storico" nelle scienze umane. Si trattava cioè di impostare lo studio di tali scienze in modo rigorosamente storico, cercando di mettere in luce i fatti, e cioè le reali condizioni storiche nelle quali concetti, idee, teorie delle scienze umane e morali erano apparsi e si erano sviluppati. Tutto ciò costituiva in effetti lo sviluppo rigoroso del metodo di Francesco De Sanctis, e per cinquanta anni sarà questo metodo a caratterizzare non solo gli studi letterari, ma anche quelli strettamente filologici: opera esemplare è Virgilio nel Medioevo (1872) di Domenico Comparetti. Inoltre, l'interesse per le "origini", in particolare le origini medievali, già proprio del romanticismo, dà luogo alla nascita in Italia della filologia romanza: "Il panorama affascinante intravisto dai Romantici è diventato un territorio così vasto che nessuno può percorrerlo individualmente. Positivisticamente, esso diventa dominio della "Scienza", un'entità che supera ogni singolo studioso. Per la prima volta si stabilisce il criterio della 'competenza', che possiamo intendere nel doppio significato di conoscenza precisa e di confine. La filologia romanza riceve un limite non solo dalla sua definitiva separazione dalla indoeuropeistica, dalla germanistica ecc., ma dalla sua polarizzazione sul Medioevo. Questa limitazione, è vero, si realizza in modo chiaro soprattutto in Italia: ed è comunque servita fino ad oggi a salvare i rapporti orizzontali tra le diverse lingue e letterature romanze." (Renzi, Lorenzo, Introduzione alla filologia romanza, Il Mulino, Bologna 1976, p. 74]) Né vanno dimenticati gli studi linguistici di Graziadio Isaia Ascoli, iniziatore della dialettologia italiana, del metodo storico-comparativo, e soprattutto lucido studioso della "questione della lingua": "Il punto di forza dell'Ascoli è nell'approfondimento della situazione sociolinguistica dell'Italia, perseguito su un terreno di concretezza e di scientifico rigore al fine d'intervenire sull'evoluzione totale della società. Sostituendo alla teoria astratta il concreto storico, l'Ascoli rompe risolutamente il primato del modello (un mito che pur in accezione democratica il Manzoni aveva conservato) e, con una dialettica appropriata alla problematica del momento, imposta in termini metalinguistici il secolare discorso sulla questione della lingua." (Dardano, Maurizio, G. I. Ascoli e la questione della lingua, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1974, pp. 100-101], cfr. anche Migliorini, Bruno, Storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze 1960) (torna su) (6) Nella lettera Sul Romanticismo, indirizzata a Cesare Taparelli d'Azeglio, scritta nel 1823, pubblicata contro la volontà dell'autore nel 1846, ripubblicata dall'autore in una redazione diversa nel 1870, Manzoni polemizzava contro l'uso classicista della mitologia in nome del "vero storico" e del "vero morale", "non solo come fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello: giacché e nell'uno e nell'altro ordine di cose, il falso può bensì dilettare, ma questo diletto, questo interesse è distrutto dalla cognizione del vero; è quindi temporario e accidentale." (cfr. Baldi, Guido (a cura di), Manzoni. Cattolicesimo e ragione borghese, Paravia, Torino 1975, pp. 108-113) (torna su) (7) Né va dimenticato il movimento chiamato "Scapigliatura", dal titolo di un romanzo di Cletto Arrighi (vero nome: Carlo Righetti, 1828-1906), La Scapigliatura e il 6 febbraio (1862). Gli 'scapigliati' reagiscono contro alcuni aspetti deteriori del tardo romanticismo appunto in nome di esigenze realistiche. Giustamente è stato detto che "la Scapigliatura preannuncia, senza tuttavia assimilarvisi né anticiparli programmaticamente, movimenti come il Verismo e il Decadentismo." (Tateo, Francesco / Valerio, Nicola / Pappalardo, Ferdinando, La letteratura nella storia d'Italia, volume terzo, Il Tripode, Napoli 1985, vol. 3, tomo I: p. 686]) (torna su) (8) Cfr. Procacci, Giuliano, Storia degli italiani,
cit., pp. 416-421: "Attorno al 1874 [...] si era cominciato in Italia a
discorrere di ‘germanesimo economico’ e un gruppo di economisti, tra i quali fa
spicco il nome di Luigi Luzzati, aveva fondato una nuova rivista, il "Giornale
degli Economisti", per propugnare appunto la necessità di rivedere il
tradizionale indirizzo liberistico della politica economica italiana." (ivi: p.
416). (9) "Il filogermanesimo trionfante in Italia negli anni ottanta, l'improvvisata e velleitaria vocazione colonialista, la spregiudicatezza e lo spirito di iniziativa dei nuovi capitani d'industria, il tradizionale livore degli agrari siciliani contro i contadini insorti, tutti insomma gli ingredienti costitutivi del nascente blocco agrario-industriale erano presenti in lui [in Crispi] in forma accentuata e a volte parossistica. Non a caso e non a torto il fascismo ne ha fatto un suo precursore." (Procacci [op. cit. 1975: pp. 431-432]) (torna su) (10) Il governo di Crispi cadde una prima volta il 31
gennaio 1891, quando la maggioranza della Camera votò contro di lui a causa
delle eccessive spese militari. Seguirono due governi, quello retto da Antonio
Starabba di Rudinì, fino al maggio del 1892, e quello retto da Antonio Giolitti,
che durò solo diciotto mesi. Nell'agosto del '92 nasceva a Genova il Partito
socialista (su questo partito, sui suoi rapporti con il movimento anarchico, e
sui primi passi dei movimenti politici cattolici, cfr. Ragionieri, Ernesto,
La storia politica e sociale, in Storia d'Italia, volume quarto, tomo
terzo, Einaudi, Torino 1976, pp. 1774-1795] e Procacci [op. cit. 1975: pp.
434-439]), e nell'autunno del 1893 esplodeva la ribellione dei "Fasci dei
lavoratori" siciliani (associazioni di contadini, anche donne e ragazzi, nate in
modo spontaneo per protestare contro le condizioni di vita soprattutto degli
operai addetti alle miniere di zolfo): "Il governo Giolitti, conformemente alla
prassi liberale [...] che partiva da una distinzione fra socialismo e
anarchismo, aveva tenuto anche nei confronti del movimento dei Fasci siciliani
un atteggiamento sostanzialmente benevolo in cui aveva una certa parte anche la
volontà di farsi in Sicilia una base e un punto di appoggio contro Crispi."
(Ragionieri [op. cit. 1976: p. 1807]). (11) E' possibile distinguere schematicamente tre filoni del verismo: il primo è costituito da un gruppo di scrittori napoletani, tra gli altri: Matilde Serao, Ferdinando Russo, Giovanni Capurno; il secondo da un gruppo di scrittori siciliani: Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto; il terzo da un gruppo di scrittori toscani, tra gli altri: Mario Pratesi e Renato Fucini (cfr. Asor Rosa, Alberto, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Samonà e Savelli, Roma 1965; seconda edizione: 1966; terza edizione: Einaudi, Torino 1988, p. 57). (torna su) (12) "Il rifiuto di un'ideologia progressista costituisce la fonte, non il limite della riuscita verghiana." (Asor Rosa [op. cit. 1965/1988: p. 56]) (torna su) (13) De Meijer, Pieter, La prosa narrativa moderna, in Letteratura Italiana, volume terzo, tomo secondo, La prosa, Einaudi, Torino 1984, p. 803. (torna su) (14) Grande attenzione ha prestato a questa opera Gianni Grana, il quale ha definito I Vicerè un romanzo miliare della narrativa italiana dell'Ottocento (Grana, Gianni, I Vicerè e la patologia del reale. Discussione e analisi storica del romanzo, Marzorati, Milano 1982, p. 7]). Si veda anche il capitolo dedicato al romanzo da Spinazzola, Vittorio, Il romanzo antistorico, Editori Riuniti, Roma 1990, su cui avremo modo di tornare. (torna su) (15) Sarà appunto la tesi di Tancredi, nipote del principe di Salina (nipote del Gattopardo) nel romanzo di Tomasi di Lampedusa, il quale si unisce agli uomini di Giuseppe Garibaldi sbarcati in Sicilia (1860) affinché tutto rimanga come è: "Se non ci siamo anche noi quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?" (torna su) |
L'autore di questo ipertesto è Giovanni Lanza il cui sito è qui: www.giovanni-lanza.de/il_romanzo_dalla_crisi_del_posit.htm