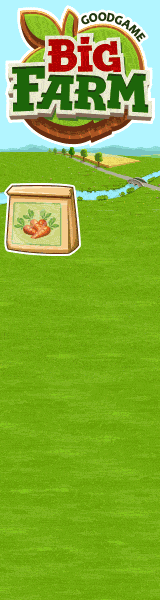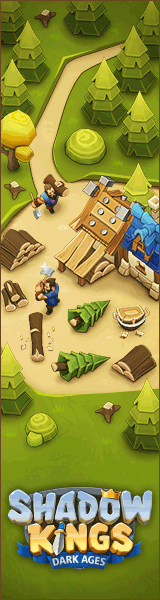CONTRO LA GRAMMATICA ITALIANA
Gioca gratis
HA SENSO UNA GRAMMATICA CONTESTUALIZZATA?

La grammatica strutturale è un'astrazione del tutto inutile. Suddividere la frase in monemi e fonemi, lessemi e morfemi non serve a nulla. E' una pura illusione quella di credere possibile scomporre una frase in tante unità minime dotate di significato univoco. Più queste unità sono minime e meno sono significative.
Si badi: un fonema non è insignificante perché suddivide i monemi in unità troppo piccole, ma perché dall'insignificanza dei monemi non può scaturire che un'insignificanza ancora più grande. E che l'insignificanza dei monemi sia già grande è dimostrato anche dal fatto che è sufficiente introdurre dei monemi modificanti o funzionali per mutare il significato di un verbo o di una proposizione.
La significatività di un enunciato non dipende neppure dalla scelta dei vocaboli, né dalla loro disposizione e neppure dal loro reciproco rapporto, ma dipende unicamente da ciò che si sa evocare rispetto a uno spazio e a un tempo determinati. P.es. se io dico "forzuto" e "forzare" posso pensare che questi monemi abbiano un qualche significato in quanto provengono da una stessa radice: "forz". In realtà noi attribuiamo un significato aprioristico a tale lessema, che per il linguaggio non ha alcun vero senso, almeno finché non lo si contestualizza.
Un messaggio può essere compreso solo se si riesce a contestualizzarlo. La semantica ha una priorità assoluta sulla sintassi. Un messaggio è significativo se trasmette qualcosa che tocca o i sensi o i sentimenti (i sensi ovviamente possono anche essere razionali, intellettuali e non solo fisici).
La grammatica non dovrebbe essere insegnata come una matematica. Nessuna parola, presa in sé, ha significato, neppure se inserita in una proposizione, se questa non viene contestualizzata, e anche quando lo è, deve sempre esistere, se si vuole una vera comunicazione, la possibilità di interpretazioni diverse. P.es. una frase di questo genere: "Un pollo mangia un uomo", la grammatica strutturale la giudicherebbe assurda perché illogica; eppure, se situata p.es. in un genere giallo-spionistico, potrebbe anche essere considerata una frase in codice, cifrata, utile per salvare una vita, e quindi altamente significativa.
Non è la possibilità d'interpretazioni diverse che rende liberi, perché la libertà sta nel trovare l'interpretazione più giusta, ma senza libertà è fuor di dubbio che non esiste possibilità di interpretazioni diverse.
Vediamo ora i sintagmi o segmenti. Prendiamo questo enunciato di Carlo Levi: "Un uccello si leva improvviso da terra frullando e scompare".
La grammatica strutturale lo considera significativo pur nella sua mancanza assoluta di riferimenti spazio-temporali. Concediamolo. Detta grammatica, tuttavia, ha la pretesa di poter individuare un sintagma autonomo, entro quell'enunciato, in grado di esprimere un senso completo indipendentemente dal contesto della frase. E tale sintagma minimo sarebbe il seguente: "un uccello improvviso da terra".
Ora, come si può ben notare, in questa combinazione di monemi non esiste predicato ma solo soggetto, la cui azione è implicita nel movimento espresso dai monemi "improvviso" e "terra". Anzi, poiché il monema "terra" da solo potrebbe anche voler dire che l'uccello d'improvviso "cade" sul suolo (magari perché colpito da un cacciatore), il vero senso di tutto il sintagma autonomo è indicato da una semplice preposizione di luogo: "da".
Senza questo monema funzionale noi non riusciremmo a capire se l'uccello è stato appena abbattuto o se si è levato dal suolo perché spaventato da uno sparo, impaurito da qualcosa o attirato da qualcos'altro (che può aver visto in aria o altrove).
Questo ragionamento, in sostanza, è pura follia e il pretendere di saper distinguere i sintagmi autonomi da quelli predicativi e altre oziosità del genere è solo una perdita di tempo.
* * *
La grammatica dice che chi invia un messaggio è definito "emittente", chi invece lo riceve è il "ricevente". Tuttavia, nella comunicazione il linguaggio è sempre circolare, altrimenti non c'è comunicazione, cioè "mettere insieme", ma solo "monologo".
Nella comunicazione umana emittente e ricevente si confondono di continuo, cioè si scambiano i ruoli senza neppure accorgersene. L'emittente può esistere solo nel momento in cui si inizia un discorso, ma subito dopo, se esiste interazione, esso è già ricevente; anzi, anche nel momento dell'inizio, è sempre difficile dire da dove provenga la motivazione che ha fatto nascere un discorso: uno può essere emittente senza sapere che inconsciamente è già stato ricevente. Cioè uno può iniziare a dire qualcosa perché qualcun altro, prima di lui, prima di quel momento, in circostanze anche remote o fortuite, può in qualche modo avercelo indotto.
In una società basata sulla comunicazione una persona è emittente solo perché un'altra persona lo è stata prima di lei. E non c'è destinatario che, a sua volta, non si trasformi subito in emittente.
Ecco perché la grammatica è una pura formalità. Il fatto stesso di sostenere che la comunicazione avviene correttamente solo se emittente e ricevente utilizzano lo stesso codice interpretativo, è sintomatico della grande povertà di questa disciplina.
La comunicazione, quella vera, direbbe esattamente il contrario, e cioè che non è affatto sufficiente possedere un codice comune per realizzare correttamente una comunicazione. Queste cose possono essere vere solo sul piano meramente formale o tecnico, ma nella realtà sociale spesso accade il contrario, e cioè che la comunicazione risulta più facile tra chi vive medesime situazioni di disagio o di aspettativa, o tra chi ha un medesimo sentire, nei confronti di determinati problemi o eventi: è molto più facile una comunicativa tra persone che hanno una medesima consapevolezza che non tra quelle che concepiscono la loro vita in maniera antagonistica. Separare la grammatica dai problemi sociali non aiuta a capire la complessità della comunicazione.
Facciamo un esempio. Dice la grammatica: "Due persone che si parlano sedute in salotto utilizzano come canale l'aria, ma se nella stanza un giradischi suonerà ad alto volume, nell'aria si produrranno interferenze e la comunicazione avverrà con difficoltà".
A tale proposito direbbe invece la comunicazione: "Due persone non parlano in salotto con un giradischi a tutto volume e se il giradischi viene acceso dopo ch'esse hanno iniziato a parlare, l'interferenza non è del giradischi, ma di chi l'ha acceso".
Questa interferenza va interpretata:
1. qualcuno non vuol far parlare quelle due persone?
2. qualcuno non s'è accorto che nel salotto ci sono due persone che parlano?
3. una delle due persone s'è messa d'accordo con una terza persona per attivare
il giradischi ad un dato momento?
La grammatica va semantizzata, altrimenti è un non senso. Questo poi senza considerare che l'interferenza, nella comunicazione sociale, può anche essere motivo d'interesse o di curiosità, di arricchimento. Ogni volta ch'essa si pone, andrebbe specificato quand'è di disturbo o di vantaggio. Non è affatto vero ch'essa di per sé ostacola la comunicazione, anzi, può anche indurre a ripensare il proprio stile comunicativo o i propri contenuti. Le circostanze determinano sempre una modificazione del linguaggio.
La comunicazione rischia d'impoverirsi incredibilmente se si costringono le persone a formulare i loro pensieri, a circoscrivere il loro linguaggio entro determinati schemi, e questo impoverimento avviene anche quando il numero delle parole è elevatissimo e la grammatica è la più rigorosa del mondo.
* * *
Le principali definizioni per spiegare il significato di una proposizione generalmente sono tre:
- è dotata di senso compiuto (p.es. "Roberto balla");
- contiene un solo verbo al modo finito (p.es. "balla");
- è chiusa da un segno di interpunzione forte.
Così la Zordan, nella sua Sintassi.
Come noto, in talune proposizioni, è sufficiente anche solo il verbo: p.es. "Piove", per dare un senso alla frase; o comunque il soggetto può essere anche sottinteso, poiché nella nostra grammatica tecnicistica è il predicato verbale a farla da padrone. Da notare però che spesso in poesia s'incontrano frasi nominali in cui il verbo è del tutto assente, come p.es. in questa di Diego Valeri: "Non una voce dentro il cuor morto".
Ma davvero una frase come "Roberto balla" è dotata di "senso compiuto"? Perché questa strana pretesa? Roberto in realtà balla da solo, perché soffre di un forte esaurimento nervoso. E quando lui dice, mentre lo fa, "ballare, ballare", invitando gli altri esauriti del reparto a fare la stessa cosa, non sta usando un modo "finito", benché gli altri abbiano capito benissimo che lui si diverte e che vorrebbe far divertire tutto il reparto. Vorrebbe, peraltro, senza dare ordini perentori, semplicemente invitando gli altri a seguire il suo esempio: ecco perché fa seguire al verbo "ballare" tre puntini di sospensione.
* * *
Facciamo un esempio di profondità di linguaggio. L'evangelista Giovanni scrisse, negli ultimi anni della sua vita, un episodio eloquente sulla fine politica che fece l'apostolo Pietro. Il lessico usato è semplicissimo, ma il messaggio è così evocativo da risultare di una profondità eccezionale.
L'episodio è narrato in 21,15ss. Giovanni s'immagina una scena irreale, in cui Gesù, dopo aver fatto colazione, chiede a Pietro per ben tre volte se l'amava davvero, più di tutti gli altri apostoli. Il riferimento cade ovviamente sulla triplice negazione, ma se fosse solo così, la proposizione sarebbe banale, anzi crudele.
Il senso di quella triplice richiesta sta in realtà nel v. 18, che Giovanni è costretto ad attribuire a Gesù, in quanto Pietro fa mostra di non comprendere minimamente il senso della domanda che gli era stata rivolta.
Non c'è autocritica in Pietro, persona ambigua per definizione, che sapeva mascherare la propria pochezza intellettuale e morale dietro un atteggiamento rude, spavaldo, temerario.
Il v. 18 è un esempio di stilizzazione suprema della personalità di Pietro: "Quand'eri più giovane ti cingevi da te (cioè facevi mostra d'essere sicuro e di poter guidare gli altri con sicurezza, salvo poi tradire di fronte all'imminenza del pericolo o di cadere in atteggiamenti opportunistici); ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti".
L'esegesi cattolica qui vede un riferimento alla morte fisica di Pietro; in realtà Giovanni sta parlando della morte politica del petrinismo, superato dall'ideologia spiritualistica di Paolo. Il v. 19a infatti è spurio, in quanto aggiunto successivamente.
La storia del cristianesimo primitivo -dice Giovanni- ha visto Pietro come protagonista, ma questo ha comportato una prosecuzione falsata dell'autentico messaggio di Cristo, finché assai presto s'è fatto largo lo spiritualismo filoellenistico di Paolo.
Di qui la conclusione amara del racconto in quelle enigmatiche ma profondissime parole che Giovanni fa dire a Gesù rivolto a Pietro: "Se voglio che rimanga finché io venga, che t'importa?"(v. 22).
Giovanni non voleva semplicemente dire che aveva visto Pietro morire, ma piuttosto che l'ideologia di Pietro non avrebbe resistito tanto quanto la sua. Infatti il vangelo di Giovanni contiene degli aspetti la cui profondità non è stata ancora esaminata a sufficienza.
Il vangelo di Giovanni è grande perché egli ha usato un linguaggio che dice e non dice, cioè un linguaggio che non pretende assoluta chiarezza, ma che si evolve lentamente e lascia trasparire la profondità delle cose in maniera progressiva, permettendo al lettore una comprensione sempre più approfondita. Quanto, nella scelta di questa strategia linguistica, egli sia stato indotto anche dalle censure su di lui è facile immaginarlo.
Tesi da dimostrare
- Una proposizione viene detta "semplice" quando la sequenza di parole che la compongono è sufficiente a far comprendere un qualche loro significato.
- Una proposizione che contiene un significato "univoco" va generalmente intesa come di "basso livello" o di "livello elementare".
- Una proposizione che contiene un significato "ambiguo" o "ambivalente" o "interpretabile" va intesa come di "alto livello" o di "livello complesso".
- Le proposizioni di origine matematica sono generalmente di "basso livello".
- Posto che un periodo sia la somma di più proposizioni, è sbagliato sostenere che un periodo è "complesso" semplicemente perché contiene più di un verbo, o che è tanto più complesso quanti più predicati verbali contiene.
- E' sbagliato attribuire al verbo un primato semantico assoluto su ogni altro componente della proposizione o del periodo.
- L'unico modo per poter attribuire un significato corrispondente alle parole usate in una proposizione o in un periodo è quello di contestualizzarle nello spazio e nel tempo.
- Il testo assume significato solo nel contesto e di questo vanno comprese le leggi che lo regolamentano.
- Comprendere il senso di una frase significa anzitutto analizzare il contesto in cui essa è stata formulata. Per togliere alla grammatica il suo tecnicismo matematico occorre storicizzarne i contenuti.
- Dunque la forma minima di base della proposizione non può essere il soggetto più il predicato verbale, ma, oltre a questo, i riferimenti contestuali di spazio e tempo, che sono categorie a priori, irrinunciabili per qualsivoglia proposizione o periodo che pretenda d'essere comprensibile e su cui si possa esercitare una qualche forma d'interpretazione.