PER LA RIFORMA DELLA
SCUOLA
pubblica laica territoriale
SCUOLA E GIOVENTÙ: IL DECALOGO DELL'ALTERNATIVA
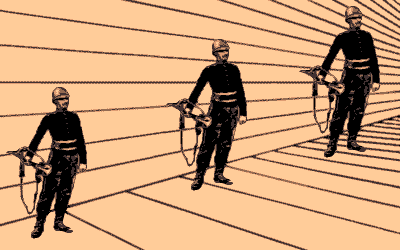
Primo: descolarizzare la società
Che la scuola rifletta l'iter di una vita piccolo-borghese (l'unica che l'odierno Stato è in grado di offrire) è testimoniato anche dal fatto che il giovane viene educato a studiare solo allo scopo di ottenere un profitto almeno sufficiente. Come noto, dalla metà degli anni '70, a causa della contestazione studentesca, lo Stato ha rinunciato alla pretesa di servirsi della scuola pubblica in maniera ideologica, al fine di riciclare il personale direttivo della sua struttura politico-amministrativa. La cultura classista, idealista e meritocratica della scuola degli anni '50 e '60 oggi è meno "classista" perché il benessere è più diffuso; meno "idealista" perché il consumismo di massa ha distrutto ogni valore; meno "meritocratica" perché ogni diploma è svalutato.
Oggi la scuola non serve praticamente a nulla: i licei sono esigenti solo per conservare la tradizione di scuole impegnative, ma lo spettro della disoccupazione post-universitaria è come una spada di Damocle per la loro futura sopravvivenza. I licei sono esigenti per timore di scomparire, ma se lo sono troppo rischiano di estinguersi prima ancora che venga varata la riforma delle superiori (a meno che non si affidino a sperimentazioni varie in campo linguistico o informatico). Gli istituti tecnici e professionali, che hanno conosciuto un boom eccezionale in questi ultimi 10-15 anni, semplicemente perché sembravano garantire, senza laurea, più di quanto potessero certe facoltà universitarie ove confluivano i liceali, permettono di svolgere, a causa del loro bassissimo livello culturale, solo mansioni limitate, circoscritte, e modestamente remunerate (salvo naturalmente le debite eccezioni); assai difficilmente queste scuole porteranno il giovane ad assumere ruoli di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche o nelle aziende. Se il livello culturale delle nostre università non fosse altrettanto basso, il 100% di questi ragazzi si accontenterebbe del misero diploma.
In una parola non esistono più scuole che possano servire come trampolino di lancio per i futuri dirigenti dei servizi statali. Oggi persino le industrie provvedono da sole a formare i manager di cui hanno bisogno. La cultura scolastica è così scarsa che per fare una qualche carriera prestigiosa il giovane deve avere: 1) una pazienza infinita, 2) sufficienti disponibilità finanziarie, 3) "aderenze" e "spinte" a tutto campo. Vengono premiate queste cose, non la sua competenza, ch'egli peraltro si farà solo dopo l'entrata in servizio, a spese della stessa amministrazione.
La vecchia scuola: perché eliminarla?
Nell'odierna scuola è solo la minaccia di un voto negativo che fa scattare, temporaneamente, l'impegno dello studio: in tal modo viene soddisfatta la logica utilitaristica del do ut des che l'insegnante impone all'allievo e che la società impone ad entrambi. Quello che manca è l'interesse per il contenuto in sé della disciplina scolastica.
La conseguenza di tutto ciò è tragica: lo studente diventa tanto più ignorante quanto più studia. Non c'è infatti nozione che meglio si dimentichi di quella studiata per forza, per soddisfare l'esigenza di un momento (che per lo studente coincide con l'arbitrio dell'insegnante, il quale è costretto dal sistema delle cose -oggi sempre meno in verità- ad essere arbitrario).
Paradossalmente la scuola di oggi è il luogo culturale in cui si fa meno cultura. I più grandi lettori di quotidiani sono i bidelli, poi vengono gli applicati. La biblioteca, aperta grazie al volontariato di qualche docente di materie letterarie, che occupa le proprie "ore buche" non a elaborare "lavori culturali" per la scuola, bensì a schedare libri e riviste o a fingere d'essere un "intellettuale", sarebbe uno strumento utilissimo non solo per la scuola (sempre che i ragazzi, stimolati dai loro docenti, sappiano ch'esso esiste), ma anche per tutto il quartiere (generalmente sprovvisto di alcuna biblioteca), se solo il Ministero stipendiasse un "operatore culturale" ad hoc (nel migliore dei casi invece ti piazza un prof con dei problemi personali che può servirsi dell'ex art. 113).
Come noto, la cultura è la riflessione sopra un'esperienza significativa. A scuola invece esiste il puro nozionismo astratto, completamente sganciato dalla vita, o meglio: del tutto funzionale a una vita che vuole tenere separati scuola e mondo del lavoro, produzione e fruizione della cultura, passato e presente, cose che si devono "sapere" e cose che si devono "studiare", ecc. La differenza fra la scuola degli anni '50 e la scuola di oggi sta solo nel nozionismo, che oggi è stato ridotto al minimo, essendo ridotte al minimo le pretese dello Stato nei confronti della scuola.
Lo studente che non si adegua a questo modello viene considerato uno stupido, perché potrebbe essere promosso colla minima fatica, oppure un "secchione", cioè uno che con le sue esigenze di "cultura" compromette la stabilità della classe, decisa sulla base dei livelli più bassi di rendimento. Per fortuna (si fa per dire!) queste scelte "divergenti" (in favore della cultura) oggi sono piuttosto rare, almeno nell'area centro-nord del nostro Paese, che è quella che meglio conosciamo.
Lo stesso insegnante che vuol fare più di quanto gli venga richiesto (vedi ad es. i cosiddetti docenti referenti), rischia di passare per un piantagrane, per uno che vuole rompere il ben collaudato meccanismo dei ruoli, impostato sulla seguente regola fondamentale: "Io ti faccio il minimo se tu mi chiedi il minimo".
A volte lo studente non fa neppure quello: il minimo si limita a "copiarlo" e quando questo non basta si limita a sperare nell'indulgenza dei consigli di classe. Anche molti docenti lavorano al di sotto del minimo, ma siccome garantiscono il sei generalizzato, agli studenti non conviene protestare.
Oggi lo studente non sa quasi nulla di quanto accade nel mondo: non ha interessi culturali extra-scolastici che partano da motivazioni personali. Quelli che ha non riguardano certo la cultura o la politica. Egli infatti sa in partenza che ciò non contribuisce ad elevargli il profitto scolastico. La scuola non chiede di tenersi aggiornati. Non ponendosi alcun problema educativo, formativo, critico e conoscitivo in senso "generale", essa resta imperturbabile a qualunque forma di crisi, di degrado, di corruzione, di criminalità e persino di conflitto bellico (si veda ad es. l'incredibile indifferenza con cui gli insegnanti hanno reagito alla guerra nel Golfo Persico, o a quella in Somalia, o a quella nella ex-Jugoslavia).
L'attualità che il giovane meglio conosce è quella che può più facilmente abbordare: sia perché maggiormente reclamizzata dai media, sia perché di basso contenuto culturale, come ad es. lo sport, la moda, films americani e cartoons, automobili e motori, le varie droghe, il sesso e la musica leggera.
Oggi lo studente non sa nulla neppure delle materie scolastiche, poiché non le studia più con continuità, al fine di migliorare il proprio rendimento o per curiosità intellettuale o per discuterne criticamente in classe. Il suo unico problema è di ripetere quelle quattro nozioni in croce sufficienti a promuoverlo.
La sua memoria non solo è diventata estremamente selettiva e parcellizzata, ma anche incredibilmente labile e vuota. Essa cioè incamera quel che serve solo per il momento in cui serve, dopodiché dimentica con relativa facilità. Inoltre, verifiche, interrogazioni, compiti in classe sono spesso programmati dal docente con un certo anticipo, per cui lo studente ha tutto il tempo per prepararsi: persino i volontari non vengono mai rifiutati e i cosiddetti "impreparati" possono giustificarsi due/tre volte a quadrimestre.
La conseguenza più negativa non sta solo nei ragionamenti schematici e superficiali che si sentono in classe, ma anche nell'atteggiamento, che nelle ragazze, in genere, è rinunciatario e passivo, mentre nei ragazzi è impulsivo e arrogante: in entrambi i sessi, tendenzialmente amorale, cioè privo di quelle necessarie motivazioni di valore per l'agire quotidiano. (E poi ci meravigliamo se i Maso ammazzano i genitori per quattrini o se tre balordi criminali lanciano macigni sulle autostrade).
La scuola di oggi è un immenso apparato burocratico privo di un'attiva funzione sociale: in essa si realizza quella sorta di "badantato" dei docenti nei confronti degli studenti, ai quali non si chiede che di "star buoni", e dello Stato nei confronti degli stessi docenti, ai quali si chiede soltanto di non scioperare durante gli scrutini finali. E la coscienza, chiamiamola piccolo-borghese, insegna agli uni che è meglio far le cose per finta quando il risultato finale è lo stesso, agli altri che è meglio essere frustrati coi soldi in tasca che "liberi" a chiedere in piazza "pane e lavoro".
A dir il vero una "funzione sociale attiva" alla scuola non manca, solo che è al "negativo", ed è quella di garantire ai giovani un "parcheggio" il più possibile prolungato, a carico naturalmente delle famiglie e, parzialmente, dello Stato, il quale così può tenerli lontani dalle contraddizioni del mondo del lavoro, che, automatizzandosi sempre più, non è in grado di trovare un'occupazione decente al "prodotto" del suo stesso benessere.
Il paradosso infatti sta proprio in questo, che da un lato sono cresciuti i tassi demografici e la scolarizzazione primaria e secondaria in virtù dell'aumentato benessere, mentre dall'altro il mercato del lavoro è incapace di soddisfare le esigenze -da esso stesso alimentate- di un'utenza con un livello culturale più elevato (almeno così si dice).
Naturalmente il problema non sta solo nei computers e nei robot che automatizzano i processi economici, ma anche e soprattutto nel fatto che vi sono più investimenti finanziari che produttivi, più concentrazione e meno espansione, mentre la redistribuzione dei redditi penalizza enormemente i lavoratori, i quali sottostanno ai due ben noti principi del capitale: "socializzare le perdite, privatizzare i profitti" e "sacrificarsi per poter competere".
Insomma, è come se la società borghese avesse fatto una promessa che ora è impossibilitata a mantenere. Si ha l'impressione, in questo senso, che chi abbandona gli studi, abbia capito in anticipo che la "parola" di questa società non ha alcun valore. Chi invece li prosegue, avrà l'opportunità di illudersi anche fino a 30 anni (se all'università andrà fuori-corso), oppure avrà 30 anni di tempo per imparare a rassegnarsi. In fondo, un giovane "mantenuto" dalla famiglia, crea allo Stato meno problemi di quello che, uscito assai presto dalla scuola, cerca di sopravvivere con le proprie forze: non pochi giovani sono disposti anche a rubare, spacciare o uccidere.
Purtroppo le nostre istituzioni s'accorgono che questa gioventù -ivi inclusa quella che si droga, si ammala di AIDS o finisce in carcere o in casa di cura- rappresenta un costo altissimo per tutta la collettività, solo al momento di fare i conti finali.
Secondo: tornare a sperare
Oggi nella scuola l'individualismo dei docenti ha raggiunto punte tali che alcuni, per disperazione, cominciano a chiedersi se non ci sia la possibilità di fare dei lavori collegiali. La perdita d'identità, l'insignificanza del proprio lavoro sono diventati così macroscopici che, in quanti non vogliono rassegnarsi, sta emergendo l'esigenza di rompere i tradizionali modelli di gestione della propria competenza. Ci si sta accorgendo, in modo progressivo, che non è giusto dare per scontata l'esperienza della frustrazione o alienazione nell'ambito scolastico. In tal senso, il bisogno di andare aldilà del puro e semplice nesso tra "nozioni" e "profitto" si esplica nella necessità di comprendere la figura dello studente in quanto "giovane in formazione", caratterizzato da specifiche problematiche adolescenziali.
In altre parole: i docenti più sensibili o più consapevoli sembrano essersi stancati del loro rapporto individualistico e meramente nozionistico con i loro allievi, e sembrano orientarsi verso un affronto più collegiale e più globale dei problemi della classe, che non sono soltanto quelli relativi al profitto, all'aspetto cognitivo o informativo, ma che riguardano anche i problemi della formazione educativa, del disagio e delle varie forme di dipendenza culturale e ideologica di cui i giovani sono fatti oggetto (per non parlare dell'orientamento professionale, che è un altro "buco nero" dell'odierna scuola).
Naturalmente qui non si prende neanche in considerazione quella categoria "soddisfatta" di docenti che sfruttano la scuola in vari modi: dal minimo pensionistico al doppio lavoro, dai congedi straordinari per motivi di...vacanze sino alla strumentazione sofisticata ch'essi fanno acquistare dai collegi e che poi usano (anche di pomeriggio) per la loro attività professionale, per incrementare la quale si servono anche degli allievi pur di arrivare ai loro genitori; per non parlare di quegli "imboscati" che partecipano a decine di convegni e congressi sindacali, culturali e scientifici, senza muovere un dito per il loro istituto. Per queste e molte altre ragioni tali docenti non si lascerebbero mettere in crisi da alcunché, se non da un intervento "dall'alto" che li costringesse a scegliere tra la scuola e la libera professione, appagando così la volontà di lavorare dell'esercito dei precari.
* * *
I giovani vivono delle contraddizioni di cui si rendono scarsamente conto; più che altro le subiscono passivamente, non essendo capaci di offrire delle risposte un minimo adeguate. Al massimo cercano di sfruttare la situazione per un tornaconto personale. Per loro la massima aspirazione è quella di avere un lavoro pulito (dal punto di vista igienico), da impiegato, non troppo stressante, che conceda abbastanza tempo libero per divertirsi e per dire "Io c'ero", che permetta di comprarsi alcune cose firmate e di rinnovare l'auto ogni 3-4 anni... In questo stile di vita si ritrovano gli stessi docenti che, abituati così dalla società, hanno il compito di riprodurre il modello nell'ambito scolastico, dove le regole del gioco sono semplici e chiare: "Vivi e lascia vivere", "Non rompere", "Fai il minimo e avrai la promozione assicurata". Chi non fa neanche il minimo spesso rientra -soprattutto nelle medie inferiori- in quei casi patetici o disperati (come ad es. la morte improvvisa di uno dei genitori, oppure il loro divorzio) ai quali comunque a fine anno la promozione è assicurata. Ai professori soprattutto interessa, aldilà di ogni considerazione, di non perdere la cattedra: se per conservarla fosse necessario bocciare invece che promuovere, ciò non costituirebbe problema. Per formare o conservare le cattedre si fanno persino resuscitare gli studenti morti, oppure se ne chiedono alcuni, ad altre scuole, in prestito temporaneo, solo per farli figurare nelle iscrizioni d'inizio anno; senza parlare della cosiddetta "caccia all'handicappato", per ognuno dei quali, nelle scuole medie, il numero dei ragazzi di ogni classe può essere diminuito di cinque unità.
Solo adesso ci stiamo rendendo conto che se non recuperiamo il livello, la dinamica dei rapporti umani coi nostri ragazzi, ovvero l'immagine della globalità, dell'interezza del rapporto educativo, della vita scolastica -che non può riguardare unicamente delle nozioni da imparare e da ripetere-, non ci sarà mai alcuna possibilità di affrontare con decisione il problema della frustrazione e dell'alienazione.
Chi è esterno alla scuola fa molta fatica a rendersi conto di questo dramma: sia perché la scuola è completamente separata dalla vita e dal mondo del lavoro, sia perché si pensa che i docenti siano dei privilegiati (fanno relativamente poco, guadagnano abbastanza bene, ecc.). E in effetti è vero che la gran parte dei docenti non ha alcuna preoccupazione educativa, tanto che si può tranquillamente affermare che oggi chiunque abbia uno straccio di laurea è idoneo all'insegnamento. I concorsi abilitanti non sono che un'accentuazione dei limiti dell'impostazione nozionistica dell'università. Anzi, i corsi abilitanti hanno avuto la funzione di riproporre quel valore del nozionismo che l'università, a partire dal '68, aveva cominciato a perdere.
Tuttavia, i docenti che vogliono stare in team, per ritrovare la propria identità, sono ancora incapaci di organizzare creativamente un lavoro collegiale secondo finalità psico-pedagogiche e programmatiche. Molti, temendo di dover fare delle cose in più, si tirano subito indietro; altri riducono il problema del rapporto umano, educativo, con la classe, al problema di fare degli argomenti non tradizionali, non previsti dai programmi ministeriali; altri ancora sono convinti che il problema comunicativo si risolva in una maggiore disponibilità al dialogo da parte del docente, a prescindere dalle necessarie conoscenze e abilità relazionali.
"Essere disponibili", per alcuni docenti, significa attendere i suggerimenti, le proposte dei ragazzi e non (anche) farsi promotori di iniziative autonome, coordinate con altre iniziative. Quando vedono i ragazzi pretendere qualcosa di creativo, si trovano spaesati, non sapendo letteralmente cosa fare. D'altra parte nessuno ci ha insegnato ad insegnare, e chi crede di saperlo fare spesso non ha valori significativi da trasmettere. Non basta insomma che un insegnante sia "bravo", occorre anche un allenamento periodico al confronto sui metodi didattici, al fine di maturare una discreta consapevolezza dei limiti e dei progressi della propria attività didattica, e anche per poter continuare a fare nuove scelte sul progetto che insieme ad altri si sta portando avanti.
Oltre a ciò dobbiamo arrivare alla convinzione che è impossibile superare la frustrazione nella scuola se non si modificano i criteri politici, amministrativi, burocratici e gestionali che tradizionalmente la tengono in piedi e la riproducono all'infinito. La frustrazione non dipende soltanto dalla "cattiva volontà" di quei docenti che non vogliono lasciarsi coinvolgere con le problematiche giovanili, non dipende solo da motivazioni soggettive che partono dalla rassegnazione o dalla sfiducia (cui a volte si cerca di reagire, da parte però di pochissimi, con l'autoritarismo fine a se stesso); dipende anche da motivazioni terribilmente "oggettive" e strutturali, indipendenti dalla volontà dei soggetti.
La scuola è funzionale alle esigenze della società, o per lo meno è funzionale alle esigenze di uno Stato e di un sistema politico-istituzionale che vuole conservare un determinato modello di società: è sempre stato così e lo è in qualunque regime sociale. Se la società è marcia e corrotta, la scuola non può pretendere di vivere in armonia con se stessa. Essa non è mai in grado di offrire soluzioni alla società, soprattutto se la crisi di cui la società soffre è di tipo strutturale e non congiunturale. Al massimo la scuola può tentare di elaborare delle riflessioni critiche nei confronti dei modelli culturali di questa società, delle riflessioni però che, qualora venissero applicate, dovrebbero comportare il superamento sia della società che della stessa scuola.
Questo problema, che riguarda la prospettiva finale, va tenuto in considerazione, poiché se oggi il docente è frustrato in quanto non riesce ad avere un rapporto umano né coi ragazzi né coi suoi colleghi, domani lo sarà ancora di più se pur avvertendo l'esigenza di questo rapporto, se pur riuscendo almeno ad impostarlo, non potrà poi perfezionarlo, approfondirlo, semplicemente perché le strutture, in modo oggettivo, reale, glielo impediscono. E' comunque inevitabile che la frustrazione tenda ad aumentare in quei docenti che avvertono il bisogno di superarla, facendo anche dei tentativi concreti: sbattere la testa contro un muro di gomma non è un fattore stimolante.
Dunque questo problema, che è eminentemente politico, non può essere risolto -come fanno alcuni- limitando gli obiettivi strategici: ad es. "fare di meno ma bene per essere meno frustrati". Ciò forse può avere un senso nel breve periodo, ma non ne ha alcuno in prospettiva. Noi dobbiamo portare la consapevolezza del disagio ai livelli massimi possibili, avendo chiaro cosa si deve fare per superare la frustrazione. L'esigenza di una soluzione radicale deve farsi strada, altrimenti si correrà il rischio, anche contro la propria volontà, di fare il gioco del sistema. Questa società, infatti, può anche essere interessata a che si realizzi un diverso rapporto fra docenti e studenti, affinché la vecchia scuola si trasformi in una nuova scuola per un sistema borghese più efficiente e razionalizzato. Probabilmente anche nella scuola, fra non molto, passerà la logica della "qualità totale" che si viene affermando nelle fabbriche. Il che vorrà dire: autonomia gestionale, ricerca di finanziamenti locali o regionali, meritocrazia e produttività, stretto funzionalismo alle esigenze del mondo economico... È questo che il sistema vuole dalla scuola per riprodursi? Dobbiamo accettarlo d'ufficio o possiamo discuterne?
Terzo: educare gli educatori
L'insegnante delle medie e delle superiori sta cominciando soltanto adesso a porsi il problema di "chi" ci sia aldilà dello studente che ogni giorno vede davanti a sé. Di qui l'esigenza di studiare la psicologia dell'età evolutiva, le diverse fasi della maturazione adolescenziale. Sempre più ci si sta accorgendo che il giovane è un soggetto in formazione, con ritmi di crescita particolari, con stati di ansia, depressione, stress, disagio (a volte non molto diversi da quelli dei docenti) che vanno assolutamente individuati e capiti. Questo non è un lavoro facoltativo o aggiuntivo, ma una delle condizioni per agevolare enormemente il rapporto educativo e didattico.
L'insegnante deve essere un educatore o un formatore, non solo un trasmettitore di nozioni, poiché se fosse solo questo il suo destino sarebbe già segnato: molti altri mezzi mediali lo superano di gran lunga. La preoccupazione educativa ch'egli deve avere (la quale, in un certo senso, dovrebbe tener conto anche delle dinamiche di gruppo vissute dai ragazzi in ambienti extra-scolastici, poiché la scuola deve interagire con tutto il contesto sociale locale) non dipende solo dalla crisi della scuola, che aumenta irreversibilmente l'alienazione dei suoi protagonisti; dipende anche dal fatto che nella più generale evoluzione del mondo occidentale (che poi riguarda anche, se non di più, i paesi centrorientali dell'Europa), i problemi umani si stanno imponendo con sempre maggior forza all'attenzione degli operatori sociali e delle agenzie educative. Sempre più cioè ci si chiede se esista la possibilità di affrontare, in maniera globale o integrata, i nostri problemi quotidiani, di ordine non solo tecnico-organizzativo, pratico-esperienziale ma anche e soprattutto etico-normativo, assiologico (problemi sempre più complessi e di difficile soluzione, soprattutto se affrontati con individualismo e settorialità).
Anche il capitalismo, con il suo principio della "qualità totale", ha bisogno di un affronto dei problemi che sia al tempo stesso più "globale" e più "personalizzato", più programmato e più diretto. Tuttavia gli strumenti che usa sono vecchi, solo l'esigenza è nuova. Nell'ambito del capitalismo, infatti, la qualità non può mai essere "totale", poiché, se così fosse, la logica del profitto per il capitale verrebbe smentita. Al singolo imprenditore la qualità è necessaria per vincere la concorrenza, ma la "qualità totale" impedirebbe al consumatore di riciclare con rapidità le merci acquistate.
Nella scuola è la stessa cosa: si avverte la necessità di raccordare il tutto alle singole parti, di unire la teoria alla prassi, ma la struttura -così com'è- tende a vanificare ogni tentativo. Bisognerebbe convincere gli insegnanti che, pur non avendo valori comuni, sul piano etico, politico o ideologico, possono, se vogliono, lavorare insieme, costringendo le istituzioni e la stessa scuola a tener conto di questa loro esigenza di "collegialità", esprimibile ad ogni livello.
* * *
Come primo "compito" per i nuovi educatori si potrebbe proporre il seguente: cercare di capire come mai i ragazzi -a parità d'età- hanno generalmente un comportamento più superficiale di quello delle ragazze, ovvero per quale ragione esistono tra i maschi molti più drogati, teppisti, criminali, alcolisti, barboni, sessualmente deviati, ecc.
A tale scopo si potrebbe chiedere di verificare la seguente ipotesi interpretativa: questa società offre al maschio (a livello d'immagine sociale, di opportunità di lavoro, di carriera, di alti stipendi ecc.) molto di più che alla femmina; sicché, chi non riesce a conseguire gli obiettivi prefissi dalla società borghese, si sente più complessato; di qui l'esigenza di evasione, di rivalsa, di rifiuto del sistema (nelle forme estreme che tutti conosciamo). E' durante la competizione per conseguire un determinato posto direttivo, che il ragazzo si accorge che le promesse del sistema sono solo delle illusioni, cioè una realtà per pochi privilegiati.
Le ragazze vengono alienate in altro modo: ad esse la società non promette le stesse cose che promette ai ragazzi. Sin da bambine vengono educate al lavoro domestico, alla riservatezza, a rispettare la volontà dei maschi... Chi non si adegua viene presto considerata un "maschiaccio" o una "ragazza facile". La loro frustrazione inizia subito nella vita privata familiare, e durante questo periodo di tempo il loro comportamento è più docile, più educato, più responsabile ed impegnato, anche perché frustrato dalla presenza invadente e prepotente del maschio. Nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, questo è molto visibile.
Ai maschi, nel complesso (le eccezioni non mancano mai), viene concessa subito la libertà, per cui, non avendo essi una corrispondente responsabilità per gestirla, sono quasi costretti a comportarsi in modo rozzo, istintivo, privo di contenuti. È la società stessa che li produce così, anche se poi se ne lamenta.
Il problema maggiore per i ragazzi si verifica quando devono abituarsi, in poco tempo, col servizio militare, a una disciplina assai esigente, e soprattutto quando si scontrano col mondo degli adulti, al momento di trovare un lavoro. L'impatto è traumatico: non essendo abituati alle frustrazioni, si demoralizzano subito di fronte alle prime difficoltà. Anche qui le eccezioni, naturalmente, non mancano, ma si tratta appunto di eccezioni.
Di fronte alle difficoltà d'inserimento socio-professionale, le ragazze si scoraggiano meno facilmente, anche se, è naturale, non si può pretendere una capacità di sopportazione illimitata. Per loro comunque le difficoltà da affrontare sono di molto superiori: si pensi, p.es., a quelle attinenti alla discriminazione dei sessi, in forza della quale esse rischiano continuamente di vivere un'esistenza marginale o comunque di second'ordine.
Ciò è davvero paradossale, poiché le ragazze, essendo abituate da tempo a sopportare le frustrazioni, potrebbero sicuramente -a parità di titolo di studio e se valorizzate adeguatamente- svolgere mansioni dirigenziali in modo molto più proficuo rispetto ai ragazzi. Gli ostacoli maggiori che le ragazze-managers incontrano non sono tanto quelli inerenti alla loro specifica professione, quanto piuttosto quelli riguardanti i loro rapporti con un mondo del lavoro gestito prevalentemente, a livello dirigenziale, dal sesso maschile.
Quarto: riformare il linguaggio
Certe espressioni linguistiche oggi non si capiscono più, semplicemente perché non esiste più il sostrato esperienziale cui quelle espressioni fanno riferimento.
A scuola i ragazzi ti ascoltano perplessi, guardandosi a vicenda, pensando che tu non sappia che loro non ti comprendono. Si stancano presto d'ascoltarti: si annoiano perché non sono abituati alla fatica di comprendere un linguaggio diverso dal loro.
Cosa fare? Costringerli a comprendere il nostro linguaggio o piegarsi alle loro capacità di comprensione? La costrizione li obbliga a ripetere meccanicamente le nostre nozioni astratte, senza però indurli alla comprensione del significato delle parole e delle espressioni. Questo perché, il nostro e il loro parlare, riferendo cose di cui a scuola e persino in società non si riesce più a fare esperienza, è come se fosse stereotipato, impersonale, terribilmente grigio. Quello che gli insegnanti vorrebbero che i ragazzi imparassero a fare sono almeno i "riassunti", ma anche in questo campo s'incontrano ostacoli insormontabili. Non sapendo come reagire a una società per la quale tutto è "essenziale", persino le cose più futili e banali, il ragazzo (e con lui spesso il docente) non ha il senso delle priorità, dell'obiettività delle cose, per cui può anche accadere che un piccolo brano di 20 righe rischi di assumere, al momento della sintesi, 20 significati diversi. Qui hanno buon gioco gli insegnanti delle discipline scientifiche, i quali si limitano a esempi così elementari che la soluzione univoca impedisce qualunque congettura. Bel modo però di sviluppare il loro Quoziente Intellettivo!
D'altra parte se ci pieghiamo alle capacità di analisi e di comprensione dei nostri ragazzi, il linguaggio s'impoverisce terribilmente, anche perché poverissima è l'esperienza che fa da sostrato al loro linguaggio (in questo senso i docenti più "realizzati" sono quelli che vivono un'esperienza non meno "povera"). L'esperienza che oggi i ragazzi vivono non ha quasi nulla di culturale: quando non sono completamente manipolati dai mass-media è perché ancora difendono, pur senza saperlo, gli ultimi valori pre-borghesi delle loro famiglie e/o dei loro ambienti d'origine.
Generalmente i loro punti di riferimento privilegiati, i loro interessi e le loro attività più consuete riguardano le discoteche, i centri sportivi, il bar, la parrocchia, il cinema e la televisione, la moda, la musica leggera, i motori e le automobili, la sessualità il più possibile anticipata, ecc. Come si può notare non c'è attività culturale né, tanto meno, politica, se non in pochissimi casi. Non sono ragazzi che "pensano", che producono "riflessioni culturali" sulla loro esperienza, sulle contraddizioni che vivono. A volte si lamentano per inezie che giudicano d'importanza vitale. Ciò che domina nei loro atteggiamenti è lo spontaneismo più istintivo, la rassegnazione di chi non sa cosa fare per cambiare le cose e, di conseguenza, il conformismo, unito all'opportunismo con cui si spera di ottenere dalla scuola il massimo possibile dando il minimo.
Per queste e altre ragioni bisognerebbe puntare, in futuro, sulla necessità di trasformare l'esperienza sociale dell'intero contesto urbano, cioè sulla necessità di vivere un'esperienza comune coi ragazzi, invitandoli a riflettere su ogni valore vissuto. Se non ci immedesimiamo nella vita dei giovani, portandoli a fare scelte di livello superiore, non si realizzerà mai alcun rapporto educativo. Bisogna insomma indurli a coinvolgersi come persone, e a confrontare le loro idee con quelle degli adulti, su di un piano di reciproca responsabilità, altrimenti il rispetto cui a scuola sono tenuti, resterà del tutto formale, relativo alla parte da sostenere nel gioco dei ruoli.
Oggi viviamo in un'epoca scarsissima di gesti significativi, mentre la cultura che offre la società, coi suoi media, è più che altro fondata su valori subumani e asociali, come il consumismo (che fa comodo agli imprenditori e ai commercianti), l'individualismo (che fa comodo a chi vuol far credere che questa società offre pari opportunità a tutti e che la mancata autorealizzazione dipende esclusivamente da una personale incapacità), il protagonismo (del leader, del maschio, di chi "conta", di chi "può"), l'istintività (fare le cose più facili, più immediate), l'emotività (commuoversi per i casi pietosi, salvo poi limitarsi a questo o alla mera assistenza) e il sensazionalismo (provare emozioni forti nel compiere o nel veder compiere azioni spericolate, impossibili, salvo poi sentirsi terribilmente svuotati).
La pseudo-cultura della nostra società viene trasmessa soprattutto per immagini. Come noto, l'immagine è la forma meno riflessiva della cultura, quella più istantanea, i cui significati sembrano così evidenti da risultare indiscutibili. In realtà l'immagine non è mai di facile interpretazione, proprio perché di natura sfuggente, ambigua, equivoca: è assurdo dire che le immagini parlano da sole. L'istituzione che vuol farci credere in questo, generalmente si serve delle immagini per scopi tutt'altro che democratici.
Bisogna dunque creare una nuova esperienza che, nella sua semplicità ma reale diversità dalle logiche dominanti, sappia riflettere su di sé e sui meccanismi perversi di questa società. Solo così si può creare una nuova cultura e un linguaggio comune a tutti. Bisogna però partire da questo presupposto: la povertà culturale dei nostri ragazzi è il frutto più maturo della povertà esperienziale degli adulti. Chi critica il mondo giovanile senza compiere un'analisi autocritica del proprio mondo, cerca soltanto degli alibi per giustificarsi. Non dobbiamo arrivare al punto che, vedendo i giovani così "diversi", i professori si sentano costretti a dare per scontata l'incomunicabilità.
Ma dobbiamo accettare anche un altro presupposto, quello per cui nessun linguaggio può pretendere d'imporsi su altri linguaggi che riflettono esperienze diverse. La regola d'oro dovrebbe essere questa: un linguaggio ha il diritto d'affermarsi se esprime un'esperienza reale, significativa, che gli corrisponda effettivamente. Detto questo però, è impossibile sostenere il principio che tutti i linguaggi astratti, astrusi, fumosi, cervellotici andrebbero aboliti. Il linguaggio migliore dovrà vincere in una competizione democratica, il cui traguardo finale non può certo essere stabilito a priori. In attesa di arrivarci noi possiamo soltanto costatare che se la povertà culturale dei nostri ragazzi permane, nonostante tutti i nostri sforzi, significa che nessuna esperienza di valore è riuscita a farsi strada nelle loro coscienze. In fondo la loro ostinata chiusura al nostro linguaggio può anche essere una forma di resistenza passiva, una sorta di sfida alla credibilità di quelle esperienze che presumono d'avere una certa importanza.
Quinto: rivalutare i diplomi
I ragazzi di oggi ritengono che la scuola non possa offrire altro che il diploma, cioè il famigerato "pezzo di carta". Escludono categoricamente di ricevere una formazione culturale generale (vedi gli istituti tecnico-professionali), o una preparazione specifica alla professione (vedi i licei classici e scientifici). Anche le magistrali (questa brutta "fotocopia" dello scientifico) non sono meno "squilibrate" degli altri istituti: si fa il latino che non serve, si studia la pedagogia come un aspetto della filosofia (in questo senso è più pedagogico l'istituto professionale femminile, se non fosse così scarso nella "cultura generale"), si fa un tirocinio presso le scuole elementari del tutto fittizio, e soprattutto si fornisce una preparazione assolutamente inadeguata ad affrontare i concorsi abilitanti, dove gli esaminatori danno sfoggio della loro elevata pedagogia teorica. In Italia, a causa della enorme arretratezza del sistema scolastico, la pedagogia è solo un mero oggetto di studio astratto, al pari della filosofia o dell'epistemologia. Le stesse magistrali introducono in un settore scolastico -quello delle elementari- in cui la figura del direttore didattico è ancora vista come un deus ex machina e dove solo di recente si è cercato di sostituire la figura unica dell'insegnante con i cosiddetti "moduli".
Il ragionamento di molti ragazzi delle superiori si riassume nei termini seguenti: "Se la scuola non dà niente, io non do niente. Siccome il coltello dalla parte del manico l'hanno sempre i professori, cercherò di fare il minimo per non restare fregato".
Il diploma, per loro, non è la chiave per aprire tutte le porte del lavoro, ma solo un'occasione in più: essi sanno benissimo che senza raccomandazioni non si fa molta strada.
Conclusione? La scuola sforna diplomati opportunisti e ignoranti, i quali, essendo stati promossi senza i necessari requisiti, chiedono di restare ignoranti ma non senza soldi. Con il loro bel diploma svalutato si consolano pensando che nella vita, se si usa intelligenza, astuzia e cinismo, si può anche superare l'handicap dell'ignoranza e fare la carriera privata che si desidera.
I docenti sanno benissimo queste cose, ma o sono i primi a insegnarle, o si lamentano senza reagire in modo costruttivo, o si adeguano malvolentieri finendo col fare, anche loro, il minimo possibile.
Sesto: nessuna costrizione in bianco
Oggi si sente dire, in campo pedagogico, che il permissivismo va sostituito con la costrizione, in quanto i giovani tendono a illudersi che nel mondo del lavoro tutto sia così facile come nel mondo della scuola e della famiglia. Il ragionamento è il seguente: "Perché mai i giovani si drogano, sono violenti, rifiutano questa società ricorrendo persino al suicidio? Perché sono stati abituati troppo bene, soprattutto sul piano materiale. Ora si deve fare marcia indietro, facendo capir loro il senso dei sacrifici e delle privazioni, del risparmio e della moderazione. Questo perché devono imparare ad accettare le frustrazioni e i disagi della società".
Bene, se le cose fossero così semplici, non dovrebbe costare molta fatica sostituire il permissivismo colla costrizione. È bene tuttavia ricordare che il permissivismo non è nato a caso: esso ha potuto sostituire la costrizione degli anni '50 e '60 perché i valori sociali di quel periodo erano incompatibili con le esigenze di libertà e autonomia delle nuove generazioni. La costrizione è durata fino al punto in cui è scoppiato il dualismo fra quei valori autoritari e individualisti, da un lato, e le esigenze democratiche ed egualitarie dei giovani, dall'altro.
È vero che il '68 ha proposto molto "permissivismo", ma è anche vero che il '68 è fallito. È forse possibile riproporre la costrizione quando gli ideali accettati da una fetta rilevante della popolazione italiana non si sono realizzati? Negli anni '50 e '60 si credeva nell'autoritarismo per tradizione e si era convinti che il modello del consumismo, di cui non si aveva ancora una particolare consapevolezza, prima o poi ci avrebbe portato la felicità in casa. Il '68 (che è durato almeno un decennio) ha distrutto l'autoritarismo, coi suoi valori classisti e borghesi, e ha contestato il consumismo, ma non avendo superato i meccanismi economici che sono alla fonte di quest'ultimo, alla fine, pur senza volerlo, non ha fatto che allargarne il raggio d'azione. Cioè se ieri avevamo un autoritarismo classista che permetteva il consumismo solo ad alcune categorie sociali, oggi abbiamo a che fare con una società così abituata alla "vita facile" (salvo le debite eccezioni) che soltanto in maniera traumatica sarebbe disposta ad accettare forme autoritarie di gestione del potere, unitamente a forme di austerità sul piano dei consumi individuali. Ecco perché non si può tornare indietro fingendo che nulla sia accaduto e che nessuna critica al sistema sia stata fatta?
Gli adulti di oggi erano giovani nel '68: se ad essi si chiedesse di usare la costrizione, per quali valori penserebbero di doverla applicare? Per gli stessi degli anni '50? Se si accetteranno in toto questi valori, ciò potrà forse avvenire in maniera naturale? anche in coloro che nel '68 erano politicamente impegnati?
Ci fu una sorta di spontaneità in quella generazione che, uscita dall'ultima guerra mondiale, pensò di costruire su valori borghesi di massa una nuova società. Ma oggi ci può essere solo odio e risentimento: all'autoritarismo saranno disponibili proprio coloro che, dopo aver visto fallire gli ideali del '68, penseranno che sia meglio accettare definitivamente quelli della borghesia. L'odio sarà appunto nei confronti di chi cercherà di smascherare questo loro tradimento o nei confronti di chi riproporrà, in forme e modi diversi, le stesse esigenze emancipative e democratiche degli anni '70.
Il problema quindi non è quello di sostituire il permissivismo con la costrizione, ma quello di lottare ancora per una società diversa, non borghese. Se dobbiamo riaffermare la costrizione per riconfermare pienamente i valori della società borghese, allora è meglio chiarirsi prima. Costrizione sì, ma non senza "possibilità di un'alternativa", cioè opportunità di creare una diversa organizzazione sociale, più democratica, più partecipata e più autogestita. Sì dunque alla costrizione, ma a condizione che sia per tutti. E' giunto cioè il momento di realizzare una giustizia popolare che parta dal basso verso l'alto. Dobbiamo sostenere la possibilità di un controllo sia sulle autorità pubbliche che sugli strati sociali più abbienti.
Bisogna precisare bene questi obiettivi, anche perché l'odierno permissivismo è un prodotto non del '68 ma del suo fallimento. Nel senso cioè che la società borghese se ne è servita per dimostrare che gli ideali del '68 non potevano essere realizzati in alcun modo. Alla borghesia non interessa, di per sé, né il permissivismo né la costrizione, ma unicamente il suo potere economico e politico. Essa infatti, in virtù di questo potere, è stata capace di usare il permissivismo, nel corso degli anni '80, per allargare la fascia dei consumatori, abbassandone incredibilmente l'età. Oggi la costrizione dovrebbe servire alla borghesia non tanto per aumentare il proprio potere, ma per conservare agevolmente quello di cui già dispone. La paura infatti è quella che i nodi delle sue contraddizioni, presenti a livello mondiale, giungano improvvisamente al pettine.
* * *
Da tempo la psicologia ha messo al bando, nel rapporto educativo adulti/giovani, l'uso delle minacce, della coercizione, dei castighi corporali, puntando tutto sulla persuasione ragionata e sulla logica. In realtà, l'uso della logica sarebbe la soluzione migliore se il giovane fosse in grado di capirla adeguatamente. Ma questo implica il contributo dell'intera società, che dovrebbe credere in una medesima cultura.
Una volta si reprimeva duramente la gioventù per impedirne l'allontanamento dalla mentalità dominante, cioè da quei valori in cui gli adulti, fino al '68, hanno ciecamente creduto. Le punizioni venivano date per garantirsi una sorta di conformismo sociale.
Oggi le punizioni fisiche sono state abolite anche perché in quella ideologia la società, nel suo complesso, ha smesso di credere. Tuttavia, la nuova cultura non appare così forte da indurre il giovane a maturare in fretta, responsabilmente, in modo da non aver bisogno d'essere oggetto di alcuna coercizione. Oggi, molti giovani appaiono calmi e tranquilli semplicemente perché hanno la possibilità, grazie ai loro genitori, di poter spendere quanto basta per appagare, più o meno, i loro desideri. Ma che succederebbe se questi ragazzi consumistici si trovassero improvvisamente senza le solite disponibilità finanziarie?
In ogni caso oggi si assiste a un fenomeno curioso, paradossale, anche se appena in fieri. Il permissivismo degli adulti (che non usano alcuna coercizione educativa e che non credono in alcuna vera alternativa) sta portando i giovani ad accettare l'idea di introdurre l'uso delle punizioni (anche severe) a carico di chi nella società "sbaglia" (vedi ad es. la cosiddetta "legge del taglione"). Il fenomeno è ancora embrionale semplicemente perché il giovane tende a sentirsi soprattutto una "vittima" della società, per cui teme di dover essere costretto a sopportare gli stessi provvedimenti coercitivi invocati.
Il clima intrafamiliare di affetto, serenità, protezione, sicurezza, ecc. appare al giovane troppo debole nei confronti delle frustrazioni sociali. Egli si rende perfettamente conto che sia la famiglia che la scuola non offrono gli strumenti indispensabili per fronteggiare le esigenze e i pericoli della moderna società. Prima ancora di fare il suo ingresso come lavoratore nella "giungla d'asfalto", il giovane ne teme la dura selezione, l'abuso impunito, l'egoismo sfrenato e, quando finalmente vi entra, avverte subito la scuola e soprattutto la famiglia come dei paradisi da dimenticare.
Anzi, guardandosi indietro, matura convinzioni ancora più critiche nei riguardi di questi due istituti sociali, che non lo hanno certo aiutato ad abituarsi all'idea di dover vivere in un "inferno". Scuola e famiglia infatti attenuano il più possibile la forza dell'impatto, anche rinviandone il momento.
Alcuni sociologi dicono che la scelta della droga parte da questa "iperprotezione inconsapevole". Tuttavia, scuola e società sanno benissimo che la mancanza di protezione e sicurezza emotiva può rischiare di fare cadere il giovane nel dramma prima ancora che diventi adulto. Ecco perché nella scuola si cerca di non bocciare "troppo", ecco perché in famiglia si cerca di essere poco severi. La speranza, oggi però del tutto vana, è quella di vedere il giovane affrontare con ottimismo i problemi sociali, forte dell'"ovattamento" di cui è stato oggetto nel periodo adolescenziale.
La richiesta di punizioni da parte dei giovani (ad es. la pena di morte per certi criminali o la recente guerra contro l'Irak) deve essere vista come un bisogno di coerenza o di giustizia, cioè come un modo per affrontare con successo il momento dell'impatto col mondo lavorativo. Qui sta la loro ingenuità. Essi non si rendono conto che i primi a dover subire le conseguenze di questa loro presunta "coerenza" sarebbero le persone meno coinvolte nella grande criminalità. All'interno di un sistema anti-democratico, una qualunque legge repressiva che non metta in discussione le fonti del malessere sociale, non fa che aumentare l'oppressione (si veda ad es. quella sulla droga).
Cosa fare dunque, vedendo il giovane che rifiuta la coerenza della famiglia perché considerata in contraddizione con l'incoerenza della società? La soluzione migliore sta nel dimostrare al giovane che anche nella società, poste certe condizioni, è possibile una maggiore giustizia, cioè nel fargli capire, attraverso la logica, i motivi di fondo per cui nella società è così difficile essere capaci di giustizia.
Settimo: orientare al lavoro
La scuola non fa niente per orientare il giovane nella scelta della futura professione. Non avendo quasi alcun rapporto col mondo del lavoro, essa non può sapere quali sono le esigenze della società. Oggi la scuola italiana viene concepita come mero serbatoio per contenere la disoccupazione e le tensioni sociali. E' una sorta di centro assistenziale, come l'INPS per i disoccupati del Sud. Di fatto la scuola statale offre solo una "subcultura generale", utile per mansioni poco qualificate. Forse le scuole che si distinguono un po', in tal senso, sono quelle regionali che garantiscono una formazione professionale.
Ma anche per scegliere la giusta scuola professionale, quali strumenti ha il giovane? Nessuno. Egli infatti proviene da una scuola statale (la media inferiore) che è totalmente incapace di orientarlo (al massimo gli fornisce degli opuscoli illustrativi, che poi è quanto si fa nelle superiori per le classi terminali, le quali vengono altresì invitate a conferenze in cui i relatori, mantenendosi sulle generali, spiegano quali facoltà universitarie "tirano di più").
Per "orientamento professionale" si dovrebbe intendere, in realtà, qualcosa di molto complesso ed elaborato: ad es. valutare le inclinazioni, le attitudini, le "vocazioni" dei giovani utilizzando strumenti e test psico-pedagogici, sociologici e di altro tipo. L'insegnante dovrebbe avvalersi anche del contributo di specialisti esterni all'ambito scolastico. E dovrebbero esistere degli "osservatori" del mercato del lavoro a livello provinciale e regionale. In tal modo si risparmierebbe del tempo prezioso, poiché un giovane soddisfatto del proprio lavoro non si preoccupa di cambiarlo o almeno lo farebbe con minor frequenza. Per non considerare il fatto che una professione sgradita comporta sempre maggiori infortuni, frustrazioni, malattie, assenteismi, ecc.
Certo è che la scuola non può preoccuparsi di queste cose se poi la società non garantisce al giovane un effettivo inserimento sociale. Nessuno vuole essere preso in giro. Ma se la società è indifferente alla gioventù, poi dovrà spendere il doppio, il triplo per affrontare tutti i casi della devianza giovanile (delinquenza, violenza negli stadi, tossicodipendenza, AIDS, ecc.).
Ottavo: dubitare fa bene
I grandi dubbi che hanno gli adolescenti sui perché della vita, non sono soltanto un fenomeno naturale, fisiologico per quell'età, ma -messi in relazione alle false certezze e al conformismo degli adulti- sono anche un fenomeno decisamente positivo, che solo un adulto chiuso, superficiale, schematico può considerare negativo.
Avere dei dubbi significa essere alla ricerca di qualcosa. Magari i giovani ne avessero di più! Eviterebbero così d'imitare troppo presto quegli atteggiamenti degli adulti basati su certezze prevalentemente al negativo: quelle certezze che bloccano ogni azione propositiva, costruttiva. I giovani di oggi acquisiscono con una facilità incredibile i modelli degli adulti, senza metterli un minimo in discussione. Quando lo fanno è solo perché ambiscono a sentirsi "grandi" prima del tempo.
Le contraddizioni, senza dubbio, spaventano l'adolescente, perché lo mettono in crisi, ma se la società in cui vive offrisse anche delle alternative, egli si sentirebbe più ottimista, conformemente alla sua vera natura. Smetterebbe cioè di credere, già all'età di 14 anni, che la legge del più forte o del più astuto è quella che deve prevalere.
Nell'adulto meno consapevole, incapace di scorgere le cause ultime del malessere sociale, la speranza è sparita da tempo. Gli adulti infatti si ritengono tali proprio perché pensano che le contraddizioni siano irrisolvibili. E' questa la certezza che hanno e con cui affrontano, dopo un breve tirocinio, i problemi della scuola.
L'ipocrisia degli adulti (quella che serve per giustificare il proprio qualunquismo) la si nota anche quando i giovani impegnati in certi gruppi socio-ricreativi e/o culturali vengono accusati d'essere dei "conformisti". Un giudizio del genere -direbbe uno psicologo- parte da un sentimento d'invidia che l'adulto (isolato) prova nei confronti di questo tipo di giovane.
Di fatto gli adulti non vivono più esperienze di gruppo significative, gratificanti: dove non c'è un obiettivo ideale per cui lottare, con chiarezza e decisione, persino le esperienze politiche o sindacali risultano incredibilmente frustranti.
Il mondo del lavoro, la società, il sistema divide gli adulti in tanti individui isolati, come singoli o come gruppi più o meno grandi. In questa situazione essi ritengono d'essere più "liberi" dei giovani, più disincantati, meno disposti ad essere raggirati. L'adulto si vanta di non avere illusioni, né speranze, né desideri, né utopie da realizzare. Si vanta cioè di non aver più bisogno di partecipare a un gruppo che lotti per una transizione. In realtà è l'essere più integrato del sistema borghese.
Nono: smetterla coi vizi
I giovani di oggi sono stati abituati ad avere tutto e subito o a pretendere questo come un diritto. Ecco perché non vedono le contraddizioni fondamentali della società capitalistica. Per loro ogni cosa è o dovrebbe essere relativamente facile: per quale motivo dovrebbero desiderare un'alternativa? Se appoggiano le Leghe non è per cambiare il sistema, ma per impedire che il sistema intacchi il loro benessere e questa logica di affermazione sociale.
Solo quando si scontrano con le assurde regole del mondo del lavoro, senza avere le necessarie "spinte e raccomandazioni" per affermarsi socialmente, soltanto allora nascono i primi dubbi, le prime delusioni. La scuola, la famiglia, i mass-media: tutto, fino a quel momento, li aveva abituati a pensare diversamente.
L'impatto col mondo produttivo -che è spietato, duro, selettivo- li costringe ad accorgersi che il diritto d'essere valorizzati per le proprie capacità intellettuali con buoni stipendi o gratifiche, non viene riconosciuto dalla società. In particolare, i giovani non riescono ad accettare l'idea di dover fare un lavoro al disotto di quello che promette il loro titolo di studio. Non essendo abituati ad alcun vero sacrificio, non concepiscono espressioni come "duro tirocinio", "umile apprendistato" (anche in lavori manuali o sottopagati). Meno che mai riescono ad accettare l'eventualità d'essere licenziati alla scadenza del contratto di formazione-lavoro.
I giovani di oggi sono stati "viziati" da una società che non ha voluto spiegare loro l'origine della ricchezza dei loro genitori, i meccanismi perversi mediante cui essa si realizza... Anzi, si è cercato d'indurre nelle loro coscienze bisogni superflui ed esigenze consumistiche, abituandoli a vivere al disopra delle loro capacità produttive, a totale carico dei propri genitori.
Perché dunque i giovani odiano la scuola al punto d'abbandonarla il più presto possibile, e proprio mentre la società diventa più alfabetizzata e più informatizzata? La risposta è semplice: perché preferiscono trovare un lavoro subito, avere dei soldi in tasca e vivere una vita da adulti. E' la società borghese che li vuole così. Soprattutto quella società delle automobili, della moda, dei divertimenti. Se i giovani sono come gli adulti, comprono e spendono come gli adulti.
I giovani -soprattutto i maschi- vogliono avere le libertà dei maggiorenni con una responsabilità da minorenni. Vogliono avere i soldi degli adulti per condurre una vita da adolescenti. Preferiscono trovare un lavoro senza scuola che andare a scuola senza prospettive di lavoro. Preferiscono godersi la vita il più presto possibile che fare dei sacrifici senza garanzie.
Decimo: ricominciare da capo
I giovani di oggi sono stanchi delle contraddizioni che vedono, sono esasperati. Dal '68 al '77 la gioventù è stata molto diversa: lottava per cambiare le cose, anche se si illudeva che fosse sufficiente mettere a nudo le contraddizioni per poterle risolvere. Era una forma di idealismo, con delle punte estremistiche (quelle che poi sfociarono nel terrorismo degli ultimi anni '70), ma seppe suscitare un grande entusiasmo: un'intera generazione si era sentita coinvolta in prima persona, impegnandosi a tutto campo.
Oggi invece i giovani si lamentano "standosene fuori", ricorrendo a varie forme di "droga": eroina, violenza, musica, moda..., oppure reagiscono con l'indifferenza. Spesso sono cinici, crudeli, non giustificano chi sbaglia, rifiutano le attenuanti, invocano la pena di morte per i casi più gravi. Provano una specie di sadismo intellettuale quando vedono qualcuno che paga per i suoi errori, quando c'è un capro espiatorio su cui scaricare le proprie frustrazioni. In questo imitano sicuramente la cultura degli adulti.
I giovani che frequentano le scuole cercano di non esporsi troppo al giudizio altrui sui loro comportamenti quotidiani, sui loro criteri interpretativi della realtà: fanno finta di ascoltarti, ti rispondono con delle battute, oppure ripetono le solite frasi fatte (le più insulse sono quelle che hanno un colore politico). Nel migliore dei casi concludono dicendo: "Cosa dobbiamo fare? Tanto non serve a niente! Ci vorrebbe un duce o un colpo di stato!".
Insomma vogliono tutto e subito, proprio come nel '68: la differenza è che oggi non fanno niente per averlo. Pretendono senza mettersi in discussione. Non si preoccupano nemmeno di conoscere i meccanismi sociali e culturali che regolano questa società. S'illudono d'essere immuni da qualunque condizionamento. Spesso infatti affermano: "Se ho voglia di farlo, lo faccio; se ho voglia di dirlo, lo dico...". Il loro individualismo è la caratteristica più negativa.
Sono istintivi nel metodo, superficiali nelle valutazioni, diffidenti nei confronti di chi chiede loro d'impegnarsi senza offrire subito qualcosa in cambio. Sono così abituati a ragionare con la logica del profitto, che un impegno politico o culturale o sociale sarebbero disposti ad accettarlo solo a condizione di ottenere una contropartita ben visibile e a breve termine. Sembrano smaliziati, ma non hanno alcuna esperienza della vita. L'unica esperienza di vita che hanno è quella individualista e borghese di ogni giorno, l'altra esperienza è quella artificiale fornita loro dai mass-media (soprattutto tv e cinema).
Sono fatalisti da un lato, perché si aspettano soluzioni dall'alto o non se ne aspettano affatto, e ingenui dall'altro. L'ingenuità è proprio il frutto della loro ignoranza, che li porta a dar ragione a chi fa la voce più grossa, ovvero a chi legittima il loro modo istintivo di vivere la vita. Anche in questo però, essi riflettono un trend che li sovrasta.
Quando fanno qualcosa le strade son le solite: sesso (il cui inizio è sceso verso i 16 anni), droga (dagli spinelli alla religione) e discoteche, più la violenza negli stadi (le bande sono ancora un fenomeno marginale, se si esclude la criminalità organizzata, che però non coinvolge molto i giovani del centro-nord).
Nei confronti di questi giovani il problema è diventato: 1) come affrontare la loro formazione educativa, anche a livello psico-pedagogico; 2) come affrontare il loro rapporto con la società civile e col mondo del lavoro.
Due postille non scientifiche
1) Scuola e psicologia borghese
A scuola, in genere, i ragazzi chiedono "aiuto", sul piano psicologico, quando sono arrivati al limite. Ed allora è troppo tardi. Normalmente affrontano la società (coi suoi problemi) in maniera individualistica, perché così gli è stato insegnato. Non hanno altri modelli. E' lo sforzo titanico del singolo contro tutto e tutti.
Tuttavia il giovane è un soggetto debole, sottoposto a varie influenze e condizionamenti, scarsamente critico. Perché così la società lo vuole. Un giovane drogato o violento o mafioso dà meno problemi di un giovane organizzato in movimenti politici che contestano il sistema. Ciò che di "sano" c'è in lui è l'esigenza di giustizia, di verità, di autenticità, ma questa esigenza viene rimossa con sempre maggiore facilità e in tempi sempre più brevi.
Uno degli slogan della psicologia è "Educare per prevenire". Educare sì, ma come? E' davvero sufficiente "educare"? oppure bisogna anche "lottare" (a livello politico) per vincere gli ostacoli che impediscono la stessa educazione? Alcuni sostengono che si può lottare in modo "culturale" (contro i modelli della società) o in modo "psicologico" (contro il disagio, la frustrazione, favorendo nuovi rapporti umani). Ma questo può essere sufficiente?
La nostra società, che è eminentemente borghese, va superata nei suoi meccanismi di fondo. Dobbiamo quindi lottare per avere spazi culturali, sociali, ma anche per avere spazi politici, poiché è in questi spazi che avviene la gestione del potere, che si decidono le linee programmatiche generali cui bisogna attenersi. Finché i vari movimenti di opinione, le varie organizzazioni politiche, sociali e culturali non saranno rappresentate negli organi parlamentari che contano, a livello nazionale e locale, qualunque lavoro fatto sul terreno culturale e sociale rischierà di non approdare a nulla, poiché incontrerà sempre resistenze fortissime o tentativi di strumentalizzazione da parte della partitocrazia e delle istituzioni statali.
Si può affrontare il politico partendo dal sociale e dal culturale (questa in fondo è la lezione gramsciana), ma al politico prima o poi bisogna arrivare, e quel giorno bisognerà far valere la propria competenza, la propria professionalità e responsabilità. Affrontare solo il sociale e il culturale, per timore di affrontare il politico, significa legittimare il sistema, eventualmente limitandosi a perfezionarlo.
E' importante lavorare bene sul terreno socio-culturale, prima di rivolgersi politicamente al sistema. La transizione così sarà meno traumatica. Ma non si può parlare di "riforme" senza pensare che l'obiettivo finale è la "rivoluzione" dei rapporti produttivi e di proprietà dominanti. Le riforme sono utili quando accelerano i tempi per la rivoluzione, o comunque quando vengono usate con queste intenzioni, altrimenti contribuiscono a illudere, anche se è insensato non farle per timore che non servano.
La psicologia borghese, in tal senso, è caratterizzata da un limite fondamentale: il relativismo. Si serve del fattore "A" per contestare il fattore "B", quando "B" appare eccessivo, esagerato, salvo poi servirsi di "B" per contestare "A" dello stesso difetto. Ovvero, se un soggetto è troppo introverso si cercherà di farlo esprimere, ma se si esprime troppo si cercherà di frenarlo. La psicologia non sa individuare un comportamento normale in sé e per sé. La "normalità" è solo tutto ciò che non è eccessivo, o comunque tutto ciò che rientra nel quotidiano vivere borghese. La differenza tra un atteggiamento e l'altro è, per la psicologia occidentale, solo una questione di forma, di grado, d'intensità, non di sostanza. Ad es. un soggetto può essere considerato "razzista" da questa psicologia, sulla base di certi pregiudizi ch'egli manifesta nelle risposte date a un test; ma un soggetto "non-razzista" è semplicemente un soggetto che rispetta i principi formali del convivere borghese.
Questa psicologia, in sostanza, non è in grado di considerare l'eccesso come una risposta istintiva a una frustrazione reale, che con la cosiddetta "normalità" non si può assolutamente risolvere. Se in una società alienata, basata sullo sfruttamento, sulla disuguaglianza, sulla violazione sistematica dei diritti umani, si chiede a un individuo d'essere "normale", ciò significa che la "normalità" deve coincidere strettamente con il conformismo, coll'adeguamento alla mentalità dominante.
La psicologia borghese è limitata proprio perché non ha rapporti con l'istanza umana di liberazione, che si manifesta sul terreno sociale, culturale e politico. La psicologia considera tale istanza come una pulsione istintiva e individualistica alla felicità. Ma un'istanza del genere, pur essendo naturale, può anche determinare un comportamento egoistico, incapace di promuovere l'umanizzazione dei rapporti sociali.
La psicologia deve farsi sociale per essere concreta, deve capire le dinamiche sociali delle classi, i rapporti di lavoro del sistema capitalistico, deve capire le esigenze dei lavoratori. La natura umana non può essere compresa a prescindere dal contesto dei rapporti sociali in cui vive. E all'interno di questi rapporti bisogna saper individuare quali sono gli aspetti "soggettivi" e "oggettivi" che portano l'essere umano a sentirsi alienato.
Paradossalmente, chi si adatta alla vita è perduto. Può sembrar vero il contrario, ma la psicologia borghese ha torto quando si preoccupa soltanto di trovare i mezzi e i modi di conformare l'individuo all'ambiente, senza mai mettere in discussione la legittimità di questo ambiente. A volte lo fa, ma guardandosi bene dall'approfondire troppo l'argomento. La psicologia ambisce ad essere una scienza neutrale, oggettiva, valida per ogni sistema sociale e politico.
I suoi orientamenti principali sono infatti i seguenti: 1) addossare all'individuo la responsabilità di certi comportamenti giudicati "anomali"; 2) attribuire una parte di responsabilità anche all'ambiente, ma escludendo a priori ch'esso possa essere fonte di condizionamenti oggettivi, strutturali, indipendenti dalla volontà dei soggetti.
La psicologia borghese rifiuta di considerare l'oggettività sociale dell'alienazione: ogni volta che s'imbatte in questo problema finisce col considerare l'alienazione un fattore costitutivo della personalità (tanto inspiegabile quanto imprescindibile, al pari del "peccato originale" per i cattolici), oppure si pone la classica domanda: "Come mai di fronte a una stessa frustrazione ambientale un soggetto la supera e un altro no?". Dopodiché essa non si chiede, ovviamente, in che modo il soggetto abbia effettivamente superato il condizionamento alienante dell'ambiente. Si limita semplicemente a dare per scontato che l'accettare i meccanismi di fondo di un determinato contesto sociale, ovvero il limitarsi a modificarne singoli aspetti d'importanza relativa, sia già una garanzia di benessere. In altre parole, la psicologia borghese non fa che predicare la filosofia della rassegnazione: colui che non desidera modificare la realtà più di tanto, viene considerato meno esposto ai rischi della frustrazione.
Questo modo di vedere le cose non tiene in alcun conto che l'individuo non può sopportare all'infinito l'atteggiamento buddista della rassegnazione, né può accontentarsi di modifiche parziali dell'ambiente sociale, soprattutto s'egli avverte il proprio disagio con una tensione così profonda da far temere alla collettività delle reazioni patologiche di rivalsa, d'istintività repressa, di violenza gratuita.
La psicologia quindi non può trascurare i fattori sociali oggettivi (cioè il sistema politico-istituzionale ed economico-produttivo, l'ideologia dominante trasmessa attraverso i media) che condizionano pesantemente la libertà dell'individuo. Essa deve far capire all'individuo che la sua "liberazione" dipende anche dalla capacità che ha di trasformare l'ambiente. Questo permette all'individuo di capire in anticipo quali solo i veri limiti di ogni sua azione e quali obiettivi si devono conseguire per superare quei limiti.
Tornando ai giovani... È molto difficile acquistare la loro fiducia. Un giovane può rispettare il docente se lo teme, ma questo non significa che ha anche fiducia in lui, cioè che è disposto a lasciarsi coinvolgere in tematiche che lo toccano in prima persona. Interpellato su un argomento non scolastico, spesso il giovane tace per timore d'essere frainteso, deriso, giudicato male. Non vuole ammettere d'avere dei problemi perché sa che la società non ammette imperfezioni. Gli è stato insegnato che gli errori si pagano sempre con molte umiliazioni. Ecco perché i giovani, a scuola, danno solo quello che serve per ottenere qualcosa. Il loro rapporto colla scuola è mercificato, perché così gli viene imposto, perché così viene imposto alla scuola dal sistema di potere. È forse in grado la psicologia di comprendere tutte queste cose? È forse in grado di comprendere che un giovane a scuola si sente umiliato non tanto perché ha un profitto scarso (per lui i professori sono troppo "sfigati" per emettere giudizi di una qualche importanza), quanto perché, avendo un profitto scarso, sa in anticipo che i compagni di classe -condizionati come sono dalla logica selettiva, disumana, individualistica di questa società- non l'aiuteranno? È forse in grado di spiegare la psicologia il motivo per cui uno di questi ragazzi -abituato a credere che nella vita per farsi strada ogni mezzo è lecito- se dovesse valutare i suoi compagni di classe in uno scrutinio finale, sarebbe molto più severo di quanto non lo siano gli stessi insegnanti?
Addendum
Sul Progetto Giovani 1993
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha elaborato il Progetto Giovani'93 nell'89, ma il primo P.G. è stato dell'85, ed era fallito per mancanza di fondi. Se non ci fosse stata la legge 162/90 sulla droga, quella che ha istituito i cosiddetti "referenti antidroga", e che ha messo ha disposizione del Ministero della P.I. vari miliardi, anche il P.G. '93 sarebbe fallito. E rischierà comunque di fallire se il governo, con la nuova Finanziaria, si metterà a tagliare i fondi alla legge 162.
Non solo, ma oggi come nell'85 il Ministero ha elaborato il P.G. in modo del tutto burocratico, facendolo cadere dall'alto, tanto che se non ci fossero stati quei finanziamenti (una vera rarità per la scuola!) nessuno l'avrebbe preso seriamente in considerazione, e sarebbe passato come una circolare fra tante. Tutti i P.G. e la stessa legge 162 sono stati elaborati nelle sedi ministeriali, senza interpellare, preventivamente, la gran massa di docenti e studenti che lavorano nella scuola. Queste due iniziative ministeriali si assomigliano nei contenuti, perché entrambe hanno lo scopo di prevenire il disagio, cioè l'insofferenza che caratterizza il mondo giovanile nell'ambito scolastico. Si assomigliano così tanto che praticamente tutto il P.G. è stato assorbito dalla legge 162.
Queste due iniziative non partono dal mondo della scuola, ma dall'esterno, cioè dalla tossicodipendenza e dalla micro e macro-criminalità del mondo giovanile. Problemi come la mafia, la droga, la violenza negli stadi, gli incidenti mortali del dopo-discoteca, i suicidi apparentemente inspiegabili di giovani benestanti e altre cose del genere hanno ovviamente preoccupato il governo, il quale ha delegato i vari ministeri (in particolare il nostro) a reagire. E il Ministero della P.I. lo ha fatto nella solita maniera verticistica: facendo piovere leggi, circolari, progetti vari, al fine di rendere la vita scolastica meno alienante, più gratificante, soprattutto per i giovani.
E così, dopo anni e anni in cui la scuola ha vissuto totalmente ai margini dei processi sociali e culturali della nostra società, dopo decenni di netta separazione della scuola dal mondo del lavoro, dall'ambiente, dal rapporto col contesto sociale, dai mass-media, ci si chiede, improvvisamente, di diventare esperti pedagogisti, psicologi, animatori, educatori qualificati, in grado di capire al volo il malessere che vive lo studente, le problematiche del suo sviluppo adolescenziale. Ci si chiede addirittura d'integrare nei nostri programmi un intervento finalizzato alla socializzazione del giovane.
Cioè ci si chiedono cose che normalmente non facciamo, che nessuno ci ha mai chiesto di fare, e che naturalmente non sappiamo fare. Normalmente queste cose vengono fatte dai docenti più interessati o più preparati, a titolo personale, in modo facoltativo, seguendo corsi particolari di aggiornamento o di formazione. Niente di più. Dal giorno alla notte invece il Ministero pretende che la scuola si trasformi da organismo burocratico e amministrativo (quale è sempre stato) a organismo di vita, di proposta culturale, di creatività a tutti i livelli. Oltre a questo ci fanno sapere -quasi fosse una specie di avvertimento- che gran parte della devianza giovanile dipende dalla precoce mortalità scolastica. In altre parole, molti ragazzi si drogano perché la scuola non piace, perché è troppo esigente, non li capisce, oppure perché non ha nulla da offrire.
Come se la scuola fosse la principale responsabile della tossicodipendenza che continua a dilagare nella nostra società, a dispetto di tutte le leggi repressive. Come se la scuola potesse essere diversa da quella che gli organi di governo vogliono. Come se la scuola fosse veramente esigente e selettiva tale da determinare l'abbandono scolastico. Come se la droga o la devianza giovanile potesse essere risolta promuovendo d'ufficio i nostri ragazzi, o trasformando la scuola in un'isola felice nel marasma della società civile. D'altro canto non si può sperare maggiore lungimiranza da parte di un Ministero che da anni misura il grado di alfabetizzazione o di cultura generale del nostro Paese sulla base dei diplomi che rilasciamo, senza considerare né l'effettivo livello culturale dei nostri ragazzi, né il problema dell'analfabetismo di ritorno (che è tipico di quelle società i cui mass-media producono solo cultura d'evasione).
È in questa situazione che gli insegnanti sono invitati, non tenuti, in virtù del P.G. e della legge 162, a essere dei veri educatori, delle persone creative. Ma educare a quali valori? a quali comportamenti? Il Ministero non ci chiede di educare il giovane a una coscienza critica della realtà, a una formazione intellettuale elevata, in grado di reggere le sfide dei tempi, non ci chiede di trasformare la cosiddetta "scuola-parcheggio" in un'istituzione formativa, educativa e professionale. Ci chiede soltanto di rendere il giovane un "protagonista". L'importante è fare delle cose, anche slegate tra loro, per agevolare lo studio di sempre, per rendere più sopportabile la divisione della scuola dalla vita e dal mondo del lavoro: non è in questione il senso di quello che si vuole fare. L'importante è cercare di evitare che lo studente, per un motivo o per un altro, rinunci in anticipo alla scuola, finendo in mezzo alla strada, senza alcun diploma, disposto a diventare o drogato o spacciatore o comunque delinquente.
Come se il modo migliore di affrontare le difficoltà della vita, dove la competizione è sempre più serrata e le qualità professionali richieste sempre più specifiche, fosse quello d'illudere lo studente che, in fondo, basta "partecipare"! Come se con 4000 referenti antidroga, scelti sulla base del volontariato, e con un centro d'informazione e consulenza per istituto (gestito peraltro non si sa da chi), il problema del disagio scolastico possa essere facilmente risolto! Senza considerare il rischio che fra qualche anno ci dicano, come se niente fosse, che i soldi sono finiti e che i futuri progetti-giovani non potranno essere realizzati.
Si ha insomma la percezione d'essere dominati dall'improvvisazione del momento. Oggi c'è il fenomeno della droga, che spinge a leggi e iniziative che sempre più hanno il sapore dell'emergenza, della eccezionalità. Domani ci sarà qualcos'altro. O forse il giorno in cui il problema della droga sarà risolto, il Ministero non avrà più nulla da chiedere ai suoi insegnanti e ai suoi studenti?
In ogni caso il Ministero che chiede ai giovani di formulare proposte culturali, creative, o di altro tipo, al fine di realizzare al meglio il P.G., è un Ministero che ancora una volta dà prova della sua grande estraneità ai veri problemi scolastici. Il primo dei quali è proprio la carenza quasi totale di attività culturale. È impossibile oggi chiedere ai ragazzi di formulare proposte di questo genere, quando per decenni s'è fatto di tutto per volerli apatici, nozionistici quel tanto che basta, indifferenti non solo alla cultura ma anche all'attualità.
Dovremmo anzi chiederci perché i ragazzi sono diventati così, qual è la cultura della nostra società che li ha resi così vuoti, e in che modo i mass-media aiutano veramente la scuola a rendere viva l'esigenza della cultura (forse coi programmi del DSE dalle 12 alle 14?), ovvero quali sono i modelli culturali che passa questa società e che a scuola assimiliamo con troppa disinvoltura. Non è significativo che per rendere più vivibile la scuola dobbiamo prima aspettarci dei progetti specifici, calati dall'alto? Come se non fosse un'esigenza quotidiana quella di poter lavorare al meglio coi nostri ragazzi, senza frustrazioni e incomprensioni reciproche!
Per non parlare dei grandi problemi che da almeno un ventennio travagliano la scuola, il primo dei quali è il fatto che i diplomi non sono rispondenti alle esigenze del mondo produttivo. Aziende e industrie si fanno propri corsi professionali per preparare il personale. Né esiste un osservatorio generale degli sbocchi professionali, cioè delle richieste occupazionali del mercato del lavoro, per cui è impossibile programmare le scelte scolastiche che i ragazzi compiono allo scadere delle medie e delle superiori.
In una situazione del genere, può essere considerato un grande successo se in molte scuole, relativamente al suddetto P.G., non sono mancati i progetti improvvisati da singoli docenti, che li hanno per così dire imposti alle loro classi. Il che, anche se di per sé è negativo, può diventare positivo se il progetto viene usato per attivare i ragazzi, portandoli a riflettere sulle loro risorse e a formulare nuovi progetti. In fondo è sempre meglio un progetto calato dall'alto che un'assenza totale di progetti, motivata col pretesto che dai giovani non viene mai fuori niente.
Non è che i ragazzi non abbiano esigenze di identità o delle idee creative, è che non riescono a esprimerle, o non sanno come farlo. È vero che il più delle volte mostrano un certo interesse solo per i problemi più concreti (dalle condizioni ambientali della scuola o dalla funzionalità dei suoi servizi: bagni, palestre, aule, biblioteca, laboratori, ecc., alla possibilità di gestire concretamente piccoli spazi di libertà: si pensi alle uscite anticipate o agli ingressi posticipati, alle giustificazioni per le interrogazioni, ecc., fino ai problemi della didattica e del diritto allo studio). Non dobbiamo però stupirci di questa concretezza, poiché i problemi tecnici e concreti, alla fine, sommati uno sull'altro, possono procurare non meno disagio della mancanza di progetti culturali.
Il problema più grave, tuttavia, è un altro: spesso i ragazzi hanno l'impressione che manifestare le proprie opinioni non serva a niente, in quanto ritengono il corpo-insegnante indisponibile ad ascoltare le loro richieste. Da tempo essi sono profondamente delusi nei confronti dell'istituzione scolastica e, se vogliamo, dell'istituzione in genere. Ciò che più li deprime è l'incomunicabilità tra loro e i docenti. Anche nei confronti di questo P.G., spesso hanno l'impressione, abituati come sono a subire passivamente gli atteggiamenti dei docenti, che si voglia chieder loro degli impegni supplementari, per attività non strettamente scolastiche: impegni gravosi che alla resa dei conti potrebbero -secondo loro- produrre anche degli svantaggi sul piano del profitto.
Cosa fare dunque? Bisogna anzitutto approfittare di questo P.G. per cominciare, insieme ai ragazzi, a ripensare i criteri con cui si vive la scuola e con cui ci chiedono di viverla, cioè i criteri con cui le istituzioni e la società intera concepiscono il loro rapporto con la scuola. Il P.G., se bene applicato, dovrebbe costringere la scuola non solo a guardar fuori dalle proprie quattro mura, interpellando e collaborando con gli enti locali, l'USL, le associazioni culturali, ricreative e sportive (ivi inclusi i Comuni, dotati anch'essi di un loro P.G.), ma anche a concepirsi secondo una logica di "tempo pieno", in stretta sintonia con le risorse e le iniziative del contesto cittadino. Quindi bisogna essere preparati collegialmente, per un lavoro proficuo sia all'interno che all'esterno della scuola.
In secondo luogo, occorre utilizzare al meglio gli spazi che i Decreti Delegati e lo stesso P.G. prevedono, al fine di affrontare insieme ai ragazzi i problemi collettivi che riguardano sia il nostro rapporto con loro, sia i loro reciproci rapporti. Il riferimento va alle assemblee di classe (che sono le più facili da gestire e dove i ragazzi normalmente, fino a ieri, pensavano solo alla gita, a programmare le interrogazioni e i compiti in classe, per quanto possibile, e dove parlavano male dei docenti), ma vi sarebbero anche le assemblee d'interclasse, di classi parallele, di sezione e d'istituto.
In terzo luogo occorre cominciare a programmare tutta l'attività didattica (tra docenti e con gli studenti), non solo per far convergere i criteri di valutazione (superando il disorientamento dei ragazzi), e per coordinare le attività, i compiti in classe e quelli a casa, ma anche e soprattutto per offrire allo studente un'immagine il più possibile unitaria del sapere che si trasmette, almeno nelle sue grandi linee. Nelle superiori, come noto, la programmazione del consiglio di classe non esiste: alcuni addirittura la fanno coincidere coi programmi ministeriali! Spesso si fa fatica a realizzarla persino nelle sperimentazioni. Eppure senza programmazione non c'è lavoro scientifico sul piano didattico, ma solo improvvisazione e dilettantismo. In tal senso vanno riviste la strutturazione e la periodicità dei consigli di classe: farne due al mese (di cui uno per gli scrutini) non serve a niente e a nessuno.