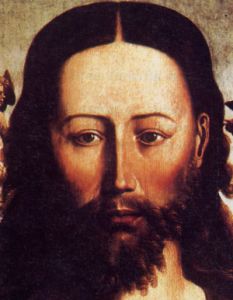
Jan van Scorel, Benedizione di Cristo, Madrid, Museo del Prado
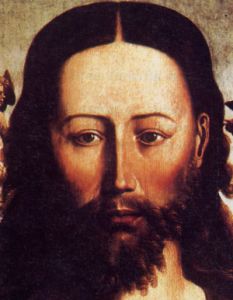
Jan van Scorel, Benedizione di Cristo, Madrid, Museo del Prado
Libro primo
I Vangeli e il loro retroterra storico-culturale
18. GESÙ
Il principio della saggezza nei confronti di Gesù - e nel contempo il principio della venerazione che gli dobbiamo - è che parliamo di lui senza luoghi comuni.
(Il teologo Albert Schweitzer)
È estremamente difficile, e costituisce il problema centrale mai risolto dalla ricerca critica, pervenire alla dottrina del Gesù storico attraverso le concezioni della comunità cristiana dell'ultimo venticinquennio del I secolo così come sono contenute nei Vangeli. Tuttavia appare possibile riconoscere, almeno approssimativamente, i tratti fondamentali della sua predicazione, nonostante l'incertezza della tradizione, le lacune, le aggiunte, le ambiguità e le esagerazioni.
Accanto alla proclamazione del prossimo avvento del Regno di Dio, al centro della predicazione di Gesù si trovava il comandamento dell'amore; dell'amore per Dio e per il Prossimo e anche per i propri nemici. Sembra che abbia prevalso in lui la tendenza a un estremo radicalismo: lotta contro le formalità del culto e la pietà ostentata, contro coloro che si autodefinivano giusti e che si permettevano di giudicare, contro l'oppressione dei deboli, lo sfruttamento dei poveri, contro la violenza, la vendetta e l'omicidio. Dovrebbero essere stati questi i tratti essenziali della sua predicazione. In seguito, alle diverse problematiche dev'essere stato preposto in modo via via più specifico il corrispondente patrimonio concettuale del Gesù sinottico. Tale ipotesi è giustificata da un confronto immediato delle dottrine bibliche più rilevanti con i loro esiti successivi.
L'insegnamento di Gesù era nuovo? Nulla è nuovo, muta solo l'ordine.
(Will Durant)Non c'è un solo pensiero cristiano... che non sia rintracciabile già prima di Gesù nella letteratura «pagana» o «giudaica».
(Karl Kautsky)
Tutti i concetti fondamentali di Gesù sono poco originali e furono espressi già prima di lui dai Salmi, dai Profeti ebrei, dai Rabbini, dagli Esseni, ai quali forse appartenne - come ammettono anche alcuni Teologi 1 -, da Giovanni il Battista, dal Buddhismo indiano, da Zarathustra, da Socrate, da Platone, dalla Stoa, dal Cinismo ecc.
La filiazione divina
Nemmeno il concetto gesuano di Dio è nuovo, di quel Dio immensamente buono, che ama il peccatore Pubblicano più del Fariseo tronfio della propria virtù, che gioisce del ritorno di un figlio perduto più che di novantanove giusti. Infatti, già il Vecchio Testamento sapeva che Dio inclina verso colui che si converte, anzi, che è proprio la disponibilità di Dio alla misericordia che rende possibile la conversione dell'infedele.
Il concetto della figliolanza divina era assai diffuso presso gli Ebrei: del «Padre che sta nei cieli» essi parlarono molto prima di Gesù, il quale, per altro, vi accenna piuttosto di rado. È solo nelle tradizioni recenziori, specie nel Vangelo giovanneo, che l'uso del nome del Padre diventa più frequente in bocca a «Gesù». Ma anche la definizione gesuana di Dio quale «Padre mio» (Mt. 7,21; 10, 32; 11, 27), pronunciata da Gesù, si trova già in molti Rabbini.
Inoltre, l'idea della filiazione divina era presente anche fuori dell'ambito della religiosità giudaica. Nel 3 millennio esisteva una preghiera alla divinità così concepita: «Non ho una madre, tu sei mia madre; non ho un padre, tu sei mio padre» 2. Il 4 capitolo del LotosSûtra contiene una parabola buddhista del figliol prodigo, che, nonostante evidenti differenze, assomiglia alla parabola di Luca. Anche nell'Inno a Zeus di Cleante, (nato nel 330 a.C.), il pensiero della filiazione divina trova un'espressione grandiosa. Esso ritorna poi soprattutto nella Stoa, dove Dio appare quale Padre premuroso e viene ribadita l'affinità degli uomini con la Divinità. I Greci definivano Dio «Padre» anche più spesso degli Ebrei, benché forse non così confidenzialmente come fa Gesù, la cui invocazione a Dio col termine abba - diminutivo aramaico del linguaggio infantile (in luogo dell'ebraico 'ha-'ab = il padre) - sarebbe meglio tradurre con «babbino» o «papà».
Anche la relazione madre-figlio come espressione del rapporto fra Dio e uomo era ben nota alle religioni misteriche molto prima del Cristianesimo. Gli studenti ellenistici conoscevano il «caro» Zeus fin dalle prime letture omeriche, così pure la «cara Signora» Atena e la «cara» Artemide 3.
L'amore verso i nemici
Anche questo caratteristico comandamento del Vangelo era diffuso da molto tempo.
La massima di Gesù: «Fate agli altri ciò che vorreste che gli altri facessero a voi» coincide chiaramente col motto di Buddha: «Agisci come se ciò che fai accadesse a te; non uccidere, e non concedere nessuna possibilità che altri lo faccia». Nella letteratura buddhistica si trova, inoltre, questa frase: «Non adirandosi si supera la collera; il male si vince col bene; l'avido si vince coi doni; con la verità si vince il bugiardo».
Anche Platone proibisce all'uomo di compiere il male, anche nel caso ch'egli lo subisca da parte di altri. (Plat., Kriton c. 10 p. 49).
L'amore per i nemici non era ignoto neppure alla Stoa: un parallelo singolare con la parola di Gesù
«Pregate per chi vi perseguita, affinché siate figli del padre celeste. Infatti, egli fa sì che il sole sorga sui buoni e sui malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt. 5, 4 sg.)troviamo in Seneca:
«Se tu imiti gli dei, fa' del bene anche agli ingrati! Infatti il sole sorge anche per i malfattori, e il male è aperto anche ai pirati» (Sen., ben. 4, 26, 1. Cfr. anche 1, 11 e De vit. 20, 5).
Un comandamento assolutamente uguale, fondato su analoghe motivazioni morali.
Persino da parte delle autorità ebraiche è raccomandato l'amore per i nemici, e anche dal V. T., benché limitatamente ai nemici personali appartenenti al proprio popolo (2 Mos. 23, 4 sg.). In ogni caso, già per Geremia e Isaia era cosa commendevole lasciarsi schiaffeggiare e sottoporsi allo scherno (Jer., Lamentazioni 3, 30; fes. 1, 6); il duplice comandamento gesuano dell'amore, che da sempre il Cristianesimo ha considerato proprietà esclusiva, deriva dalla teologia ebraica tradizionale.
L'insegnamento di Gesù era già prefigurato nel Giudaismo
In generale, il Gesù dei Sinottici, pur con tutta la sua ostilità verso l'uso farisaico della Legge, non vi si allontana mai del tutto. Anzi, sovente si pone in un rapporto positivo in questioni importanti, quantunque sia evidente una progressiva presa di distanza, e la sua lotta contro il Fariseismo, che talvolta viene contestata, è diretta contro la Legge.
Tuttavia, quasi per ogni indicazione etica di Gesù si trovano dei paralleli (spesso addirittura letterali) nella letteratura rabbinica, come possiamo dimostrare con qualche esempio.
Le parole di Gesù «Sarete misurati con lo stesso metro, col quale avrete misurato» trova riscontro letterale in una parte del Talmud, la Mischna; nella letteratura giudaica del tempo troviamo letteralmente o quasi la parabola di Gesù del trave e della pagliuzza; e ancora la sua osservazione, secondo la quale era sufficiente la pena che ogni giorno reca con sé; oppure il detto sul tesoro celeste che né tignole né ruggine potranno corrodere (Mt. 7, 3 sgg.; 6, 34; 6, 19). Il suo ammonimento
«Chi guarda una donna con concupiscenza, ha già commesso adulterio nel proprio cuore» (Mt. 5, 28)si ritrova nel Talmud nella forma seguente:
«Chi osserva intensamente una donna dev'essere giudicato come se avesse usato con lei un commercio sessuale».Quando Gesù dice
«È meglio per te che vada in rovina una sola delle tue membra, piuttosto che venga scagliato nell'inferno tutto il tuo corpo» (Mt.5, 29),l'ammonimento corrisponde all'insegnamento giudaico:
«È meglio che il tuo ventre scoppi, piuttosto che precipiti nell'abisso della perdizione».All'ammonimento di Gesù:
«Ma io vi dico: chiunque vada in collera col fratello, sarà sottoposto al giudizio; e chi dice "sciocco" al proprio fratello sarà sottoposto al giudizio del Sinedrio; e chi gli dice "stolto" sarà sottoposto al fuoco dell'inferno»,fa eco il parallelo rabbinico:
«Chi dice al suo prossimo "servo", colui sarà sottoposto al bando; chi gli dice "bastardo", colui riceverà le quaranta [frustate]; chi gli dice "empio", colui potrà dire addio alla propria vita» 4.
La predicazione di Gesù appare, dunque, prefigurata nel Giudaismo e solo in questo contesto diventa completamente intelligibile. Tuttavia è evidente che
L'insegnamento del Galileo risente anche del pensiero greco
Questa affermazione risulterà subito giustificata, qualora si tenga presente che la Galilea, chiamata allora spregiativamente la «Galilea dei Pagani», ai tempi di Gesù non era più un paese esclusivamente giudaico, ma contava una popolazione mista, ampiamente aperta all'influenza ellenistica, composta da latifondisti stranieri e dalle guarnigioni della potenza occupante, nonché dagli Ebrei della Diaspora ivi immigrati e dalle schiere di pellegrini che, specie in occasione delle festività, affluivano a Gerusalemme. La città contava allora quasi 50.000 abitanti, ma vi giungevano ogni anno circa 120.000 pellegrini 5.
E non deve trascurarsi il fatto che vi regnava una casata reale di cultura ellenistica: Erode I il Grande (37-4 a.C.), despota orientale e suddito dei Romani, che non era ebreo, i figli Archelao, Filippo ed Erode Antipa, governatore di Galilea e Perea, il «Re Erode» dei Vangeli 6. Costoro si circondavano di dotti greci, amavano la letteratura e l'arte greca, edificavano città su modelli architettonici greci, contribuendo così all'ellenizzazione della Galilea. Le città greche di Hippos e di Gadara si trovavano non lontano dal teatro dell'attività pubblica di Gesù e sono visibili dalla riva occidentale del lago di Genezareth.
Molti Ebrei parlavano greco, e parecchi avevano nomi greci (fra i discepoli di Gesù, ad esempio, Andrea e Filippo); anche l'Aramaico era contaminato da una ricchissima terminologia ricalcata sul Greco. Rabbini palestinesi spesso compivano i loro studi non solo ad Alessandria, ma anche ad Atene e a Roma. Le Sinagoghe di Galilea recano tracce evidenti dell'influenza greca, e anche a Gerusalemme esistevano Sinagoghe greche. Persino la lingua del culto era spesso il Greco.
Nazareth era toccata dai grandi snodi stradali del traffico mondiale e circondata da città greche. Molto spesso si sente dire che Gesù, della cui esistenza esteriore sappiamo, per altro assai poco, intraprese viaggi in quelli che allora erano considerati paesi stranieri 7. Anche studiosi, che attribuiscono all'Ellenismo un'influenza pressoché nulla sulla Galilea, ammettono la possibilità che Gesù sia stato sfiorato dagli atteggiamenti filosofici allora più diffusi; ma ci sono altri teologi che ritengono ch'egli potesse parlare delle sue ultime esperienze di vita solo ed esclusivamente graeco more.
In ogni caso è possibile individuare fin nei particolari un certo influsso del pensiero greco su Gesù; la sua espressione «Dare è più gratificante che prendere» si trova nell'Etica a Nocomaco di Aristotele; l'altra massima intorno all'angustia delle porte che conducono alla salvezza e alla larghezza della via che conduce alla perdizione è già presente in Esiodo e nel racconto di Prodico concernente le scelte di vita di Eracle.
L'esortazione di Gesù al discepolo che vuol dare sepoltura al padre «Lascia che i morti seppelliscano i morti! Ma tu va', e annuncia il Regno di Dio» trova corrispondenza nel comportamento del discepolo di Serapide, che alla morte del padre non abbandona il Serapeion «in nome di Serapide» 8. O ancora, il discepolo di Gesù che non deve por mano all'aratro né voltarsi indietro ha un riferimento preciso nel contadino corinzio, il quale fu talmente avvinto dalla lettura del Gorgia platonico, che abbandonò l'aratro per recarsi da Platone 9. E la proibizione di portare con sé due vesti suggerisce immediatamente l'utilizzazione da parte di Gesù del patrimonio concettuale della filosofia cinica 10.
Può essere interessante notare che a Gadara, non lontano da Nazareth, è dimostrata l'attività di una scuola filosofica cinica dal III secolo a.C. fino ad epoca cristiana inoltrata. D'altra parte, i predicatori cinici erano presenti dappertutto: anche nelle regioni intorno alla Galilea essi si muovevano da una località all'altra, parlando nelle piazze e nei vicoli, nei teatri e nelle sale. Sarebbe davvero assai strano che Gesù non ne avesse mai sentito parlare.
Il Cinismo, fenomeno culturale ben diverso da quel che appare nelle raccolte di aneddoti della tarda antichità e dal significato che il termine ha assunto nell'uso linguistico moderno, (tale stravolgimento, forse, non è semplicemente casuale) presenta non poche affinità col Cristianesimo. Nel Cinismo trovavano espressione particolarmente rilevante, rispetto a tutte le altre scuole filosofiche greche, il concetto di monoteismo e la condanna del culto degli dèi; nel contempo proclamava l'ideale etico della autarcheia, combattendo aspramente la ricerca di onori e ricchezze, il lusso e la corruzione, e concedeva ben poco credito alle conoscenze e alle scienze tradizionali: i suoi predicatori vaganti, spesso uomini assai seri, pieni di dignità e denominati già allora episkopoi (= Vescovi), percorrevano il mondo intero, rivolgendosi preferibilmente al popolino, ai poveri e agli schiavi, e non si peritavano di frequentare le peggiori compagnie.
Come Gesù affermò una volta che non sono i sani ad aver bisogno del medico, bensì i malati, allo stesso modo il discepolo di Socrate, Antistene, fondatore del Cinismo, all'accusa di frequentare cattive compagnie, ribatté con queste parole: «Anche i medici stanno vicini ai malati, ma non per questo hanno la febbre». Non era poi raro il caso di Cinici, che talvolta godevano di notevole prestigio presso le comunità cristiane, scambiati per cristiani e, viceversa, di cristiani scambiati per Cinici.
Nella predicazione di Gesù, come oggi riconosce chiunque non sia vittima di pregiudizi dogmatici, si trova ben poco di originale. Teologi autorevoli definiscono «concezione ingenua» 11 la credenza nell'unicità e nell'assolutezza del suo insegnamento, spiegando all'unisono che nella sua interpretazione del momento storico e nelle sue idee escatologiche si è completamente sbagliato. Alla sua visione del mondo, che era quella propria dell'epoca, (né poteva essere altrimenti), non erano estranee credenze bizzarre nella presenza di spiriti, angeli e demoni. E neppure le sue convinzioni etiche erano nuove, il che non ne sminuisce l'altissimo valore.
Il tratto caratteristico del Gesù sinottico non è la dipendenza da altri, già riconosciuta da Celso, ma l'intensità della sua predicazione. Con la sua consequenzialità rigorosa, con l'esclusione del superfluo e con la sottolineatura dell'essenziale, Gesù va ben al di là di molte concezioni precedenti. Egli fu capace di scuotere e di attrarre, come è capace di fare ancor oggi. «Chi si trova vicino a me, sta vicino al fuoco», suona una sua frase tramandata al di fuori dei testi biblici canonici. Dietro la sua predicazione, ed è questo l'elemento più significativo, si trova il Gesù sinottico: vita e dottrina vi coincidono.
In verità, anche Gesù condivide questo tratto con ogni altro vero Maestro; infatti, come una valutazione storica non riesce a scorgere nel suo messaggio nulla di «originale», allo stesso modo non può vedere in lui un uomo incomparabile. C'è stato anche Buddha, Socrate e tanti altri, e, come Goethe fece notare a Lavater, non abbiamo bisogno di strappare le splendide penne ai mille volatili del cielo come se fossero state usurpate, al fine di adornare con esse un unico uccello del paradiso 12.
Note
1
Ad esempio, Grundmann, Geschichte Jesu Christi, 110.
2
Cit. da Schneider, Geistesgeschichte, 1, 32.
3
Hom., Il. 20, 347. Secondo Schneider, Geistesgeschichte, 1, 32.
4
Cfr. Mt. 5, 22 con Qidduschin 28 a Bar, cit. secondo Klostermann, Das
Matthäusevangelium, 43. Cfr. anche Fiebig, Jesu Bergpredigt,
38.
5
Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, 1, 89 sgg.
6
Ad eccezione di Mt. 2 e Lc. 1, 5, dove si fa riferimento a suo padre
Erode il Grande.
7
Mc. 7, 24; 7, 31; 8, 27; 10, 1. In proposito, Wechssler, 169 sgg.
8
Lc. 9, 60; Mt. 8, 22. Schneider, Geistesgeschichte, 1, 38.
9
Lc. 9, 62. Schneider, Geistesgeschichte, 1, 38, dove si trova
l'indicazione delle fonti. Cfr. anche Wechssler, 260.
10
Schneider, Geistesgeschichte, 1, 37 con riferimento a Lc. 9, 3; Mc.
6, 9; Mt. 10, 10.
11
Windisch, Der Sinn der
Bcrgpredigt, 105, nota 1.
12
Lettera del 22 giugno 1781.
Goethe trovava che Socrate, ad esempio, «si poteva paragonare
alla vita e alla morte di Gesù», (Dichtung und
Wahrheit, 2, 6).