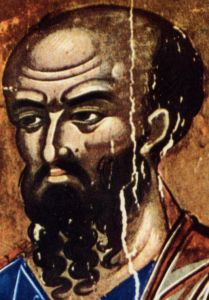
Apostolo Paolo, icona del Monte Athos, XVI sec.
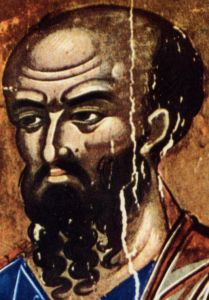
Apostolo Paolo, icona del Monte Athos, XVI sec.
Libro secondo
Paolo
24. LA PRASSI PAOLINA
Tutto lo stile comportamentale, di cui ormai da due millenni la Chiesa Romana si serve con tanta maestria e che costituisce uno strumento essenziale per la conservazione del suo dominio mondiale, appare già prefigurato in Paolo in misura davvero sconcertante.
(Eduard Meyer, Ursprung und Anfänge, III, 413)Paolo era attivissimo nell'azione, perché confuso nella teoria.
(Will Durant, 657)
Pochi aspetti della personalità di Paolo sono stati soggetti a valutazioni tanto controverse quanto i modi d'esercizio della sua opera missionaria. Gregorio di Nazianzio, per esempio, lo definì «il più nobile dei combattenti» e lo Harnack e altri teologi liberali videro in lui «il missionario più eccelso dell'età antica» 1; ma già Porfirio nutrì una marcata avversione contro la prassi di Paolo, Voltaire lo additò al disprezzo come un fanatico altezzoso e ambizioso, Spengler lo accusò «di attività brutale, senza tatto né spessore», e soprattutto Nietzsche riversò sopra di lui tutta la propria collera, definendolo il contromodello della buona novella, il più grande di tutti gli Apostoli della vendetta, il genio dell'odio.
«La vita, l'esempio, l'insegnamento, la morte, il significato e il giusto dell'intero Vangelo, nulla sopravvisse, quando questo falsario concepì per mero odio ciò di cui soltanto lui aveva bisogno. Non la realtà, non la verità storica!» 2.
È necessario circoscrivere l'analisi alle sue Lettere, per costituire la premessa obiettiva di un giudizio corretto su Paolo. Tutti i tratti opportunistici del suo carattere derivano principalmente dalle notizie contenute negli Atti, utilizzabili quale fonte storiografica solo con la massima circospezione. È vero che anche le Lettere attestano spesso un'elasticità non trascurabile, un certo qual scendere a patti col mondo: se una volta dice: «Dico a voi, Pagani; come Apostolo delle Genti io farò onore al mio ministero», altrove scrive: «Noi siamo Giudei per nascita, e non peccatori pagani», per poi affermare chiaro e tondo: «Sono diventato tutto per tutti, per poter in ogni caso salvare qualcuno» (Rom. 11, 13; Gal. 2, 15; 1 Cor. 9, 19 sgg.).
È chiaro che il missionario doveva parlare ai Giudei in modo diverso che ai Greci, giacché erano nutriti da retroterra culturali e da interessi differenti. Paolo non fu affatto un opportunista, perché con il totale sacrificio della propria persona rinunciò a tutto, conducendo spesso un'esistenza assai dura in nome delle sue concezioni religiose; ma fu intollerante e autoritario, prototipo di un invasato zelota confessionale, o, se si vuole usare la definizione del Teologo Deißmann,
«...un classico dell'intolleranza»
In effetti, la tesi per cui Paolo sarebbe stato come Apostolo un fanatico ingentilito o persino magnanimo, fornito di grandissima tolleranza, uomo bonario, assolutamente mite, l'incarnazione vivente di quel che predicava, viene contraddetta in modo evidentissimo dal contenuto delle sue Epistole, le quali dimostrano inconfutabilmente che dopo Damasco Paolo modificò certamente la sua fede, ma niente affatto il suo carattere.
Appare qui decisiva la sua posizione nei riguardi del comandamento dell'amore pel prossimo, che anche per lui costituì certo il nucleo centrale della predicazione, ma tale concetto di prossimo appare di già circoscritto e riferito più ai confratelli che a coloro che la pensavano diversamente: «Facciamo del bene a tutti - scrive nella Lettera ai Galati - ma specialmente ai fratelli nella fede» 3. Ma così si introduce un elemento concettuale di rilevanza decisiva, se è vero che il comandamento di Gesù all'amore non conosceva barriere di alcun genere; il Cristo di Giovanni, modellato su quello di Paolo, finirà poi col pregare Dio solo ed esclusivamente per i cristiani 4, mentre per il Quarto Evangelista l'amore per il nemico non esiste già più.
Inoltre tale comandamento sussiste per Paolo in forma singolarmente alterata, cioè collegato alla fiducia consolatoria in un atto di vendicativa giustizia di Dio; Paolo, infatti, raccomanda:
«Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; perché così facendo accumulerai carboni accesi sul suo capo» (Rom. 12, 17 sgg.).
Il risentimento che promana da questo passo, quest'arte sublime della vendetta, sono stati percepiti allo stesso modo da uomini pur così diversi come Nietzsche, Kierkegaard e Scheler. Ma anche a giudizio del teologo Preisker è stato così ferito al cuore l'intendimento profondo di Gesù, ed è penetrato nel concetto cristiano dell'amore uno spirito totalmente diverso.
Le Epistole più importanti sono scritti direttamente polemici; una volta egli stesso definisce la propria opera addirittura un incontro di pugilato (1 Cor. 9, 26), e la metafora della lotta, che ricorre tanto spesso nel Paganesimo (specie nella Stoa), viene accolta e utilizzata volentieri da Paolo: per Cristo egli presta un «servizio militare» e i suoi collaboratori sono «commilitoni» (2 Cor. 10, 3; Phil. 2, 25).
Ma non mancò di combattere anche contro le sue stesse comunità e, almeno sporadicamente, persino contro i loro capi più in vista (Cfr. Gal. 2, 13; 1 Cor. 1, 12; Atti, 15, 37 sgg.), per esempio Barnaba, cui pur doveva la sua chiamata ad Antiochia, col quale, già prima del secondo viaggio di missione, «giunse a uno scontro assai acceso, in conseguenza del quale i due si separarono» (Atti, 15, 39. Cfr. in proposito le attenuanti del cattolico Schuchert, 66): dopo tale evento Barnaba non viene più nominato negli Atti degli Apostoli.
Egli amava imporre agli altri la propria opinione e non tollerava che intorno a lui ci fosse qualcuno capace di pensiero autonomo. Anche un Cattolico (Ricciotti, Paulus, 574) è costretto ad ammetterlo: «Apollo, pensatore dalle idee originali, non resistette a lungo; per non parlare di Barnaba». Rimasero con Paolo giovani come Timoteo, neofiti come Tito o personaggi malleabili come Luca. Chiunque insegni qualcosa di diverso viene da lui anatemizzato:
«Ma se anche noi o un Angelo dal cielo (!) vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!».
Dopo aver ribadito tale maledizione nello stesso passo e dopo aver ripetuto anche verso la fine di questa lettera:
«Dio voglia che siano annichiliti coloro che vi recano turbamento! »,subito di seguito proclama:
«Perché tutta le Legge trova il compimento in un unico comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso» (Gal. 1, 8 sgg.; 5,12 sgg.).
Altrettanto grottesca suona la predica di Paolo alla fine della Prima Lettera ai Corinzi, dove tuona:
«Sia anatema per chi non ama il Signore», per continuare subito dopo: «La grazia del Signore Gesù sia con voi! Il mio amore è con voi tutti in Gesù Cristo!» 5.
Questo metodo, canonizzato nel N.T., fece scuola: la Prima Lettera di Clemente, lo scritto postpaolino più antico, che definisce Paolo «il massimo modello di pazienza», minaccia i Corinzi con queste parole:
«Ma se voi non siete obbedienti e non mi date ascolto, possa trapassarvi la spada!».
In seguito Agostino solleciterà dallo Stato quella stessa spada distruttrice per combattere gli eretici, e tale prassi sarà poi completamente legittimata dalla Chiesa. Il paolino Anathema sit!, che spesso andava oltre le forme giudaiche di scomunica, ricollegandosi direttamente a concezioni magiche e a formule malediche proprie del Paganesimo, diventerà il modello primigenio delle Bolle cattoliche di scomunica.
Ma Paolo ad altri insegna:
«Non giudicate prima del tempo, finché non sia giunto il Signore», oppure: «In questo, o uomo, non ti puoi discolpare, chiunque tu sia a giudicare. Perché quando giudichi un altro, condanni te stesso; poiché tu fai la stessa cosa che giudichi» (1 Cor. 4, 5; Rom. Cfr. anche Gal. 6, 1; e la pseudopaolina, forse, 2 Thess. 3, 15).Come non condividere l'esclamazione di Nietzsche:
«"Non giudicate!", essi dicono, ma spediscono all'Inferno tutto quel che li ostacola»?
Facendo propria l'espressione usata da uno scrittore greco a proposito dei Cretesi, i nemici non cristiani sono per Paolo «fiere selvagge» con cui lottare (1 Cor. 15, 32). La rottura coi Giudei fu immediatamente radicale. Già nella sua Prima Epistola, quegli Ebrei che secondo un teologo cattolico (Ricciotti) erano per l'Apostolo «oggetto del massimo affetto», diventano esseri odiati da Dio, maledetti fino al giorno del giudizio: sono le stesse espressioni stereotipe dei vecchi antisemiti 6. Nella Lettera ai Filippesi (3, 8) definisce «sterco» l'intero patrimonio religioso e spirituale del Giudaismo.
Già in Paolo ricorre, dunque, quella funesta distinzione fra «orto»dossi ed «etero»dossi, che, attraverso la formulazione di Cipriano, secondo la quale non v'ha salvezza fuori dalla Chiesa, e l'intolleranza di Agostino, condusse alle Crociate, ai pogrom contro gli Ebrei, alle camere di tortura e ai roghi.
Benché fisicamente debole e malaticcio, Paolo fu uomo di straordinaria energia e propagandista così possente, che durante il Terzo Reich taluni teologi protestanti paragonarono le sue comunità agli «stendardi delle camicie brune dell'esercito hitleriano», parlando di una «SA di Gesù Cristo» 7. Paolo stesso, poi, con la modestia che gli fu propria, definì se stesso «collaboratore di Dio» 8. Eppure, le sue missioni nelle più svariate regioni non erano allora nulla di eccezionale: molto prima di lui lo avevano fatto in grande stile Senofane, Empedocle ed Eraclito, e predicatori buddhisti si erano spinti fino in Egitto. In quell'epoca e ancora in seguito per molto tempo viaggiavano per il mondo missionari-filosofi, soprattutto Stoici e Cinici, diffusori delle religioni misteriche e del Giudaismo. il Vangelo di Matteo dice a proposito di Scribi e Farisei: «Percorrete la terra e il mare per fare un solo proselita» (Mt. 23, 15).
La situazione complessiva favoriva l'azione missionaria: strade eccellenti dall'Eufrate alla Britannia, buoni collegamenti marittimi, ricettività religiosa e superstizione, l'unità politica della monarchia universale di Roma, l'unità giuridica e la garanzia della legge, l'esistenza di una lingua internazionale come il Greco, l'analogia delle condizioni materiali di vita, la multirazzialità e la permeabilità etnica, e, non da ultimo, la tolleranza della politica religiosa dei Romani. Un'epigrafe sepolcrale di un mercante frigio del II secolo ci informa che compì 270 volte il viaggio a Roma. Per quanto concerne Paolo, però, il cattolico Guardini esclama: «Non comprendiamo come abbia potuto farlo»; e subito allude a un soccorso divino.
Note
1
Greg. Naz., or. 2, 84. Harnack, Marcion, 10.
2
Per Porfirio ad es. Fr. 27 (Harnack). Spengler, Der Untergang des
Abendlandes, 2a ed., 524. Nietzsche, Antichrist, 42. Cfr. 45.
3
Gal. 6, 10. Cfr. anche Rom. 12,18. In proposito Preisker, Das Ethos des
Urchristentums, 184 sg.
4
Jh. 17, 9. Cfr. anche 1 Jh. 2, 9 sgg.; 3, 14 sgg.; 4, 20 sg. Inoltre
Preisker, ibid., 205. Cfr., ad es., anche Werner, Jesus Christus-Das
Licht der Welt, 29 sg.
5
1 Cor. 16, 22 sgg. Cfr., ad es., le attenuazioni giustificatorie nei
cattolici Daniel-Rops, Die Kirche, 89 oppure di Schuchert, 75:
«non è uomo di fiacchezze umanitarie!».
6
1 Thess. 2, 15 sg. Leipoldt, Jesus u. Paulus, 13. Schneider, Das
Frühchristentum als antisemitische Bewegung, 5. Oepke, 198 sg.
E. Meyer, Ursprung u. Anfänge, III, 85.
7
Le SA, Sturmabteilungen, erano reparti speciali d'assalto del Partito
nazista [n.d.t.].
8
1 Cor. 3, 9. Sulla superbia Pauli (Lutero), autoesaltazione e umile
boriosità, che farà poi scuola nella Chiesa,
cfr., ad es., 2 Cor. 3, 6 sgg.; 11, 22 sgg.; 12, 1 sgg; 1 Cor. 3, 10
sgg.; 11, 1; 2 Cor. 6, 3 sgg.; Thess. 2, 10; 1, 6; Phil. 3, 17. 3, 4.
4, 9; 1 Cor. 2, 6 sgg.; 4, 16; 9, 15; 14, 18; 2 Cor. 1, 12; 1, 14; 3,
1; 5, 12; 10, 13. Sull'accusa di autoesaltazione da parte dei
cristiani: 2 Cor. 3, 1; 5, 12; 10, 13. Inoltre: Fridrichsen, Zum Stil
des paulinischen Peristasenkatalogs 2 Cor 11, 23 sgg.; 25 sgg. idem,
Peristasenkatalog und Res Gestae, 78 sgg. Windisch, Paulus u. Christus,
189. Schneider, Geistesgeschichte, 1, 107. K.L. Schmidt, Der Jude u.
der Christ Paulus, 207.