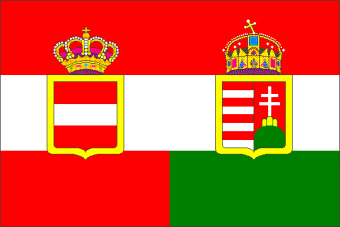LA REPUBBLICA UNGHERESE DEI CONSIGLI
I 113 giorni della rivoluzione del 1919
LA FINE DELL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO
Durante la I guerra mondiale l'oppressione nazionale (politica ed economica) nell'impero austro-ungarico s'era talmente intensificata che venne a crearsi una situazione rivoluzionaria, stimolata anche dal fatto che in Russia l'Ottobre bolscevico stava dando ai lavoratori speranze di mutamenti radicali.
Né gli agrari né la grande borghesia dell'impero erano interessati a liquidare la monarchia al governo, anche perché erano troppo preoccupati dell'ascesa del protagonismo popolare. La monarchia veniva definita "dualista" in quanto l'imperatore austriaco era nel contempo re d'Ungheria (1867-1918).
Dei due paesi: Austria e Ungheria, quest'ultimo, pur fruendo d'una relativa autonomia, di fatto - soprattutto sul piano economico - dipendeva dalla volontà dell'Austria, i cui quadri dirigenti consideravano rozza e provinciale la nazione magiara.
La stessa nobiltà ungherese, i latifondisti e la grande borghesia guardavano con disprezzo le popolazioni dei loro territori: croati, serbi, romeni, sloveni, ucraini ecc., i quali intorno al 1910 costituivano più della metà dell'intera popolazione nazionale, circa 11 milioni sui 21 registrati. E di questi 11 milioni ben 2 erano già morti o feriti o imprigionati nel corso della I guerra mondiale.
Il paese era in preda alla fame e minacciato dalla bancarotta: mancavano generi di prima necessità come calzature, vestiario, sapone, petrolio ecc. Inevitabilmente i prezzi salivano alle stelle e di questo solo la borghesia produttiva traeva beneficio.
La maggior parte delle aziende peraltro produceva per l'esercito, con ritmi, per il singolo operaio, di 12 ore al giorno e con un regime militare di controllo della produzione, per cui la più piccola infrazione veniva punita con le leggi in tempo di guerra. La militarizzazione dell'economia aveva praticamente ipersviluppato il capitalismo monopolistico, con pochi cartelli industriali.
Il blocco imperialista austro-tedesco stava portando l'Ungheria alla rovina. La popolazione maschile attiva era al fronte e vi era scarsità di manodopera: tutta l'economia era dissestata. Per di più avvenivano, da parte del governo austriaco, continue requisizioni di grano, foraggio e bestiame, una parte delle quali finiva addirittura in Germania.
Era per questo motivo che i contadini magiari lottavano contro i latifondisti non solo sul piano economico, ma anche su quello politico-nazionale, essendo essi appartenenti soprattutto alle nazionalità oppresse dell'impero.
Ma era soprattutto il proletariato operaio a volere risolutamente la fine della monarchia, la democratizzazione politica e la creazione di Stati nazionali indipendenti. Nell'autunno del 1917 i socialisti rivoluzionari, sulla scia di quanto facevano i bolscevichi russi, avevano chiamato i lavoratori e i soldati di tutte le nazionalità coinvolte a lottare contro la guerra imperialista, organizzando un meeting di migliaia di persone presso il parco municipale di Budapest.
Il primo sciopero politico generale fu del gennaio 1918, seguito, il mese dopo, dall'insurrezione dei marinai della flotta da guerra a Cattaro, sulla costa dalmata (attualmente nel territorio del Montenegro). Cominciarono a formarsi nel paese i primi nuclei di "soviet" di deputati operai e di soldati.
Il 18 giugno uno sciopero generale, da economico (contro la riduzione della razione del pane, che nel gennaio precedente era stata imposta a 100 gr. pro-capite), si trasformò immediatamente in politico. Gli operai chiedevano esplicitamente la fine immediata della guerra, la smilitarizzazione delle aziende e la conclusione di una pace senza annessioni né riparazioni.
Presa dal panico, la polizia cominciò a sparare sui dimostranti, scatenando un'ondata di scioperi di solidarietà in tutto il paese. Nel contempo iniziano a formarsi a Budapest, a Vienna e in altre città i Consigli di deputati operai, guidati dai riformisti socialisti e dai socialdemocratici, i quali, dopo modeste concessioni da parte del governo, misero fine allo sciopero generale. (1)
Alla fine di giugno, dopo il fallimento dell'offensiva a sud di Trento, che costò all'impero oltre 100.000 soldati, il governo Seidler fu costretto a dimettersi.
A metà settembre le truppe dell'Intesa aprono il fronte dei Balcani: crolla immediatamente la Bulgaria, che spiana la strada all'offensiva da sud contro l'impero.
In ottobre le truppe italiane rompono il fronte sul Piave, minacciando l'impero da sud-ovest. Nel contempo il popolo ucraino si solleva per ottenere la propria indipendenza. I soldati austro-ungarici si rifiutano ogni giorno di più di proseguire una guerra senza prospettive. Anzi, molti di loro cominciano a familiarizzare con l'Armata Rossa in Ucraina. Il che preoccupa molto il governo Hussarek, successore di Seidler, che fa subito evacuare l'Ucraina.
Tuttavia 300.000 soldati, tornando a casa dopo la pace di Brest-Litovsk, divulgano le notizie della rivoluzione d'Ottobre e creano propri consigli rappresentativi: 150.000 di loro disertano e si vanno ad aggiungere agli altri 100.000 dell'agosto precedente. Molti di loro si trasformano in truppe partigiane antigovernative (in Croazia p.es. erano in 50.000).
Approfittando della situazione, il movimento contadino, in Dalmazia, Istria, sul litorale croato, si rifiuta di eseguire gli obblighi verso gli agrari e di pagare le tasse al governo. In Bosnia ed Erzegovina si attaccano persino gli organi amministrativi locali per distruggere le liste dei debiti.
In altre località di Voivodina, Galizia, Slovacchia, Bucovina, Carnia, Croazia... i contadini cominciano a requisire le terre ai latifondisti e a dividersele equamente; spesso si caccia la gendarmeria e l'amministrazione statale, unendo la lotta per la terra a quella nazionale.
Il 14 ottobre 1918 viene proclamato in Boemia lo sciopero politico generale, per la costituzione dello Stato cecoslovacco. Come al solito era iniziato per un motivo economico: le disposizioni del governo di trasferire dalla Boemia all'Austria le riserve di carbone e di prodotti alimentari. Ma subito dopo scoppia la rivoluzione nazionale democratico-borghese.
Il 28 ottobre nasce lo Stato cecoslovacco, guidato da una leadership borghese, pur essendo stati gli operai a guidare l'insurrezione.
Nelle terre slave meridionali la borghesia, vedendo la formazione dei primi nuclei di comitati rivoluzionari per la costituzione di repubbliche "sovietiche", sull'esempio russo, si affretta a proclamare l'istituzione di uno Stato autonomo di sloveni, croati e serbi (Jugoslavia).
La Bucovina settentrionale (non quella occidentale) si unisce all'Ucraina "sovietica". Anche le terre polacche si staccano dall'Austria-Ungheria.
Nella notte del 31 ottobre scoppia la rivoluzione democratico-borghese anche in Ungheria. Lo Stato indipendente repubblicano nasce il 16 novembre.
I partiti borghesi austriaci, diversamente da quelli ungheresi, non avevano il coraggio di liquidare la monarchia, anche se si rendevano conto che l'impero era finito e che occorreva creare un nuovo Stato tedesco-austriaco.
A questa indecisione suppliranno le masse popolari, che obbligheranno il governo a firmare l'armistizio con l'Intesa il 3 novembre. Il 12 viene proclamata la repubblica austriaca, che però non ebbe nulla di rivoluzionario, sia perché l'apparato statale e molte leggi rimasero in vigore, sia perché la direzione delle masse popolari fu assunta dai socialdemocratici di destra, sia perché la chiesa cattolica si schierò apertamente dalla parte della borghesia.
Tuttavia proprio in Austria fu creato, il 3 novembre 1918, il primo partito comunista dell'Europa occidentale.
Sulle ceneri dell'impero austro-ungarico si erano formati molti Stati indipendenti: Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia (Serbia, Croazia e Slovenia); la popolazione polacca si poté riunire ai propri connazionali le cui terre erano state inglobate dalla monarchia; la Transilvania tornò alla Romania; alcune zone del litorale settentrionale dell'Adriatico si unirono all'Italia; gli ucraini dell'Austria orientale lottarono per l'unificazione dell'Ucraina "sovietica".
Purtroppo, in seguito ad accordi iniqui con gli imperialisti dell'Intesa, non pochi danni furono compiuti contro altre popolazioni: p.es. alla Polonia fu data l'intera Galizia, compresa l'Ucraina occidentale; alla Cecoslovacchia fu data l'Ucraina transcarpatica; alla Romania la Bucovina settentrionale, che invece voleva unirsi con l'Ucraina "sovietica"; alcune zone abitate da slavi furono date all'Italia.
Ma quel che è peggio è che in tutti i nuovi Stati nazionali i frutti della lotta delle masse contadine e operaie vennero raccolti solo dalla borghesia, appoggiata dai capi opportunisti della socialdemocrazia e dalle potenze dell'Intesa.
Le rivoluzioni proletarie proseguirono solo, nel 1919, in Slovacchia e in Ungheria, dove più forti erano le tradizioni secolari di guerre di liberazione nazionale.
Qui va detto che sia la Russia del 1917 che l'Ungheria del 1918 rappresentavano l'anello più debole dei paesi imperialisti europei, in quanto il loro potere si basava prevalentemente sui grandi proprietari fondiari, che dominavano sin dal Medioevo.
(1) Il partito socialdemocratico ungherese era stato fondato da Leo Frankel, che aveva partecipato alla Comune di Parigi e che era stato amico di Marx. La sua influenza sulle masse operaie, molto sindacalizzate, era notevole. (torna su)