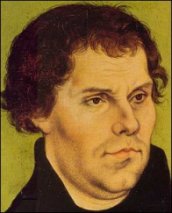|
|
LA RIFORMA PROTESTANTE
Dalla riforma della chiesa
|
|
LA LIBERTA' UMANA in Erasmo e in Lutero
I - II


“Il padre rialza il suo bambino, ancora incapace di camminare, che è caduto e gli fa vedere un frutto per attirarlo; ma la debolezza delle sue membra è tale che egli cadrebbe ancora se suo padre non gli tendesse la mano per sostenerlo e guidare i suoi passi. Così, condotto dal padre, il figlio arriva al frutto che il padre gli dà volentieri come ricompensa della sua camminata. Il bambino non avrebbe potuto rialzarsi se suo padre non l’avesse sostenuto, non avrebbe visto il frutto se suo padre non glielo avesse mostrato, non avrebbe potuto avanzare se suo padre non l’avesse continuamente aiutato nel suo incedere traballante e non avrebbe potuto prendere, infine, il frutto se suo padre non glielo avesse messo nelle mani. Che cosa potrà dunque attribuire a sé il bambino? Ha tuttavia fatto qualcosa, ma non può vantarsi delle proprie forze dato che deve a suo padre tutto ciò che egli è”.[1]
C’è in questa bella immagine tutto quel che il cristiano umanista Erasmo può fare per avvicinarsi a Lutero.
Siamo molto lontani dall’umanesimo classico e rinascimentale, quello dell’uomo artefice del proprio destino, ma non abbastanza per avvicinarci a Lutero: il bambino, per quanto dipendente dal padre, ci mette del suo e si guadagna in parte, sia pur minima, il frutto. La libertà umana è molto limitata e incerta, come il movimento di un bambino ai suoi primi passi, ma c’è, anche se promossa dalla protezione divina.
Il merito umano è in Erasmo ridotto al minimo, ma c’è.
Scrive Erasmo: “Quella forza dell’anima mediante la quale noi giudichiamo, e non importa che tu preferisca chiamare nous, cioè mente o intelletto, oppure logos, il peccato l’ha oscurata, certo, ma non l’ha spenta”.[2] E ancora: “La nostra libertà di scelta, ancorché ferita dal peccato, non è stata distrutta e, benché sia stata distorta al punto da farci inclinare piuttosto verso il male che verso il bene, almeno fino a quando non riceviamo il soccorso della grazia, tuttavia non è sparita”. E, più avanti: “Pretendere che le facoltà più notevoli della natura umana siano state corrotte a tal punto da far sì che noi non possiamo far altro che ignorare e odiare Dio e che, pur giustificati per la grazia della fede, nessuno possa far altro che peccare, è dare un’importanza esagerata al peccato originale”.[3]
Non bisogna esagerare, perdere il senso della misura.
“Mentre siamo interamente occupati a cantare le lodi della fede, dobbiamo guardarci dal rovinare il libero arbitrio perché, se venisse ad essere cancellato, io allora non vedo come si potrebbero risolvere le questioni della giustizia e della misericordia divine”.[4] Se, infatti, si azzera la libertà e la conseguente responsabilità umana, Dio diventa responsabile anche del male che fa l’uomo. Se Dio salva alcuni senza alcun merito e lascia al loro destino di dannati altri non responsabili, la sua misericordia diventa incomprensibile per la nostra ragione. Ci vuole, quindi, misura. Ma nei conflitti è difficile mantenere il senso della misura.
Infatti: “Il conflitto con Pelagio ha reso Agostino meno giusto nei confronti del libero arbitrio di quello che era prima. Quanto a Lutero egli aveva incominciato col riconoscere un certo ruolo al libero arbitrio, ma il calore della discussione lo trascinò a togliergli ogni valore. Ma mi ricorda a questo proposito che i Greci rimproveravano, credo, a Licurgo, nel suo odio contro l’ubriachezza, di aver fatto sradicare i vigneti mentre avrebbe potuto, facilitando l’accesso alle fontane, bandire l’ubriachezza e mantenere parimenti l’uso del vino”.[5]
In chiusura, Erasmo scrive: “Senza dubbio Pelagio è stato troppo largo nei confronti del libero arbitrio e Scoto ancor più, ma Lutero ha cominciato con il mutilarlo amputandogli il braccio destro, poi non contento di questo risultato lo ha sgozzato e interamente annullato. In quanto a me, preferisco la dottrina di quelli che concedono qualcosa al libero arbitrio pur riconoscendo il potere più grande alla grazia. Non era quindi necessario evitare lo scoglio di Scilla dell’orgoglio per cadere nello scoglio di Cariddi … Teniamoci dunque alla soluzione di mezzo … C’è pur qualche merito, ma bisogna riconoscere che se lo si è conquistato lo si deve a Dio … Mi si potrà dire: a che serve il libero arbitrio se non può far nulla da solo? Mi limiterò a rispondere: e a che cosa servirebbe l’uomo tutto intero se Dio agisse con lui come il vasaio con l’argilla o se Dio agisse su di lui come potrebbe agire su una pietruzza?”.[6]
Misura, dunque, ma non per sola ripugnanza per gli estremismi: c’è il ballo l’idea di uomo, che Erasmo non intende degradare a cosa, a semplice materiale di lavorazione divina. Egli può vestire di umiltà cristiana la dignità umana, celebrata dall’umanesimo, ma non può accettarne l’annullamento. Così come non può accettare che, di conseguenza, “le questioni della giustizia e della misericordia divine” diventino umanamente incomprensibili.
Questo è il punto cruciale: per Lutero Erasmo guarda alla giustizia divina con occhi umani, mentre lui non ha difficoltà ad esaltare l’onnipotenza divina che sottrae l’azione divina ad ogni criterio di ragionevolezza umana. Per Erasmo c’è parentela, familiarità tra la ragione umana e quella divina, per Lutero Dio è onnipotenza assoluta. Per riconoscerla non ha difficoltà a negare la “dignità” umanistica all’uomo.
Nel rapportarsi a Dio Erasmo si immagina come il bambino del tutto dipendente dal padre ma fatto a sua somiglianza, capace di capire la sua parola e di riconoscere la sua giustizia. Per Lutero il peccato di Adamo sembra aver cancellato questa somiglianza e ridotto l’uomo a una bestia da soma nel bel mezzo della lotta tra Dio e Satana: “ La volontà umana è stata posta nel mezzo, come una bestia da soma. Se la cavalca Dio, vuole e va dove Dio vuole … Se invece la cavalca Satana, vuole e va dove Satana vuole. E non è nella sua facoltà scegliere o cercarsi uno dei due cavalieri, bensì sono i cavalieri a combattersi l’un l’altro per ottenerla e possederla”.[7]
Bambino bisognoso di ogni cura paterna, ma simile al padre, o bestia da soma in balia di cavalieri in conflitto.
Per Lutero è intollerabile che si misuri con metro umano la giustizia divina, che si porti Dio in tribunale e lo si esponga al giudizio della “Signora Ragione, quella cosiddetta umana”.
“Pretendono qui che Dio agisca in base al diritto umano e faccia quello che sembra a loro giusto; o, altrimenti che cessi di essere Dio. I misteri della sua maestà non gli serviranno a nulla; che renda piuttosto giustizia del perché è Dio o del perché vuole o compie ciò che non ha nessuna parvenza di giustizia – quasi che si citasse in giudizio un calzolaio o un fabbricante di cinture. La carne non ritiene Dio degno di tanto onore da credere che egli sia giusto e buono quando dice e compie cose che vanno al di là delle definizioni contenute nel Codice di Giustiniano o nel quinto libro dell’Etica di Aristotele.
Che la maestà divina, creatrice di ogni cosa, si sottometta alle feci di una sua creatura!”[8]
Due concezioni dell’uomo e di Dio incompatibili.
“Dio è incessantemente attivo in tutte le sue creature e non le lascia mai a riposo” ma non è responsabile del male che esse compiono: “Dio opera il male in noi – cioè attraverso di noi – non per colpa sua, bensì per nostra mancanza. Noi siamo per natura malvagi, Dio invece è buono; quando, grazie alla natura della sua onnipotenza, ci trascina con la sua azione, per quanto egli sia buono, con uno strumento cattivo non può fare che il male, sebbene, nella sua sapienza, faccia buon uso di questo male per la sua gloria e per la nostra salvezza. Allo stesso modo, trovandosi di fronte alla volontà cattiva di Satana (non però creandola così, ma perché è divenuta cattiva in seguito all’abbandono di Dio e ai peccati di Satana), Dio la afferra con la sua azione e la spinge dove vuole, anche se tale volontà non cessa di essere malvagia in virtù di questa azione divina”.[9]
“Ma resta ancora la possibilità che qualcuno obietti: perché Dio non sospende questo movimento della sua onnipotenza, da cui la volontà degli empi è spinta a rimanere malvagia e a divenire peggiore? La risposta è la seguente: questo vuol dire desiderare che Dio cessi di essere Dio a causa degli empi; tu desideri infatti che sospenda il suo potere e la sua azione, ovvero che cessi di essere buono, affinché gli empi non divengano peggiori.
Perché allora non trasforma le volontà malvagie che mette in movimento? Questo appartiene ai segreti della maestà divina, dove «inscrutabili sono i suoi giudizi» [Rom, 11, 33]. Né sta a noi indagare questi misteri, bensì adorarli. Se poi la carne e il sangue si sentono scandalizzati e mormorano, ebbene lasciamoli mormorare; tanto non servirà a nulla, né Dio perciò cambierà. E se molti empi si ritrarranno indietro scandalizzati [Giov. 6,66], resteranno gli eletti.
Lo stesso si risponderà a quanti domandano: perché Dio ha permesso la caduta di Adamo? E perché ci fa nascere macchiati tutti dal medesimo peccato? Avrebbe potuto salvare Adamo e creare noi da un’altra materia, oppure dopo che quel seme fosse purificato”.[10]
La risposta l’abbiamo già incontrata[11]: per la volontà divina non c’è nessuna causa o ragione che possa essergli prescritta come regola o misura.
[1]Erasmo – Lutero, Libero arbitrio Servo arbitrio, ed. Claudiana, Torino 2009, pag. 108.
[2] Ibidem, pag. 60.
[3] Ibidem, pag. 111.
[4] Ibidem, pag. 106
[5] Ibidem, pag. 107
[6] Ibidem, pag. 113-4
[7] De servo arbitrio, 635
[8] Ibidem, 729
[9] Ibidem, 711
[10] Ibidem, 712
[11] “A ciò si risponde: egli è Dio e per la sua volontà non esiste nessuna causa o ragione che possa essergli prescritta come regola e misura, dal momento che non esiste nulla a lui uguale o superiore. Se infatti per tale volontà esistesse qualche regola o misura, o qualche causa o ragione, allora non potrebbe più essere la volontà di Dio. Ciò che Dio vuole è giusto non già perché egli deve o ha dovuto volere così; ma al contrario: ciò che accade deve essere giusto perché egli vuole così. Si può prescrivere una causa e una ragione alla volontà della creatura, ma non alla volontà del Creatore – a meno che tu non gli anteponga un altro creatore”.
Fonte: ANNO ACCADEMICO 2010-11 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO
Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999.
Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.
Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.
Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf)
Plotino (pdf)