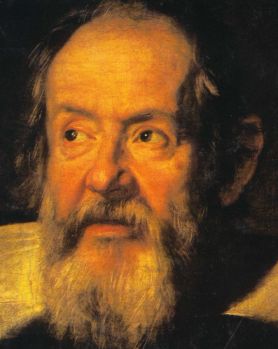|
|
CIVILSKUL
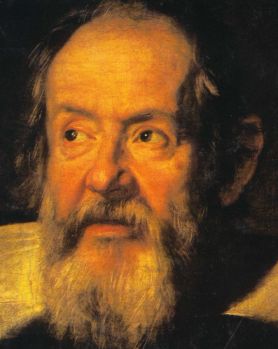 Progetto per favorire lo sviluppo della democrazia nella scuola
1. Premessa generale
Che definizione possiamo dare alla parola
“civiltà”?
Quali sono le caratteristiche salienti che ci permettono di
individuare (nella storia passata ma anche nel presente) una “civiltà”?
Quand'è che una persona o un atteggiamento della persona può essere
considerato “civile”?
Quali modalità possiamo utilizzare per far comprendere ai nostri
allievi quando si può parlare di “civiltà” e quando no?
2. Occasioni da cui partire
L'ingresso degli alunni stranieri nelle
classi comporta una modifica del linguaggio e del comportamento.
Fai un elenco delle espressioni verbali che un immigrato
potrebbe considerare “incivili” e che quindi non dovrebbero più essere
usate.
Fai un elenco degli atteggiamenti che un immigrato potrebbe
considerare “incivili” e che quindi non dovrebbero più essere usati.Le forme di indisciplina possono essere
occasione per stabilire un codice di autoregolamentazione del
comportamento da parte della classe?
E' fattibile che una classe si dia delle regole di comportamento
civile per se stessa (con l'aiuto del docente)?
E che queste regole vengano sottoposte all'approvazione dei genitori?
E che la violazione di queste regole possa comportare delle sanzioni
unanimemente condivise? (o condivise da un'ampia maggioranza?)
Quali possono essere i campi d'intervento per queste regole?
(rapporti tra coetanei, rapporti tra i sessi, rapporti tra coetanei di
diversa provenienza geografica, etnia, lingue e religioni, rapporti tra
coetanei con o senza handicap).
Quali sono le modalità per monitorare l'efficacia delle regole di
comportamento civile e per rivedere il loro contenuto e le forme
applicative?
E' fattibile che il docente assegni dei compiti di responsabilità
agli allievi in rapporto al grado di rispetto del codice di
autoregolamentazione?Esiste un codice di autoregolamentazione
degli impegni o dei doveri di responsabilità cui ogni componente
della classe è tenuto? (regole per l'attribuzione di compiti, di
verifiche, di valutazioni…)
In sintesi: la classe può diventare un luogo in cui si
esercita la democrazia?Le forme di rappresentanza democratica
degli studenti negli organi istituzionali della scuola di
appartenenza possono essere considerate adeguate all'esigenza di
partecipazione democratica espressa dagli studenti?
Che cosa si può fare perché questa esigenza si sviluppi e si
manifesti in maniera adeguata?Che cosa si può fare perché la scuola diventi
un luogo di formazione e di educazione ai valori civili non solo
per gli studenti ma anche per i genitori e per il territorio locale?
In sintesi: la scuola può diventare un luogo in cui si
esercita la democrazia?Se in una scuola esiste un organo di
stampa gestito da docenti e studenti o dai soli docenti o dai soli
studenti, quali sono le regole democratiche che la redazione si è data
per la stesura degli articoli?Se in una scuola esiste una rete interna o un
collegamento a una rete esterna, in cui sia possibile comunicare con
qualcuno, usando la strumentazione più varia o comunque quella
disponibile (email, chat, forum, mailing list ecc.), i soggetti della
comunicazione conoscono le regole fondamentali di una comunicazione a
distanza?
Si sono dati un codice o utilizzano quelli a disposizione nel web?
3. Sviluppo teorico
- Competenze disciplinari
- Nello studio storico delle civiltà quali sono
gli argomenti che il docente usa per dimostrare che una determinata
organizzazione sociale o determinati comportamenti umani possono essere
considerati “civili” o che rientrano nel concetto di “civiltà”?
- Si è mai trovato il docente a dover riflettere sul concetto di
“civiltà” così com'esso veniva formulato dal libro di testo?
- Ha mai svolto il docente una ricerca particolare sul concetto di
“civiltà”?
- E' in grado di docente di stabilire con relativa sicurezza che
l'oggetto del suo insegnamento è coerente col concetto di “civiltà” in
cui egli crede?
- Quali sono per le proprie discipline o
contenuti disciplinari d'insegnamento: Educazione fisica, Musica,
Religione, Educazione tecnica, Educazione civica, Letteratura, Scienze,
Lingue, Educazione artistica, Economia, Diritto ecc. le condizioni per
le quali si può sostenere che l'affronto di una determinata disciplina o
contenuto disciplinare favorisce lo sviluppo di una civiltà?
- E' possibile elencare degli esempi in cui si
illustra come nello studio di una determinata disciplina un'espressione
teorica o un comportamento pratico possono essere considerati favorevoli
allo sviluppo di una civiltà?
- Quali sono le categorie fondamentali con cui
oggi noi attribuiamo il termine “civile” o “civiltà” a determinate forme
di pensiero o di comportamento?
- E' possibile, utilizzando delle coppie di
termini contrapposti, stabilire dei criteri di comportamento “civili”
validi per ogni tempo e luogo? P.es. Amore/Odio, Amicizia/Inimicizia,
Giustizia/Ingiustizia, Verità/Falsità, Tolleranza/Intolleranza,
Rispetto/Prevaricazione ecc.
4. Mezzi e strumenti di lavoro
Raccolta dei fondamentali testi (filosofici,
politici, giuridici, religiosi, etici…) che utilizziamo per definire il
concetto di “civiltà”.Raccolta di esempi di comportamenti e di
espressioni verbali dei personaggi della storia (universale e locale).Raccolta di esempi di comportamenti, di
espressioni verbali o testi scritti dei nostri allievi.Raccolta di esempi tratti dai libri di testo,
giudicati accettabili o discutibili, in riferimento alla comprensione di
un concetto “umano” o “democratico” di civiltà.
5. Modalità operativa
Realizzazione di un portale dinamico,
interattivo, in cui si raccolgano i materiali prodotti e si possa
discuterci sopra, in qualunque forma e con qualunque mezzo.Realizzazione di un motore di ricerca interno
in cui sia possibile trovare qualunque occorrenza a qualunque parola
digitata.Produzione dei materiali in qualsivoglia
forma digitale, multimediale o ipertestuale.
6. Forme di valutazione
Test sul processo di apprendimentoSondaggi di gradimentoRiflessione in itinere da parte degli
insegnanti sui processi di lavorazione dei materiali e sulle motivazioni
dell'agireRiflessione di bilancio sulle conclusioni del
progetto
Bibliografia
- D. Defoe,
Robinson Crusoe
- J. Swith,
Viaggi di Gulliver
- D. Diderot, Lettera sui ciechi per l'uso di quelli che vedono
- D. Diderot, Lettera sui sordi e sui muti per l'uso di quelli che intendono e parlano
- D. Diderot, Supplemento al viaggio di Bougainville
- J.-J. Rousseau,
Discorso sull'origine della disuguaglianza
- J.-J. Rousseau,
Emilio o dell'educazione
- Plutarco di Cheronea,
L'arte di ascoltare
- M. Morgan,
E venne chiamata due cuori, Sonzogno (sugli aborigeni australiani)
- Papalagi di Tuiavii di Tiavea
www.millelireonline.it/SchedeMOL/2_papalagi/papalagi.pdf
- M. Vargas LLosa, Il narratore ambulante, Rizzoli (sugli indios dell'Amazzonia)
- Kuki Gallman,
Notti africane, Mondatori (sui Masai)
- S. Onori, Vite di riserva, Teoria (sui Lakota)
- R. Menchu,
Mi chiamo Rigoberta Menchu, Giunti (sui Maya)
- L. Sepulveda,
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Guanda (sugli indios
dell'Amazzonia)
- Lettura trasversale dei miti dei popoli antichi
- La lettura del pianeta attraverso le mappe geografiche (le tesi di Peters)
|