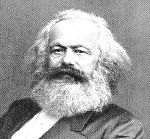|
|
MARX-ENGELS
|
|
FRIEDRICH ENGELS
Era nato a Barmen, in Renania, nel 1820. Suo padre, un industriale tessile, non gli fece neppure terminare il ginnasio per poterlo mandare a lavorare dapprima nel suo ufficio commerciale, in seguito (nel '37) a Brema per fare un tirocinio economico presso un console che gestiva un'importante ditta di esportazioni. Non si iscrisse quindi all'università e venne educato in un clima rigidamente pietistico.
A Brema si lega al movimento letterario della Giovane Germania, che subiva l'influsso di Heine e Börne, nonché dei giovani hegeliani con le loro discussioni sulla religione. Nel '39, sul Telegrafo per la Germania, pubblica un articolo dal titolo Lettere dal Wuppertal, in cui descrive le condizioni di vita miserevoli, la diffusione del misticismo e dell'alcolismo nel suo ambiente natìo, elencando i dati sulle malattie professionali dei tessitori, sul lavoro dei fanciulli, sull'ipocrisia pietistica degli imprenditori, che impiegano i bambini più piccoli dando loro i salari più bassi. Ciò che soprattutto lo infastidisce è l'oscurantismo dei pietisti e dei mistici, che impediscono la lettura dei romanzi, la frequenza ai concerti, lo studio della scienza e della filosofia, l'applicazione alle arti, le simpatie per l'illuminismo...
A detta di Engels, fu proprio il direttore del Telegraph, Gutzkov, a imprimere un carattere politico, di impegno sociale, al movimento della Giovane Germania, sulla base delle idee liberali giusnaturalistiche e costituzionali, della partecipazione popolare all'amministrazione dello Stato, dell'emancipazione degli ebrei e, più in generale, della libertà di coscienza e di religione. Nel '39, leggendo Strauss, Engels comincia a dubitare della fede religiosa, rinunciando anche alle posizioni mistiche di Schleiermacher. Grazie a Strauss pensa di cominciare a studiare la filosofia hegeliana.
Agli inizi del '41 scrive un importante articolo sul "Telegraph", parlando di un certo E. Arndt, un antico oppositore di Napoleone, costretto dapprima a fuggire dalla Germania, per poi rientrarvi al momento della guerra di liberazione. Engels aveva considerato positivo non solo il fatto d'essersi liberati, in quanto tedeschi, dal giogo straniero, ma anche il fatto che il popolo si fosse ribellato senza aspettare il permesso dei sovrani, anzi costringendo quest'ultimi a capeggiare l'insurrezione. Il miglior risultato di quegli anni -scrive Engels- fu che, dopo la guerra, gli uomini che avevano assunto un atteggiamento più consapevole e risoluto, parvero alquanto pericolosi ai governanti prussiani. Engels evidenzia anche che Napoleone aveva realizzato cose significative, come l'emancipazione degli ebrei, l'istituzione delle giurie, l'introduzione del Codice civile, ecc., per cui il monarchismo indifferenziato di Arndt, secondo cui è sufficiente che tra principi e sudditi vi sia un reciproco impegno per il benessere del paese, appare ad Engels molto equivoco, in quanto tale impegno, perché diventi giusto, deve essere regolato dal diritto e non dalle buone intenzioni o dalle manifestazioni di moralità (ovviamente Engels non si riferiva alla scuola storica tedesca del diritto, per cui il sovrano, qualunque cosa facesse, restava inamovibile).
Alla fine del '41 Engels si reca a Berlino per prestare servizio militare. Nel tempo libero frequenta come uditore i corsi universitari e si avvicina al circolo dei giovani hegeliani. Pur rimproverando ad Hegel di non aver capito la rivoluzione parigina del 1830, si entusiasma per i suoi principi filosofici (soprattutto per la dialettica), ma ne rifiuta le conclusioni illiberali. Accetta la filosofia baueriana dell'autocoscienza. Scrive un articolo e due opuscoli contro Schelling. Per Engels, come per i giovani hegeliani, Hegel aveva concluso il ciclo filosofico iniziato con Cartesio: ora il problema era diventato quello di innalzare tutta la Germania alle migliori conquiste dell'hegelismo. In tal senso la posizione di Schelling, che cercava d'introdurre la fede, il misticismo, la mitologia e la fantasia gnostica nella filosofia, andava -secondo Engels- decisamente condannata, per evitare di riportare la filosofia ai livelli pre-hegeliani. Se il mondo non è razionale, è il mondo che va cambiato, non la filosofia. Schelling, secondo Engels, non ha avuto il coraggio di dirlo, portando così avanti un'opposizione persa in partenza. Per Engels è attraverso la filosofia dell'autocoscienza che il mondo può essere cambiato. E' con questo spirito che dal '42 comincia a collaborare alla "Gazzetta renana".
Sempre nello stesso anno scrive un saggio su Federico Gugliemo IV, re di Prussia, pubblicato nel volume miscellaneo di Herwegh, Ventun fogli dalla Svizzera, che uscì nel '43, con contributi di Bauer, Strauss, Hess e altri. Engels sottolinea che l'opinione pubblica è interessata soprattutto a due cose: la costituzione parlamentare e la libertà di stampa (ottenuta la seconda sarà facile ottenere la prima. Ottenute entrambe sarà facile rompere l'alleanza con la Russia).
Il '42 fu importante per Engels per altre due ragioni: la prima perché conobbe di persona Hess alla redazione della "Gazzetta renana" di Colonia, maturando, dopo quell'incontro, delle precise convinzioni comuniste; la seconda perché si trasferì in Inghilterra per lavorare nella filanda di Manchester di comproprietà del padre. Durante il viaggio deviò di nuovo per Colonia, dove s'incontrò per la prima con Marx; ma, dato che Engels, durante il suo soggiorno berlinese, era stato legato al gruppo dei "Liberi", coi quali Marx aveva avuto serie divergenze, l'incontro ebbe carattere alquanto distaccato.
La vita in Inghilterra diede moltissimo a Engels. Egli prese a studiare con grande interesse la situazione degli operai, frequentando le riunioni dei cartisti, stringendo legami con i leaders dell'ala sinistra del loro movimento, come pure con esponenti socialisti seguaci di R. Owen, e collaborando alla loro stampa. Conobbe inoltre i capi della sezione londinese della Lega dei Giusti.
Studiando la struttura economica e statale dell'Inghilterra, Engels arrivò alla conclusione che alla base delle lotte politiche vi fossero degli interessi materiali. Egli scoprì il carattere di classe sia dei partiti politici che dello Stato inglese, e individuò nel proletariato cosciente la forza più progressista.
Nell'estate del '42 i cartisti avevano organizzato un grande sciopero, ma il governo, reagendo con durezza, lo fece fallire. Questo e altri episodi fecero maturare ad Engels la convinzione che in quella situazione una rivoluzione pacifica era impossibile. Se a tale conclusione gli inglesi non erano ancora arrivati, dipendeva dal fatto che consideravano lo Stato e la legge al di sopra delle parti, ma Engels prevedeva che una generale disoccupazione del proletariato, e quindi il timore di dover morire di fame, avrebbe sicuramente portato a una rivoluzione sociale, non semplicemente politica, dettata cioè da interessi concreti, materiali, non da principi astratti, teorici, cui gli inglesi per tradizione erano refrattari. La lotta della democrazia contro l'aristocrazia in Inghilterra era già una lotta dei "poveri" contro i "ricchi", per cui -dice Engels- era impossibile un'alleanza politica della borghesia col proletariato. Come si può vedere, anche Engels, come Marx, vedeva nella rivoluzione politica un momento poco significativo rispetto alla rivoluzione sociale. Entrambi cioè erano convinti che il proletariato, messo di fronte a situazioni di estrema indigenza, avrebbe trovato da solo, in se stesso, spontaneamente, la forza per ribellarsi, senza bisogno d'essere guidato da un partito specifico.
Nei Lineamenti di una critica dell'economia politica, un lungo saggio apparso nel numero unico degli "Annali franco-tedeschi", Engels gettava le basi di una critica scientifica dell'economia politica borghese e quindi del capitalismo. Marx ne restò fortemente impressionato. In effetti, Engels rilevò che la prassi della libera concorrenza teorizzata da Smith, Mill, Malthus, Ricardo e Say, era penetrata in tutti gli aspetti della vita inglese portando a perfezione la reciproca schiavitù degli uomini: ovvero, lotta dei capitalisti fra loro per accaparrarsi il mercato, salario dei lavoratori ridotto al minimo, conflitto dei lavoratori tra loro, crisi economiche di sovrapproduzione, rovina assoluta di chi dispone di pochi capitali, di piccoli possessi fondiari, di scarsa professionalità, concentrazione della proprietà e formazione dei monopoli, ecc. Tutte le contraddizioni -dice Engels- nascono dalla separazione originaria del capitale dal lavoro, cioè dalla scissione dell'umanità in capitalisti e lavoratori. Queste contraddizioni potrebbero essere risolte eliminando la proprietà privata e organizzando razionalmente la produzione, in modo che i produttori conoscano esattamente i bisogni dei consumatori.
Oltre a questo importante saggio, Engels ne aveva spedito un altro dall'Inghilterra per gli Annali franco-tedeschi: La situazione dell'Inghilterra, che conteneva parecchie notazioni sociologiche sulla rivoluzione industriale. Egli inoltre evidenziava il fatto che i socialisti inglesi conoscevano, dello sviluppo filosofico euroccidentale, solo il materialismo francese, ignorando completamente la filosofia tedesca.
Praticamente Engels, in Inghilterra, era giunto alle stesse conclusioni di Marx in Francia. Lui stesso ricorderà che quando, ritornando nell'estate del '44 in Germania, fece visita a Marx a Parigi, risultò che concordavano in tutti i campi della teoria. Da quell'incontro cominciò il loro stretto lavoro comune.
IL GIOVANE ENGELS
Annali Franco-Tedeschi. Abbozzo di una critica dell'economia politica
Il giovane Engels era molto più severo nei confronti del capitalismo di quanto non lo fosse nella maturità. Quando scrive negli Annali che "il sistema delle fabbriche e la schiavitù moderna non è per nulla inferiore all'antica per inumanità e crudeltà...", esprime senza dubbio un giudizio etico incontestabile, ancorché non storicamente documentato.
"Dietro la farisaica umanità dei monopolisti si nasconde una barbarie che gli antichi non conoscevano" - dice ancora.
Tuttavia, nella maturità, quand'egli avrà occasione di fondare tale giudizio storicamente, il giudizio etico diventerà più sfumato, molto meno categorico. L'Engels maturo considerava il capitalismo una inevitabile barbarie, frutto di una necessaria evoluzione storica, e quindi, sotto questo aspetto, un progresso rispetto allo schiavismo antico o al servaggio feudale.
L'approfondimento storico portò a indebolire il giudizio etico di riprovazione. Questo atteggiamento fu una conseguenza del fatto che il marxismo occidentale non riuscì a organizzare alcuna rivoluzione politica.
Viceversa, ai tempi degli Annali, e fino al '48, questa speranza era stata molto forte nei giovani comunisti tedeschi.
Va tuttavia detto che già nel giovane Engels vi era la tendenza a considerare come necessaria una determinata evoluzione della civiltà occidentale, in quanto che egli ha sempre visto come un progresso indiscutibile il passaggio dal clericalismo feudale al panteismo borghese e quindi all'ateismo comunista.
Egli cioè -e in questo trovò ampi consensi da parte di Marx- sacrificò sul terreno del progresso ideologico quelli che potevano essere stati i meriti del feudalesimo rispetto al capitalismo. Quanto, in questo atteggiamento semplicistico, fu determinante il peso della tradizione luterana tedesca, che senza volerlo aveva avviato un processo verso il superamento della religione in sé (e non solo della religione cattolico-romana), è facile immaginarlo.
I tedeschi dell'800, specie la sinistra hegeliana, si vantavano di essere approdati all'ateismo esplicito, razionale - cosa che in quel momento non si era verificata in maniera altrettanto radicale in nessun'altra parte d'Europa, neppure nella Francia rivoluzionaria, dove alla religione cristiana si cercò di sostituire una religione laica della ragione.
Resta comunque straordinario il fatto che Engels avesse già piena consapevolezza dei limiti del capitalismo in età giovanissima, prima ancora dello stesso Marx, il quale iniziò l'analisi economica solo in un secondo momento.
Non solo, ma egli addirittura pose subito un nesso - condiviso poi da Marx - tra economia borghese e religione cristiana: cosa che però né l'uno né l'altro ha mai approfondito con un'analisi di tipo culturale, anche se Marx molto meno di Engels.
Con la sua incredibile perspicacia, Engels riuscì a porre le basi di quella che si può considerare la scienza prossima ventura, e cioè lo studio delle motivazioni culturali (e quindi religiose) che hanno non solo giustificato ma anche favorito il processo di transizione dall'economia schiavistica a quella feudale e da questa a quella borghese: ed è la scienza delle transizioni.
Uno studio approfondito di questo nesso, che è in fondo l'esame di un intreccio non esplicito tra elementi strutturali e sovrastrutturali, deve ancora essere fatto. Non si tratta semplicemente di una sociologia della cultura (o della religione), poiché l'oggetto di studio principale resta sempre la società nel suo complesso e non la cultura (o la religione, che di tutte le manifestazioni culturali resta la più importante), e non è neppure una scienza o una storia dell'economia, in quanto la nuova scienza escluderà a priori l'ipotesi che possa esistere uno sviluppo autonomo dell'economia senza un contestuale sviluppo della cultura, che di quella economia è espressione e insieme ispirazione. Tra struttura e sovrastruttura esiste un nesso di reciproca dipendenza.
Non è neppure una storia della civiltà, poiché la scienza delle transizioni non potrà limitarsi ad affrontare il nesso dal punto di vista politico-istituzionale o, al contrario, dal punto di vista del minimalismo quotidiano.
All'ordine del giorno non devono essere posti i ruoli istituzionali della cultura (o della religione) nei confronti dei poteri politici, siano essi statali o no. O, al contrario, gli aspetti folcloristici, rituali della cultura, che è quasi sempre cultura religiosa.
Ciò che va studiato è il legame causale tra riflessione culturale ed evoluzione dei rapporti sociali. Di questi rapporti l'economia è solo un aspetto, come la religione è un aspetto della cultura. Si tratta, beninteso, di un legame causale reciproco.
I due campi privilegiati della nuova scienza storica dovranno essere il sociale, che include l'economico, il tecnologico, il materiale, il rapporto con l'ambiente, l'organizzazione della vita civile, del lavoro ecc. E il culturale, che sta ad indicare qualunque riflessione intellettuale fatta intorno a determinati problemi.
P.es. lo studio del dibattito sugli universali, svoltosi negli ambiti universitari medievali, dovrà cercare di verificare quali possibili conseguenze pratiche poteva aver quel dibattito sui rapporti sociali. E' stato fatto uno studio del genere oppure si è preferito tenere separata l'analisi filosofico-teologica da quella economico-sociale?
Senza considerare che il nesso di "sociale" e "culturale" va poi rapportato al "politico", in quanto la politica trae forza da ciò che la precede, anche se, successivamente, può determinare, col peso della sua autorità, lo svolgimento degli aspetti socio-culturali.
Non dovrà più esistere separazione tra scienze umane e scienze esatte. Anzi, non dovranno esistere neppure le "scienze umane", in quanto esisterà un'unica scienza, quella dell'essere umano, che si autoconcepisce come soggetto integro, organico, unitario.
La contrapposizione dovrà essere tra scienza unitaria e scienze separate, o, se vogliamo, tra scienza dell'uomo e scienze dei poteri, tra scienza della verità e scienza degli interessi (i quali trasformano la verità in opinioni): in una parola, tra co-scienza e in-coscienza.