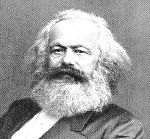|
|
MARX-ENGELS
|
|
La simpatia per Marx
Veniamo subito al punto: Marx è simpatico (per lo meno a chi scrive) per il suo senso umanitario. Questo senso si trasforma in umanistico alla fine di un lungo viaggio intellettuale.
La lunghezza in questione non è data da chissà quali complicazioni riflessive, ma dalle complicazioni esistenti nel concetto di vita sociale sedimentato storicamente.
Queste complicazioni sono vere e proprie montature psicologiche determinate dall’instaurazione oligarchica nel sistema sociale sin dalla notte dei tempi. L’evoluzione dell’oligarchia ha seguito l’evoluzione materiale, adattandosi alle situazioni senza mai tralasciare principi oppressivi nei confronti dei privi di potere decisionale in quanto esclusi dall’accesso alla gestione dei beni prodotti. L’oligarchia si spiega antropologicamente con estrema facilità: essa si rifà al potere del più forte. I presunti realisti sostengono che non può esserci altra via, l’umanità sarebbe fatta così. Il più forte è colui che prende e che provvede al sostentamento dei più deboli. La generosità è un mezzo, non è un fine: i più deboli operano per sostenere la forza che li tiene in vita, che fa funzionare l’intero sistema. La forza è un totem che provvede, teoricamente, a tutto e a tutti.
Nelle pieghe di queste convinzioni avvengono lotte immaginarie per un più sicuro possesso del bene, non per la gestione relativa a monte. La massa si rivolge all’oligarchia più a portata di mano, cercando di entrare a farvi parte. La critica soprattutto perché ne è esclusa. Così fa l’oligarchia bassa nei confronti di quella meno bassa. Il culmine è rappresentato da chi decide, riservandosi, oneri ed onori: se è capace avrà più attenzione nei confronti dei primi che dei secondi. Nel tipo di società che conosciamo maggiormente, l’individualismo si muove cercando di avvalersi di una copertura corporativa. Nel fondo, è comunque l’individuo a voler prevalere: egli non si batte per la corporazione che rappresenta a meno che non gli convenga e finché gli conviene.
Una vergogna sociale di questo genere si manifesta con l’avvento della borghesia al potere. Mentre i poteri arcaici, Impero e Chiesa, ragionavano comunque in termini generali, la borghesia punta invece e decisamente al particolare, e cioè al proprio esclusivo interesse. E’ la rivoluzione industriale a scatenare gli appetiti borghesi, ovvero gli appetiti di una oligarchia attiva che di fatto ha preso il comando del sistema sin dai tempi di Napoleone. Questa oligarchia si caratterizza molto bene. Il vertice è rappresentato da speculatori finanziari che si muovono senza regole, se non quella di fare denaro e aumentare il proprio potere a tutti i costi. Essi sono animati elusivamente da interessi spiccioli, la soddisfazione dei quali viene elevata ad efficace panacea di tutti i mali. Non esistono programmi a lunga scadenza, tanto meno strategie sociali avanzate. La politica, i governi, sono praticamente loro emanazioni e dunque non c’è censura per quanto riguarda il loro agire, singoli eroi a parte.
La qualità di vita proposta dal nuovo sistema retrocede alla preistoria. Né mancano consulenze richieste all’uomo di Neanderthal. L’Ottocento è un secolo glorioso per l’industria: peccato che la gloria costi alla massa dei lavoratori sofferenze inenarrabili, privazioni, miseria, malattie, morti precoci e infami. I lavoratori erano trattati come animali, più tardi, nel ‘900, come animali da macello, carne da cannone (vedi le due guerre mondiali).
Ma restiamo nel ‘800 e leggiamo le molte denuncie relative alle condizioni della mano d’opera da parte di osservatori compassionevoli: per brevità, uno su tutti, Charles Dickens che direttamente e indirettamente evidenzia l’orrore delle fabbriche del tempo. E’ in questo clima compassionevole che si forma la personalità di Marx. Il suo “Capitale”, scritto di getto e corretto “al volo” dal suo sodale Engels, è un monumento alla pietas che l’autore prova per la terribile situazione civile che l’Europa sta vivendo a favore di un pugno di capitalisti, vale a dire a favore di oligarchi spregiudicati e impunibili.
Marx alza un grido di dolore e di indignazione per tutto questo, mascherando i suoi più veri sentimenti sotto la coltre di una razionalità capace di rendere oggettiva la protesta e plausibile la reazione. Il filosofo non si cura più di tanto dei veri motivi e delle vere cause dell’affermazione capitalista. La sua protesta va fuori della storia per cause umanitarie, vale a dire per un’autentica sofferenza spirituale dovuta alla visione del degrado dell’uomo catturato dalla macchina produttiva. La sua sofferenza spirituale non va verso la constatazione del degrado umano completo, di un degrado, cioè, che coinvolge, ovviamente, anche gli aguzzini, con quel che ne consegue in termini di virtù umane.
Marx, con la sua iniziativa, va a sostituire praticamente il ruolo della Chiesa nella trattazione della personalità umana e del relativo rispetto, nel nome del concetto di umanità che la Chiesa moderna ha perso di vista, ritirandosi nel potere temporale come un principato qualsiasi. Il filosofo si rifà involontariamente al Vangelo, predicando laicamente la solidarietà umana. La scelta laica, e dunque la condanna della religione convenzionale, è fatta spontaneamente per dare concretezza all’operazione catartica che egli intende proporre. Marx vuole andare ben oltre la solita dichiarazione astratta di principi, vuole costruire un proprio sistema che stia oggettivamente in piedi.
Che l’operazione possa riuscire non è una preoccupazione reale per Marx, per quanto ci sia realismo nelle sue parole e nei suoi concetti. Questo realismo è tuttavia soggetto ad un idealismo acuto ed incisivo, radicato nell’animo di molti intellettuali del tempo: non dimentichiamo l’atmosfera romantica allora presente in opposizione al positivismo, peraltro volgarizzato dalla borghesia.
Comte, il padre del positivismo, raccomandava un’assunzione di responsabilità sociale da parte di coloro che stavano realizzando il nuovo mondo positivo, e cioè concreto, libero da gravami metafisici, completamente a disposizione dell’uomo (ma non senza responsabilità generali: Comte ragionava come un buon padre, confidando in figli comprensivi e orgogliosi di se stessi).
La vera visione di Marx si proietta nel futuro. Il sistema cambierà quando l’uomo si renderà conto della bontà della proposta: il marxismo non deve imporre, ma convincere.
Certo, Marx ha fretta, per lo meno ce l’ha a parole. Vuole superare il risentimento che prova per l’ingiustizia sociale cui è costretto ad assistere, “dipingendo” il nuovo mondo e partendo da tinte forti. Chiaramente e utopicamente egli predica la rivoluzione, guidata da intellettuali bene attrezzati mentalmente: la rivoluzione è il primo passo verso il cambiamento. Il secondo è la presa di potere da parte dei proletari, capitanati dai soliti intellettuali attrezzati mentalmente. Il terzo è l’abolizione della classi e quindi l’abbattimento delle oligarchie. Il quarto è il potere al popolo, intendendo come popolo qualunque cittadino.
Ovviamente, non essendoci più classi, non sussistono più contrapposizioni classiste. Marx sogna la fratellanza umana, sogna l’umanità coesa, ma non certo piatta. Solidale, piuttosto.
La solidarietà comporta l’aiuto reciproco a seconda delle proprie possibilità e delle necessità altrui. Lo sviluppo sociale marxiano si affida, quindi, alle virtù dianoetiche, non a quelle fisiche, muscolari, sulle quali si reggeva, dichiaratamente, la sua epoca.
Il ricorso alla spregiudicatezza e alla risoluzione energica propugnate da Marx è la risposta alla classica vessazione dei più forti verso i più deboli, storicamente lordata di sangue e di impunità. Il filosofo concepisce in modo ordinato un risentimento istintivo, fatto di desiderio di punizione esemplare: a ben vedere, il fenomeno, essendo figlio di filosofia, è più ideale che materiale: diventerà materiale nelle mani di presunti epigoni marxiani, in concomitanza con crisi sociali inaspettate o provocate o aiutate a manifestarsi: tutte e tre le cose insieme, per quanto riguarda la rivoluzione russa.
Più specificatamente, l’eversione portata avanti da Marx e sancita nero su bianco nel “Capitale” fu interpretata come un vero e proprio placet ad agire nella direzione più opportuna a salvaguardia degli interessi popolari. Al popolo, non interessava tanto la visione ideale del manifesto marxista, quanto l’invito a “spezzare le proprie catene” e prendere ciò che il capitalista teneva ingiustamente per sé. Questa ingiustizia si ricavava dalle condizioni di vita cui il capitalista stesso costringeva il lavoratore, profittando della inurbazione disordinata e quindi della numerosa mano d’opera disponibile. Il concetto di classe operaia consentiva un’unione di intenti, favorita, ovviamente, dalla medesima piattaforma di miseria sulla quale ogni lavoratore si trovava. Le cose cambieranno, e la classe operaia resterà soltanto una parola, con il relativo benessere intervenuto a seguito di lotte comuni, ma in contesti diversi: il capitalista riuscirà ad avere ragione degli appetiti individuali, blandendoli opportunamente e assicurandosi il potere in altro modo. Ma qui si riparla del futuro. Il presente, subito dopo Marx, è roseo per i lavoratori anche per il riconoscimento da parte del sistema dell’importanza dei lavoratori stessi come consumatori: un riconoscimento che darà scatto significativo alla macchina industriale.
Sul piano filosofico, che è quello più importante per quanto riguarda il pensiero di Marx, va detto che il filosofo tedesco era immerso in un’atmosfera culturale caratterizzata da Illuminismo e, appunto, Idealismo (moderno). Il primo, l’Illuminismo, era per la razionalità e per l’assunzione di consapevolezze oggettive, con tanto di responsabilità piena: l’uomo si ritrovava così al centro del mondo con l’intera sua corporeità. La rivoluzione industriale terrà conto di questa investitura e farà il bene e il male che conosciamo. L’Idealismo moderno corona filosoficamente l’Illuminismo. Marx acquisisce da Hegel principalmente questo input: la tesi di Hegel è epocale, una volta spogliata dei suoi orpelli verbali, di certe sue infatuazioni. Essa si rivolge con attenzione particolare alla personalità umana, alla figura dell’uomo, alla una intelligenza. Affermando che cioè che è reale è razionale e viceversa, Hegel eleva la positività, l’oggettività ad unico fattore esistente. La divinità, nel sistema di Hegel, viene sfumata, allontanata a favore della sensibilità umana. La trascendenza, con lui, non ha più una ragione d’essere importante, tanto meno determinante come, direttamente e indirettamente, è ancora in Kant. L’idea di Hegel sconvolge psicologicamente il mondo di allora, permettendo all’uomo di sentirsi protagonista diretto della sorte propria e di quella del mondo intero.
Finisce la sudditanza psicologica nei confronti della trascendenza e soprattutto termina il potere occulto della religione. La filosofia di Hegel ufficializza la caduta dei valori religiosi applicati alla vita di tutti i giorni. La caduta era già un portato inarrestabile della rivoluzione industriale.
Il materialismo moderno – vale a dire il successo dell’uomo sulla natura, un successo assai meno relativo che in passato – diviene un riferimento assoluto e assolutamente rassicurante, in quanto “tangibile”, al posto di quello religioso, spirituale ed astratto, cioè incontrollabile. Comincia seriamente una divisione netta fra mondo laico e mondo religioso: il primo deve costituire per sé una base solida, materializzando, per così dire, i contenuti delle lezioni morali che la Chiesa ha dispensato per secoli, tenendo unita la società e dando dei valori etici cui aspirare per una sana crescita civile (a parte sta una realtà più dura che recita potere ecclesiastico come quello laico, ma gli animi furono più colpiti dal primo aspetto della Chiesa).
E’ il protagonismo hegeliano ad infondere coraggio a Marx e a consentirgli di scendere in campo, nelle vicende sociali, benché egli viva ai margini del sistema. Nella sua discesa in campo egli trascina l’intero proletariato, legittimandolo attraverso la rivelazione umanistica di Hegel.
D’altro canto, la rivelazione umanistica di Hegel va a coprire il buco psicologico creato dalla sconfitta dell’efficacia religiosa nelle cose dell’uomo. La sconfitta è causata dalla rivoluzione industriale, ovviamente. Il ruolo umano diventa, quindi, principale nella visione del mondo ed Hegel ratifica questo passaggio. La questione spirituale viene assunta, nel contempo, dal movimento romantico con conseguenze dirette nella trattazione delle problematiche sociali. Marx indossa entrambe le vesti: è razionale ed è sentimentale. Consapevolmente nel primo caso, da cui il suo piglio deciso, e inconsapevolmente nel secondo, agendo comunque con tutte e due le ispirazioni, specialmente con la seconda in quanto provocata dalla prima in termini di sistemazione sociale partendo da sottozero. Voglia o non voglia, il filosofo tedesco del comunismo è legato alla preoccupazione di umanizzare ciò che è umano, ma che è tenuto in condizioni disumane. La sua pietas è sì razionale, ma lo è in funzione sentimentale. Lo stesso vale per Mazzini, ma in Mazzini prevale un sentimento edulcorato a sfavore di un senso realistico che invece Marx arriva a possedere in sommo grado.
Il sentimento del filosofo tedesco è puro ed è partecipato sino in fondo. Sino al punto di indurre il filosofo ad analisi economiche che di fatto vanno oltre le sue competenze.
L’errore basilare di Marx, nel suo impeto egualitario, è la prossima morte del capitalismo per auto asfissia. La storia ha dimostrato tutt’altro, ha evidenziato una capacità di adattamento alle varie situazioni da parte del capitalismo. Questa capacità capitalistica ha consentito l’evoluzione dell’economia e ha determinato un certo progresso. Si tratta di risultati esclusivamente materiali, significativi di una mentalità prona verso l’ottenimento del bene (rivalsa dalle antiche privazioni) e prigioniera di attribuzioni miracolistiche (ma il miracolo è umano) al risultato raggiunto.
Il capitalismo – traducibile in individualismo (una caratteristica elementare umana) – non è mai entrato veramente in crisi e mai vi entrerà, in quanto ha sempre fatto pagare i suoi errori, le sue esagerazioni (e così continua a fare) alla massa che, con la sua varia attività, alimenta il sistema. La massa riceve a discrezione dal vertice, ma il vertice non usa alcuna discrezionalità con la massa: non la rispetta. La massa si è battuta e si batte non per avere il potere, ma per cavare maggiori risorse dal sistema. L’oligarca ha quindi mano libera su qualsivoglia strategia operativa. E’ la formula vincente con la quale è stata abbattuta ogni opposizione e umiliato l’Idealismo.
Naturalmente l’abbattimento autentico dell’oppositore al sistema capitalistico è stato quello relativo al cosiddetto comunismo sovietico. Parlare di comunismo per quanto riguarda il regime di Stalin (ma, poi, da nessuna parte il comunismo è stato sinora realizzato) è un’assurdità. Correttamente, la visione di Marx prevede un mondo perfetto (o perfettibile, partendo da basi “giuste”): in questa perfezione non può esserci posto per l’obbligo all’adozione di una causa, qualunque essa sia.
D’altra parte, la storia non può essere cambiata di colpo. Marx ha un punto di partenza, ma questo punto di partenza ha un passato con cui deve fare i conti, non è una cosa improvvisa. L’impeto catartico marxiano non prende in esame le situazioni precedenti a fondo e neppure quella contemporanea, se non da un punto di vista emotivo. L’emozione è forte ed incisiva, chiama in causa la ragione, ma entrambe non bastano a giustificare un cambiamento repentino come quello che l’indignazione di Marx vorrebbe realizzare. Questa indignazione serve ad intellettuali frustrati per dare il via a manifestazioni di stampo comunista: ma il fenomeno si ferma alle soglie del comunismo, in quanto si avvale delle esortazioni marxiane a fare la rivoluzione tramite nuclei di cacciatori ben preparati, capaci di addestrare la “truppa”.
La fretta, l’entusiasmo, la voglia di menare le mani, l’odio di classe, causano le limitazioni di questi messaggeri rivoluzionari, provocando una vera e propria involuzione rivoluzionaria, scatenante una evoluzione, sempre rivoluzionaria, su basi improprie rispetto ai dettami di Marx (da qui l’involuzione). La massa non viene affatto preparata al nuovo vangelo, ma istigata allo scatenamento della forza bruta finalmente libera di manifestarsi. Si accenna alla rivoluzione russa che, contrariamente alle previsioni del filosofo tedesco, è una rivoluzione agraria, non industriale: lo zarismo è in grave crisi, gli stati europei brigano per la sua caduta (specie i tedeschi) nella speranza di un’uscita della Russia dalla guerra mondiale (la prima ovviamente), un pugno di ardimentosi, capitanati da Lenin, vengono foraggiati e incoraggiati a dare l’ultima spallata allo zar: vinse il comunismo o vinse il superamento di una crisi? Certo, la speranza in un mondo migliore. Sotto certi aspetti fu così (la Russia e poi Urss fece un balzo di qualche secolo con Lenin e Stalin) ma a realizzare tutto questo, con ricorso a crudeltà enormi, fu un regime, fu una dittatura e non certo la dittatura del proletariato, ma di una manciata di uomini che governò con il terrore. La dottrina Stalin, poi, è quanto di meno comunista ci sia perché il dittatore georgiano non voleva esportare il comunismo, ma imporlo. Il programma di Marx esce stravolto e sconvolto da tutto ciò e il personaggio viene infamato.
Molti concludono dicendo che il comunismo è un’utopia. La cosa è sicura in quanto, come si diceva, il comunismo è frutto di una teoria filosofica alimentata da una preoccupazione pratica di tipo pietistico (ma di una pietas ad alto livello), non di un’analisi storica rigorosa. Resta il fatto che, al di là delle molte chiacchiere intorno a Marx (troppe e confuse per chi scrive, malate di retorica e di protagonismo esteriore), egli rimane un esempio raro di umanità. Un’umanità sfociante in un Umanesimo edificante per stima profonda nei confronti dell’uomo. Tutto questo non glielo toglie nessuno. Chapeau!