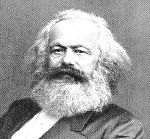|
|
MARX-ENGELS
|
|
I FATTORI STORICI DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO
Abbiamo visto (cfr. precedente articolo: Il "determinismo storico" marxiano) che l’organizzazione economica è il perno attorno al quale ruotano gli aspetti non economici della vita sociale, e che essa è in gran parte (per la maggior parte) prodotto diretto delle tecniche produttive che vi sono a base, laddove gli altri aspetti costitutivi di tale organizzazione (forza-lavoro, ambiente… ovvero, in sostanza, le altre forze produttive) ricoprono un ruolo solo marginale (seppure, come vedremo, non inesistente) come fattori determinanti di tale organizzazione. Essi cioè, pur facendone indiscutibilmente parte, come variabili e componenti costitutive, non sono in linea di massima capaci di determinarla attivamente, di darle forma, non quantomeno nei suoi aspetti essenziali.
– Priorità (relativa) della tecnica e dell’economia –
Con questo però, è bene chiarirlo, non si vuole assolutamente dire che l’organizzazione economica dipenda solo dalle tecniche produttive, ma che dipende direttamente soprattutto da esse e indirettamente (anche se spesso in modo sostanziale) da altri fattori, tra i quali ad esempio quelli ambientali o la forza-lavoro concretamente disponibile in un dato sistema. Perché diciamo “indirettamente”? Perché, anche qualora questo secondo tipo di fattori ricopra un ruolo essenziale nel determinare la struttura tecnica e, attraverso essa, economica della società, è lo sviluppo tecnologico della produzione ciò che impronta direttamente di sé la sfera economica (cioè l’organizzazione sociale della produzione), così come attorno all’organizzazione economica si organizza la società nei suoi aspetti non economici (sovrastrutturali).
Spesso quindi, i fattori sopra citati sono secondari solo in ultima istanza, potendo in realtà essere la causa scatenante delle trasformazioni tecnico-produttive e, attraverso queste, delle stesse strutture economiche della società.
Se ad esempio guardiamo alla Mesopotamia e all’Egitto, laddove sorsero le prime forme tecnicamente integrate di produzione sociale, nonché quindi di organizzazione economica centralizzata (potere amministrativo del sovrano e dei funzionari), ci accorgiamo di come una tale forma di organizzazione strutturale fosse la reazione umana a un ambiente particolare, la cui produttività agricola dipendeva fortemente dalle canalizzazioni idriche, che potevano essere realizzate, appunto, solo attraverso un’organizzazione tecnico-produttiva fortemente integrata. E' chiaro come, in questo caso, specifici fattori ambientali abbiano ricoperto un ruolo primario nel definire l’organizzazione tecnica della produzione (basata sulla collaborazione e la specializzazione, piuttosto che sul lavoro individuale) e con essa, di conseguenza, la sfera economica della società (basata sulla contrapposizione tra una casta amministrativa e dirigistica dominante, a una massa di lavoratori manuali a essa asserviti).
Il punto centrale per comprendere la società nei suoi vari aspetti è quindi, sempre, l’economia, a sua volta prodotto delle tecniche produttive. Ma tale sfera tecnico-produttiva non sempre si sviluppa esclusivamente da se stessa, sulla base di un astratto processo di auto-avanzamento, potendo al contrario essere anche influenzata o addirittura determinata da fattori di altra natura (storici, ambientali, ecc.) Qualora questi fattori, che condizionano il divenire storico dell’organizzazione produttiva, siano poi a loro volta il prodotto indiretto di quell’organizzazione (cioè non si presentino rispetto a essa come fattori meramente casuali) si potrà parlare di una retroazione e quindi di un processo dialettico circolare (causa -> effetto che è a sua volta causa di -> effetto sulla causa originaria).
La storia è piena di questi effetti di ritorno (delle sovrastrutture sulla struttura, dell’ambiente sull’economia, ecc.) che ne costituiscono una componente essenziale, nella misura in cui appunto possono contribuire a determinare la stessa struttura tecnico-produttiva della società. Purtuttavia, quest’ultima è e rimane la chiave di volta per comprendere la società nei suoi diversi aspetti, anche qualora (peraltro molto spesso) sia a sua volta in gran parte prodotto di fattori a sé estrinseci.
– Una visione sistemica, non lineare, della storia –
Bisogna infine notare, come società giunte a un medesimo livello di sviluppo tecnico (che quindi dispongono concretamente degli stessi mezzi produttivi) possano dare vita a organizzazioni economiche e sociali più o meno diverse tra loro. Ad esempio, Egizi e Mesopotamici svilupparono entrambi un’economia centralizzata, come espressione di tecniche produttive fortemente integrate (canalizzazioni e lavori pubblici) richiedenti una rigida gerarchia decisionale (convergente nel sovrano e nei poteri amministrativi statali). Eppure l’economia egizia si sviluppò in forme decisamente più centralizzate rispetto a quella mesopotamica, dove vi fu un più rigoglioso sviluppo dell’iniziativa e del capitale privati, e dove il potere dirigistico del sovrano fu maggiormente bilanciato da quello sacerdotale.
A cosa si deve ascrivere allora una tale differenza di organizzazione economica (peraltro relativamente lieve, qualora ad esempio si paragonino queste realtà a quella privatistica greca, rispetto a esse radicalmente differente), se si considerano tali affinità di fondo nell’organizzazione tecnica della produzione? Tale differenza non potrà essere fatta risalire a ragioni tecniche, dal momento che i livelli delle due civiltà in questione erano a questo proposito in sostanza equivalenti, ma dovrà essere attribuita ad altri fattori (ad esempio a ragioni ambientali (…quali ragionevolmente la maggiore uniformità territoriale e il radicale isolamento dell’Egitto, che resero la struttura interna di tale stato più organica e meno dispersiva rispetto a quella delle città-stato mesopotamiche?), piuttosto che a diverse tradizioni di governo (sovrastrutture) sviluppatesi nel corso dei secoli, ecc.)
E' sbagliato insomma, o quantomeno discutibile, voler fare risalire tutti i caratteri dell’organizzazione economica ai caratteri tecnico-produttivi della società, ma è un fatto che tale organizzazione sia da ascrivere in primo luogo e nei suoi caratteri essenziali a essi, e in seconda battuta (magari proprio per rendere conto della relativa diversità di popoli accomunati per il resto da un medesimo modo di produzione) ad altri fattori.
Così, la visione marxiana della storia umana si basa sull’idea che ogni fattore o piano di essa possieda (quantomeno in potenza) un’intrinseca capacità di influenzare tutti gli altri, secondo una visione sistemica e disordinata, più che lineare e deterministica (quale quella di Hegel, che vedeva ogni fase storica come il prodotto di quella storicamente e logicamente precedente). E tuttavia, in un tale bilancio, alcune priorità di fondo si impongono: a) quella delle tecniche alla base della produzione come cause fondamentali dell’organizzazione economica da una parte, e b) quella di quest’ultima come causa principale degli aspetti sovrastrutturali dall’altra.
– I fattori alla base delle trasformazioni tecnico-economiche delle società umane –
Restano da definire ora, nel dettaglio, quelli che sono i fattori capaci di determinare la trasformazione tecnico-economica delle società umane (ovvero la trasformazione interna dei singoli modi di produzione o, al limite, il passaggio dall’uno all’altro di essi).
Si può ipotizzare che l’uomo, per sua natura, conosca un naturale impulso verso il miglioramento delle condizioni materiali della propria esistenza. Per questo, vi è una tendenza innata della specie umana a progredire nella conoscenza della realtà e, ancor più in profondità, nella capacità di dominarla e piegarla ai propri fini esistenziali, di benessere e sicurezza materiali.
Di conseguenza, possiamo dire che, in mancanza di ragioni storiche che spingano in senso opposto a questo, la specie umana sia caratterizzata da un innato impulso verso il progresso tecnologico e scientifico (del resto, la stessa religione, oggi chiaramente relegata al ruolo di “anti-scienza”, costituì nelle sue fasi iniziali un tentativo dell’uomo di spiegare la realtà naturale circostante, di interagire con essa e soprattutto di piegarla al proprio volere: si pensi al significato politico del culto degli dei tra gli antichi, ai culti propiziatori, ecc.)
Ciò che vogliamo trattare qui avanti è perciò: a) la natura dei fattori storici capaci di favorire, accelerare, frenare o addirittura determinare un arretramento delle conoscenze tecnico-scientifiche in un dato contesto tecnico-produttivo; b) la relazione tra i singoli modi di produzione e il progresso tecnologico, ovvero quanto il singolo modo di produzione possa, per sua stessa natura, favorire o sfavorire un tale progresso.
(a) I fattori perturbanti la struttura tecnico-produttiva di un sistema economico
In primo luogo analizziamo i fattori capaci di perturbare (in senso progressivo o, più facilmente, regressivo) un sistema economico dato. Intendiamo con ciò l’insorgere, all’interno di uno specifico modo di produzione, di fattori non previsti, capaci a volte di determinarne la fine, e con essa la nascita di una nuova organizzazione economica.
Questi fattori possono essere suddivisi in due tipologie: fattori estranei all’organizzazione su cui vanno a impattare, quindi fattori o avvenimenti (solitamente di lunga durata) non generati da tale organizzazione; fattori la cui origine è, in parte o del tutto, ascrivibile come effetto di ritorno alla stessa organizzazione su cui finiscono per incidere.
In questo secondo caso, si può parlare di un processo dialettico, non casuale, nella misura in cui il sistema pone la propria antitesi (crisi), la quale facilmente si risolve poi in un suo superamento, ovvero nella nascita di un nuovo modo di produzione. Nel caso precedente invece, possiamo dire che la storia sia interamente mossa dal Caso, dall’imponderabile. Anche riguardo al secondo tipo di fattori però, non possiamo parlare del dispiegarsi di una logica aprioristica, determinabile secondo criteri rigidi, validi in modo assoluto a prescindere dal contesto storico particolare. Ci troviamo quindi in una sorta di “regno intermedio” tra determinismo e pura casualità storica.
In che categorie storiche possiamo fare rientrare i fattori qui enunciati? Ovviamente in tutte, tranne che in quella delle forze tecniche, che ne sono infatti influenzate esternamente. Tutto ciò che non rientra in tale categoria, ovvero ciò che non appartiene agli strumenti tecnici alla base della produzione, può dunque esercitare un’influenza su di essi, determinandone una trasformazione estrinseca, la cui origine non risiede cioè in tali forze e/o nel sistema socio-produttivo che ne è espressione a livello economico.
Possiamo dividere questo insieme di fattori in tre categorie:
1- eventi storici generici (ad esempio, l’incontro o lo scontro con popolazioni giunte a un diverso grado di sviluppo tecnico, capaci di influenzare – come si è detto, in avanti o, più spesso, indietro – il livello tecnologico della società in questione);
2- il cambiamento delle forze produttive non tecnologiche, ovvero dei fattori ambientali, sociali, della forza-lavoro, ecc. (trasformazioni climatiche e ambientali, spesso peraltro prodotto delle stesse attività produttive, mutamenti nella popolazione, nella possibilità di approvvigionamento delle materie prime alla base del processo produttivo, ecc. possono modificare per ragioni di forza maggiore le stesse tecniche produttive, cambiando di conseguenza anche l’assetto economico di una società);
3- le sovrastrutture (sia politico-istituzionali, sia ideologiche – in particolare religiose) grazie alla loro peculiare capacità di guidare i comportamenti umani, quindi a volte di inibire alcuni possibili sviluppi di carattere tecnico e produttivo, considerati illeciti, in favore di altri.
(b) Modi di produzione e innovazione tecnologica
Questi tre tipi di fattori possono dunque, nelle loro pressoché infinite declinazioni storiche, alterare (accelerandolo, bloccandolo, o determinandone addirittura un regresso) il naturale impulso delle forze produttive in direzione di un sempre maggiore sviluppo tecnico, ovvero di sempre maggiori efficienza produttiva e prosperità materiale.
Tuttavia, sarebbe fuorviante credere che, in tutti i modi di produzione, le forze tecniche conoscano, almeno tendenzialmente, un incremento quantitativamente equivalente. Al contrario, ognuno di essi è caratterizzato, in linea di massima, da potenziali di sviluppo molto diversi, funzione del minore o maggiore dinamismo e della minore o maggiore apertura al cambiamento, nonché della più o meno strutturale esigenza d’implementazione dei mezzi alla base della produzione.
Si può dunque parlare, anche qui, di un effetto retroattivo: in questo caso dell’economia rispetto agli aspetti tecnologici e produttivi, dal momento che questi ultimi, pur generando il modo di produzione economico-sociale, ne sono poi a propria volta influenzati. Del resto, non si deve assolutamente trascurare (come si è già detto) l’effetto che le stesse sovrastrutture possono avere in questo processo, ma con l’osservazione preliminare che esse sono pur sempre espressione delle strutture economiche e che, di conseguenza, tale fattore è in gran parte subordinato alle prime in quanto da esse derivato (e ciò anche se, a volte, le sovrastrutture possono conoscere un’evoluzione almeno in parte autonoma rispetto alla struttura economica, e esercitare quindi un’influenza ad essa non totalmente riconducibile.)
Se si eccettua l’ultimo modo (socialista/comunista) del tutto ipotetico, i modi produttivi individuati da Marx, peraltro storicamente confermati, sono essenzialmente cinque: quello primitivo o selvaggio (caratterizzato dall’assenza della sovrastruttura politica detta Stato); quello dispotico o asiatico; quello schiavile;quello feudale; quello borghese.
1- Il primo modo, selvaggio o tribale, è caratterizzato da un’organizzazione socio-economica basata sulla famiglia, ovvero sull’aggregazione di più famiglie imparentate tra loro (tribù) ed è privo di una reale divisione o specializzazione del lavoro. In esso, il progresso tecnico deve ancora iniziare, per così dire. E non in tutti casi esso inizia, quantomeno nella forma da noi intesa. Vi sono moltissimi esempi di società rimaste ferme fino a poco tempo fa a un tale stadio di organizzazione economica, e da esso uscite solo in seguito all’incontro con civiltà più progredite (ovvero, secondo la casistica prima enunciata, a causa di fattori storici fortuiti e a sé estrinseci).
Di solito, i fattori che portano a un’evoluzione di tali comunità verso forme di organizzazione più avanzate sono costituiti da un insieme di ragioni ambientali (ad esempio, quelle alla base della nascita della civiltà mesopotamica) e/o da un lento processo di crescita della popolazione (spesso risultato, a sua volta, di un graduale miglioramento delle tecniche produttive). Tale crescita infatti, determina l’esigenza di un’implementazione della produzione, che si realizza attraverso forme di organizzazione del lavoro maggiormente specialistiche e quindi con la nascita di una struttura economica e politica verticistica.
In molte popolazioni poi, come si è appena detto, tale processo di emancipazione è stato accelerato o addirittura avviato dal contatto con altre popolazioni che avevano già superato lo stadio tribale primitivo.
Infine, ma non in ultimo, può esservi un naturale e autonomo processo di avanzamento tecnologico, il quale tuttavia, spesso, non basta da solo a determinare la fine di tale stadio (come dimostra la storia di tante popolazioni mondiali, rimaste per millenni “ferme” ad esso).
2- Lo stadio dispotico e quello feudale possono, almeno in questa sede, essere trattati assieme, a causa delle profonde affinità strutturali che li caratterizzano.
Entrambi sono infatti caratterizzati da una struttura sociale ed economica conchiusa in se stessa, verticistica, laddove però il feudalesimo ripropone tali caratteri “in piccolo” (cioè nell’ambito di piccole comunità dominate da un signore locale, coadiuvato da una forza militare, più che amministrativa, che costituisce la base del suo potere di riscuotere i tributi della manodopera agricola) e il dispotismo asiatico “in grande” (cioè nell’ambito di stati territoriali a volte enormi, come i vari imperi persiano, cinese, ecc., caratterizzati da un sovrano coadiuvato nell’esercizio del suo dominio da un’immensa macchina amministrativa e militare).
In entrambi questi contesti, la natura chiusa e conservativa dell’organizzazione economica (basata tendenzialmente sulla ripetizione di attività prestabilite che si svolgono secondo modalità a loro volta prefissate, spesso cristallizzatesi in tradizioni, e divenute col tempo vere e proprie leggi o istituzioni sociali) determina in linea di massima uno sviluppo tecnologico quantitativamente modesto.
Vi è tuttavia anche una profonda differenza tra questi due modi di organizzazione produttiva. Le grandi corti asiatiche infatti, hanno a disposizione (data la vastità dei territori da cui possono riscuotere i propri tributi) immense ricchezze, che possono poi reinvestire in varie attività, tra le quali la ricerca tecnico-scientifica. Per questo le civiltà orientali, e dispotiche in genere, hanno conosciuto nel corso dei secoli progressi sul piano tecnologico (e più in generale, in ambito culturale e spirituale) che spesso danno loro lustro ancora oggi.
Più modeste sono invece le possibilità materiali dei castelli feudali, nonché quindi la loro capacità di sviluppo tecnico. (Non a caso, di solito, le civiltà feudali sono conseguenza del regresso di società più prospere e tecnicamente evolute verso forme di organizzazione decisamente più barbare e primitive – un discorso che vale tanto per il medioevo europeo e cristiano, quanto, ad esempio, per quello greco-egeo del cosiddetto Periodo oscuro).
3- La società schiavile, essenzialmente (e non solo marginalmente) basata sulla contrapposizione tra una consistente (a volte, ma non sempre, maggioritaria) fascia di proprietari agricoli e imprenditori urbani e una vasta classe di lavoratori privi di diritti (tra cui di solito, le stesse libertà fondamentali), possiede caratteri che per molti aspetti la avvicinano alla società borghese moderna, ma per altri la distanziano da essa.
La struttura essenzialmente anarchica (privatistica, in termini giuridici) della proprietà e della produzione, porta infatti un consistente sviluppo dell’iniziativa privata, anche e non in ultimo di carattere commerciale, nonché quindi una strutturale esigenza da parte dei singoli produttori di incrementare la propria produzione, tra l’altro perché spesso in competizione tra loro (concorrenza commerciale).
Una tale esigenza di sviluppo tecnico-produttivo (tipica di molte società aperte, dinamiche e socialmente competitive, soprattutto laddove tale competizione segua in gran parte i binari della concorrenza di mercato) si scontra tuttavia con la presenza di una vasta classe di schiavi, base appunto della tecnologia di un tale modo di produzione.
In un tale tipo di organizzazione economica difatti, finalità essenziale per il produttore/imprenditore non è tanto l’implementazione tecnologica (lo sviluppo di nuovi macchinari) quanto piuttosto l’approvvigionamento di sempre nuova forza-lavoro schiavile. Nonostante dunque, il fattore competitivo sia insito, ed anzi spesso economicamente e ideologicamente prioritario, in tali tipi di contesti, il loro coefficiente di sviluppo tecnologico è fortemente limitato dalla centralità della manodopera schiavile, ovvero dalla loro peculiare struttura tecnico-produttiva.
4- Infine, ultima in ordine di sviluppo, è la società borghese, ovvero il modo di produzione capitalistico moderno.
Come il precedente, anche questo modo di produzione sociale è caratterizzato dalla netta prevalenza della dimensione privata e anarchica rispetto a quella statale o pubblica (dirigismo economico). Anche qui il mercato e la concorrenza privata sono fattori centrali, di più anzi che nel modo precedente, dal momento che la produzione è oramai pressoché totalmente finalizzata al commercio.
La grande differenza tra questi due modi produttivi risiede nella tecnologia alla loro base, che in quest’ultimo caso non ha come fondamento il lavoro schiavile ma il lavoro libero, salariato. L’assenza (per motivi anche culturali, ideologici) dell’uso di forza-lavoro schiavile comporta un diverso atteggiamento dell’imprenditore nei confronti della tecnologia, vista come elemento centrale della produzione, e oggetto perciò di continui investimenti e di ricerca sistematica.
La tecnologia (lo sviluppo della produzione su basi tecnologiche) diviene così il pilastro stesso di una tale forma di organizzazione economica, totalmente basata sulla concorrenza di mercato. Si crea cioè un’alleanza strategica tra mercato (capitalismo) e avanzamento tecnico, laddove ogni imprenditore cerca, (anche) attraverso il miglioramento degli strumenti alla base della propria produzione, di guadagnare nuove fette di mercato a spese della concorrenza.
In questo contesto socio-produttivo quindi, l’esigenza strutturale di avanzamento tecnico giunge ai suoi livelli più avanzati, divenendo il pilastro stesso del funzionamento economico della società. Senza un investimento sistematico nella crescita tecnologica, la concorrenza capitalistica di mercato (basata su grandi quantità di merci, che necessitano appunto di una produzione di carattere industriale) non potrebbe assolutamente sussistere.
Per questo la società borghese costituisce, rispetto a tutte le organizzazioni economiche precedenti, quella di gran lunga più avanzata tecnologicamente, e quella i cui sviluppi tecnologici sono decisamente più consistenti e rapidi.
Alcuni pensatori (non solo Marx) prevedono peraltro che i futuri sviluppi dell’attuale produzione industriale finiranno per rendere obsoleta l’organizzazione economica borghese, in quanto il movente dell’accumulazione capitalistica diventerà rispetto a essi non più un incentivo bensì, al contrario, un freno. Sarà allora necessario alle forze tecniche alla base della produzione, per continuare ad avanzare, liberarsi di tale prigione, sviluppando una nuova forma di organizzazione economica.
Secondo Emanuele Severino, la società che sorgerà da tale superamento sarà caratterizzata da un’organizzazione economica schiettamente tecnocentrica, nel senso che l’esigenza di avanzamento tecnico fine a se stessa, non più asservita alle logiche economiche del capitalismo, diventerà la vera protagonista di questo nuovo modo di produzione sociale.
Una volta di più dunque, l’avanzare delle forze tecniche alla base della produzione renderà necessario un radicale cambiamento di paradigma economico (modo di produzione), al fine di rendere possibile il concreto espletamento di tali forze.