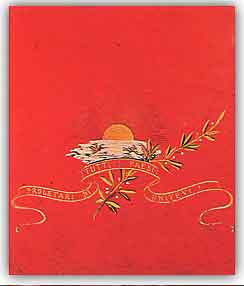|

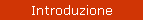
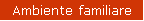
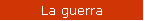
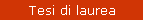

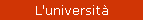
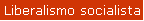
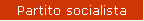
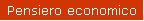

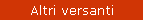

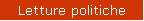


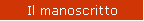

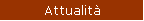
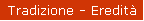

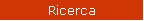
| |
CONCLUSIONI
Attualità del socialismo liberale
Nell’introduzione alla prima edizione di “Socialismo liberale”, scritta
all’incirca venti anni fa, Norberto Bobbio sosteneva che le idee espresse da
Carlo Rosselli nel saggio di Lipari erano tutt’altro che morte. Rinasceva
nell’ambito stesso della sinistra con maggior forza la domanda: <<Come
riaffermare le irrinunciabili esigenze dei principi fondamentali del liberalismo
senza rinnegare il socialismo come fine?>>. Il libro di Rosselli era stato un
tentativo di rispondere a questa domanda.
La sconfitta storica dell’Unione Sovietica ha favorito in questi ultimi anni
la ripresa del dibattito sulle forme di socialismo alternativo a quello che
aveva avuto la sua prima compiuta attuazione storica nell’Unione Sovietica.
|
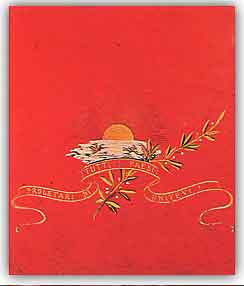 |
Il dibattito di questi anni ha confermato la sostanziale differenza tra
l’interpretazione rosselliana del socialismo liberale e quella, più corrente nel
dibattito teorico – politico, in cui la congiunzione di due concezioni della
storia e della prassi politica, considerate per lunga tradizione antitetiche,
avviene nella forma di una sintesi dottrinale o di un compromesso pratico, come
una nuova formula politica. Rosselli non si propone il problema di trovare una
conciliazione tra due opposte dottrine: per lui il socialismo, una volta
liberato dall’involucro dottrinale, il marxismo, che sinora lo aveva irrigidito
in un sistema filosofico imposto ed accettato dogmaticamente, è la
continuazione, il perfezionamento, l’ultima fase, del processo d’emancipazione
dell’uomo, di cui il primo momento è rappresentato dal pensiero liberale e dalla
sua attuazione storica nel riconoscimento pubblico dei diritti della persona
umana, avvenuto attraverso le rivoluzioni americana e francese.
Dopo la caduta del comunismo storico sono spuntati qua e là nel nostro paese
alcuni nuovi movimenti che tentano di rinnovarsi richiamandosi al socialismo
liberale. Meno diffusa la formula rovesciata “liberalsocialismo”, che nasceva
dal grembo della tradizione liberale com’eresia del liberalismo d’origine
intellettuale, mentre il socialismo liberale nelle sue varie apparizioni
storiche, da quell’anarchica a quella rosselliana, era nata all’interno dei
movimenti di sinistra il cui soggetto storico era la classe operaia.
Detto in parole povere, il socialismo liberale potrebbe essere definito un
socialismo di destra ed il liberalsocialismo, invece, un liberalismo di
sinistra.
Più volte ci è accaduto di osservare che lo spostamento di significato
storico dei termini del linguaggio politico può trasformare un’espressione
all’inizio ossimorica in una congiunzione di termini totalmente compatibili fra
loro. Nella storia dell’Ottocento i liberali ed i democratici hanno
rappresentato due partiti opposti. Poi è avvenuto che la democrazia è stata a
poco a poco considerata come un’ulteriore fase di sviluppo del liberalismo; così
il rapporto fra il liberalismo ed il socialismo nel corso del Novecento.
Su questo tema, storico e teorico insieme, Bovero si è posto analiticamente
il problema in questi termini: i rapporti tra liberalismo e socialismo possono
essere di necessità, di possibilità e di impossibilità. La sintesi è possibile,
ma solo a certe condizioni, poste certe definizioni, tenendo conto che tanto
l’uno che l’altro hanno più significati e posto che venga prescelto, per l’uno e
per l’altro quel significato che rende non contraddittorio il concetto “liberalsocialismo”.
Di questa compossibilità è un esempio la tesi rosselliana secondo cui il
liberalismo viene inteso come metodo, il socialismo come fine.
Il socialismo liberale come sintesi filosofica aveva fatto la sua
apparizione nel liberalsocialismo di Calogero, per il quale libertà e giustizia
sono due principi ideali, di cui l’uno non può stare senza l’altro.
Del socialismo liberale di Rosselli non si sarebbe mai potuto dire che era
un ircocervo. Che il socialismo fosse storicamente l’erede del liberalismo
poteva essere un interpretazione errata della storia. Ma una critica di questo
genere non avrebbe niente a che vedere con la critica filosofica dell’ibrido
connubio. In realtà, poi, del Partito d’azione, come coacervo, le tesi
liberalsocialiste non furono che una delle componenti.
Fu nei riguardi del compromesso pratico che rosselliani e liberalsocialisti
percorsero la stessa strada nel Partito d’azione: nella sfera economica,
l’economia a due settori, privato e pubblico, una terza via tra libero mercato e
collettivismo; in diritto, l’affiancamento dei diritti sociali ai diritti
individuali; in politica, l’allargamento della democrazia alla fabbrica.
Era naturale che nel dibattito politico di oggi, l’attualità di Rosselli sia
stata cercata nella risposta alla domanda: <<Quale socialismo?>>. Ed è
altrettanto naturale che chi ha inteso rispondervi abbia messo in evidenza in
modo particolare l’antistatalismo rosselliano, facendo riferimento, sia
all’articolo “Contro lo Stato” del dicembre 1934, in cui Rosselli indica nello
Stato <<il mostro del mondo moderno che sta divorando la società>>, ed in quanto
tale deve essere abbattuto, sia alla tesi più volte da Rosselli espressa che
<<la rivoluzione italiana, se non vorrà degenerare in una nuova statolatria,
dovrà, sulle macerie dello Stato fascista capitalista, far risorgere la Società,
federazione di associazioni quanto più libere e varie possibili>>, sia
all’articolo in dialogo con Camillo Berneri del dicembre 1935, in cui Rosselli
ridefinisce la sua posizione con la formula <<socialismo federalista liberale>>.
A dire il vero la ragione più forte del rinnovato interesse per l’opera
teorica di Rosselli in questi ultimi anni è stata il rinnovato dibattito – un
dibattito esclusivamente italiano – sul Partito d’azione.
Che un partito di Terza forza, come si proponeva di essere il Partito
d’azione tra capitalismo e comunismo, fosse predestinato ad essere attaccato da
destra e da sinistra, non c’è da meravigliarsi.
L’accusa rivolta all’azionismo di non essere equidistante tra fascismo e
comunismo dipende anche da una non corretta percezione del fatto che i
protagonisti della guerra civile europea sono stati non due ma tre, capitalismo,
fascismo e comunismo, e pertanto chi si mette da un punto di vista puramente
negativo, compie, senza volerlo, una doppia affermazione. Solo ponendosi dal
punto di vista di ciò che un movimento di Terza forza afferma si può cogliere
non solo quali sono stati i suoi reali opposti, ma in base a quali criteri se ne
distingue. In quanto Terza forza, il Partito d’azione si poneva tra capitalismo
e collettivismo. Sotto questo aspetto la sua contrapposizione al collettivismo
in economia era nettissima, così come contro l’autoritarismo in politica.
Una delle ragioni dell’avversione all’azionismo, va ricercata nella
autopresentazione che gli azionisti facevano di se stessi come di
un’aristocrazia del pensiero chiamata a debellare una volta per sempre i vecchi
mali dell’Italia: il fascismo come autobiografia della nazione. Delle due Italie,
l’Italia civile contrapposta all’Italia barbara, essi soli si consideravano i
più genuini rappresentanti della prima. Bobbio, a riguardo, parla di un certo
complesso di superiorità che giustificava la loro scelta di non ricollegarsi a
nessuno dei partiti precedenti, e, anche della loro pretesa di porsi alla testa
del riscatto nazionale attraverso una concezione etica della politica, intesa la
politica come vocazione e come missione nel momento delle grandi crisi di
civiltà.
Il Partito d’azione, nato come partito nuovo negli anni del regime durante
la guerra, allo scopo di liberare l’Italia dal fascismo, per opera di giovani
intellettuali per i quali l’adesione ad un movimento politico clandestino era la
loro prima esperienza politica, e quindi come partito eminentemente,
esclusivamente antifascista, era destinato a perdere la propria ragion d’essere
una volta debellato il fascismo e restituita l’Italia alla democrazia. Proprio
per la sua natura di partito di combattimento, in cui l’aggregazione dei suoi
membri era avvenuta attraverso un reclutamento soprattutto di intellettuali, il
partito fu sempre sin dal primo momento un partito composito, in cui confluivano
gruppi diversi uniti prima di tutto dall’antifascismo.
Le anime del Partito d’azione. Oltre le due ali estreme, quella socialista
di Lussu e quella democratico – repubblicana di La Malfa, inconciliabili, lo
stesso centro, che è del partito il nucleo ideologico forte del socialismo
liberale, racchiude quelle che sono state chiamate le due anime dell’azionismo,
l’anima giacobina, ben rappresentata nell’azionismo torinese da Vittorio Foa, e
quella moderata, che ebbe la sua espressione nella rivista milanese di Mario
Paggi ed in quella fiorentina di Piero Calamandrei.
Quale di queste due anime sia quella maggiormente debitrice del pensiero e
dell’opera di Rosselli, è una domanda a cui non si può dare una risposta netta.
Quando scrive “Socialismo liberale” Rosselli ha il suo modello ideale
nell’Inghilterra laburista. Sulla rivoluzione russa, Rosselli, non poteva più
avere alcuna illusione. Perciò ogni qual volta predica la rivoluzione italiana
necessaria a liberare il paese dal fascismo, ha cura di avvertire che quella
italiana non dovrà essere come quella comunista, che del fascismo prolungherebbe
le forme dittatoriali e la mentalità, eludendo quei problemi di libertà e di
moralità di cui il fascismo ci ha confermato l’importanza.
Ma via via che il fascismo diventa sempre più aggressivo, Rosselli ritiene
inevitabile un’alleanza di tutti i partiti di sinistra, la formazione di un
partito unito del proletariato, dove i comunisti apporteranno le loro virtù
organizzative, ed il movimento GL immetterà quella libertà intellettuale, che
loro difetta. GL come coscienza critica della sinistra, in particolare del
comunismo. Tanto più se si considera la ferma convinzione che sin dall’inizio
della sua intransigente coerente e coraggiosa battaglia politica Rosselli non
esita a manifestare la necessità non solo di difendere la libertà anche con la
forza, ma anche di imporla con la forza, sospendendo il rispetto delle regole
democratiche: <<Noi non siamo dei rasseganti, e prima di cedere le armi vogliamo
combattere>>. Alcuni anni più tardi: <<il rispetto della legalità democratica,
agli inizi del moto liberatore è la tomba della rivoluzione>>.
|