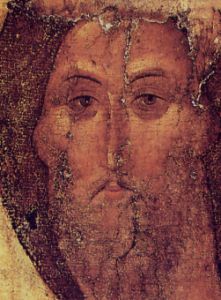
A. Rublev, Volto di Cristo, icona russa
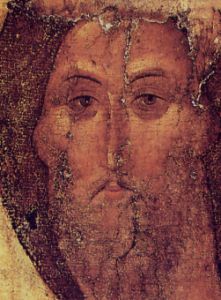
A. Rublev, Volto di Cristo, icona russa
Libro secondo
Paolo
è il primo cristiano, l'inventore della cristianità! Fino ad allora c'erano solo alcuni membri di sette giudaiche.
(Friedrich Nietzsche, Morgenröte, 1, 68)è facile comprendere come mai il Cristianesimo di Gesù non riuscì a imporsi politicamente e socialmente, e perché venne agevolmente oppresso dalla polizia e dalla chiesa, mentre il Paolinismo... sommerse l'intero mondo occidentale civilizzato.
(Bernard Shaw, 108)Oggi Cristianesimo vuol dire in massima parte Paolo.
(Il teologo cattolico Ricciotti)
19. LA COMUNITÀ PRIMITIVA
La conoscenza del periodo apostolico ci deriva, oltre che dalle Epistole paoline, soprattutto dagli Atti degli Apostoli, anche se le loro forti tendenze alla trasfigurazione degli eventi sono ben note da lungo tempo e riconosciute pressoché unanimemente. Composti parecchi decenni dopo la morte di Gesù, ostentano un'evoluzione totalmente pacifica e armonica, benché in realtà i contrasti fossero stati davvero aspri.
I discepoli sperarono fino all'ultimo che Gesù avrebbe salvato Israele (Lc. 24, 21); probabilmente alcuni di loro restarono a Gerusalemme, ma la maggior parte tornarono forse in patria, in Galilea 1, dove potevano riprendersi gradualmente dalle sofferenze dell'esperienza patita. Ed è lì che si costituì, forse, la cellula prima della Chiesa cristiana (Lohmeyer) e che si rafforzò l'idea della Resurrezione di Gesù.
Dopo qualche tempo, tuttavia, almeno una parte dei fuggiaschi tornò a Gerusalemme; in effetti, anche gli Apostoli, come allora numerosi Ebrei, sul monte di Sion attesero il Messia, gli eventi definitivi della storia e la Gerusalemme celeste. Ivi si raccolsero intorno a Pietro, ai figli di Zebedeo e a Giovanni, allargando via via la loro cerchia di influenza con la predicazione e il dialogo.
Questo gruppo, in ogni caso, appariva una setta giudaica più che una nuova comunità religiosa, rappresentando in un primo tempo una mera corrente dell'Ebraismo fra le tante allora in auge, una Sinagoga che si distingueva dalla fede degli altri Ebrei principalmente per la credenza nell'immediato ritorno del Crocifisso 2. Gli Apostoli e i loro seguaci non intesero proclamare al mondo una nuova religione. Come dimostra soprattutto il Vangelo di Matteo, opera di un ebreo cristiano, l'immagine tradita di Gesù venne colorita prima di tutto proprio da loro e reinterpretata nel senso del Giudaismo dei Farisei, ossequiente alla Legge.
È possibile indicare qualche prova di questo evento importante.
Gesù non si preoccupava del Sabato, come attesta anche Matteo (Mt. 12, 1 sgg.); eppure egli in altra occasione gli fa dire : «Pregate soltanto che la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato (!)» (Mt. 24,20). Negli ambienti giudaico-cristiani, dunque, da cui proviene il Vangelo di Matteo, evidentemente il Sabato veniva di nuovo rispettato con scrupolo. Nel passo corrispondente del Vangelo di Marco (pagano-cristiano), al contrario, Gesù si limita a dire: «Ma pregate anche che ciò non accada d'inverno! » (Mc. 13, 18).
Altro esempio: Gesù aveva proibito il divorzio senz'alcuna eccezione (Mc. 10, 11; Lc. 16, 18), e tuttavia Matteo gli pone sulle labbra l'affermazione per cui il divorzio sarebbe lecito nel caso di adulterio della donna, richiamandosi anche in questo frangente alle concezioni giudaiche 3. Analogamente Matteo riplasma spesso la tradizione in senso giudaico, un processo questo indubbiamente assecondato già dall'adesione di Giacomo, fratello di Gesù, che non era personalmente un Fariseo e nemmeno un simpatizzante di questa corrente ebraica.
La frattura all'interno della Comunità primitiva
La cerchia più antica dei discepoli di Gesù constava esclusivamente di Ebrei, i quali erano da un lato Israeliti rigidamente fedeli alla Legge, alla tradizione, alle festività giudaiche, alle norme alimentari, ai riti purificatori e ai tempi stabiliti per le preghiere; dall'altro, tuttavia, non mancavano adepti di stirpe ebraica, ellenizzati e di lingua greca. Rientrati dalla Diaspora, dove vivevano in numero tre volte superiore agli Ebrei di Palestina 4, erano più vicini alla cultura ellenistica; fra di loro si trovavano anche Greci convertiti all'Ebraismo, i cosiddetti proseliti.
Codesti Ellenizzati, ben presto numerosi nella Comunità primitiva, si sentivano meno vincolati alle tradizioni nazionali e religiose degli altri Ebrei, per cui talvolta non nascondevano una certa ostilità nei loro confronti. «Nei giorni in cui s'accrebbe il numero dei discepoli, si giunse alla diatriba degli Ellenizzanti con gli Ebrei» - leggiamo negli Atti, che raccontano anche che gli Ellenizzanti avevano propri capi, i «Sette», tutti recanti nomi schiettamente greci.
Il Nuovo Testamento, naturalmente, tenta di occultare l'esistenza di due fazioni all'interno della Comunità primitiva, nella quale sarebbe stata presente solo una suddivisione di compiti: la predicazione sarebbe stata riservata agli Apostoli; ai «Sette», cioè agli Ellenizzanti, il servizio di mensa (Atti, 6, 1 sgg.). In realtà, però, non si accenna mai a questa attività diaconale dei «Sette», al loro presunto servizio di mensa; al contrario, si parla dappertutto del loro servizio kerygmatico, della loro predicazione, che avrebbe dovuto essere un esclusivo privilegio degli Apostoli. E dunque non c'è dubbio che i «Sette» non esercitavano affatto il servizio di mensa, ma erano i capi degli Ellenizzanti, come gli Apostoli lo erano degli Ebrei.
La causa prima della discordia potrebbe essere stata una forma di trascuranza verso le vedove ellenistiche durante il pasto quotidiano (Atti, 6, 1): esse sarebbero state «trascurate», «lasciate da parte» continuamente, come lascia intendere il testo greco. Insomma, venivano volontariamente poste in posizione di subordine. E allora tale conflitto non era causa, bensì conseguenza di una tensione già presente, dietro la quale si intravedono non tanto le ovvie differenze di lingua e di cultura, quanto il problema della predicazione, vale a dire due differenti tendenze del Cristianesimo: i giudeo-cristiani conservatori, guidati dagli Apostoli, poi chiamati «i Dodici», e gli Ellenizzanti, guidati dai «Sette», ben più radicali e sostenitori di posizioni più avanzate.
Secondo il punto di vista comune della ricerca critica, nella Comunità primitiva i due gruppi si trovarono fin dall'inizio l'uno accanto all'altro, ciascuno con una propria amministrazione. Julius Wellhausen (Kritische Analyse, 11) vi scorge addirittura i primordi di uno scisma, che non si attuò solo perché «a Gerusalemme il terreno divenne tanto scottante sotto i piedi degli Ellenizzanti, che furono costretti a fuggire».
Questa fuga conferma irrefutabilmente la spaccatura della Comunità primitiva: la sua componente più attiva, antisinagogale, fu ben presto combattuta dai Giudei 5, e dopo la lapidazione del proprio portavoce Stefano, accusato di «bestemmiare contro Mosé», vale a dire di aver attaccato il Tempio e la Legge, abbandonò precipitosamente la città ormai diventata poco sicura 6. Gli Ellenizzanti, come raccontano ancora gli Atti, fuggirono fino in Fenicia, a Cipro e in Antiochia, dando così inizio alla missione cristiana e alla vera e propria storia del Cristianesimo. Il gruppo conservatore, invece, fedele alla Legge giudaica, cui appartenevano anche gli Apostoli, in un primo tempo fu lasciato tranquillo, godendo - come raccontano ancora gli Atti degli Apostoli - di pace «in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria» (Cfr. Atti, 8, 1; 8, 4; 11, 19 con 9, 31).
E dunque la cerchia intorno agli Apostoli non venne infastidita, invece il gruppo degli Ellenizzanti fu perseguitato; mentre Stefano veniva lapidato per la propria confessione, agli Apostoli non fu torto un capello; mentre i seguaci del primo martire cristiano si disperdevano ai quattro venti, gli Apostoli se ne stettero tranquilli in città.
E ciò significa, con tutta evidenza, che i contrasti interni alla Comunità primitiva erano noti anche agli estranei; e prova, inoltre, che gli Apostoli non possono aver condiviso in aspetti assolutamente fondamentali la fede di Stefano e dei suoi amici perseguitati, dai quali prese le mosse la missione cristiana. Del resto, la ricerca teologica distingue nella Comunità primitiva una gran messe di correnti e di concezioni le più svariate.
Il motivo principale di contrasto fra gli Ebrei e gli Ellenizzanti era costituito dal problema escatologico. Per i giudeo-cristiani il nucleo centrale della fede si trovava nella speranza del prossimo ritorno del Crocifisso, mentre i pagano-cristiani rimossero ben presto l'aspettazione della fine mediante gli atti rituali di pietà, il misticismo, l'estasi, la glossolalia, la fede in un dio vissuto e risorto sulla terra, onorato cultualmente come gli dèi delle pratiche misteriche e alla cui resurrezione si partecipa con l'assunzione dei sacramenti.
Inoltre, c'era fra loro tutta una serie di rilevanti punti di frizione: per i giudeo-cristiani vigevano il rigido rispetto della Legge, la permanenza nel Tempio, l'obbligo della circoncisione prima del battesimo, un atteggiamento penitenziale pronunciato che ne costituiva addirittura una caratteristica dirimente e, non da ultimo, la loro diffusa benché volontaria comunanza dei beni. Tutto ciò era estraneo ai pagano-cristiani, che rifiutavano la Legge giudaica, trascuravano l'appartenenza al Tempio, non esigevano la circoncisione prima del battesimo, sottolineavano il carattere gioioso della nuova fede e non attribuivano soverchia importanza all'ideale pauperistico.
I capi dei due gruppi erano Pietro e Giacomo da una parte, e Paolo dall'altra.
Pietro
I contestatori della storicità della figura di Gesù hanno visto anche in Pietro un'invenzione della fantasia, una creazione mitica, da porre in relazione con divinità come Giano, Proteo, Atlante, Petra ecc. Ma la sua persona è ritenuta storicamente fondata, tanto più perché non ne parlano favorevolmente né Paolo né gli Evangelisti.
Ciò che gli Atti degli Apostoli, la nostra fonte principale, raccontano di Pietro è, per la verità, in massima parte leggendario. La sua persona storica resta per noi quasi completamente oscura, come quella degli altri Apostoli, a meno di non illustrarla con un noto agiografo cristiano sulla scorta di una severa plastica romanica del XII secolo.
Secondo i Vangeli, Simone bar Jona, il nome originale del pescatore di Betsaida, insieme ai figli di Zebedeo Giacomo il Vecchio e Giovanni, fu una delle persone più vicine a Gesù. Benché il Signore, come è stato scritto un po' pomposamente, percorresse col discepolo prediletto strade nelle quali neppure Pietro era in grado di addentrarsi, proprio a lui avrebbe conferito il primato su tutti gli Apostoli, designandolo addirittura primo Papa. (Ma di questo avremo occasione di parlare in seguito). Tuttavia il capo vero e proprio dei giudeo cristiani diventò, già nei primi anni '40,
Giacomo, il fratello di Gesù 7
Quando il Signore era ancora in vita, a quanto pare Giacomo ebbe per lui scarsa comprensione; in seguito, però, volle anch'egli andare incontro al Risorto, unendosi lla nuova setta ormai in crescita (1 Cor. 15, 7; Atti, 1, 14). Giacomo divenne il primo personaggio delineato con precisione della storia del Cristianesimo. In una descrizione pregnante risalente alla fine del II secolo, in verità poco attendibile, di lui si dice:
«Egli fu santo fin nel seno materno. Non bevve vino o alcun'altra bevanda alcolica né mangiò carni di animali. Nessuna lama toccò mai il suo capo, non si unse d'olio né prese un bagno. A lui solo fu concesso di entrare nel santuario, perché non indossava abiti di lana, ma di lino. Si recava nel Tempio sempre da solo, dove lo si poteva trovare inginocchiato a pregare Dio perché perdonasse il popolo; così le sue ginocchia erano indurite come quelle di un cammello» (In Euseb., h. e. 2, 23, 4 sgg.).
Consacrato Nasireo dalla madre Maria, Giacomo, che viveva notoriamente nell'ascesi e che si richiamava alla Legge, dette l'avvio a una duplice rielaborazione della dottrina di Gesù, da un lato nel senso di una vita monastica lontana dal mondo, dall'altro nell'inclinazione a una stretta osservanza della Legge, a un rinnovato richiamo alla Thora, contro la quale Gesù aveva combattuto fino alla morte. Con Giacomo ha inizio per il Cristianesimo un processo, gravido di conseguenze, di rinnovata giudaicizzazione della religione, che influenzerà anche i Vangeli, soprattutto quello di Matteo, particolarmente prediletto dalla Chiesa.
In alcuni elenchi falsificati e contraddittori di Episcopi, Giacomo compare quale primo Vescovo di Gerusalemme 8. Il suo «seggio episcopale» - come ironizza lo Harnack - veniva ancora o già mostrato nel IV secolo. In realtà Giacomo, ben presto al di sopra di tutti gli Apostoli, guidò tutta la cristianità primitiva, godendo di un rango superiore allo stesso Pietro, che pare gli abbia riconosciuto la primazia all'interno della Comunità originaria 9. Egli capeggiò, dunque, la Comunità per vent'anni, finché i Giudei non lo lapidarono intorno al 62 10. Dopo la sua morte fu Simeone, un cugino di Gesù, che venne crocifisso come supposto discendente di Davide durante l'Impero di Traiano, ad assumere la guida della Comunità di Gerusalemme 11, di cui intendiamo perseguire lo sviluppo e la fine almeno nei suoi tratti fondamentali.
La fine del Cristianesimo giudaico
Dopo la cacciata del gruppo di Stefano, contrario alla Legge, i membri conservatori della Comunità primitiva rimasero incontrastati nella città ancora per alcuni decenni. Fu solo nel 66 o nel 67, poco prima dell'assedio di Gerusalemme da parte dei Romani che si trasferirono compatti nei territori a est del Giordano, nella cittadina di Pella 12, perché - come scrive un Teologo cattolico (Erhard) - non volevano impugnare le armi, atto allora impensabile per dei cristiani.
Alcuni anni dopo la conquista di Gerusalemme per mano di Tito, i giudeo-cristiani rientrarono da Pella; ma dopo che venne domata la rivolta di Bar Kochba (135 d.C.), cui non avevano preso parte perché duramente perseguitati dal capo ribelle (Just., apol. 1, 31. Euseb., h.e. 4, 8, 4), essi furono scacciati dalla città insieme a tutti i Giudei. L'ingresso in Gerusalemme, ora chiamata Aelia Capitolina, fu vietato a tutti gli Ebrei, pena la morte. Era così giunta la conclusione definitiva del Cristianesimo giudaico in Palestina, la cui totale rottura con la Sinagoga aveva avuto luogo alla fine del secolo, e fors'anche prima.
Il Cristianesimo giudaico perdurò a est del Giordano e in Siria fino al IV secolo inoltrato, ma dopo la conquista di Gerusalemme si trattò di una minoranza priva di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo vero e proprio del Cristianesimo. Già nel II secolo gli eredi diretti degli Apostoli, gli Ebioniti e i Nazorei, furono dichiarati eretici ed eterodossi dai rappresentanti del Cattolicesimo nascente, e nel IV secolo i loro epigoni furono irrisi da San Gerolamo, che li definì «Ebrei dimidiati» e «Cristiani dimidiati». Mentre il Cristianesimo più antico periva in solitudine, le promanazioni del gruppo degli Ellenizzanti erano divenute potentissime nel mondo greco-romano, tanto da segnare il destino futuro della nuova religione. Capo dei pagano-cristiani divenne Paolo.
Note
1
Ciò si può evincere con una certa sicurezza da
Mc,. 14, 28 e 16, 7.
2
Atti, 24, 5. 14. K.L. Schmidt, Die Kirche des Urchristentum, 279.
Lohmeyer, Kultus u. Evangelium, 123. Erbt, 21. Heiler, Urkirche u.
Ostkirche, 66 sgg. Bultmann, Das Urchristentum, 195. Dibelius
Kümmel, 82. Goppelt, Christentum u. Judentum, 72. B. Le Roy
Kurkhart, 194. Wenschkewitz, 106 sg. Leipoldt, Jesu
Verhältnis, 184 sg.; 201. Haenchen, Apostelgeschichte, 186.
3
Mt. 5, 32; 19,9; inoltre, ad es., Leipoldt, Die Frau in der antiken
Welt, 154.
4
Mentre i Giudei viventi in Palestina ai tempi di Gesù
vengono stimati intorno al milione, quelli della Diaspora dispersi per
l'Impero Romano, compresi i Proseliti, vengono valutati in circa 3
milioni e mezzo. Cfr. Knopf, Einführung, 184 sg. Grundmann,
Das Problem des hellenistischen Christentums, 54 sgg.
5
Cfr. Atti, 8, 1 sgg.; 9, 1 sg.; 11, 19. Altresì Gal. 1,13;
1 Cor. 15, 9.
6
Atti, 8, 1 e 6, 11. Schoeps, Urgemeinde, Judentum, Gnosis, 13, dubita
persino della storicità di Stefano e lo definisce una
probabile «controfigura inserita da Luca per motivi
tendenziosi, sulla quale dovevano essere scaricate dottrine
imbarazzanti per l'autore».
7
Gal. 2, 9; Atti, 15; 21, 18 sgg.
8
Euseb., h.e. 2, 1, 2 sgg. Altresì Lohmeyer,
Galiläa u. Jerusalem, 56.
9
Da Paolo, Giacomo viene citato prima di Pietro: Gal. 2, 9. Cfr. anche
Atti, 12, 17; 15, 13 sgg. Inoltre, E. Meyer, Ursprung und
Anfänge III, 223. Wagenmann, 15 sgg. Schoeps, Theologie des
Judenchristentums, 125 con riferimento a Atti, 12, 17; recentemente
ancora attenuato da Schoeps, Paulus, 61. Urchristentum, Judentum,
Gnosis, 7, nota l.
10
Joseph., ant. jud. 20, 9, 1. Egesippo sposta il martirio all'anno 66:
in Euseb., h. e. 2, 23, 18.
11
Euseb., h. e. 4, 22, 4 sgg.; 3, 32, 1 sgg.
12
Euseb., h. e. 3, 5, 3. Cfr. anche Schoeps, Theologie u. Geschichte
des Judenchristentums, 265 sgg. Idem, Urchristentum, Judentum, Gnosis,
8.