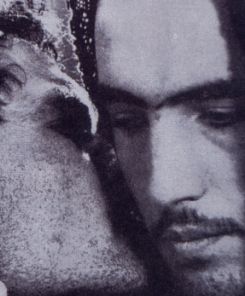
Il bacio di Giuda, fotogramma del film Il vangelo secondo Matteo di P. P. Pasolini
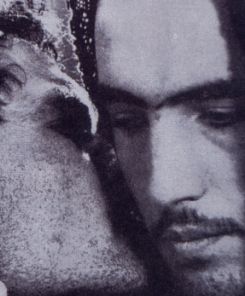
Il bacio di Giuda, fotogramma del film Il vangelo secondo Matteo di P. P. Pasolini
Libro secondo
Paolo
20. IL MIRACOLO DI DAMASCO
...il suo capo era diventato di colpo lucente... ha il pensiero dei pensieri, la chiave delle chiavi, la luce delle luci; d'ora in poi la storia gira intorno a lui.
(Friedrich Nietzsche, Morgenröte, 1, 68)Il Paolo precristiano
L'Apostolo non assunse il nome di Paolo soltanto in occasione della sua conversione; probabilmente portava da sempre un duplice nome, l'ebraico Saul e il romano Paulus. Per altro, l'usanza di cambiar nome nel caso di conversione o iniziazione era normale sia nel Giudaismo che nel Paganesimo, trapassando poi anche nel Cristianesimo. Già Simone riceve da Gesù il nome di Pietro al momento della sua chiamata (Mc. 3, 16; Lc. 6, 14); in seguito saranno cambiati i nomi di martiri e di santi, e ancor oggi quelli di suore e frati all'atto della monacazione. Il cambiamento di nome dei Papi ha origini profane: avvenne per la prima volta con Sergio IV (1009-1012), il cui vero nome, Bocca di Porco, parve poco adatto alla bisogna!
Circa l'aspetto fisico di Paolo, piccolo, calvo, con le gambe storte e il naso adunco, siamo informati da un opuscolo cristiano del II secolo, fonte per altro piuttosto dubbia, che pare ricalcare la descrizione della fisionomia di Socrate (Acta Paul. et Thecl. 3. Inoltre Baeck, 99).
Paolo era originario dell'Asia Minore, l'odierna Turchia, esattamente della città di Tarso, culturalmente importante e profondamente impregnata di spiriti greci. Il padre, sicuramente un benestante, faceva parte della setta dei Farisei e godeva della cittadinanza romana, diritto che passò poi anche al figlio.
Quasi nulla sappiamo della sua giovinezza. Crebbe in un ambiente culturale ellenistico e fu educato nella religione giudaica, due componenti decisive del suo pensiero, e forse studiò per alcuni anni a Gerusalemme, nella scuola di Gamaliel I, nipote di Hillel, ma il fatto è ancora oggetto di discussione (Atti, 22, 3 è un po' in contrasto con Gal. 1, 22 sg.).
Il Paolo precristiano compare nel N.T. come zelante cultore della Legge e nemico implacabile dei cristiani: assistette con «piacere» alla lapidazione di Stefano e sembra sia stato uno degli sgherri più accaniti (Atti, 8, 1; Gal. 1, 13 sg.), dediti alla persecuzione della componente ellenizzata della Comunità. Soprattutto gli Atti degli Apostoli evocano icasticamente l'immagine di un fanatico (Atti, 22, 4; 8, 3; 26, 9 sgg.), creata evidentemente per far apparire ancora più grandioso il miracolo della sua conversione; si tratta, quindi, di un'esagerazione tendenziosa, se non addirittura di una leggenda (Haenchen).
La conversione
Secondo gli Atti, Paolo ottenne dal Sommo Sacerdote il potere discrezionale di perseguire i seguaci di Gesù anche fuori di Gerusalemme (Atti, 9, 2); ma un giorno incontrò il Signore sulla via di Damasco. Paolo cita ripetutamente questa esperienza, ma ogni volta in maniera stringatissima e sempre allo scopo di rafforzare la propria autorità di Apostolo (Gal. 1, 15; 1 Cor. 9, 1; 15, 8), contestata a Gerusalemme.
Dobbiamo agli Atti la descrizione pittoresca dell'evento, rappresentato in tre versioni ogni volta diverse (Atti, 9, 3-9; 22, 6-11; 26, 12-18), il che - come opina il cattolico Ricciotti - rende le notizie molto più interessanti «che se fossero effettivamente identiche». La storiografia cattolica crede anche di sapere che l'accadimento meraviglioso si è svolto nel volgere di «secondi», e nel VI secolo si era già in grado di precisare con esattezza anche il luogo: presso la seconda pietra miliare prima di Damasco (Preuschen, 55).
Modelli o parallelismi presenti nella storia delle religioni
Secondo gli Atti, Paolo in pieno deserto, a mezzogiorno, venne scaraventato al suolo da una luce soprannaturale, quindi si svolse il dialogo seguente:
«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». «Signore, chi sei?»; «Sono Gesù, che tu perseguiti. Ti sarà difficile recalcitrare.» (Atti, 9, 3 sgg.).
Ora, noi sappiamo che l'autore degli Atti si è inventato in buona fede gran parte del fatto, ma ciononostante questa scena davanti a Damasco, mutatis mutandis, potrebbe essere storicamente vera: infatti, in tutta la storia religiosa vengono rese mediante immagini poetiche esperienze indescrivibili. E il calore accecante del sole favorisce le visioni, e soprattutto il deserto è stato da sempre luogo particolarmente generoso di apparizioni di tal fatta. In Arabia viandanti solitari si sentono così spesso chiamati da una voce misteriosa, che esiste in arabo una precisa denominazione di questa voce, cioè il termine Hatif.
La voce del cielo che dice «Ti sarà difficile recalcitrare» è una citazione dalle Baccanti di Euripide 1. È vero che si trova anche in Pindaro e in Eschilo 2, ma nelle Baccanti, dramma del miracolo kat'exochén, (prima rappresentazione nel 406 a.C.), ricorre in una situazione del tutto analoga alla storia della conversione di Paolo. La medesima locuzione, che qui Cristo rivolge al suo persecutore Paolo, viene là usata da Dioniso, dio misconosciuto, nei riguardi del suo persecutore Penteo.
Entrambe le volte la nuova divinità si serve di quel motto per esortare il suo più implacabile persecutore, ed entrambi i persecutori vengono subito dopo colpiti dalla portentosa punizione del dio, Penteo dalla morte, Paolo da una cecità momentanea. Tale sorprendente concordanza di motivi non poteva essere casuale, tanto più che è possibile riscontrare ulteriori singolari coincidenze fra il dramma euripideo e gli Atti degli Apostoli, in parte già individuate da Celso.
Sicuri parallelismi storico-religiosi si trovano anche in Omero, Sofocle, Virgilio e non da ultimo nella leggenda veterotestamentaria di Eliodoro.
Eliodoro, ministro delle finanze del re di Siria Seleuco III, ricevette l'ordine di rubare il tesoro del Tempio di Gerusalemme, ma proprio sulla soglia venne abbattuto al suolo da un cavaliere splendente d'oro, e accecato e muto fu portato via dai suoi compagni. Analogamente cade anche Paolo, il quale avrebbe dovuto rastrellare i cristiani di Damasco: a causa della visione luminosa non può più vedere e i suoi compagni lo portano via.
E come la preghiera del Gran Sacerdote Onias salva Eliodoro, assegnandogli il compito di proclamare la potenza del Dio che lo ha abbattuto, allo stesso modo Paolo viene guarito per intermediazione di Anania, e incaricato di predicare quel Dio che lo ha gettato a terra. E come i Giudei perseguitati da Eliodoro esaltano Dio per tale caso miracoloso, così lo esaltano i cristiani già perseguitati da Paolo. Nella narrazione della conversione di Paolo ci sono addirittura echi letterali della leggenda veterotestamentaria 3.
Incongruenze
Secondo una versione dei fatti, i compagni di Paolo ebbero un'audizione, secondo un'altra una visione; secondo una narrazione essi udirono la voce ma non videro nessuno, secondo l'altra videro la luce ma non sentirono nessuno (cfr. Atti, 9, 7 con 22, 9). (Il cattolico Daniel-Rops trasforma la voce una volta sentita e una volta no in «un confuso mormorio»). Secondo le due prime versioni la luce che si «aprì» a Paolo avvolse soltanto lui, secondo la terza versione anche gli accompagnatori (cfr. Atti, 9, 3 e 22, 6 con 26, 13), ma accecò solo Paolo e non gli accompagnatori, che pure, secondo la terza versione, l'avevano vista anche loro. Secondo una versione i compagni rimasero impietriti, secondo l'altra caddero a terra (cfr. Atti, 9, 7 con 26, 14).
Più tardi Agostino, per giustificare le violente misure da lui imposte contro gli «eretici», si richiamerà a questo passo. D'altra parte, nelle conversioni forzate nemmeno la Chiesa si comporta diversamente da quel Cristo, che abbatte al suolo Paolo prima di chiamarlo alla sua missione! 4
E così, fra portenti e contraddizioni, procede il racconto della conversione paolina.
A Damasco viveva un seguace di Gesù di nome Anania, che, prescelto per il Battesimo di Paolo, apprende mediante visione l'arrivo di Paolo e il suo indirizzo (Atti, 9, 10 sgg.), esattamente la casa in cui prende dimora, oppure, secondo la versione riveduta e corretta di Daniel-Rops, a cui tale narrazione appariva piuttosto profana, «laddove egli verisimilmente crollò... vegliando e pregando».
La providentia specialissima celebra qui i propri trionfi, non meno della fantasia cattolica. Paolo viene battezzato a casa di un certo Giuda, e un Protestante meno recente, assai più tradizionalista, i cui scritti sul nuovo Testamento un Collegio d'esperti un po' meno conservatori definisce forse i più dotti, ma anche i più strampalati dell'intero secolo XIX (Overbeck), crede di sapere addirittura che Anania compì questo atto sublime nell'attigua stanza da bagno di Giuda 5. Dunque, ma solo nelle due prime versioni, Gesù spedisce Paolo a Damasco, dove Anania gli impartisce le necessarie istruzioni; nella terza versione, invece, nella quale Anania non compare affatto, è Gesù in persona che istruisce immediatamente Paolo 6.
In un punto importante, tuttavia, i racconti degli Atti coincidono, cioè laddove tutti e tre parlano non della visione di una figura, ma dell'audizione di una voce: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Ma purtroppo soltanto Paolo in persona afferma e ribadisce d'aver visto il Signore.
Note
1 Eurip.,
Bacch. 795. Cfr. anche Smend, 41. Klausner, Von Jesus zu
Paulus, 306. Schneider, Geistesgeschichte, 1, 291 sg.
2
Pind., Pyth. 2, 95. Aisch. Ag. 1624.
3
2 Mak. 3 specie vers. 27. In proposito Windisch, Die
Christusepiphanie von Damaskus, 1 sgg.
4
Aug., ep. 185, 22.
5
Th. Zahn, Die Apostelgeschichte des Lucas, 327, nota 15.
6
Cfr. Atti, 9, 5 sgg. e 22, 10 con 26, 15 sgg.