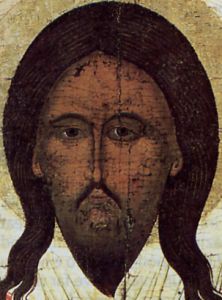
Volto di Cristo non dipinto da mano d'uomo, icona russa del XVI sec.
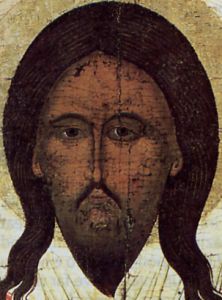
Volto di Cristo non dipinto da mano d'uomo, icona russa del XVI sec.
Libro secondo
Paolo
21. LA LOTTA DI PAOLO CONTRO GLI APOSTOLI
Nel suo nuovo mondo cristiano Paolo era solo, e aveva alle sue spalle i peggiori avversari.
(Il teologo Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, 1, 109)...per ognuno gli avversari sono ingannatori guidati da volgari necessità materiali, non Apostoli di Cristo, ma strumenti di Satana, il contrasto personale è insuperabile, una riconciliazione fra Paolo e Pietro assolutamente esclusa.
(Eduard Meyer, Ursprung u. Anfänge, III, 459)
Dopo la conversione, Paolo visse alcun tempo in «Arabia» (Gal. 1, 17), come si chiamava allora il territorio immediatamente a Sud di Damasco, e solo dopo tre anni si recò a Gerusalemme per una breve presa di contatto con gli altri. Ma probabilmente già da prima s'era formata una concezione del tutto personale della predicazione cristiana, della quale, in ogni caso, doveva pur possedere un'idea almeno approssimativa, perché altrimenti non avrebbe potuto perseguitare i seguaci di Gesù. Le sue conoscenze furono poi completate presso i cristiani di Damasco, durante la sua prima visita a Gerusalemme e infine in Antiochia.
Paolo, in verità, pretende d'essere stato personalmente chiamato dal Signore, perché ribadisce ripetutamente di non aver ascoltato il Vangelo da nessun uomo, nemmeno a Gerusalemme dagli Apostoli, che talvolta definisce con scherno «superapostoli» o «arciapostoli» 1, ai quali non ritiene d'essere affatto inferiore e il cui prestigio lo lascia indifferente (Gal. 1, 1 sgg.; 2, 6). Egli sottace o sminuisce qualsiasi contatto coi cristiani, come l'incontro con Pietro e Giacomo:
«Solo dopo tre anni mi recai a Gerusalemme per parlare con Cefa, ma restai con lui solo quindici giorni. In quell'occasione non vidi nessuno degli altri Apostoli, eccetto Giacomo, fratello del Signore».E ribadisce solennemente con un giuramento:
«Quel che vi scrivo adesso potrei testimoniarlo davanti a Dio, ché dico la pura verità» (Gal. 1, 18 sgg. Cfr. soprattutto anche Gal. 1, 12).
Il contatto con gli Apostoli, d'altra parte, non può essere stato molto stretto. Fatta eccezione per i due personaggi più importanti, l'ex persecutore, oltretutto già allora avversario della Legge, non s'incontrò personalmente con nessuno. Tuttavia gli Atti degli Apostoli, estremamente tendenziosi e composti probabilmente da Luca, discepolo di Paolo, allo scopo di occultare le divergenze fra le parti, racconta -in aperto contrasto con quanto dice Paolo -che questi si trattenne da Barnaba, che Barnaba lo presentò agli altri Apostoli e che predicò a tutti il Vangelo (Cfr. Atti, 9, 26-28 con Gal. 1, 18-24). In realtà, il conflitto fra lui e la Comunità di Gerusalemme risale proprio a questo primo incontro, sulle cui esperienze - come si esprime il Teologo cattolico Ehrhard - Paolo sorvola con fine delicatezza.
Gli inizi del Cristianesimo pagano
Non c'è momento che abbia più profondamente falsato la tradizione storica del Cristianesimo primitivo del suo completo trapasso nelle mani dei pagano-cristiani.
(Il teologo Overbeck)
Con l'aiuto di Barnaba, un Levita proveniente da Cipro, da sempre di tendenze ellenizzanti, poté recarsi nella capitale di Siria, Antiochia, che coi suoi 800.000 abitanti era la terza città del mondo. Qui si era costituita una comunità cristiana riconducibile all'attività della cerchia di Stefano, allora non più legata alla religione giudaica, e che Paolo - ivi attivo per 14 anni - influenzò profondamente 2. E ancora da Antiochia prende le mosse la sua evoluzione successiva, per molto tempo decisiva per la storia del Cristianesimo: la penetrazione nell'Impero Romano, il passaggio dall'ambito culturale palestinese a quello ellenistico, la liberazione dei pagano-cristiani dalla Legge Mosaica e ulteriori importanti riforme teologiche.
La confluenza ora incipiente delle correnti culturali dell'orientalismo ellenistico, della filosofia greca e delle religioni misteriche modificò notevolmente l'insegnamento di Gesù. Mentre a Gerusalemme i giudeo-cristiani ricadevano ampiamente nel Giudaismo, i pagano-cristiani soccombettero lentamente, ma inesorabilmente, all'influsso del paganesimo. Anche la notizia a tutti nota, secondo la quale furono proprio i discepoli d'Antiochia a essere chiamati per la prima volta «Cristianici» (Atti, 11, 26), indica chiaramente che ivi la nuova religione aveva ormai assunto una caratteristica tutta propria.
In un primo momento la Comunità originaria osservò in silenzio le tendenze dei cristiani antiocheni, ma il suo atteggiamento mutò allorché, verso la metà degli anni '40, Paolo iniziò a diffondere ben oltre Antiochia il suo Cristianesimo eslege durante la cosiddetta prima missione, nella quale, per altro, il ruolo principale fu svolto ancora una volta da Barnaba.
Inoltre l'opposizione dei cristiani gerosolimitani venne rafforzata dalla cooptazione di molti Farisei, aspramente combattuti da Gesù, coi quali, tuttavia, gli Apostoli si affratellarono: e non furono i Farisei a recedere dalle loro posizioni, ma furono gli Apostoli a fare delle concessioni di principio (Leipoldt, Jesu Verhältnis, 184).
Infine, sembra che la crescente pressione romana su Israele abbia favorito il sentimento nazionale di molti cristiani di Gerusalemme e la consapevolezza della loro appartenenza al Giudaismo. In ogni caso, s'accrebbe il loro risentimento verso la critica alla Legge Mosaica e protestarono contro la diffusione di una fede, che si poneva in così aperta contraddizione con la propria tradizione giudaica.
Alcuni inviati della Comunità apostolica si recarono ad Antiochia, «falsi fratelli intromessisi», come Paolo li definisce, e ne scaturì, come ammettono anche gli Atti degli Apostoli, una «ribellione», una «violenta polemica» (Gal. 2, 4; Atti, 15, 2). Poiché non si pervenne a un accordo, in compagnia di Barnaba, Paolo si recò per la seconda volta a Gerusalemme, conformemente a una rivelazione, com'egli si esprime; cioè, commenta il Teologo Nock, «non in seguito a un ordine di presentarmi e di fornire spiegazioni, e nemmeno per una naturale sottomissione ai miei superiori, quali io non ritengo ch'essi siano» (Gal. 2, 2; Nock, Paulus, 83).
Il Concilio Apostolico
Nel «Concilio Apostolico» che ne conseguì, (così viene definita alquanto pomposamente questa riunione assolutamente informale, avvenuta quattordici anni dopo il primo colloquio), Paolo e compagni non si piegarono «neppure per un'ora (Gal. 2, 5) ai giudeo-cristiani. Per gli Atti tale affermazione è troppo cruda, e l'importante manoscritto neotestamentario D, creato intorno al 500, falsificando il testo, la rivolta nel suo esatto contrario.
L'esito dell'incontro fu decisamente poco conciliante: i seguaci di Giacomo dovevano predicare ai Giudei, Paolo e i suoi ai Pagani (Gal. 2, 9). Egli, insomma, era riuscito a strappare la dispensa dalla Legge Giudaica per i pagano-cristiani e a ottenere per sé mano libera nell'attività missionaria. Tuttavia dovette acquistarsi tale autonomia mediante un sostegno finanziario alla Comunità originaria, per cui Lutero tradusse le raccolte di denaro citate in 2 Cor. 9, 13 non con «elemosine» o «opere di carità», bensì con il termine «tasse».
Secondo gli Atti, che su questo punto contraddicono Paolo più di una volta, fu anche obbligato all'osservanza di un minimo rituale giudaico, al rispetto dei comandamenti di Noè, all'astinenza dei pagano-cristiani dai sacrifici idolatri di animali uccisi versando sangue o mediante soffocamento, e dall'impudicizia (Cfr. Gal. 2, 10 con Atti, 15, 28 sg.) Di codesta Clausula Jacobaea, il «Decreto Apostolico», non si preoccuparono molto né gli estremisti giudaico-cristiani né Paolo, nonostante la formulazione solenne «sia piaciuta allo Spirito Santo e a noi» Atti, 15, 28).
Dai cristiani i primi pretesero di nuovo subito la circoncisione e una rigorosa osservanza della Legge, il secondo promosse e favorì un distacco totale da essa (Cfr. 1 Cor. 8)!. In termini complessivi il Concilio Apostolico fu un mero compromesso, in quanto non fu in grado di portare una chiarificazione sul contrasto fondamentale, girandovi intorno senza affrontarlo, come dimostra con evidenza
La controversia antiochena
Quando Pietro giunse subito dopo in Antiochia, ebbero luogo scontri nuovi e più gravi, e Paolo a quel punto si mosse contro Pietro con estrema durezza, contrapponendoglisi «viso a viso», rinfacciandogli la sua «ipocrisia», e con lui - scrive Paolo - «cominciarono a simulare anche i giudeo-cristiani, tanto che anche Barnaba fu indotto a simulare insieme a loro» (Gal. 2, 13).
Le decisioni del Vicario di Cristo, che inizialmente avrà pur guidato la Comunità originaria, non vennero ripetutamente considerate vincolanti, almeno fin dall'inizio, come solo molti secoli dopo lo diventeranno abitualmente quelle dei Papi. Anche cristiani assolutamente modesti allora poterono permettersi di muovergli dei rimproveri (Atti, 11, 2 sg.). Durante la controversia antiochena, Paolo pretese il diritto, di decidere autonomamente rispetto a Pietro; per questa ragione tale atteggiamento fu sempre particolarmente imbarazzante per i Cattolici, e a buon diritto venne utilizzato da Lutero come argomentazione contro la fede nell'infallibilità del Papa.
Sono eloquenti in proposito le acrobazie esegetiche dei Padri della Chiesa.
Tertulliano ci insegna che siamo qui in presenza soltanto di un errore comportamentale, non dottrinale (Tert,. praescr. haeret. 23); la Chiesa predilesse fin dal principio tali distinzioni artificiose: anche quando in seguito procedette alla liquidazione di milioni di «streghe» si trattò pur sempre e in ogni caso di un errore di comportamento. Gerolamo sostenne che Pietro e Paolo avrebbero fatto finta di polemizzare fra loro, per poi poter procedere tanto più efficacemente contro i giudeocristiani (Hieron., Comment. in Gal. 2, 11). Agostino, che trovò sgradevole l'idea della finzione polemica dei Principi degli Apostoli, respinse il suggerimento di Gerolamo, ammettendo la bocciatura di Pietro (Aug,. ep. 28; ep. 70).
Il che spiacque a S. Tommaso, che si limitò a definire veniale il peccato di Pietro. Ippolito, poi, negò recisamente i contrasti fra gli Apostoli, trasformando sbrigativamente in Pagani e Giudei gli avversari giudeo-cristiani di Paolo. Per Clemente Alessandrino l'avversario di Paolo non fu affatto Pietro, ma un giovane sconosciuto. E Ireneo preferì stendere sulla diatriba il pietoso velo del silenzio, lasciando credere che le discussioni di Gerusalemme si fossero svolte in bellissima concordia d'intenti. Insomma, si evitò accuratamente di porre in risalto i contrasti e, al contrario, si fece di tutto per sottolineare l'armonia all'interno della Comunità primitiva.
Ma cosa accadde in realtà?
In Antiochia Pietro si adeguò immediatamente all'ambiente nuovo, e, ignorando i Comandamenti cerimoniali della Legge validi per la Comunità originaria, consumò i pasti insieme ai pagano-cristiani. E continuò a farlo finché non giunsero alcuni inviati di Giacomo, e Pietro mutò fulmineamente opinione, rifiutò quella compagnia, e, come se ciò non bastasse, volle tutto a un tratto costringere i pagano-cristiani a vivere al modo dei giudeo-cristiani (Gal. 2, 12-14).
Evidentemente, dunque, Pietro, che «ebbe timore degli inviati di Giacomo», già da allora non era più il primus apostolorum, l'autorità prima della Comunità gerosolimitana, e tanto meno poteva esserlo fuori di essa. «Per il vasto ambito del Paganesimo cristiano le regole e le direttive sono impartite da Paolo, che le impone contro Pietro» (Windisch, Paulus und Christus, 297).
Dopo questo conflitto non si pervenne mai più a un accordo; anzi, come anche il cattolico Ehrhard è costretto ad ammettere, il cambiamento di atteggiamento di Pietro equivale all'abbandono al proprio destino del Cristianesimo Pagano. Sicuramente Paolo non avrebbe passato sotto silenzio un riconoscimento da parte di Pietro; al contrario, se ne sarebbe servito a tutti gli effetti. Ma Paolo tace, e questo argumentum ex silentio è determinante. Inoltre, egli si era inimicato anche con Barnaba, nonché con una grande parte dei cristiani antiocheni.
La Comunità primitiva contro Paolo
In primo luogo, poi, tutti i giudeo-cristiani furono ostili a Paolo, del quale contestarono l'apostolato fra i Pagani, e che considerarono persona ipocrita, pronto a compiacere superficialmente la gente, ad agevolare troppo l'accesso al Cristianesimo, a falsarlo e a predicare non la parola di Gesù, ma se stesso. Fu anche accusato di truffa finanziaria e di cupidigia, venne disprezzato come pessimo oratore, gli fu rinfacciata la sua viltà e venne definito strambo e pazzo 3. E alla fine fu deciso - per dirla con un teologo cattolico (Ehrhard, Urkirche u. Frühkatholizismus, 51) - di alienargli il consenso delle sue stesse comunità.
Da quel momento in poi, dunque, non si trattò più di diatribe su dottrine e princìpi, ma di una lotta vera e propria per il potere. Mentre Paolo si trovava impegnato nei suoi lunghi viaggi missionari, agitatori giudeo-cristiani penetravano nei territori di sua competenza, forniti di lettere commendizie dei primi Apostoli 4, talvolta fors'anche falsificate 5. Nelle Comunità dei Galati s'insinuarono «quelli di Giacomo», a Corinto si precipitarono i seguaci di Pietro e Pietro medesimo, per «arginare la dottrina fuorviante di Paolo» 6. Anche un Cattolico (Koestner) ammette l'esistenza di un «partito di Cefa a Corinto», ma solo per dimostrare «il prestigio di Pietro»!
Alcuni decenni dopo, la Prima Epistola di Clemente definisce i Corinzi «militanti nei partiti degli Apostoli», e un esegeta moderno parla di una Chiesa lacerata, che minaccia di frantumarsi in piccoli gruppi forniti di parole d'ordine specifiche, di una crisi di fondo di prima grandezza (1 Clem. 47, 4; 46, 5. Eichholz, 52 e 49). Tutto lascia intendere, inoltre, che in Efeso i cristiani antipaolini fossero molto più fanatici.
Paolo contro la Comunità Primitiva
Naturalmente la battaglia non fu condotta da una parte sola.
Nelle Epistole paoline ritornano di continuo le lamentele sui giudeocristiani di Gerusalemme, tuonano le maledizioni, si moltiplicano la sua mordente polemica e il suo velenoso sarcasmo. Nella Lettera ai Galati, dal cui tenore fu tanto impressionato Lutero, sostiene ch'essi non si muovono nella verità del Vangelo, che lo stravolgono, che sobillano la Comunità, la stregano, la confondono, la deviano, e non si perita di maledire ripetutamente e con energia i suoi avversari 7.
In seguito Paolo divenne ancor più aspro, lamentando litigi, discordie, spaccature. Non parla di due, ma di quattro partiti, che si richiamavano a lui, ad Apollo, a Pietro e a Cristo 8. Paolo accusa gli avversari di predicare un altro Gesù, un altro spirito, un altro Vangelo; di falsare la parola di Dio, di proclamare Cristo mossi solo dall'invidia, dall'odio e dalla discordia 9. Lascia capire che asserviscono i suoi seguaci, li sfruttano, li schiaffeggiano, e che hanno personalmente oltraggiato e umiliato lui stesso 10. Da parte sua, egli affibbia loro l'appellativo di «cani» (questa parola aveva allora un valore un po' diverso), e di «mutilati» 11, con sprezzante, allusione alla loro circoncisione e alla propaganda che ne facevano:
«Genti di tal conio sono falsi apostoli, operai imbroglioni, che di Apostoli del Cristo hanno soltanto la maschera. E non c'è da meravigliarsi: infatti, lo stesso Satana assume la maschera di Angelo della Luce» (2 Cor. 11, 13 sg.).
Ma chi erano codesti servitori di Satana, codesti falsi Apostoli? Chi osservi più attentamente - scrive il Teologo Lietzmann - riconosce dietro di loro «le ombre dei grandi di Gerusalemme. Nel suo nuovo mondo cristiano stava da solo, avendo alle spalle gli avversari peggiori».
Può servire a mettere meglio a fuoco il rapporto fra Pietro e Paolo la constatazione che quest'ultimo evita il nome onorifico grecizzato di Pietro, la roccia, utilizzando al suo posto la forma aramaica Cefa, che non significava nulla per il lettore di lingua greca. Su questo fatto assai eloquente, da parte cattolica si tenta di scorgere semplicemente un richiamo di Paolo alla tradizione originale, ch'egli, per altro, rispetta così poco che, per dare legittimazione al complesso della sua dottrina, si richiama a un mandato personale ricevuto da Dio.
Negli ultimi anni della sua vita l'ostilità verso la Comunità originaria si acutizzò ulteriormente, soprattutto nei confronti delle sue correnti più radicali. Nella Lettera ai Romani e nelle lettere da Roma Paolo non fa più menzione di Pietro, ch'era ormai l'avversario principale, dopo aver rotto per sempre ogni forma di relazione coi primi Apostoli. Ma già durante i due anni di prigionia di Paolo in Cesarea, Giacomo, il primo «vescovo» di Gerusalemme, non fece assolutamente nulla per lui. Al contrario, gli antipaolini raccolti intorno al fratello di Gesù dispiegarono in tutto il mondo un'attività più intensa solo allo scopo - come lamenta Paolo - «di aggiungere ulteriori motivi di preoccupazione alla mia prigionia» 12.
La lotta proseguì anche dopo la morte di Paolo
Tutte le correnti giudeo-cristiane scaturite dalla Comunità primitiva, anche le più moderate, rifiutarono Paolo come Apostolo e continuarono la polemica anche dopo la sua morte, come è in parte attestato persino nel N.T. La Lettera di Giacomo polemizza apertamente e decisamente contro la dottrina paolina della giustificazione, nonostante che anch'egli, stranamente, si fondi come Paolo sul medesimo passo veterotestamentario 13. Anche nel Vangelo del giudeo-cristiano Matteo, composto circa vent'anni dopo la morte di Paolo, i non giudei vengono definiti cani e porci, e tali espressioni, in contrasto con tutta la tradizione sinottica, vengono poste sulla bocca di Gesù, per il quale gli uomini sono tutti uguali (Mt. 7, 6; 10, 5 sg.). E per qualche tempo fu guardato con estremo sospetto dalla Comunità di Roma, anch'essa fondata da giudeo-cristiani.
Poco mancò poi che l'Apostolo, altamente stimato dai Marcioniti e da molti Gnostici, ma totalmente ignorato da personaggi ecclesiastici di primo piano nel II secolo come Papias e Giustino, venisse dichiarato eretico dalla Chiesa (Knox, 114). Il Padre della Chiesa Tertulliano lo chiama spregiativamente «Apostolo degli eretici» (haereticorum apostolus) e avrebbe preferito di tutto cuore disconoscergli anche quel titolo, per valorizzare maggiormente i meriti dei primissimi Apostoli (Tert., adv. Marc. 3, 5; 1, 20).
Dall'altra parte, ovviamente, anche i seguaci di Paolo continuarono dopo la sua morte un'acutissima polemica contro i giudeo-cristiani. Con accenti frementi di zelo la Lettera a Tito, scritta qualche decennio dopo la sua dipartita, così si esprime:
«Perché esistono molti che rifiutano di sottomettersi, chiacchieroni e truffatori, specialmente tra le file dei giudeo-cristiani; bisognerebbe tappar loro la bocca, in quanto gettano nello scompiglio intere famiglie, propagando inaudite dottrine in nome di un lucro davvero turpe».
E Tito viene esortato a «combatterli senza alcun riguardo» (Tit. 1, 10 sgg.). Altrettanto decisamente i giudeo-cristiani vengono combattuti nella Lettera a Timoteo, anch'essa un falso (1 Tim. 1, 4 sgg.).
Questa specie di guerra lasciò tracce ancora più evidenti fuori dal N.T. Fu soprattutto il Giudaismo cristiano a scagliare le accuse più aspre contro Paolo. Nelle Omelie pseudoclementine, tramandate sotto il nome di uno dei primi Vescovi di Roma, i giudeo-cristiani fecero di Paolo un eresiarca, l'eretico più antico della cristianità, anzi, addirittura l'«Anticristo» 14.
Ma come si pone la storiografia ecclesiastica cattolica di fronte a questa polemica rovente all'interno del Cristianesimo primitivo? Essa sminuisce, banalizza, marginalizza tale spettacolo disastroso, sostenendo che l'opposizione giudeo-cristiana sarebbe stata costituita da un gruppetto sparuto della Comunità originaria. Ma questa tesi appare già contraddetta dalla semplice riflessione che una minoranza irrilevante non avrebbe potuto sostenere una simile polemica tanto a lungo e con tanto vigore, e per di più contro l'autorità degli Apostoli. A meno che il loro prestigio fosse davvero assai scarso!
Il tentativo di occultare questo enorme conflitto caratterizza già gli Atti degli Apostoli, chiaramente pensati per appianare e mediare le controversie: Pietro e Paolo vivono le medesime esaltazioni celestiali, compiono gli stessi miracoli e tengono discorsi pressoché uguali. Quando diventa impossibile nascondere anche le tracce dei loro contrasti, li si minimizza: non esistono differenze, ciascuna fazione è buona e agisce in piena legittimità.
A partire dal II secolo, così, la sintesi conciliatrice della Chiesa inventò lo splendido parallelismo, l'accoppiata ideale dei Principi degli Apostoli Pietro e Paolo, i modelli della cristianità, cui rivolgersi con assoluta venerazione. E ciò si verificò, forse, non senza un discreto farsi da parte di Paolo (Cfr. Gal. 2, 7 sg.), che a poco a poco fu posto in ombra dal «primo Papa». E nel 1647 Innocenzo X condannò come eresia l'equiparazione di Pietro con Paolo (Mirbt, 381).
Il contrasto fra il Cristianesimo paolino e quello petrino venne posto in risalto nel XIX secolo dalla Scuola di Tubinga, ma anche nella ricerca critica più recente o recentissima viene unanimemente ammesso che, aldilà dei riconoscimenti formali, fra la Comunità originaria e Paolo si giunse ad aspri conflitti, sostenuti non da una esigua minoranza giudeo-cristiana, ma apertamente guidati in prima persona dagli Apostoli stessi; e che non si trattò sic et simpliciter di diatribe limitate ad aspetti cerimoniali secondari, quali la circoncisione e le norme alimentari, ma di differenze ben più sostanziali, concernenti la teologia di Paolo, assai lontana sia dalla fede dei primi Apostoli che dall'insegnamento di Gesù.
Questo fatto decisivo verrà approfondito nei due capitoli successivi, che non potranno non trattare, almeno di sfuggita, il problema delle fonti.
Note
1
2 Cor. 11, 5; 12, 11. Interpretato come ironico dalla maggior parte
degli studiosi. Cfr., ad es., Ackermann, Jesus, 152. Hamack, Mission u.
Ausbreitung, I, 353. Goguel, 51. Albertz, 150.
2
Grundmann, Das Problem des hellenistischen Christentums, 1, 73. Anche
Heitmüller, Zum Problem Paulus u. Jesus, 320 sgg.
3
1 Cor. 9, 1 sg.; Gal. 1, 6-10; Thess. 2, 3 sg.; 2 Cor. 12, 1-14; 4,
1-5; 12, 16-18; Thess. 2, 5; 2 Cor. 10, 1; 10, 10; 11, 6; 5, 13; 11, 1;
11, 1216 sgg. Inoltre Feine-Behm, 159 sg. Schoeps, Paulus, 72 sgg.
Sospetta una certa avidità di denaro in Paolo anche il
teologo cattolico Guardini, Das Bild von Jesus dem Christus, 41.
4
2 Cor. 3, 1. Inoltre Pfleiderer, 1, 87 sg. e 131.
5
1 Cor. 3, l; Kol. 4,18; Thess. 2, 2; 3, 17; inoltre Nock, Paulus,
116. E anche Ricciotti, Paulus, 162.
6
E. Meyer, Ursprung und Anfänge, III, 441. Cfr. anche
Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, I, 110. Idem, Sitzungsbericht
der Berliner Akademie der Wissenschaften, Phil. hist. Kl. 1930, 153
sgg. Nock, Paulus, 87.
7
Gal. 2, 14; 1, 6 sg.; 4, 17; 4, 9; 3, 13; 5, 1; 3, 1; 1, 8 sg.; 5, 12.
8
1 Cor. 3, 3; 11, 18; 1, 10-12.
9
2 Cor. 10, 12-18; 11, 4; 2, 117; Phil. 1, 15 sg.
10
2 Cor. 11, 20; 2, 5; 7, 12; 2, 1; 12, 21.
11
Phil. 3, 2. Che in questo passo si intendano i giudeo-cristiani e
non, ad esempio, i Giudei, viene espressamente rilevato da Ehrhard,
Urkirche u. Frühkatholizismus, 55.
12
Phil. 1, 17. Inoltre Stauffer, Die Urkirche, 301.
13
Cfr. Jak. 2, 14 sgg. (a
condizione, naturalmente, che la lettera di Giacomo non sia, come
alcuni suppongono, uno scritto puramente giudaico) con Rom. 4, 3;
inoltre 1 Mos. 15, 6. In proposito Diem, 400 sgg. Anche Lietzmann,
Geschichte der alten Kirche, 1, 213.
14
Ps. Clem., rec. 3, 61. Cfr.
specialmente anche Ps. Clem., hom. 17, 13 sgg.; 18, 6 sgg. Schoeps,
Theologie u. Geschichte des Judenchristentums, 118 sgg. Idem, Paulus,
77 sgg. Idem, Urchristentums, Judentum, Gnosis, 17 sgg.