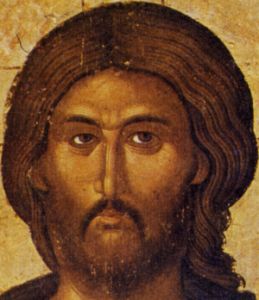
Volto di Cristo, icona greca
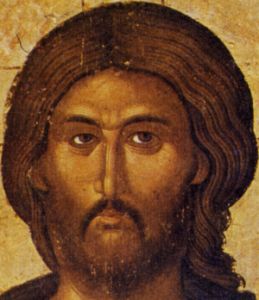
Volto di Cristo, icona greca
Libro secondo
Paolo
22. DA GESÙ A CRISTO (parte prima)
Il Cristianesimo è la religione fondata da Paolo, la quale in luogo del Vangelo di Gesù introduce un Vangelo su Gesù.
(Wilhelm Nestle, Krisis, 89)Le false Epistole di Paolo
Come già su Gesù e sugli Apostoli, nemmeno su Paolo possediamo testimonianze storiche autonome. Ciò che di lui conosciamo deriva quasi esclusivamente dalle sue Epistole e dagli Atti degli Apostoli, che non sono solo poco attendibili, ma spesso sono in aperta contraddizione con le lettere, delle quali parecchie furono falsificate, alcune completamente, altre soltanto in parte; certune poi non sono altro che centoni rappezzati coi brandelli di altri scritti.
Non appartengono sicuramente a Paolo le «Epistole pastorali» (così definite da circa due secoli), vale a dire le due Lettere a Timoteo (Schleiermacher se ne accorse a proposito della Prima) e la Lettera a Tito. L'inautenticità di queste tre Epistole fu stabilita per la prima volta dallo studioso di Tubinga Johann Gottfried Eichhorn nel 1812: furono composte in Asia Minore alcuni decenni dopo la morte di Paolo, adottando sapientemente lo stile di quelle autentiche. Il Teologo Hans von Campenhausen compendia il risultato critico dell'intera ricerca critica sulla Bibbia nella dichiarazione che qui
«abbiamo a che fare con una falsificazione esemplare, quantunque di alto livello culturale, che con ogni probabilità si colloca nella prima metà del II secolo».
Non a caso proprio queste tre Epistole mancano nelle raccolte più antiche delle lettere paoline, dichiarate spurie non per ragioni storicofilologiche, ma soltanto teologiche, già nel II secolo da Marcione (che pure si richiamava a Paolo), e rifiutate anche da altri «eretici» cristiani dei primi tempi 1. Con tutta probabilità le Lettere Pastorali furono composte proprio per poter combattere Marcione per mezzo di Paolo. Nel II e nel III secolo in ambienti cattolici venne falsificata tutta una serie di scritti, attribuiti poi agli Apostoli, soprattutto per combattere i Marcioniti, considerati estremamente pericolosi per la Chiesa; a Paolo venne, ad esempio, attribuita anche una Terza Epistola ai Corinzi.
In seguito proprio le lettere paoline falsificate acquistarono una particolare importanza per il Cattolicesimo montante: Ireneo, Tertulliano, Clemente Alessandrino, Origene e altri le usarono addirittura contro quelle autentiche, nei confronti delle quali erano naturalmente molto più sofisticate sotto il profilo della teologia e del diritto ecclesiastico. Anzi, furono propriamente tali attività falsarie a rendere conformi alle esigenze della Chiesa le Epistole autentiche e ad accrescere il prestigio di Paolo all'interno della Chiesa cattolica.
Come abbiamo già ricordato, mancò poco che questi venisse dichiarato eretico, perché essa non poteva ancora utilizzare ai propri fini l'autore delle Lettere autentiche. In seguito anche i Papi citarono con particolare predilezione proprio le pseudo-lettere pastorali, soprattutto per giustificare le condanne contro gli eretici e per rafforzare la loro pretesa di riconoscimento delle proprie scelte dottrinali.
Anche la Lettera agli Efesini viene definita un pietoso inganno da quasi tutta la Teologia critica, da molti anche la Lettera ai Colossesi e soprattutto la Seconda Lettera ai Tessalonicesi, ma su questi scritti non è stata raggiunta un'unanimità di giudizio.
È invece generalmente negata la paolinità della Lettera agli Ebrei: Tertulliano ne indicò come autore Barnaba, altri l'attribuirono a Luca o a Clemente di Roma. Ma essa entrò nel N.T. solo in quanto presunta opera di Paolo, dove venne accettata senza obiezioni fino a Lutero, il quale, forse giustamente, ne ritenne autore Apollo.
Le altre lettere paoline neotestamentarie sono oggi considerate autentiche, anche se contengono aggiunte di mani estranee o vennero messe insieme, sulla base di «determinati punti di vista della comunità cristiana», da un ignoto scrittore, che si servì di testi paolini risalenti a epoche assai differenti, com'è il caso della Seconda e anche della Prima Lettera ai Corinzi 2.
Al problema dell'autenticità si aggiunge quello della esegesi.
Molti passi sono plurivalenti, la loro interpretazione è difficile e la traduzione stessa è già in certa misura (molto più che in altri scritti neotestamentari) un'interpretazione.
L'autore della Seconda Lettera di Pietro riscontrava nelle epistole paoline la presenza di «molte cose di difficile comprensione» (2 Petr. 3, 16). Il Vescovo Policarpo, forse proprio l'autore delle Lettere Pastorali attribuite all'Apostolo, non era in grado di «tener dietro alla sapienza del santo e celebre Paolo» (Polyc., ad Phil. 3, 2). Lo stesso Agostino confessò che molte cose gli «erano del tutto oscure» (Aug., civ. Dei, 20, 19, 2).
Lutero, poi, come prima di lui Marcione, aprì la strada a un'interpretazione corretta, per certi aspetti, del pensiero paolino; altri, invece, si limitarono a perseverare nel travisamento di Paolo. Perciò Goethe poté affermare a buon diritto che l'Apostolo ha scritto cose, che l'intera Chiesa cristiana non è in grado di comprendere fino al giorno d'oggi.
E ciò vale ancora per i nostri tempi. Divenne addirittura famoso un motto del teologo di Basilea e amico di Freud, Franz Overbeck, rivolto durante un colloquio al teologo Harnack, a lui molto ostile: Paolo ebbe un solo discepolo che lo comprese, Marcione - e questi lo travisò. E ancora di recente H.J. Schoeps (Paulus, 1) ha scritto di Paolo: «Da Marcione a Karl Barth, da Agostino a Lutero, a Schweitzer o a Bultmann, o è stato travisato o compreso solo parzialmente».
E da codesto Paolo, che, come compendia Schoeps (ibid.) alla fine della sua opera sull'Apostolo, fu sostanzialmente frainteso dai suoi seguaci, non solo, ma che lui stesso «fin dal principio ha tutto inteso erroneamente», derivano i nuclei centrali della fede cristiana.
Come dovremo spiegare in seguito, fu Paolo che per primo favorì l'evoluzione della concezione determinante, che consentì di trasformare Gesù in Cristo, una persona umana in un Dio insegnato, venerato e oggetto di culto da parte della Chiesa: in un principio metafisico, un'essenza spirituale ultraterrena inviata sulla terra a redimere l'umanità e da Dio nuovamente innalzata al cielo dopo la sua Resurrezione 3.
Ma come si pervenne a tale innovazione?
Il Gesù storico non si ritenne un Dio
Gesù non si identificò mai con Dio, né disse «Io» per intendere Dio.
(Il teologo Wendland)La frase: «Io sono figlio di Dio» non venne inserita da Gesù nel suo Vangelo, e chi ve la introduce come una frase accanto a tante altre, aggiunge al Vangelo qualcosa di estraneo.
(Il teologo Harnack)
Nonostante molteplici ritocchi e aggiustamenti, i Vangeli consentono ancora di determinare con chiarezza quanto fosse lungi dalle intenzioni del Maestro di Galilea la propria identificazione con Dio. Proprio i perfezionamenti apportati dai Vangeli più recenti al testo più antico svelano il processo neotestamentario di divinizzazione, come abbiamo già dettagliatamente mostrato. A questo punto ci limiteremo ad alcune aggiunte chiarificatrici del mutamento gravido di conseguenze che, attraverso i primi Apostoli, condusse da Gesù alla Cristologia paolina.
Nel N.T. Gesù rivolge le proprie preghiere non a se stesso ma a Dio, giungendo persino a un certo grado di tensione manifesta nei suoi riguardi, quando gli chiede di allontanare il calice amaro e prorompe nella celebre lamentazione: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » (Mc. 14, 36; 15, 34), che ben presto divenne tanto imbarazzante, che il Vangelo Apocrifo di Pietro la modifica: «Mia forza, o mia forza, perché mi hai abbandonato?» (Ev. Petr. 19), e il Vangelo di Luca sostituisce quella dubbia espressione con la frase: «Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio» (Lc. 23, 46. Cfr. inoltre Ps. 31, 6).
Inoltre, il Gesù sinottico distingue sovente fra sé e Dio, definendo buono lui, non se stesso, il che gli Evangelisti più recenti non tralasciano di comunicare. Per Gesù è poi chiaro che non è lui, ma Dio a concedere i posti nel Regno, del cui avvento solo Dio possiede la conoscenza (Mc. 10, 40; 13, 32). Soprattutto nel Vangelo più antico, benché già sottoposto allo stravolgimento di una pluridecennale tradizione orale, Gesù appare ripetutamente come un uomo, che è ben conscio dell'enorme distanza da Dio.
È certamente vero che alla domanda del Gran Sacerdote se Gesù fosse il Cristo, il figlio dell'Altissimo, ivi si legge la chiara risposta:
«Sì, lo sono; e vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza e giungere con le nuvole dei cielo» (Mc. 14,60 sgg.).Ma già C.G. Montefiore osserva opportunamente:
«Come possiamo sperare di arguire anche soltanto approssimativamente ciò che Gesù ha inteso con queste parole, se non sappiamo con certezza nemmeno quel che ha effettivamente detto?».
La Teologia critica ritiene storicamente infondata qualsiasi affermazione messianica di Gesù nella Bibbia: infatti non esiste alcuna prova che il Gesù storico abbia preteso per sé uno solo dei titoli messianici - Messia, Figlio di Dio, Figlio di Davide, Figlio dell'Uomo - che circa mezzo secolo dopo la sua morte gli furono attribuiti dagli Evangelisti. E secondo il parere unanime dei teologi critici, Gesù non sollecitò alcuna forma di fede in se stesso; anzi, è loro propria l'osservazione importantissima, che al centro della sua predicazione si trova l'annuncio dell'approssimarsi del Regno, ma nessun comandamento di fede; e che il concetto di «fede» in Gesù penetrò solo in seguito in alcuni passi evangelici di creazione recente, come invenzione della Comunità successiva e della sua attività propagandistica; insomma, che Gesù non entra affatto nella dottrina da lui proclamata. Solo il Quarto Vangelo pone sulla bocca di Gesù esortazioni alla fede, mentre le due uniche eccezioni nei Sinottici sono nate in seguito a una rielaborazione posteriore, come risulta chiaramente dalla comparazione testuale 4.
Taluni particolari, apparentemente insignificanti, tradiscono il processo di esaltazione della figura di Gesù, che abbiamo già indicato. Così se Marco a proposito di Giuseppe di Arimatea dice che anch'egli «attendeva il Regno di Dio», Matteo, con una sottile ma eloquente differenziazione, scrive che anch'egli «era diventato un discepolo di Gesù» 5. In tal modo il «Regno di Dio» annunciato nel Vangelo di Marco, in quello di Matteo diventa più spesso il Regno di Gesù o del Figlio dell'Uomo, e l'Annunciatore si trasforma in Annunciato 6. O ancora, se in Marco Gesù parla degli umili «che ci credono», Matteo aggiunge «che credono in me» (Cfr. Mc. 9, 42 con Mt. 18, 6). Se in Marco gli Apostoli, dopo la passeggiata di Gesù sulle acque, sono solo «fuori di sé per la meraviglia», in Matteo si prostrano ed esclamano: «Davvero Tu sei il Figlio di Dio! » (Cfr. Mc. 6, 51 sg. con Mt. 14, 33).
E dunque il Maestro di Galilea pose al centro della sua predicazione non se stesso, ma Dio e il Prossimo; annunciò non il Cristo, ma il «Regno»; non si presentò agli uditori gridando «credete in me!» (appare ridicolo solo pensarci); egli non pretese per sé una venerazione religiosa, né fu mai oggetto di culto da parte della Comunità primitiva.
Neppure i primi apostoli ritennero Gesù un Dio
Rispetto a Paolo, i primissimi Apostoli «non erano ancora così teologicamente evoluti».
(Il teologo cattolico Meinertz, 1, 218)
Per i primi Apostoli Gesù era una persona umana: «un uomo privilegiato da Dio mediante azioni straordinarie, miracoli e portenti»; era il «profeta» annunciato da Mosé, era il «servo» di Dio, «il santo e il giusto», che fu «innalzato». Solo dopo la Resurrezione, Dio «lo ha fatto Signore e Cristo» 7. Cristo è la traduzione greca di messia (aram. mescîha, ebr. maschîach), che, secondo le concezioni veterotestamentarie, è certo creatura al di sopra di tutti gli uomini, straordinariamente privilegiata, ma pur sempre un essere mortale. Nel Giudaismo non è mai esistito un Messia che fosse Dio stesso o che possedesse un'essenza divina.
E agli occhi di Apostoli rigidamente monoteisti come avrebbe mai potuto apparire Signore del cielo e della terra e di tutte le creature un uomo, col quale condividevano la vita quotidiana, col quale viaggiavano da un luogo all'altro e col quale erano fuggiti? Se gli abitanti di Nazareth potevano permettersi di dire: «Ma questi non è il figlio del falegname e di Maria, fratello di Giacomo, Joses, Giuda, Simone? E le sue sorelle non vivono forse fra noi?» (Mc. 6, 3); gli Apostoli, che dovettero sperimentare proprio a Nazareth il fallimento della sua taumaturgia, come avrebbero mai potuto ritenerlo il Creatore dell'Universo? Questo dogma venne proclamato dalla Chiesa, la quale accusò di primitiva eresia i giudeo-cristiani ben fermi nella loro antica fede.
Gli Apostoli e la Comunità primitiva - come dichiarano all'unisono i teologi e gli storici moderni - non erano affatto divisi dal popolo ebraico e dalla sua religione; essi non conoscevano né una fede in Gesù né la sua nascita da una Vergine, della quale non sa nulla nemmeno Paolo, né una sua preesistenza, idea estranea anche ai Sinottici, e con certezza almeno a Marco. La Comunità primitiva non aveva alcuna dottrina consapevolmente strutturata e nemmeno un credo religioso saldamente determinato. Infatti anche
Il «Credo Apostolico» non deriva dagli Apostoli
Il cosiddetto «Credo Apostolico» non fu messo insieme dagli Apostoli e non riproduce i loro convincimenti: il testo originale, come ha dimostrato inequivocabilmente l'indagine storico-filologica, nacque nel II secolo, molto probabilmente nella primissima età cattolica fra il 150 e il 175, a Roma, e non in Asia Minore.
Questo Symbolum Romanum, forse creato per combattere i Marcioniti, è la forma più antica del Credo cristiano, che in un lungo corso di tempo incorporò tutta una serie di aggiunte: per esempio, l'articolo attuale «Credo in una santa Chiesa cattolica, nella comunità dei santi», originariamente suonava: «Credo in una santa chiesa». Le parole «cattolica» e «comunità dei santi» sono appendici inserite nei secoli successivi (Trillhaas, 14; 28; 86).
Ancora nel III secolo la lettera del Credo era fluida, come viene attestato da innumerevoli varianti, e il testo definitivo venne fissato solo nel Medioevo. Non ci sono due scrittori cristiani antichi che citino un'identica formula, e accade addirittura che uno stesso Padre della Chiesa utilizzi forme differenti.
La tesi della composizione apostolica del Credo venne diffusa alla fine del II secolo 8 e accreditata per più di un millennio. Fu l'Umanista Lorenzo Valla (1407-1457), funzionario curiale sotto molti Pontefici, che demolì tale leggenda. Nel 1865 un Sinodo tenuto a Zurigo fece decadere l'obbligo dei parroci Protestanti al cosiddetto Credo Apostolico, e in seguito anche le autorità ecclesiastiche di Berna e di Basilea lasciarono perdere quest'obbligo, come fece anche Württemberg nel 1912.
E allora, che cosa hanno insegnato gli Apostoli?
Essi si limitarono a completare la predicazione di Gesù con la notizia della sua morte e della sua Resurrezione (fatto non raro in quel tempo), mentre per il resto si attennero alla speranza nel suo immediato ritorno e nella prossima realizzazione del Regno di Dio (Atti, 3, 20). Infatti, era proprio della fede giudaica il convincimento che i Profeti sarebbero ritornati per proseguire la loro missione terrena: soltanto poche generazioni prima anche il «Maestro di Giustizia» degli Esseni subito dopo il trapasso venne innalzato al rango di Messia e di Giudice Universale, il cui ritorno veniva dato per certo. E fu grazie all'accettazione delle future aspettazioni giudaiche (Cfr. Mc. 13) che la Comunità primitiva venne rinsaldata nella speranza in codesto Regno messianico terreno.
Anche Paolo aveva contato sull'immediato ritorno di Cristo
Paolo fu «ossessionato dalla preoccupazione che l'annunciazione si sarebbe realizzata con estrema rapidità e che il tempo fosse assai ristretto; infatti - a suo giudizio - Gesù risorto sarebbe stato sottratto alla terra solo per poco, e il suo ritorno sarebbe accaduto in tempi brevissimi, in pochi anni, se non in poche settimane».
(Il teologo Overbeck)È innegabile che Paolo, come l'intera cristianità primitiva, si sia ingannato: la Parusia attesa in un tempo assai prossimo non si realizzò affatto.
(H.J. Schoeps)
Anche da cristiano Paolo conservò le tradizionali convinzioni escatologiche, ma senza le valenze politiche nazionalistiche loro proprie. Come tutti i cristiani del tempo credette che il mondo si avviasse alla fine, e l'attesa dell'immediato ritorno di Cristo ispirò e infiammò l'intera sua opera, e difese apertamente tale credenza con estrema decisione.
«Noi, quelli che viviamo, quelli che sopravviviamo fino all'arrivo del Signore».
Così scrive nella Prima Lettera ai Tessalonicesi (1 Thess. 4, 15), ma è un concetto che emerge chiaramente anche da Epistole successive:
«Lo spazio di tempo che rimane è assai breve - esorta i Corinzi - il mondo qual è va incontro al tramonto» (1 Cor. 7, 29 sgg.),e promette solennemente:
«Ecco, vi svelo un segreto: non tutti noi moriremo, ma tutti saremo trasformati»,concludendo con l'invocazione dei cristiani più antichi: «Vieni, o Signore!» (1 Cor. 15, 51; 16, 22).
... e poi abbandonò tale fede
A poco a poco, col passare degli anni, la speranza di Paolo nella prossima Parusia svanì, e la delusione fu accelerata dalla morte di molti cristiani, ai quali aveva solennemente promesso che sarebbero vissuti fino all'arrivo del Signore (1 Thess., 4, 15). E allora spiegò i casi di morte non previsti come castigo di Dio per l'assunzione peccaminosa dell'Eucaristia 9, assicurando però che anche i fratelli defunti sarebbero subito risorti all'arrivo del Cristo, mentre tutti gli altri trapassati avrebbero dovuto attendere fino alla resurrezione finale 10.
Ma alla fine lasciò perdere del tutto tale credenza originaria, spiritualizzando l'ingenuo realismo della propria escatologia e insegnando, contro ogni evidenza concreta, che il mutamento eonico tanto atteso, la palingenesi, benché esteriormente invisibile, almeno per i credenti era già avvenuta mediante la morte e la Resurrezione di Gesù. Per l'uomo «in Cristo» è improvvisamente incominciato il nuovo Eone:
«Se uno è in Cristo - così egli si sente in dovere di affermare - costui è una nuova creatura (2 Cor. 5, 17): il vecchio è trapassato, ecco, è divenuto qualcosa di nuovo».Finalmente la salvazione profetizzata da Isaia è diventata presente.
«Vedete, ora c'è il tempo tanto atteso, vedete, ora c'è il dì della salvazione» (2 Cor. 6, 2).
Mentre i primi Apostoli, insieme a tutta la loro Comunità, credevano nell'immediato irrompere del nuovo Eone, in stridente contrasto con essi Paolo afferma che codesto Eone ha già avuto principio con la morte e con la resurrezione di Gesù. Ormai non è più il Cristo che dovrà giungere sulla terra, ma è il cristiano che soffre e muore per lui che otterrà con la morte il ricongiungimento con Cristo.
Allora si comprese che tale mutamento della fede paolina, data la promessa contenuta nella Prima Lettera ai Tessalonicesi, (forse la testimonianza più antica del N.T.), per cui i cristiani ancora in vita sarebbero «sopravvissuti fino all'arrivo del Signore» (1 Thess. 4, 15), non poteva evidentemente reggersi in piedi. Perciò venne falsificata la Seconda Lettera ai Tessalonicesi, in tutto o in parte, interpolandovi alcuni passi.
L'intervento si evince dal fatto che la Seconda Lettera ai Tessalonicesi è una copia pressoché integrale della Prima, ma riguardo alla Parusia dice esattamente il contrario: se nella Prima Epistola Paolo ne aveva sostenuto l'arrivo assolutamente inaspettato, condannando ogni calcolo apocalittico, il «Paolo» della Seconda Lettera (a detta di tutti i sostenitori della sua autenticità scritta solo pochi mesi dopo la Prima) prende posizione contro l'idea di un immediato ritorno di Gesù.
Se nella Prima lettera egli dichiara che questo giorno è inatteso e giunge improvvisamente, come un ladro nella notte, l'autore della Seconda comunica ai destinatari l'esistenza di tutta una serie di tappe importantissime non ancora compiute (Cfr. 1 Thess. 5, 1 sgg. con 2 Thess. 2, 3 sgg.).
Inoltre, prega i confratelli, contemporaneamente sconfessando come falsa la Prima Lettera autentica di Paolo, affinché non si lascino trascinare nella confusione da un'epistola che «si millanta dovrebbe provenire dalla mia penna»! (2 Thess. 2, 2). Evidentemente la Seconda Lettera si propone di svalutare e svuotare di significato la Prima, data la scarsissima credibilità della dottrina sull'attesa della fine prossima, ormai sconfessata dai fatti, e di abituare i fedeli all'inevitabile ritardo del ritorno di Cristo.
A dispetto di tutto ciò non mancano studiosi assai seri che sostengono l'autenticità della Seconda Lettera, che sarebbe quindi l'espressione del cambiamento d'opinione di Paolo, anche se in questo caso non potrebbe assolutamente essere stata scritta subito dopo la Prima (cosa per altro indimostrabile), come pure sostengono perlopiù i propugnatori della sua autenticità.
Note
1
Cfr. Clem. Al., strom. 2, 11, 52. Hieron., praef. comm. in ep. ad Tit.
2
Nock, Paulus, 7. Barnikol, Mensch und Messias, 5. Bornkamm, Studien
zu Antike u. Urchristentum, II, 139. Cfr. anche A. Schweitzer, Die
Mystik des Apostes Paulus, 49 sg. Una serie di lettere e di rnissive
più ampie alle comunità andarono perdute, ad
esempio, ai Laodicesi, assai probabilmente anche altre lettere ai
Corinzi e ai Filippesi. Cfr. Kol. 4, 16; 1 Cor. 5, 9. 2 Cor. 2, 3.
Philip. 3, l.
3
Phil. 2, 5-11. È controverso se qui Paolo citi un canto a
Cristo formatosi già prima, come ritiene Lohmeyer in Kyrios
Christos. Cfr., ad es., contro di lui Windisch, Paulus u. Christus,
163. Nel contesto che qui ci interessa ciò non è
importante. Cfr. su Phil. 2, 5 sgg. anche Rom. 1, 11 sgg.; 8, 3; 1 Cor.
1, 23; 15, 23 sgg.; 2 Cor. 8, 9.
2 Cor. 3, 1. Inoltre Pfleiderer, 1, 87 sg. e 131.
4 L'eccezione
Mt. 18, 6. Mc. 9, 42. Inoltre Mt. 18, 10; Lc. 17, 2.
Bousset, Jesus, 93.
5 Cfr.
Mc. 15, 43 con Mt. 27, 57. In proposito Dibelius, Formgeschichte,
198.
6 Cfr.,
ad es., Mc. 9, 1 con Mt. 16, 28. Altre prove cita Bousset, Kyrios
Christos, 52. Cfr. anche Grässer, 201.
7 Atti,
2, 22; 3, 22; 7, 37; 4, 27; 3, 14; 2, 33; 2, 36.
8 Iren.,
adv. haer. 1, 10, 1; 3, 4, 1. La prova più antica per
la leggenda che ne scaturì: Apostol. Constitutiones, 6, 14.
9 1
Cor. 11, 29 sgg. In proposito A. Schweitzer, Die Mystik des Apostels
Paulus, 93.
10
1 Cor. 15, 22 sgg. Cfr. anche 1 Thess. 4, 16 sg.