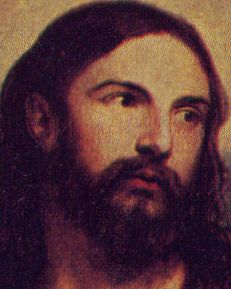
Anton van Dick, Il Cristo della moneta
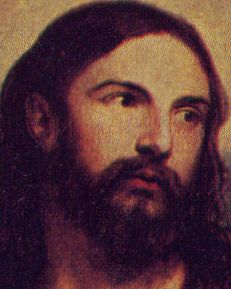
Anton van Dick, Il Cristo della moneta
Libro secondo
Paolo
22. DA GESÙ A CRISTO (parte seconda)
Paolo trasse dal Paganesimo la sua Cristologia
Alla metamorfosi della fede paolina, che sostituì la predicazione gesuana del prossimo avvento del Regno di Dio con concezioni soggettivistiche dell'Aldilà e con l'illusione dell'immortalità personale, contribuì in modo decisivo l'ambiente pagano nel quale egli viveva. Era diviso da Gesù in egual misura non solo dalla Comunità primitiva, ma anche dai cristiani Ellenizzati, dai quali trasse tutti gli elementi determinanti dei proprio pensiero. In ultima istanza, la dottrina concernente l'aspettazione della fine del mondo era estranea ai Greci, che nella religione cercavano «conoscenza», «verità», «vita» «immortalità», tutti strumenti di salvazione, che poi diventeranno anche cristiani 1.
E così Paolo fu necessitato alla riformulazione della sua teologia non solo dal mancato ritorno del Cristo e dai dubbi che ne derivavano, ma anche dall'abito mentale affatto diverso dei Greci. Egli cominciò allora a diffondere il mito del Figlio di Dio che muore e risorge (credenza nutrita da secoli), già prima di lui trasferito alla persona di Gesù nelle comunità pagano-cristiane. E come abbiamo già visto, anche figure storiche vissute ben prima di Gesù erano state venerate come esseri soprannaturali, come sotéres e kyrioi, uomini come Zarathustra o Buddha, che per altro, proprio come Gesù, non avevano mai levato pretese di divinizzazione.
Per i primi cristiani di Gerusalemme Gesù era il «Signore» (Mali = mio Signore; Maran = nostro Signore), nient'altro che un titolo onorifico ebraico, una formula di cortesia scevra di pretenziosità dogmatiche, usata nei riguardi di un Maestro e di una Guida. Ma quando quest'espressione fu ellenizzata e fatta propria dai Greci, si usò la parola kyrios, con la quale però la Septuaginta, la più antica traduzione greca del Vecchio Testamento, indicava sempre Jahvè, cioè Dio, con la conseguenza che il concetto originario cadde nel dimenticatoio, mentre quello nuovo s'impose ben presto nell'uso della Chiesa.
Tale scivolamento semantico venne agevolato dal fatto che anche molte divinità precristiane erano sovente definite «Signore/a», e che ancor prima della composizione dei più antichi scritti neotestamentari gli Imperatori Romani, venerati ormai come divinità, erano denominati kyrioi. Quindi, dal culto dei re il nome trapassò alla figura neotestamentaria di Gesù, unitamente alla parola sotér, «Salvatore», «Redentore», così che dalla venerazione di Gesù quale sotér e kyrios a poco a poco ebbe inizio il processo della sua divinizzazione. Come gli imperatori furono prima insigniti del titolo di «Redentore» e «Signore», ottenendo poi la definizione di «Dio», allo stesso modo tale predicato si impose per Gesù.
E non si trattò soltanto di una nuova denominazione, ma anche di un modo nuovo di porsi nei suoi confronti, perché nelle cerimonie religiose della Comunità si cominciò a farlo oggetto di venerazione, inaugurando il culto del Cristo: la Comunità primitiva vide in lui il Messia tanto atteso e i pagano-cristiani trasformarono il Messia in Figlio di Dio in accezione metafisica: era nato il Cristianesimo. Probabilmente già le prime Comunità pagano-cristiane pensavano a Gesù come al Figlio di Dio disceso dal cielo, dato che queste persone vivevano in un milieu religioso, che pullulava di kyrioi e di Signori divini, ai quali adesso si sovraordinò il Signore. Paolo scrive ai Corinzi:
«Infatti, se anche vi sono delle pretese divinità sia in cielo che in terra - e ci sono molti dèi e molti signori - per noi esiste soltanto un Dio» (1 Cor. 8,5 sg.).
Dobbiamo ricordare, inoltre, che i confini fra Dio e Creatura non erano allora invalicabili; soprattutto i Greci ellenistici, dai quali prese avvio la divinizzazione di Gesù, furono particolarmente permeabili e sempre pronti a ritenere un'incarnazione della divinità anche piccoli benefattori. Un antico autore della Chiesa attesta che «la superficialità dei Greci ama assegnare attributi divini a chi ha loro procurato qualcosa o li ha aiutati in qualche circostanza col consiglio o l'azione» (Firm. Mat., err. 7, 6). Una prova lampante di questa tendenza si trova anche nel N.T.: dopo la guarigione di un paralitico ad opera di Paolo e di Barnaba, gli abitanti di Lystra esclamarono:
«Gli dèi hanno assunto sembianze umane e sono discesi fra noi! E allora chiamarono Barnaba Zeus, e Paolo Ermes».
E il sacerdote del tempio di Giove s'affrettò a portare tori e corone da sacrificare agli Apostoli (Atti, 14, 8 sgg.).
Anche l'arrivo di Apollonio sarebbe stato celebrato dagli Spartani quale epifania divina, se egli lo avesse consentito; e ancora nel IV secolo a Efeso venivano concessi onori divini alla sua statua 2.
Nell'antichità i processi di eroizzazione, di deificazione e di apoteosi erano all'ordine del giorno, e si volgeva lo sguardo intorno alla perpetua ricerca di Salvatori e di Redentori. Specialmente fra i Greci la venerazione divina costituiva quella forma specifica di ringraziamento, che poi trapassò nel Cristianesimo attraverso Paolo e la sua Comunità.
Come abbiamo già dettagliatamente mostrato, anche per il Cristo biblico si ripropone il destino dei Redentori pagani: vivono dall'eternità, giungono al mondo in modo portentoso, perlopiù partoriti da una vergine, e sono Demiurghi, Profeti, Salvatori. Anch'essi proclamano: «Io sono il Pastore», «Io sono la verità», «Io sono la luce del genere umano», «Chi crede verrà salvato, chi non crede andrà incontro alla condanna» (Bultmann, Das Urchristentum, 183) ecc.
Agiscono anch'essi per amore del prossimo, si distinguono per mezzo di miracoli e di profezie, discendono negli Inferi per liberare i defunti, resuscitano spesso il terzo giorno o dopo tre giorni, innalzandosi quindi al Padre celeste. Come i cristiani, anche i loro fedeli, mediante l'unione cultuale, partecipano della nuova vita eterna del Dio risorto, redenti dalle sue sofferenze. «Consolatevi, voi Misti! Come il Dio viene salvato, così dai suoi dolori (ek ponòn) scaturisce per voi la salvazione» - recita un'invocazione misterica (Firm. Mat., err. 22, 1).
È significativo che Paolo descriva la beatitudine con parole schiettamente greche ed ellenistiche. Le sue Lettere, come vedremo, sono zeppe di formule tratte dal lessico religioso dei Pagani, che in modo sorprendente spesso coincidono anche concettualmente con le idee delle religioni misteriche e con la filosofia greca.
Il culto di Mitra, che denota tanti e tanto sorprendenti parallelismi col Cristianesimo, proprio a Tarso, patria di Paolo, aveva un santuario già in epoca precristiana (Plutarch., Vita Pompei, 24). Nella stessa Tarso è attestato, poi, il culto di una divinità agreste che muore e risorge, Sandan, protettrice della città, la cui morte e resurrezione veniva celebrata solennemente tutti gli anni. Ovviamente in quella città erano ben conosciuti Adone, Attis e Osiride, divinità che muoiono e risorgono.
L'intero dramma salvifico del Cristianesimo -preesistenza, incarnazione, martirio, morte, resurrezione, discesa all'Inferno e ascesa in cielo -è una contaminazione di concezioni misteriche e di filosofia ellenistica; esso contiene un evidente parallelismo con quei Figli di Dio precristiani discendenti dalla luce celeste, che sulla terra combattono, patiscono, muoiono, ritornano a Dio trasfigurati e continuano ad essere venerati nel culto.
A tutto questo si ricollega Paolo, imbevuto del patrimonio culturale ellenistico fin dalla più tenera età, aprendo la strada a un mutamento radicale, lui, il «Rabbi in abiti di predicatore stoico itinerante», il «sognatore ed estatico» 3, la cui Teologia entusiastico-intuitiva il teologo Pfleiderer definì della stessa natura della concezione e della produzione artistiche. Paolo traspose il mito dell'uomo che discende dai cieli al profeta di Galilea, trasformando il suo insegnamento in una religione misterica e lui stesso in una divinità misterica, e creando quindi la grandiosa fede nel Cristo figlio di Dio. Secondo un dotto cattolico (Meinertz), così facendo Paolo attinse «dal più profondo della sua anima»; infatti, anche per i Cattolici questa metamorfosi del Cristo, la sua preesistenza, la sua comparsa come falegname con annessa ascesa al cielo e intronizzazione, non possono essere immediatamente evinti dalla dottrina di Gesù.
...e ignorò il Gesù storico
Non abbiam bisogno di ribadirlo: la Teologia paolina non definì affatto l'opera e la figura umana di Gesù. Su questo dato di fatto non c'è nulla da discutere. Colui, del quale Paolo volle essere discepolo e servo, non fu propriamente la persona storica di Gesù, bensì un altro.
(Il teologo Wrede)
Come ammettono quasi tutti gli studiosi, Paolo non conobbe il Gesù storico 4, e in ogni caso non fu mai suo discepolo. Dopo la conversione attese tre anni prima di presentarsi per la prima volta al Principe degli Apostoli, e la visita fu breve e niente affatto cordiale. In un secondo momento, la Comunità primitiva sostenne che si discostava dal Vangelo, rendendolo oscuro e falso. Ma egli fa riferimento a una rivelazione celeste. Paolo menziona Gesù tanto raramente che viene scomodato l'argumentum ex silentio: tutto ciò ch'egli poté dire su Gesù non necessariamente si deve trovare nelle sue Lettere. Ipotesi resa piuttosto fragile dalla dichiarazione dello stesso Paolo:
«Anche se noi abbiamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora non lo conosciamo più in questo modo» (2 Cor. 5, 16).
Le Lettere non recano traccia di una tradizione palestinese di Gesù: Paolo accenna solo incidentalmente alle parole di Gesù (anche un Cattolico lo dice!: Ricciotti, Das Leben Jesu, 92) e si discute se si riferisca a lui quattro, tre o due volte 5. Solo tre volte egli raccomanda l'imitazione di Cristo, pensando però non a Gesù, ma alla sua preesistenza divina 6.
A tal proposito è singolare che il titolo messianico di «Il Cristo» (che è la traduzione dell'ebraico l'Unto) solo nella Lettera ai Romani ricorre due volte, di più che in tutti i Vangeli sinottici. E d'altra parte Paolo evita chiaramente il semplice nome di «Gesù», che in tutto il corpus Paulinum conosce solo 15 occorrenze, mentre la definizione di «Cristo» ricorre ben 378 volte.
L'indagine critica è pressoché unanime nel riconoscere che la figura paolina del Cristo non è definita né dalla personalità di Gesù né dal complesso della sua predicazione etico-religiosa, e che anzi l'Apostolo appare inventore di una sua personale teologia proprio in questioni essenziali. Già Nietzsche sorride ironicamente sulla libertà con la quale Paolo
«ha affrontato, quasi evitandolo, il problema della persona di Gesù: uno che è morto, che sarebbe stato veduto dopo il decesso; un tizio mandato a morte dai Giudei... Un puro e semplice motivetto conduttore, al quale egli aggiunge la propria musica» (Nietzsche, Wille zur Macht, Aph. 101).
Un esimio contestatore della storicità di Gesù, Arthur Drews, non avrebbe potuto dichiarare senza ragioni plausibili che Paolo di Gesù non sapeva nulla.
Come che sia, non si trova alcuna relazione storica fra Paolo e Gesù. Una vaga affinità interiore trova le proprie radici nell'utilizzazione di entrambi della tradizione giudaica, ma Paolo non si preoccupa né del carattere e della condotta di Gesù né tampoco della sua dottrina morale. Della vita di Gesù gli sta a cuore soltanto un aspetto: la sua morte, e definisce apertamente il proprio Vangelo come «la parola della croce», scrivendo inoltre: «Mi sono proposto di non mostrarvi altra scienza se non quella di Gesù il Cristo, cioè del Crocifisso» (1 Cor. 1, 18; 2, 2).
E mentre in tal modo si smarrisce la conoscenza del Gesù storico, si consolida la fede nel Cristo mitico.
«Io dimentico tutto ciò ch'è alle mie spalle e mi protendo a ciò che mi è innanzi, e vado verso la meta prefissata, verso il gioiello» (Phil. 3, 13 sg.).
confessione più volte ripetuta da Paolo, che caratterizza la sua evoluzione. Egli proietta Gesù sempre più decisamente in ambito mitico e metafisico, facendolo diventare alla fine da individuo umano per così dire una figura cosmica, un'entità spirituale ultraterrena: il Cristo mistico. Ma con esso poteva giustificare qualsiasi contenuto religioso, attribuendogli, come poi fece realmente, qualunque cosa volesse.
Vediamo di riassumere: Gesù (in ebraico Jeschua o, in forma più antica, Jehoschua, grecizzato in Jason o Jasios, diffuso nome proprio giudeo, che significa «soccorso di Jahvè», corrispondente grosso modo al nostro cognome Diotaiuti) non molto dopo la sua morte diventa il Cristo, da un Ebreo deriva un Cristiano, dalla sua fede nasce la fede in lui, cioè, per dirla con Herder, da un vivente disegno di Gesù per il bene dell'uomo scaturisce una spensierata adorazione della sua persona.
Già il filosofo inglese Lord Bolingbroke (m. 1751) individuò nel N.T. due Religioni, quella di Gesù e quella di Paolo; analogamente Kant distinse acutamente fra la dottrina di Gesù e quel che di essa fecero già, a suo avviso, gli Apostoli, i quali
«in luogo del concreto insegnamento religioso del santo Maestro, esaltarono la venerazione dei Maestro stesso» 7.Altrettanto decisamente Lessing separò la religione del Cristo, cioè
«quella religione ch'egli stesso conobbe e praticò come persona umana, e che ogni uomo potrebbe condividere», dalla religione cristiana «che presuppone come vero ch'egli fu più che uomo, facendone come tale un oggetto di venerazione» 8.Anche Fichte e Schelling riconobbero che, per usare le parole di quest'ultimo,
«già nella spiritualità di Paolo, l'Apostolo delle Genti, il Cristianesimo divenne altra cosa da quel che fu negli intenti dei suo fondatore» (Schelling, IX Vorlesung, 198).
Paolo diede inizio, dunque, a questo mutamento radicale, decisivo per la Chiesa. Con lui cominciò il trapasso dall'originario Cristianesimo escatologico a quello sacramentale; al posto del prossimo avvento del messianico Regno sulla terra, ansiosamente atteso dagli Apostoli e dai giudeo-cristiani, subentrò il concetto greco di immortalità, il profeta ebreo divenne il cristiano Figlio di Dio. In altri termini: la delusione dell'attesa venne compensata con la fede nell'Aldilà. Senza questa trasformazione, la mancata realizzazione del Regno avrebbe segnato il destino finale della giovane setta di Gesù.
Tuttavia per Paolo Gesù non si identifica con Dio, come insegna la Chiesa, e tanto meno è in lui presente una qualsiasi traccia di dottrina trinitaria. Ma fu lui a dissolvere il monoteismo veterotestamentario, introducendovi una dottrina biteistica. Appoggiandosi a Paolo, la Chiesa collocò in second'ordine l'etica dell'amore, che fu al centro della predicazione di Gesù, ponendo in primo piano la fede in lui, mai proclamata dal Nazareno, al posto della di lui fede. Metafisica invece di ethos, fede invece di amore, cristologia invece di discorsi della montagna; questo è stato, grosso modo, il suo cammino: la dogmatica diventò più importante dell'etica, la retta fede più importante dell'agire rettamente.
Gesù fu innalzato al cielo perché non desse più fastidio in terra, come attesta significativamente il presunto credo «apostolico», che non contiene una sola parola dell'insegnamento di Gesù, ma solo le dottrine della Chiesa posteriore! La posta in gioco reale si trova formulata nella memorabile frase del Padre della Chiesa Ippolito:
«Il Verbo balzò dal cielo nel corpo della Vergine, dal corpo della Vergine sulla croce, dalla croce nell'Ade; poi saltò nuovamente sulla terra - oh! la nuova resurrezione! - e dalla terra in cielo. E così si assise alla destra dei Padre» (Cit. da Werner, Entstehung, 714).
I nobili ideali di Gesù furono rimossi dallo pseudoideale di una fede e di una ecclesiasticità, che la massa (ma non solo quella) scambiò per il valore originario, mentre in realtà poneva esigenze tanto insignificanti da potere essere adempiute comodamente anche dai più fiacchi. Va da sé che era necessario lasciare in vigore i comandamenti biblici, tuttavia sviliti nella loro importanza e vieppiù deprivati della loro radicalità.
Nel Medio Evo, poi, il teologo ufficiale della Chiesa, Tommaso d'Aquino, sostituì i principi del Discorso della Montagna con l'Etica del pagano Aristotele, in ogni caso per la massa dei fedeli, mentre i pochi cristiani decisi a vivere con maggior rigore dovettero darsi alla vita monastica, istituzione della quale Gesù non aveva mai parlato.
Note
1
Cfr. Jh. 14, 6; 17, 3; Did. 9, 3; 10, 3; 2 Clem. 20, 5. Cfr. Knopf,
Das nachapostolische Zeitalter, 373 sgg.
2
Philostr., vita Apoll. 4, 31. Lact., div. inst., 5, 3, 14.
3
Fascher, Das Neue Testament, col. 941. Klausner, Von Jesus zu Paulus,
305.
4 Il
passo controverso: 2 Cor. 5, 16; 1 Cor. 9, 1 si riferisce certamente
alla visione presso Damasco. Cfr. anche 1 Cor. 15, 8.
5 I
passi in questione: 1 Cor. 7,
10; 9, 14; 11, 24 sg.; 1 Thess. 4, 15. I due ultimi passi non sono in
discussione. Cfr. ad es. Bultmann, Theologie des N. T., I, 185. Cfr.
anche la sezione «Le parole del Signore» in Drews,
Díe Christusmythe, 11, 134 sgg.
6 1
Thess. 1, 6; Rom. 15, 7; Kol. 3, 13. In proposito Nock, Paulus, 195.
Bultmann, Theologie des N. T., 185.
7 Lettera
a Lavater dell'8/4/1774. Cit. da Nestle, Krisis, 280.
8 Lessing,
Die Religion Christi, 1780, cit. da Nestle, Krisis, 280.