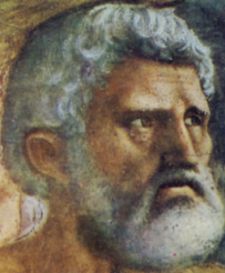
Masaccio, Il Tributo, Volto di Pietro
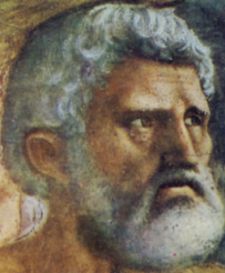
Masaccio, Il Tributo, Volto di Pietro
Libro secondo
Paolo
23. ULTERIORI DEFORMAZIONI DELL'INSEGNAMENTO DI GESÙ AD OPERA DI PAOLO
Tutti gli aspetti più belli del Cristianesimo sono legati a Gesù, tutti quelli deteriori a Paolo.
(Il teologo Overbeck, 55)La dottrina cristiana della salvazione non deriva da Gesù
Per quanto si sia radicata profondamente fra i cristiani, di questa dottrina il Gesù autentico non sapeva nulla.
(Il teologo Grimm, 180)DIALOGO NELL'ANNO 33
A.: La sa l'ultima?
B.: No. Cos'è successo?
A.: Il mondo è redento.
B.: Se lo dice Lei.
A.: Sì. Il buon Dio ha assunto forma umana e si è fatto giustiziare
a Gerusalemme; e con ciò il mondo è ora redento e il diavolo è buggerato.
B.: Eh, ciò è davvero molto carino 1.
Sulla base di tutto ciò che è stato tramandato su Gesù si può dire che la dottrina paolina della redenzione gli fu completamente estranea. Infatti, egli predica un «Padre» che non perdona il peccatore pentito solo mediante una mediazione espiatoria, ma tutti coloro che sono essi stessi disposti al perdono e alla conversione; un «Padre» che, come nella parabola del figliol prodigo, va egli stesso alla ricerca del peccatore. Gesù non fa dipendere la remissione dei peccati dalla sua morte, bensì, come insegna nel Pater Noster e in altri luoghi, unicamente dalla disponibilità degli uomini a perdonare il prossimo (Mt. 6, 12; 6, 14 sg.; Mc. 11, 25 sg.).
Se la sua morte fosse stata da lui ritenuta necessaria per la redenzione e per la remissione dei peccati, come avrebbe potuto dire che quel calice amaro venisse allontanato e «i tuoi peccati ti sono perdonati»? (Mc. 2,9 sgg.). La teoria della redenzione sorse solo quando lo scandalo inatteso della morte sulla croce - «in realtà nient'altro che una disgrazia» - (Blüher, 282. Cfr. anche Pfleiderer, 1, 372) costrinse i cristiani a una differente interpretazione. Ma in questo modo l'insegnamento originario non venne solo modificato, ma anche svuotato di significato.
Come molte altre cose, in seguito valorizzate dalla Chiesa, nei Sinottici la dottrina della redenzione non svolge ruolo alcuno. Si allude ad essa esclusivamente in due passi, che per altro, secondo il giudizio della maggior parte degli esegeti più moderni, non sono autentici. L'espressione concernente il sacrificio della vita quale riscatto per «molti», che Matteo e Marco pongono sulla bocca di Gesù, ma che manca in Luca (Mt. 20, 28; Mc. 11, 25), o risale alle concezioni paoline oppure è un'invenzione della comunità ellenistica, se non addirittura della Comunità palestinese intorno a Gesù, essendo la sussunzione di un versetto dal capitolo 53 di Isaia. Il secondo e ultimo passo che pone espressamente in relazione la morte di Gesù con la remissione dei peccati si trova solo in Matteo, ma manca in Marco, in Luca e nella Prima Lettera ai Corinzi 2.
È significativo il fatto che per gli Ebioniti, gli immediati credi della Comunità primitiva, la morte di Gesù sulla croce non ebbe alcun carattere conciliatorio né alcun significato salvifico, e perciò essi non usavano calici durante la cerimonia eucaristica, celebrata significativamente con estrema semplicità con pane e sale, secondo la tradizione più antica. Com'è noto, i discendenti degli Apostoli negavano anche la divinità di Gesù e la sua nascita da una vergine.
E allora, da dove trasse Paolo la propria teoria della salvazione?
La purificazione dai peccati mediante il sangue era già ben nota anche ai popoli primitivi, ed è del pari antichissima la credenza nella salvazione dell'umanità mediante il «figlio». Nell'antica religione babilonese Marduk venne inviato sulla terra dal padre Ea per salvare gli uomini; Eracle e Dioniso discesero anch'essi sulla terra come divinità redentrici; nel culto di Mitra il sangue di un toro ucciso, versato sul peccatore, lo purificava dalle colpe; in sanscrito la parola significante «venerare religiosamente» (ârâdh) vuol dire esattamente «riconciliare», «placare la collera».
Nell'antichità era altresì diffusissima l'idea del re, che soffre e muore per il suo popolo. Un'opera cristiana del I secolo ricorda i numerosi monarchi pagani, che in circostanze critiche, in seguito a un responso oracolare, avevano sacrificato la vita «per salvare i concittadini col proprio sangue» (1 Clem. 55, 1). Anche il Sommo Sacerdote Caifa allude a tale concezione, quando consiglia ai Giudei ch'era meglio per loro
«che un singolo perisse per il popolo, e non che un intero popolo precipitasse nella rovina» 3.
Tertulliano, Padre della Chiesa, intorno al 200 scrive:
«Nel mondo pagano era consentito riconciliarsi mediante sacrifici umani con la Diana degli Sciti, col Mercurio dei Galli e col Saturno degli Africani; ancor oggi, proprio a Roma, viene versato sangue umano in onore di Giove Latino» (Tert., Scorpi. 7. Cfr. anche Firm. Mat., err. 26, 2. Cicero, in Vatin. 6).
Verso la metà del III secolo anche Origene fa un chiaro riferimento a questa usanza specifica del Re e del Giusto, che patisce e muore per le colpe del suo popolo, parlando dei
«numerosi racconti di Greci e Barbari, che trattano della morte di pochi in nome dei bene comune, per liberare le loro città e i loro popoli dalle disgrazie che li opprimevano» 4.
In occasione di questi atti di riconciliazione, spesso venivano uccisi anche dei malfattori, come avveniva ancora in epoca tarda nella greca Rodi e a Marsiglia.
Gli Ebrei d'età più antica condividevano con Cananei, Moabiti e Cartaginesi l'usanza di uccidere dei bambini per riconciliarsi con la divinità; in seguito al posto dei bambini subentrarono i delinquenti. Anche l'agnello pasquale, arrostito a forma di croce (simbolo religioso presente già in epoca precristiana), era un surrogato dell'uccisione del primogenito.
Simili usanze erano note a Paolo, che una volta vi allude; e alle concezioni sottese a tali costumanze poteva ricorrere tanto più facilmente per il fatto che anche Gesù era stato giustiziato come malfattore 5. Come il sangue di tutti gli uomini immolati prima di lui possedeva una forza espiatoria, la medesima virtù doveva possedere anche il suo. Paolo predica continuamente la riconciliazione (katallaghé) e la redenzione (apolytrosis), lo strumento d'espiazione «nel suo sangue», la redenzione «mediante il suo sangue», la pacificazione «attraverso il sangue versato sulla croce»(Rom. 3, 25; Eph. 1, 7; Kol. 1, 20). Evidentemente non fu nemmeno sfiorato dal pensiero che Dio potrebbe, forse, perdonare una colpa anche senza una riparazione «ufficiale».
A Paolo erano ovviamente ben note anche le idee di espiazione presenti nel V.T., soprattutto i patimenti del giusto come riparazione sostitutiva delle colpe di tutti 6, ma non è possibile stabilire se e in quale misura fu condizionato dalle relative tradizioni teologiche della Comunità primitiva. In ogni caso le cose erano talmente comuni, che i Vangeli non forniscono per la morte espiatoria di Gesù nessuna spiegazione ulteriore.
Ancora nel nostro secolo accade che si tenti di riconciliare la collera celeste mediante sacrifici umani: qualche decennio fa in India una madre uccise la figlia di quattro anni per placare l'ira di una divinità, dopo che tutti gli altri mezzi avevano fallito. Negli Stati Uniti nel 1933 due persone vennero uccise come vittime sacrificali da una setta religiosa, e nel 1960 degli Indi cileni sacrificarono agli dèi due membri della propria schiatta a causa di una catastrofe naturale. Qualcuno se ne potrebbe meravigliare o scandalizzare, e poi forse pregare Cristo, la cui morte ha redento lui stesso.
Resta naturalmente imperscrutabile la ragione per cui tutto ciò si verificò così in ritardo, perché gli uomini dei millenni trascorsi non furono salvati; ma è chiaro che Gesù doveva diventare il Redentore, che si doveva andare incontro in qualche modo a una necessità religiosa delle masse, che dappertutto si attendevano Redentori, Salvatori e Messia. E se il Cristianesimo voleva ottenere una qualche influenza determinante, anche nel suo caso alla domanda doveva conseguire l'offerta adeguata. «In fondo si trattava proprio di questo: il Pagano di quei tempi aveva bisogno di questo e questo andava cercando» 7.
Quanto più cattivo è l'uomo, tanto più è necessaria la sua redenzione
Perché la fede cristiana si fonda quasi totalmente sulla conoscenza chiara di due cose: la corruzione della natura umana e la redenzione per opera di Gesù Cristo.
(Blaise Pascal, Pensées, III, 194)
Ma Gesù non ha parlato nemmeno del presupposto di tale dottrina della redenzione, cioè di quella connaturata malvagità di tutti gli uomini parimenti sostenuta da Paolo 8. È vero il contrario: egli nutre un ottimismo morale: non si trova in lui nessuna affermazione dell'incapacità dell'uomo al bene, della sua ineluttabile condanna senza l'opera mediatrice del Cristianesimo. Paolo, invece - come viene ammesso anche da parte cattolica - dedica i primi tre capitoli della Lettera ai Romani alla dimostrazione di questa tesi: infatti, quanto più cattivo è l'uomo, tanto più necessaria è la sua redenzione.
Di conseguenza egli pone in primissimo piano la dottrina dell'universalità della corruzione umana: gli uomini sono cattivi «per natura», sono scellerati, «creature dell'ira», «schiavi del peccato» (Eph. 2, 3; Rom. 6, 17), immersi fino al collo nella «sporcizia della lussuria», nelle «passioni nefande». Non c'è vizio cui non siano abbarbicati:
«Sono ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia e malizia, pieni d'invidia, di istinti assassini, di discordia, di perfidia e abiezione; essi sono denigratori, calunniatori, nemici di Dio, gente violenta e altezzosa, millantatori, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, privi d'amore e di misericordia» (Rom. 1, 29 sgg.).La dottrina del peccato originale
In nessun passo dei Sinottici Gesù riconduce la peccaminosa miseria degli uomini a una colpa primigenia, e tanto meno al peccato originale. Evidentemente la narrazione biblica della caduta non ebbe per lui quell'importanza decisiva, attribuitale poi da Paolo e dalla Chiesa.
(Il teologo Gross, Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas, 1, 66 sg.)
Da questo totale disprezzo del mondo naturale venne dedotta la dottrina del peccato originale, elevata ad articolo di fede solo nel XVI secolo, che non viene sostenuta né da Paolo né da nessun altro autore neotestamentario. Secondo tale dogma ogni creatura umana viene al mondo già come capro espiatorio, perché la sua anima è stata contaminata dalla «caduta» di Adamo ed Eva; ma i Padri della Chiesa più antichi dichiarano esplicitamente che i bambini sono senza colpa 9! Del resto, Paolo stesso attesta che nella sua comunità di Corinto i figli di genitori cristiani non erano battezzati. Soltanto assai più tardi, quando scoprì il peccato originale, la Chiesa stabilì come obbligo rigoroso di coscienza dei seguaci che battezzassero tutti i neonati «fin dal seno materno» (Gross, ibid., I, 66).
Intorno al 400 il monaco irlandese Pelagio, insieme all'amico Celestio, giureconsulto romano, protestò vigorosamente contro il dogma nascente: sostenendo che l'uomo è in grado di agire secondo la morale, che la dottrina del peccato originale lo trasforma in una sorta di marionetta e serve solo come alibi di cristiani infingardi, essi provocarono la polemica pelagiana (411-431). L'episcopato orientale inclinava, perlomeno sentimentalmente, verso le loro concezioni e il Vescovo di Roma Zosimo, in un primo momento favorevole a Pelagio e Celestio, fu poi aizzato contro di loro.
Ma l'avversario vero e proprio fu Agostino. In principio costui chiamò Pelagio «nostro fratello», poi lo fece condannare quale eretico a Cartagine prima, quindi a Roma, e infine nel Concilio di Efeso del 431. In realtà Agostino rappresentava le nuove tendenze di pensiero, Pelagio la tradizione; e fu esattamente lui «il padre del dogma del peccato originale nel vero senso della parola» (Gross, ibid., I, 375), che conobbe in seguito un processo di estremizzazione con la Riforma. Zuinglio, tuttavia, sotto molti aspetti un'eccezione fra i Riformatori, definito da Lutero addirittura «pagano» a causa della sua tolleranza, condannò come non evangelico l'articolo dottrinale concernente il peccato originale. Nemmeno la maggior parte delle Chiese cristiane d'Oriente conosce una dottrina ben definita intorno al problema, e nel XIX secolo una scuola teologica abissina negò recisamente il peccato originale.
Taluni teologi cattolici tentano di spiegare il silenzio assoluto di Gesù sul dogma del peccato originale, sostenendo che i suoi uditori non sarebbero stati ancora in grado «di cogliere il significato di un tale mistero» 10. Singolare davvero che solo pochi anni dopo, con Paolo, fossero capaci, come si presume, di comprenderlo, e di comprendere oltretutto anche Gesù, che proclamava un segreto terribilmente più complicato e, secondo il punto di vista dei cattolici, incomparabilmente più estraneo alla cultura ebraica, vale a dire il mistero della Trinità.
Ma neppure l'astruso teologismo del peccato originale è specificamente cristiano, se è vero che concezioni analoghe erano assai diffuse nelle religioni pagane: intorno al 2000 a.C. un poeta sumerico scrive: «Mai da donna nacque bambino senza peccato» (Kuschke, 74).
La dottrina della predestinazione
Si aggiunga infine che quel Dio, il quale prescrive comprensione e perdono di qualsiasi colpa, non li mette in pratica, ma si adopera esattamente a favore del contrario... fino a quelle poche eccezioni, che, chissà mai perché, vengono salvati per grazia. Ma lasciando pure da parte questa riflessione, ne risulta che il buon Dio avrebbe creato il mondo perché il demonio se ne impadronisse; e allora avrebbe fatto molto meglio a lasciar perdere.
(Arthur Schopenhauer, 318)
Nemmeno il dogma sconfortante della predestinazione, connesso a quello del peccato originale, fu mai accennato da Gesù. Ma a sentir Paolo, Dio si comporta come un despota senza scrupoli, destinando ab aeterno uno alla salvazione, un altro alla dannazione: tutto dipende
«non dalla volontà o dagli sforzi di ciascuno, ma dalla misericordia divina... Dio ha pietà di chi vuole, e, se vuole, lo indurisce» (Rom. 9,16 sgg. Cfr. anche Rom. 9, 8 sgg.; 8, 28);
il che, detto en passant, prova che il Nuovo Testamento nega la libera volontà dell'uomo.
E non era poi un concetto originale, giacché sopravvive nel Cristianesimo non poco della fede pagana nel Fato e dell'arbitrio del Dio veterotestamentario. Ma anche agli Esseni era familiare una concezione identica a questa propagandata da Paolo. Il Corano, poi, che accentua l'idea della predestinazione con particolare rigore, insegna - come Paolo - che
«Dio consente che si perda nell'errore chi vuole, e chi vuole egli guida per il giusto sentiero» (Sura 6, 125).
Certo, Paolo sostiene anche il contrario:
«Infatti Dio ha chiuso tutti nella disobbedienza, per usare poi a tutti misericordia» (Rom. 11, 32),
ragion per cui di tanto in tanto la sua dottrina sulla predestinazione viene contestata. Ma resta decisivo il fatto che le frasi sopra citate ebbero il loro seguito, anche se relativamente tardi. Agostino riprese, elaborò e difese con estrema radicalità tale concetto, benché non lo avesse accolto fin dall'inizio della sua attività dottrinale. E anche i Riformatori lo fecero proprio: Calvino ne divenne il propugnatore più famigerato.
Il Gesù della Bibbia non ne sapeva nulla: nella sua predicazione, come scrive Wilhelm Nestle (Krisis, 56), ci si viene a trovare quasi sempre all'interno di una sfera concettuale naturalistica, schietta e puramente umana: «il cuore vi dà il suo assenso, e la ragione non vi si oppone».
Gli esordi dell'ascesi
Contrariamente a un'opinione assai diffusa, condivisa anche da uomini come Schopenhauer e Tolstoi, pur con tutte le esortazioni a una rinuncia a se stessi, Gesù non insegnò mai il rifiuto della società né la negazione della sensualità e della natura. È vero che nei Sinottici si trovano parole che paiono indicare questa tendenza, ma se ne trovano assai più numerose e decisive che vanno in senso opposto (Mt. 19, 10 sgg.; 19, 21; Lc. 12, 33).
In primo luogo va detto che il Gesù sinottico non vive affatto da asceta, e nemmeno i suoi discepoli 11. Certo, l'Evangelista pone in bocca a Gesù le parole:
«Finché lo sposo si trova con loro, essi non possono digiunare. Ma verranno giorni in cui lo sposo sarà loro tolto; allora, in quei giorni, digiuneranno» (Mc. 2, 19 sg.).
Solo che tale riferimento al costume cristiano del digiuno è un'interpolazione postuma, una giustificazione della successiva prassi ecclesiastica, nata quando i cristiani digiunavano senza rendersi conto, per altro, che così si scostavano dall'esempio di Gesù (Dibelius, 97). Che questo rinvio al futuro contenga un vaticinium ex eventu dimostra con particolare evidenza l'espressione «in quei giorni digiuneranno», chiara allusione all'astinenza cristiana del venerdì. Il presunto digiuno osservato da Gesù per quaranta giorni nel deserto non è che un calco della storia di Mosè e di Elia, che digiunarono per quaranta giorni e quaranta notti 12.
Il Gesù della Bibbia non abita nel deserto, come Giovanni Battista, dal quale si allontanò proprio perché rifiutava le sue predicazioni penitenziali, la sua ascesi, la sua insistenza più sulla minaccia che sulla promessa del prossimo regno di Dio; non respinge il mondo, non fugge le gioie e le feste, anzi, come già Buddha prima di lui, viene bollato dai suoi avversari come «ghiottone e ubriacone», insulti coi quali gli Ebrei schernivano il frutto di una relazione illegittima, quando il comportamento tradiva la macchia originaria della nascita.
E con tutto ciò, pur in stridente contrasto con Gesù, la pratica ascetica penetrò nel Cristianesimo già ad opera di Paolo: astinenza e mortificazione delle passioni assumono in lui toni solenni. Sarx, la carne, vi compare addirittura come sede del peccato: nel corpo non c'è assolutamente «nulla di buono», è un «corpo di morte», tutto ciò ch'esso vuole «significa morte» e «odio contro Dio» (Rom. 7, 18; 7, 24; 8, 6 sg.). Il cristiano deve «spossare e asservire il corpo», «ucciderlo» (1 Cor. 9, 27; Gal. 5, 24; Rom. 8, 13; Kol. 3, 5), e così via.
Paolo è instancabile nel predicare l'odio della carne, tanto che appare difficile svalutare la corporeità più di quanto egli abbia fatto.
Esordisce il dispregio della donna
All'Apostolo (Paolo) non importa proprio nulla dell'equiparazione dell'uomo con la donna.
(Il teologo Leipoldt, Der soziale Gedanke, 119)Nella donna scorge con marcato disprezzo soltanto un'entità sessuale.
(Il teologo Preisker, Das Ethos des Urchristentums, 150)
Come dimostra il celebre Codice di Ammurabi, nella Babilonia del 2000 a.C. la donna godeva di un prestigio superiore a quello assegnatole 1500 anni dopo dal giudaismo veterotestamentario. Nel Codice di Ammurabi, per esempio, il ripudio facile veniva combattuto, mentre nel V.T. viene addirittura considerato come una punizione dover mantenere una moglie vita natural durante 13.
A differenza degli antichi Ebrei, il Gesù della Bibbia non giudicò inferiori le donne, che fecero parte della cerchia dei suoi discepoli e che fra i suoi seguaci furono forse più numerose degli uomini 14. Secondo un'antica lezione del Vangelo di Luca, Gesù venne posto sotto accusa dagli Ebrei anche perché, a loro avviso, induceva all'abiura le donne (e i bambini). A lui fu estranea qualsiasi forma di deprezzamento della figura femminile: prese sotto la sua protezione una donna contro il disprezzo dei Farisei, additò a modello di corretto comportamento nelle cerimonie sacrificali una povera vedova, guarì donne ammalate e accettò i loro servigi e il loro appoggio finanziario 15.
Già Renan (115), che scade spesso tanto facilmente nel kitsch, percepì con finezza l'atteggiamento di straordinaria delicatezza di Gesù verso le donne, e gli studi moderni ne han dato conferma. Né Gesù insegnò mai qualsivoglia forma di ostilità nei riguardi del matrimonio; alcuni discepoli erano sposati e tali restarono, come il primo Apostolo, che aveva anche figli 16; lo stesso Pietro compì un viaggio di missione in compagnia della moglie 17, e per lungo tempo i primi predicatori cristiani si spostavano per il mondo insieme alle loro famiglie.
Per Paolo, al contrario, l'uomo e la donna sono eguali solo in teoria (Gal. 3, 28); nella pratica la donna appare totalmente subordinata: ad essa viene interdetto in linea di principio il diritto di parlare nelle riunioni della Comunità e se vuol sapere qualcosa deve chiederla al marito, in casa (1 Cor. 11, 3 sgg; 14, 33 sgg.). La Prima Lettera ai Corinzi mostra con chiarezza la scarsa considerazione ch'egli nutre per la donna, quando stila la graduatoria Dio - Cristo - Uomo - Donna; inoltre prescrive il velo durante la preghiera e il servizio religioso, segno esteriore della sua bassezza, in quanto portare il velo significa «vergognarsi a causa del peccato introdotto nel mondo ad opera della donna» 18.
Ma la diffamazione paolina della donna non si arresta qui: l'uomo è «immagine e gloria di Dio», la donna semplicemente «gloria dell'uomo»; l'uomo non deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo è stato creato per la donna, bensì la donna per l'uomo (1 Cor. 11, 3 sg.). Secondo alcuni esegeti, qui Paolo ha trasformato la donna in un uomo di second'ordine.
Solo davanti a Dio le donne sono eguali agli uomini (come, d'altra parte, anche gli schiavi sono per lui eguali ai padroni) (1 Cor. 11, 11 sg.), parità religiosa già esistente nel culto di Iside e nei Misteri di Eleusi e di Andania.
Tuttavia lo stesso Paolo ebbe, a quanto pare, buoni rapporti con le donne, i cui nomi si trovano nelle elencazioni delle persone salutate nella maggior parte delle sue Epistole, e il primo discepolo in Europa fu una donna di Lidia. Ma ciò che rimase e si affermò presso la posterità furono le tesi da lui sostenute nelle Lettere.
L'avversione paolina verso le donne riproduce l'analogo disprezzo proprio del Rabbinismo: per gli esperti della Thora la donna era in assoluto un soggetto inferiore, quantunque coniugassero con tale dispregio una grandissima stima del sesso. Infatti nel V.T. Jahvè aveva sempre consentito la poligamia, perché, come spiega Agostino, i Patriarchi avevano il dovere di moltiplicare il popolo di Dio! Anzi, gli Ebrei avevano addirittura un Angelo Custode addetto all'istinto sessuale, che Paolo, purtroppo, non andò a predicare, forse perché - come si è ipotizzato - era impotente fin dall'infanzia 19.
La diffamazione del matrimonio
Paolo è pieno di un profondo disprezzo verso gli aspetti naturali del matrimonio, che attenua a semplice svalutazione di questo principio per lui fondamentale solo per una forma di riguardo verso i fratelli cristiani. Per lui la femmina è soprattutto portatrice dell'elemento sessuale nonché sua causa prima. Perciò viene esposta come tale alla medesima svalutazione, anzi al suo dispregio.
(Il teologo Delling, 154)
Nella trattazione paolina della questione matrimoniale incidono evidentemente anche le concezioni giudaiche, che non solo consideravano la femmina un essere inferiore, ma giudicavano una contaminazione anche il rapporto sessuale (2 Mos. 19, 15; 2 Cor. 6, 17; 1 Cor. 7, 14). Per Paolo il matrimonio non è altro che una concessione alla carne peccaminosa, un male necessario, consentito solo «onde evitare di cadere in preda alla concupiscenza» (1 Cor. 7, 1 sg. Cfr. anche 7, 8 sg.). Anche i mariti però dovranno avere le mogli come se non le avessero; e sarebbe molto meglio rimanere scapoli, giacché il matrimonio non reca con sé nulla di buono (1 Cor. 7, 28 sgg. Inoltre Delling, 62 sgg.).
Paolo esclude un sincero legame matrimoniale; per lui non esiste una comunione né spirituale né sentimentale né sociale fra marito e moglie; come ammettono anche i suoi ammiratori, può sussistere soltanto un'attrazione di natura sessuale. Su questo punto Kant, il quale scorge nel matrimonio un contratto stipulato per l'uso reciproco del sesso (Kant, Metaphisik der Sitten, I, 24), si viene a trovare in ottima compagnia con S. Paolo.
Ma l'Apostolo non va d'accordo con Gesù nemmeno sul problema del divorzio, sul quale anche i Sinottici si pronunciano in modo contraddittorio. In Marco e in Luca, Gesù vieta assolutamente la separazione, ma in Matteo la approva, e in più luoghi, in caso di adulterio da parte della donna (Cfr. Mc. 10, 11; Lc. 16, 18 con Mt. 5, 32; 19, 9). In stridente contrasto col divieto presente in Marco e Luca, Paolo ammette il divorzio nel cosiddetto Privilegium Paulinum, in caso di matrimonio misto fra cristiani e pagani, qualora questi ultimi richiedano la separazione 20. Ma anche la motivazione di questa concessione è in contrasto con le ragioni addotte in Matteo, che sono sicuramente spurie, precisamente un'aggiunta giudeocristiana dell'autore.
Secondo Clemente Alessandrino Paolo era sposato, ma si tratta di un'ipotesi avallata da pochissimi studiosi 21.
Dovrebbe essere ormai chiaro che lo schietto messaggio di Gesù fu da Paolo alterato nei suoi tratti fondamentali. La distanza fra i due è innegabile ed enorme. Vari dogmi risalgono all'Apostolo: il dogma di Gesù figlio di Dio in senso spirituale, il dogma del suo ritorno nel Giudizio Universale, il dogma della predestinazione; inoltre, la contrapposizione di spirito e carne e soprattutto, come vedremo, la dottrina dell'Eucaristia.
L'importanza centrale che Paolo attribuisce all'amore per il prossimo, la presa di distanza dalle norme religiose del Giudaismo spesso esteriori e ormai sopravvissute a se stesse corrispondono, tuttavia, alla predicazione originaria. Sotto questo aspetto, anzi, Paolo andò anche al di là di Gesù, ma certamente seguendo un suo proprio progetto. Al posto della Legge da Gesù combattuta e della meritorietà della fede, egli introdusse la fede in Gesù, facendone una Nuova Legge.
Paolo ha lasciato nel Cristianesimo un'impronta talmente profonda, che una sua depaolinizzazione equivarrebbe alla sua distruzione. E infatti non esiste nessuna corrente cristiana di una qualche consistenza che non si sia richiamata anche e soprattutto a lui, che non abbia ispirato e sorretto, a cominciare da Marcione e dallo Gnosticismo cristiano fino a Lutero. La Riforma, in realtà, si rifece non a Gesù, ma al Paolinismo, come pure la teologia dialettica moderna.
Da tutto ciò si evince che l'autentico fondatore del Cristianesimo fu Paolo, l'Apostolo delle Genti come viene ammesso senza riserve dagli osservatori sgombri da pregiudizi, fra i quali non mancano molti teologi. Contro questo dato di fatto i Cattolici si limitano a qualche fiacca giustificazione, dicendo, ad esempio, che l'attività di Paolo non si fonda più sulla semplice predicazione di Gesù, ma su una propria elaborazione personale, sulla sua personale fede in Cristo; che la sua rappresentazione del Cristo risplende con colori più vivi e ricchi di quanto siano in grado di fare le affermazioni dello stesso Gesù, e altri eufemismi del genere. Eppure anche da parte cattolica si ammette che «oggi Cristianesimo significa in grandissima misura Paolo» (Ricciotti, Paulus, 570), per cui essere anticristiani equivale perlopiù a essere antipaolini.
Però tale contrasto non riguarda soltanto il messaggio di Paolo, ma anche la sua prassi, poi proseguita e sviluppata in alto grado dalla Chiesa.
Note
1
Arthur Schopenhauer, cit. da Th. Ussing, Europa u. Asien, 138.
2
Cfr. Mt. 26, 28 con Mc. 14, 24; Lc. 22, 20; 1 Cor. 11, 25.
3
Jh. 11,50. Cfr. anche 18, 14. Inoltre Zehren, 98.
4
Orig. Cels. 1, 31. Cfr. anche la lunga enumerazione di sacrifici
umani dei pagani in Euseb., praep. ev. 4, 16.
5
1 Cor. 4, 13; cfr. in proposito Schneider, Geistesgeschichte, 1, 127;
454 sgg. Leipoldt, Antisemitismus in der alten Welt, 28 sg. Weinel,
Biblische Theologie, 232. Zehren, 98 sg. Schöpf, 22 sgg.
Schwenn.
6
Cfr. 1 Cor. 15, 3; Rom. 4, 25; Gal. 3, 13 e altrove.
7
Seeberg, 1, 189. Cfr. anche Harnack, Marcion, 17.
8
Rom. 3, 9-17; 5, 12-21; 7, 14-25; Eph. 2, 3.
9
Aristides, Apol. 15; Athenag., res. mort. 14. Hermas, sim. 9, 29, 1.
10
Così A. Gaudel; secondo Gross, ibid 1, 52. Cfr. ibidem
anche per quel che segue.
11
Mc. 2, 18; Mt. 9, 14; Lc. 5, 33. In proposito Heussi, Ursprung des
Mönchtums, 15 sgg.
12
Lc. 4, 1 sgg.; Mt. 4,1 sgg.; Mc. 1,12 sg.; 2 Mos. 34, 28; 1 Re 19, 8.
13
5 Mos. 22, 13 sgg.; 22, 28 sg. In proposito Delitzsch, Die
große Täuschung, 1, 77 sgg. Leipoldt, Die Frau in
der antiken Welt, 77 sgg. Idem, Der soziale Gedanke, 72 sgg. Preisker,
Christentum u. Ehe, 77.
14
Leipoldt, Die Frau in der antiken Welt, 142 sgg. Sulla cerchia dei
discepoli, Mc. 15, 40 sg.; Lc. 8, 2 sg.; 10, 38 sgg.
15
Lc. 10, 38 sgg.; 23, 27sgg.;
7, 36 sgg.; Mc. 12, 41 sgg.; Lc. 8, 1 sgg. Inoltre Leipoldt, Die Frau
in der antiken Welt, 119 sgg. Idem, Der soziale Gedanke, 87. Nielsen,
205.
16
Mc. 1, 29 sgg.; 10, 29; 1
Petr. 5,13. Inoltre W. Bauer in Hennecke, 117 sg.
17
1 Cor. 9, 5; Mc. 1, 30; Mt. 8,
14; Lc. 4, 38.
18
Delling, 108sg. Inoltre 1 Cor.
11, 3; 14, 34.
19
Fascher, Zeitschrift
für neutestamentliche Wissenschaft, 28, 1929, 65.
20
1 Cor. 7, 12 sgg. soprattutto
v. 15 sg. All'uopo Bornkamm, Die Stellung des N.T zur Ehescheidung, 283
sgg.
21
Clem Al, strom. 3, 6, 53. Per
il matrimonio di Paolo, Jeremias, War Paulus Witwer?, 310 sgg.