TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
Locke: la proprietà privata
I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X
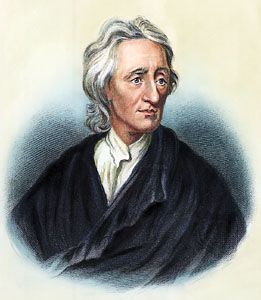
Lo Stato nasce a difesa e a garanzia della legge naturale e dei diritti naturali.
Tra i diritti naturali, quello della proprietà privata sta molto a cuore a Locke: ne parla spesso e dedica alla sua fondazione filosofica tutto il quinto capitolo del Secondo trattato. Questa fondazione merita la nostra attenzione.
La “ragione naturale” e la “rivelazione” legittimano il diritto alla proprietà.
“Dio, che ha dato il mondo agli uomini in comune, ha anche dato loro la ragione, per farne l’uso più vantaggioso alla vita e più comodo. La terra e tutto ciò che vi si trova è data agli uomini per la sussistenza e il conforto della loro esistenza. Ma, sebbene tutti i frutti ch’essa produce naturalmente e gli animali ch’essa nutre, in quanto sono prodotti spontaneamente dalla natura, appartengano agli uomini in comune, e sebbene nessuno abbia originariamente, ad esclusione degli altri uomini, dominio privato su alcuno di essi fin tanto che sono a quel modo nello stato naturale, tuttavia, dal momento che son dati per l’uso degli uomini, vi deve essere necessariamente un mezzo per appropriarsene in una qualche maniera”.
L’appropriazione potrebbe essere pensata in termini comunitari, secondo l’utopia socialista di Tommaso Moro, ad esempio, ma l’utopia di Locke è imperniata sulla proprietà privata. Se Moro, nel primo Cinquecento, ha denunciato i guasti sociali dell’affermarsi della moderna proprietà capitalistica, Locke, nell’ultimo Seicento, di quella proprietà ne esalta i vantaggi e ne scrive la legittimazione filosofica.
Egli parte dalla proprietà che per natura ogni uomo ha della propria persona.
Come si possa appartenere a se stessi, cioè essere nello stesso tempo proprietari e proprietà, Locke non lo spiega, ma lo sostiene categoricamente.
“Sebbene la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, pure ognuno ha la proprietà della propria persona, alla quale ha diritto nessun altro che lui. Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani possiamo dire che sono propriamente suoi. A tutte quelle cose dunque che egli trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate, egli ha congiunto il proprio lavoro, e cioè unito qualcosa che gli è proprio, e con ciò le rende proprietà sua. Poiché son rimosse da lui dallo stato comune in cui la natura le ha poste, esse, mediante il suo lavoro, hanno, connesso con sé, qualcosa che esclude il comune diritto di altri. Infatti, poiché questo lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore, nessun altro che lui può avere diritto a ciò ch’è stato aggiunto mediante esso, almeno quando siano lasciate in comune per gli altri cose sufficienti e altrettanto buone”.[1]
Ci sono, nel passo appena citato, due limitazioni al diritto all’appropriazione dei beni naturali: 1) in comune devono restare “cose sufficienti e altrettanto buone”; 2) il diritto alla proprietà riguarda “ciò che è stato aggiunto mediante” il lavoro al prodotto naturale.
Mentre la prima limitazione è ancora presente nelle pagine seguenti, la seconda viene subito travolta. Continua, infatti, Locke: “Chi si nutre delle ghiande ch’egli coglie sotto una quercia o delle mele che raccoglie dagli alberi di una foresta, certamente se le è appropriate. Nessuno può negare che questo cibo sia suo. Domando allora: quando hanno cominciato ad essere sue? Quando le ha digerite? O quando le mangia? O quando le ha cotte? O quando le ha portate a casa? O quando le ha colte? È chiaro che se non è il primo atto di raccoglierle quello che le rende sue, nessun altro atto lo potrebbe. È quel lavoro che ha posto una differenza tra quei frutti e quelli comuni, in quanto vi ha aggiunto qualcosa di più di quel che ha fatto la natura, madre comune di tutti, e così diventano suo diritto privato”.[2]
Locke è passato, in poche righe, dall’appropriazione di ciò che il suo lavoro ha aggiunto al prodotto naturale all’appropriazione anche del prodotto stesso.
Locke si rende conto che il passaggio è piuttosto disinvolto e prevede obiezioni: “ Si dirà forse ch’egli non aveva diritto alle ghiande o alle mele che si è appropriate in quel modo, per il fatto che non aveva il consenso di tutti gli uomini a farle sue? Era forse un furto prendere a quel modo per sé ciò che spettava a tutti in comune? Se fosse necessario un consenso del genere, sarebbe morto di fame, nonostante l’abbondanza che Dio gli ha dato”.[3]
La conclusione mistifica: l’abbondanza Dio non l’ha data a lui, ma in comune a tutti gli uomini. Anche sul consenso il discorso di Locke è pretestuoso: c’è un consenso che si può avere subito, senza morire di fame, ed è quello degli altri uomini interessati allo stesso prodotto, senza aspettare l’impossibile consenso universale. Ma, soprattutto, altro è sostenere che il valore aggiunto col lavoro al prodotto naturale appartiene al lavoratore, altro è sostenere che il prodotto naturale, una volta valorizzato col lavoro, è interamente suo, compreso ciò che è dato in comune da Dio.
Locke insiste: “Sebbene l’acqua che scorre in una fontana sia di tutti, chi può dubitare tuttavia che quella ch’è in un secchio appartenga esclusivamente a colui che l’ha attinta? Il suo lavoro l’ha presa dalle mani della natura, in cui era comune e apparteneva egualmente a tutti i figli di lei, e con ciò se l’è appropriata”.[4] Non ha più esitazioni: “A questo modo tale legge di ragione assegna il cervo a quell’indiano che l’ha ucciso: è riconosciuto un bene di colui che vi ha dedicato il suo lavoro, sebbene fosse diritto comune di altri”.
A Moro la ragione ha detto cose diverse.
L’altra limitazione, la prima, ricompare, adesso, profondamente modificata: ci si può, col lavoro, appropriare di tutti i beni naturali che si possono consumare in proprio, prima che si deteriorino. Al dovere di lasciare agli altri dei beni altrettanto buoni e sufficienti, subentra quello di non sprecare (Locke, in verità, è convinto che di beni naturali, compresa la terra buona da coltivare, ce ne siano in abbondanza per tutti, e lo dice più volte).
“La stessa legge di natura che ci conferisce con quel mezzo la proprietà, ce la limita anche. «Dio ci ha dato abbondantemente ogni cosa» (I Tim. VI, 17): questa è la voce della ragione confermata dalla rivelazione. Ma con quale limitazione Dio ce l’ha data? «A godere». Di quanto si può prima che vada perduto far uso a vantaggio della propria vita, di tanto si può col proprio lavoro istituire la proprietà: tutto ciò che oltrepassa questo limite, eccede la parte di ciascuno e spetta ad altri. Nulla fu creato da Dio per l’uomo onde vada perduto e distrutto”.[5]
Il lavoro legittima, per Locke, anche la proprietà privata della terra.
“Poiché ora il principale oggetto della proprietà consiste non nei frutti della terra o negli animali che vivono in essa, ma nella terra stessa, come quella che comprende in sé e porta con sé tutto il resto, mi pare evidente che anche la proprietà della terra sia acquisita allo stesso modo che l’altra. Quanta terra un uomo lavori, semini, bonifichi e coltivi, usandone il prodotto, tanta è proprietà sua”. Così dice la ragione a Locke e la rivelazione conferma: “Dio, quando diede il mondo in comune a tutti gli uomini, comandò all’uomo anche di lavorare, e l’insufficienza della sua condizione esige ch’egli lavori. Dio e la sua ragione gli hanno comandato di sottomettere la terra, cioè a dire di coltivarla a beneficio della vita, stendendo su di essa qualcosa che era suo proprio, cioè a dire il suo lavoro. Colui che, in ottemperanza a questo comando di Dio, ha sottomesso, coltivato e seminato una porzione di terra, vi ha con ciò aggiunto qualcosa ch’era sua proprietà, che un altro non può fare oggetto d’un suo diritto, né potrebbe togliergli senza ingiustizia”.[6]
Locke ripropone lo stesso sofisma già usato per legittimare l’appropriazione dei frutti naturali, del cervo ucciso dall’indiano, dell’acqua nel secchio: aggiungere lavoro privato a ciò ch’è comune rende privato il tutto.
La coscienza di Locke è tranquilla: questa appropriazione non “torna a pregiudizio di altri, poiché ne rimane sempre abbastanza e altrettanto buona, e più di quanta possa servire a chi ne è ancora sprovvisto”.[7]
I beni comuni sono abbondanti e illimitati!
Con questa rassicurazione di Locke, possiamo essere sereni.
Locke non legittima, però, le recinzioni che avevano suscitato lo sdegno di Tommaso Moro: “Nella terra ch’è comune in Inghilterra o in ogni altro paese, ove si trovi, sotto un governo, una moltitudine di uomini, che abbiano moneta e commercio, nessuno può recingere o appropriarsi una parte senza il consenso di tutti gli altri membri della comunità, in quanto quella terra rimane comune per contratto, cioè a dire per la legge del paese, che non deve essere violata. E sebbene sia comune rispetto a quegli uomini determinati, non lo è rispetto a tutta l’umanità, ma è proprietà associata di quel determinato paese o di quella determinata parrocchia”.[8]
La distinzione è importante. Per Locke si prestano ad appropriazione mediante il lavoro solo i beni naturali nello stato di natura e comuni a tutti gli uomini. Dove invece ci sia Stato e leggi positive che definiscono ciò ch’è privato e ciò ch’è comune le cose cambiano: bisogna fare i conti con quelle leggi positive.
Nello stato di natura la proprietà privata non crea conflitti, secondo Locke, perché l’appropriazione ha quei due limiti che già abbiamo visto.
“La misura della proprietà è stata dalla natura ben stabilita in base all’entità del lavoro e dei comodi della vita: non c’è lavoro umano che possa sottomettere o appropriarsi tutto, né fruizione che possa consumare più che una piccola parte, così ch’è impossibile che un uomo per questa via invada il diritto di un altro”.[9]
Le limitate possibilità umane di lavoro e di consumo, insieme alla deperibilità dei prodotti, mettono, secondo Locke, una rassicurante misura alla proprietà privata. Ma, i prodotti hanno tempi diversi per il loro consumo: se le prugne durano pochi giorni, le noci durano anche un anno e ci sono anche beni non deperibili, come certi metalli e i diamanti. Questa differenza anima i primi scambi, il baratto, il cui sviluppo mette, a un certo punto, in campo un nuovo elemento che cambia tutto, il denaro.
“E così siam giunti all’uso della moneta, cioè a dire di qualcosa di durevole che si può tenere senza che vada perduto, e che per mutuo consenso si può prendere in cambio dei mezzi di sussistenza per la vita che sono utili, sì, ma corruttibili”.[10]
I limiti naturali all’appropriazione privata, con il denaro, saltano e si passa dall’eguaglianza originaria degli uomini alla loro crescente diseguaglianza.
“La dove non si trovi nulla che sia insieme durevole e raro, e quindi prezioso sì da esser accumulato, gli uomini non tenderanno a estendere i loro possessi di terra, per quanto sia abbondante e libera a prendersi”. Ma, “appena scoprì qualcosa che presso i suoi vicini avesse la funzione e il valore della moneta, l’uomo cominciò subito a estendere i suoi possessi”.[11]
Il denaro apre all’accumulazione illimitata, che Locke considera positiva: essa, infatti, è un potente stimolo al lavoro, alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo degli scambi, con generale vantaggio per la società.
Il denaro non va guardato con sospetto come elemento capace di stravolgere l’economia, come insegnava Aristotele, ma va considerato come motore dello sviluppo economico e sociale, secondo l’ideologia delle forze borghesi allora in espansione e tese alla conquista della direzione della società.
Note
[1] Ib. p. 249.
[2] Ib. pp. 249-250.
[3] Ib. p. 250.
[4] Ib. p. 250.
[5] Ib. p. 251.
[6] Ib. p. 252.
[7] Ib. p. 252.
[8] Ib. p. 253.
[9] Ib. p. 254.
[10] Ib. p. 262
[11] ib. pp. 262-263.
ANNO ACCADEMICO 2012-13 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO
Torino 11 marzo 2013
Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999.
Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.
Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.
Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf)
Plotino (pdf)
L'altare della Vittoria e il crocifisso (pdf)
Fonti
- Locke John, Saggi sulla legge naturale, 2007, Laterza; Saggio sull'intelletto umano. Testo inglese a fronte, 2007, Bompiani; Saggio sull'intelligenza umana, 2006, Laterza; Trattato sul governo, 2006, Editori Riuniti; Lettera sulla tolleranza, 2005, Laterza; Saggio sull'intelletto umano, 2005, La Scuola; Scritti sulla tolleranza, 2005, UTET; Sulla tolleranza e l'unità di Dio. Testo inglese e latino a fronte, 2002, Bompiani; Secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile. Testo inglese a fronte, 2001, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli; Scritti etico-religiosi, 2000, UTET; Malebranche e la visione in Dio. Con un commento di Leibniz, 1995, ETS; Du gouvernement civil. Traduit de l'anglois (rist. anast. 1690), 1988, Centro Editoriale Toscano
Critica
- Manti Franco; Locke John, Locke e il costituzionalismo. In appendice: Costituzione della Carolina antica-Antica costituzione inglese, 2004, Name
- Merlo Maurizio, La legge e la coscienza. Il problema della libertà nella filosofia politica di John Locke, 2006, Polimetrica
- Costantini Dino, La passione per la solitudine. Una lettura del Secondo trattato sul governo di John Locke, 2003, Il Poligrafo
- Russo Raffaele, Virtù difficili: John Locke e gli antichi maestri, 2003, Guida
- Russo Raffaele, Ragione e ascolto. L'ermeneutica di John Locke, 2001, Guida
- Yolton John W., John Locke, 1997, Il Mulino
- Farina Paolo, Pensare il mondo che cambia. Uno studio su economia e politica in John Locke, 1996, Guerini Scientifica
- Dunn John, 1Il pensiero politico di John Locke, 1992, Il Mulino
- Tedeschi Mario, La libertà religiosa nel pensiero di John Locke, 1990, Giappichelli
- Sabetti Alfredo, La filosofia politica di John Locke, 1971, Liguori
Download