LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
LE ORIGINI E LA NATURA DELLA DEMOCRAZIA IN GRECIA
1-2-3-4-5-6-7
IL PERCORSO CULTURALE E POLITICO DEI GRECI
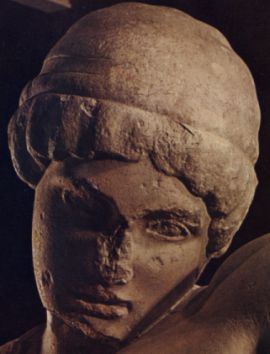
(b.4) La scoperta della ragione
Senza alcun dubbio la scoperta della ragione fu una delle componenti essenziali nel passaggio della civiltà greca dall’epoca oscura a quella arcaica. Ne abbiamo del resto già parlato, ma sempre in concomitanza con altri temi, come del resto era naturale che avvenisse, essendo questi ultimi ad essa strettamente intrecciati.
Abbiamo già visto come, da molti punti di vista, l’aspetto di novità di quest’epoca rispetto alla precedente risiedesse nel fatto di riunire in un unico luogo fisico (la città-stato) due mondi in precedenza separati.
Ma abbiamo visto anche come essa fosse caratterizzata da elementi radicalmente nuovi rispetto alla cosiddetta età oscura. In particolare, da una rivalutazione della singolarità e del contingente rispetto all’assoluto, dell’essere rispetto al dover essere. Se in precedenza, ad esempio, nella poesia e nelle manifestazioni letterarie i valori eroici erano prevalsi nettamente sugli aspetti intimi e personali, ora invece – nel mutato contesto culturale che si era venuto a creare – anche questi ultimi acquistavano importanza e dignità. Non che lo spirito competitivo o agonale tipicamente greco, che una tale tensione verso l’ideale appunto determinava, fosse oramai cosa del passato: al contrario, esso rimaneva uno dei valori portanti della società greca. Tuttavia, e al tempo stesso, l’individuo scopriva il proprio peso e il proprio valore essenziale in quanto cellula o elemento portante della società.
A proposito di tali cambiamenti, possiamo fare un rapido raffronto tra i due grandi poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea, espressione di sensibilità diverse: più profondamente arcaica il primo, più moderna l’altro. La natura, per esempio, che nell’Iliade appare ridotta a un arido campo di battaglia o al mezzo attraverso il quale gli dei manifestano la propria volontà ai mortali, si trasforma nell’Odissea in un paesaggio variegato, misterioso, pieno di pericoli e di insidie, ma proprio per questo degno anche di essere esplorato. Mentre il difficile tema della diversità tra le culture umane, appiattito nell’Iliade sull’opposizione tra due popoli (e i loro eserciti) in guerra per questioni di onore e di predominio, viene invece nell’Odissea sviluppato attraverso la narrazione degli stravaganti incontri di Ulisse e dei suoi gregari durante le tappe del loro viaggio di ritorno. Infine – altro aspetto fondamentale – in quest’ultima opera fa la sua prima comparsa il mondo familiare, dell’intimità e degli affetti, ancora del tutto assente invece in quella precedente.
Ma una tale rivalutazione della vita nella sua inesauribile varietà, e in tutti i suoi piani (da quelli naturali, a quelli culturali, a quelli interiori), non è l’unica novità di questa stagione culturale. Oltre e complementariamente a una tale attitudine a osservare e, per così dire, a lasciar parlare la realtà, se ne può infatti riscontrare un’altra concernente il modo di collegare ciò che si osserva.
Se in passato l’uomo greco aveva cercato di spiegare i fatti d’esperienza attraverso il mito, struttura narrativa che più che per cause razionali procedeva per personaggi (le forze divine che muovono il mondo sensibile), ora invece iniziava a elaborare una visione del mondo basata su vere e proprie spiegazioni, su ragionamenti di senso compiuto.
È su questo aspetto che vogliamo soffermarci più in dettaglio qui avanti, isolandolo da tutto ciò che, pur a esso legato, vi rimane comunque estrinseco. Una particolare attenzione sarà dedicata alla filosofia, una disciplina che nacque in Grecia proprio in questo periodo e che fu invece del tutto assente nel vicino mondo orientale.
Come abbiamo già visto, anche nella letteratura e nella politica la ragione, l’impulso all’indagine aperta e problematica sulla realtà, ebbe un peso essenziale. Come il poeta indagava e scandagliava impietosamente tanto se stesso quanto la società in cui viveva, giungendo a conclusioni sempre personali e spesso anche in contrasto con la tradizione, così nella vita politica il cittadino si trovava costretto – in contrasto con l’antico uso della forza e dell’arbitrio da parte delle classi più alte – a porre in atto delle vere e proprie strategie che gli garantissero un seguito politico, a volte conciliando tra loro differenti punti di vista, altre volte sostenendo attivamente alcuni interessi a scapito di altri. Anche in questi campi insomma, la ragione tendeva a divenire un aspetto sempre più essenziale dell’agire. E tuttavia, fu nella filosofia (e nelle scienze) che l’impulso al pensiero sistematico formale conobbe le sue espressioni più profonde e audaci.
Prima di inoltrarci in questo argomento, però, ci sembra d’obbligo cercare di individuare, per quanto possibile, quelle che furono le cause alla base del sorgere non solo di questa nuova branca del sapere, ma più in generale di questa nuova attitudine alla conoscenza razionale. In seconda battuta, ci occuperemo delle differenze che sussisterono tra la Grecia e le civiltà del Vicino Oriente in merito ai compiti e agli scopi della conoscenza. In ultimo, appunto, tenteremo di inquadrare le problematiche e il ruolo sociale dei primi filosofi.
(b.4.1) le cause della scoperta della ragione
Se il tema qui affrontato fosse la fine del Medioevo cristiano, allora potremmo parlare di una ri-scoperta della ragione dopo i molti secoli d’oscurantismo religioso che avevano teso a offuscarla. Trattandosi invece dell’epoca arcaica della storia greca, dobbiamo parlare piuttosto di una vera e propria scoperta: è indubbio infatti, che il modo di pensare prevalente non solo nel periodo oscuro, ma anche in quello miceneo precedente, fosse ancora essenzialmente di tipo magico e religioso.
Quella greca fu la prima, e per molto tempo anche l’unica civiltà che – a partire appunto dall’età arcaica – tentò di emanciparsi da una tale impostazione. Essa difatti, cominciò allora a porsi in modo crescente e un po’ in tutti gli ambiti l’obiettivo di giustificare razionalmente i fenomeni d’esperienza, compresi peraltro quelli più complessi, per i quali ancora più forte era la tendenza a ricorrere al soprannaturale, al mito. I greci iniziarono insomma, proprio a partire da questo periodo, a investigare il reale in tutte le possibili direzioni, interiori ed esteriori. E le discipline che inventarono, oltre ovviamente ai cambiamenti che apportarono a quelle già esistenti, testimoniano bene di questo sforzo immane.
Certo, come si è già più volte visto, gran parte delle tecniche e delle conoscenze razionali di cui si servirono (dalla scrittura alfabetica, all’astronomia, alla geometria) non ebbero i propri natali in Grecia, bensì nei più progrediti e ricchi stati del Vicino Oriente. Ciò non toglie tuttavia, che furono proprio i Greci i primi popoli al mondo a tentare di dare alla ragione un valore conoscitivo (almeno tendenzialmente) assoluto, ad ambire cioè a spiegare l’intera realtà attraverso uno strumento assolutamente umano. Un’impostazione questa, che in futuro sarebbe stata uno dei caratteri distintivi della civiltà occidentale, che di quella greca fu fondamentalmente un parto.
Il compito da affrontare qui, è dunque quello di tentare, nei limiti del possibile, di individuare i motivi che furono alla base di una tale svolta.
Perché, a partire dall’età arcaica, iniziò tra i popoli ellenici a manifestarsi una tendenza sempre più spiccata a cercare di spiegare razionalmente la realtà in tutte le sue sfaccettature? E perché, contrariamente che nel Vicino Oriente, tale tendenza portò qui alla nascita della filosofia: disciplina che cerca di spiegare la Totalità con strumenti alternativi a quelli, fondamentalmente irrazionali, forniti dal mito e dalla religione?
Cerchiamo di rispondere anzitutto alla prima domanda. I fattori alla base della scoperta della ragione furono essenzialmente di due tipi: da una parte vi furono le profonde trasformazioni avvenute all'interno della vita materiale e degli orizzonti mentali dei Greci a partire dall'VIII secolo, conseguenza più o meno diretta della grande colonizzazione che coinvolse la maggior parte delle popolazioni elleniche indirizzandosi tanto a est quanto a ovest dei loro precedenti insediamenti; dall'altra vi fu la ripresa dei contatti con gli stati e con le civiltà del Vicino Oriente, vere e proprie fucine di civiltà per il mondo mediterraneo, in particolare orientale.
Quanto al primo ordine di fattori, si ricorderà come le imprese di espansione al di fuori dei precedenti confini (peraltro legate in prima istanza all’esigenza di acquisire nuove terre) favorissero in modo considerevole lo sviluppo dei traffici e la nascita di nuove classi urbane e in genere commerciali, determinando un maggiore afflusso di materie prime dall'esterno e fornendo nuovi mercati di sbocco per i prodotti delle regioni greche.
Anche senza considerare (dal momento che lo abbiamo già fatto) come queste attività e questi nuovi ceti introducessero una concezione del mondo diversa da quelle dei periodi precedenti, non si può comunque non vedere come tali sviluppi comportassero un avanzamento delle tecniche sia produttive sia marittime, e di conseguenza anche un ampliamento degli orizzonti fisici e mentali delle popolazioni greche. Le quali dunque – e veniamo così al secondo punto del nostro discorso – iniziarono a emanciparsi dall'isolamento che le aveva caratterizzate nei secoli precedenti, in più entrando spesso in contatto con civiltà gravide di nuovi e potenti stimoli culturali.
Tutti questi progressi tecnici e materiali, e il conseguente mutamento insorto nelle concrete prospettive di vita di gran parte della popolazione, rinnovarono profondamente questa civiltà, che iniziò a concepire una nuova fiducia nelle proprie forze, anche grazie appunto all'incontro con saperi e idee per lei del tutto nuovi: spunti di sviluppo a cui – con la mentalità duttile e pragmatica che da sempre la caratterizzava – essa si mostrò estremamente ricettiva, sviluppandoli secondo modalità proprie e originali.
Il tema delle influenze culturali esterne rimanda poi a quello che fu l'altro grande fattore alla base dello sviluppo della razionalità nel mondo greco arcaico, vale a dire ai contatti sempre più frequenti con le vicine civiltà orientali. Possiamo elencare i principali debiti dottrinali contratti dal mondo greco con esse attraverso quattro punti: dalla Mesopotamia l'osservazione degli astri (astronomia), dall'Egitto la geometria, dai Fenici la scrittura alfabetica e dai Lidi la moneta.
Né fu certamente un caso che i primissimi filosofi greci fossero tutti di origini ioniche e non propriamente greche. Le coste anatoliche infatti, costituirono a lungo l'avanguardia del progresso sia materiale che culturale degli Elleni. (Mileto in particolare, antichissima colonia d'origine micenea, fu un centro importantissimo per il commercio e per gli scambi culturali con il Vicino Oriente.) Né che essi fossero tutti al tempo stesso dei “sapienti”, ovvero individui che abbracciavano più o meno l'intero sapere del proprio tempo, dal momento che, data appunto la spiccata superiorità culturale delle vicine civiltà orientali rispetto a quelle greche, l'influenza esercitata dalle prime sulle seconde passava più o meno attraverso tutti i campi della conoscenza e delle arti, al tempo peraltro ancora pressoché indistinti tra loro.
E anche se alcuni di questi sapienti (come per esempio Pitagora) cercarono asilo lontano dalle proprie regioni di origine, e in particolare nel sud Italia (Sicilia, Magna Grecia) dove diedero vita a importanti scuole di pensiero, ciò non toglie che la filosofia e più in generale il sapere teorico degli Elleni sorsero non nella madrepatria propriamente detta, né appunto nelle zone occidentali del mondo ellenico, bensì in quelle più orientali della Grecia ionica. Solo a partire dalle Guerre Persiane difatti, la madrepatria cominciò a riacquisire il ruolo politicamente e culturalmente egemone che aveva avuto nei secoli precedenti la grande colonizzazione.
(b.4.2) la Grecia e il Vicino Oriente: due diverse concezioni della ragione
Cerchiamo ora di rispondere alla seconda domanda: al perché cioè proprio in Grecia sia sorta la filosofia, e più in generale una concezione della conoscenza avulsa da ogni interesse pratico e di forte rottura con le credenze del passato.
Il Vicino Oriente, con le sue millenarie tradizioni statali e imperiali (delle quali l’Egitto, la Mesopotamia e l’Impero assiro furono solo le principali estrinsecazioni) era giunto nell’VIII secolo ad un livello di civiltà decisamente superiore alla Grecia e alle regioni ellenizzate. Da sempre fucina di civiltà (Chester Starr, ad esempio, ipotizza che anche lo stato cinese e quello indiano sorgessero per influsso indiretto di quello mesopotamico), sin da tempi antichissimi esso aveva profondamente influenzato il mondo greco ed egeo. Non vi è dunque da stupirsi se, anche in questo periodo, esso assolse un ruolo centrale nella sua rinascita.
I debiti che la Grecia ebbe verso tale mondo li abbiamo già brevemente elencati. Tuttavia, bisogna porre l’accento anche su un altro fatto essenziale, e cioè il differente clima culturale e politico in cui tali progressi ebbero luogo, e la profonda diversità di fondo che ciò finì per determinare.
Per comprendere la ragione di questi sviluppi divergenti, è essenziale considerare il diverso tipo di organizzazione sociale e politica alla base di questi due mondi, e il ruolo che in essi quindi assolveva il sapere.
La ricerca e la speculazione erano, negli stati asiatici, fondamentalmente nelle mani del Re e della Corte, i quali, in qualità di massime autorità politiche, la sostenevano e incoraggiavano nella misura in cui essa era funzionale alle loro esigenze di gestione dei territori e delle popolazioni. Ricorda ad esempio Lévêque, che nell’ambiente spirituale del palazzo orientale “[la speculazione] resta un fatto di sottomissione al re”. La conoscenza razionale aveva quindi in queste regioni un'impronta prevalentemente empirica e applicativa (la geometria ad esempio nacque in Egitto, dove particolarmente urgente era il problema di misurare le superfici coltivate) restando comunque, anche laddove ciò non era vero, strettamente legata alle tradizioni e alle consuetudini, ovvero mantenendo una natura prevalentemente conservativa. Per tutte queste ragioni, la scienza vicino-orientale non si pose mai in netta contrapposizione col patrimonio mitico e religioso, e in generale con le credenze, del passato.
Nel mondo greco, al contrario, erano assenti tanto delle strutture di potere paragonabili alle corti asiatiche, dotate cioè di un’autorità indiscutibile e capaci di imporre in tutti i campi una volontà insindacabile (e ciò tanto più da che si sviluppò la città-stato come “mondo secolare e razionale che ammette rapporti di parità tra i cittadini e prende come base una legge (nomos) uguale per tutti” (Lévêque)), quanto un complesso di verità rigidamente stabilite e vincolanti sul piano religioso e in genere delle tradizioni. O meglio, tali verità, pur esistendo, non impedivano che ogni singolo centro politico si costituisse in modo fondamentalmente autonomo.
Ricorda a tale proposito Moses Finley che “sebbene tutti i greci conoscessero e onorassero l’intero pantheon, è inconcepibile che un individuo o una città potessero onorare tutti i riti relativi a ciascuno di loro. Ogni città aveva una propria divinità tutelare e dei vincoli particolari con certi altri dèi e dèe, che di conseguenza erano celebrati più che lo stesso Zeus, l’incontrastato capo del pantheon, sebbene nessuno volesse negarne la supremazia.”
In campo religioso come in campo politico insomma, vigeva in Grecia una sostanziale anarchia che finiva per valorizzare l’arbitrio e la creatività individuali a scapito di un già debole spirito di sistema.
Oltre a ciò, bisogna poi ricordare quello spirito pessimistico e problematico che, sin dalle fasi più antiche, aveva caratterizzato le civiltà elleniche, e di cui sono un chiaro esempio figure come Achille e Ulisse (quali, quantomeno, vengono descritte nei due grandi poemi omerici). Si potrebbe anzi ipotizzare che la razionalità costituì, all’interno di un quadro culturale già incline alla riflessione e alla problematizzazione, l’elemento di novità che permise alla civiltà greca di rinnovarsi e di dar vita a nuove e originali creazioni dello spirito, ovvero a una nuova idea di conoscenza.
Per le ragioni appena descritte dunque, il sapere e la speculazione razionale presero ben presto presso i Greci una direzione molto diversa rispetto a quella presa presso i vicini popoli asiatici: quella cioè della filosofia e più in generale di una ricerca in gran parte disinteressata alle proprie possibili implicazioni pratiche. Certo, anche la ricerca applicata, la tecnica (techne), conobbe durante il periodo arcaico un fortissimo sviluppo – e ciò tanto più in quanto in Grecia non aveva ancora preso piede un tipo di produzione sistematicamente basata sull’impiego di forza-lavoro schiavile. Ciò non toglie però, che fu proprio l’impulso teoretico, quello orientato cioè verso la ricerca pura, uno dei fattori che più risolutamente distinsero quella greca dalle altre civiltà circostanti.
Sintetizza bene Pierre Lévêque, laddove parlando dei primi filosofi ionici scrive: “La gloria dei primi pensatori ionici fu di essersi sbarazzati completamente del pragmatismo, ricercando esclusivamente la spiegazione razionale; di aver fondato insomma la scienza sostituendo l’astronomia all’astrologia e lo studioso di geometria all’agrimensore.”
(b.4.3) la speculazione dei primi filosofi
Quel che ovviamente non vogliamo fare qui, e nemmeno più avanti, è trattare la filosofia greca in dettaglio. Ciò che ci interessa è piuttosto mettere in luce la relazione che essa, come fenomeno culturale, intrattenne con la polis.
Abbiamo già visto come una tale disciplina fosse l’espressione più alta e ambiziosa del razionalismo greco di questo periodo. Altre ne erano sorte che, come la medicina, cercavano di porre ordine all’interno di un determinato ambito di fatti attraverso l’elaborazione di ipotesi di ricerca, ovviamente ancora rudimentali e ingenue. E altre che, come la storia (da intendersi ancora come un’indagine molto generale su eventi, personaggi e luoghi), miravano a sostituire le leggende e i miti del passato con fatti accertati direttamente dall’autore o raccolti da testimoni attendibili.
Ma l’audacia della filosofia era molto maggiore: essa difatti mirava a sostituirsi a quel patrimonio di idee (per la verità per nulla univoche) che erano alla base della tradizionale visione greca del Cosmo.
Il primo autore che si possa in qualche modo definire filosofo fu Senofane. Egli, originario dell’Asia Minore ionica, pur non avendo elaborato (come gli altri pensatori qui trattati) teorie di carattere cosmologico, aprì la strada alla vera e propria riflessione filosofica ponendo, attraverso versi dallo stile limpido e luminoso, il discrimine fondamentale tra una conoscenza di tipo razionale e veritiero e le comuni e ingannevoli opinioni del volgo, basate in gran parte sulla mitologia e la religione o comunque su suggestioni irrazionali. Non a caso Senofane fu ritenuto dagli antichi il fondatore della scuola di pensiero eleatica, che della rigida distinzione tra verità (aletheia) e opinione (doxa) fece il proprio concetto fondamentale.
La riflessione di Senofane però non fu solo gnoseologica ma anche etica, e questi due aspetti del suo pensiero furono profondamente connessi tra loro. Senofane criticava difatti non soltanto il bagaglio delle verità tradizionali (arrivando così a prendere le distanze da Omero e da tutta la tradizione poetica antecedente), ma anche e complementariamente i valori che da tali credenze derivavano.
Per farsi un’idea della critica sferzante che egli riservò ai costumi e alle convinzioni dei suoi contemporanei, possiamo rifarci a quello che è forse il frammento più celebre di tutta la sua opera. In esso si legge che “se buoi, cavalli e leoni avessero le mani, / […] certamente si fingerebbero le immagini e le figure / degli dei a guisa del proprio aspetto, / come cavalli i cavalli e come buoi i buoi”.
Ma il suo anticonformismo aveva anche dei risvolti più pratici e immediati. In altri versi, ad esempio, egli negava ogni valore a quelle gare atletiche che tanto piacevano ai suoi contemporanei e i cui premi costituivano ai loro occhi una delle massime aspirazioni. Egli scriveva infatti che “[anche se] colui che vince una gara di corsa o di pentathlon / […] ha diritto al mantenimento a spese dello stato / e riceve in premio un trofeo / […] egli non vale quanto me: la mia sapienza / ha più valore che non la forza di uomini e cavalli”.
Senofane fu insomma il primo esempio nella storia greca e occidentale di intellettuale radicalmente anticonformista, di un pensatore a tal punto compreso della propria libera ricerca da prendere risolutamente le distanze dallo stesso contesto culturale da cui essa era sorta.
E tuttavia una tale posizione – come del resto quelle degli intellettuali e poeti già esaminati – non deve assolutamente essere scambiata per disinteresse verso la vita politica e i problemi anche materiali dello stato, come dimostrano chiaramente questi versi: “Se anche vi sia tra i cittadini un campione nel pugilato, / nel pentathlon e nella lotta, / […] non per questo avrà un buon governo la città: / […] non si ingrassano così le casse dello stato”.
Anche per Senofane dunque, la città-stato costituiva uno dei fini essenziali della propria riflessione, l’orizzonte all’interno del quale essa assumeva un significato concreto uscendo dalla vuota astrattezza. Niente di più lontano, insomma, da uno sterile ripiegamento su se stesso e sulla propria interiorità da parte di un uomo che, pure, aveva fatto della libertà e dello sradicamento il carattere principale della sua esistenza.
Ma la filosofia intesa come indagine sul Cosmo o sulla Natura non sorse con Senofane bensì con Talete, anche lui originario della Grecia ionica e anche lui vissuto tra VII e VI secolo.
La domanda alla base della sua riflessione (e in genere di quella dei filosofi pre-sofistici) era più o meno la seguente: cosa genera la molteplicità degli enti naturali e contingenti? Ovvero, qual è il principio unitario (archè) alla base della natura (fusis) nella sua inesauribile varietà?
A tale domanda egli rispondeva l’acqua. Non si sa bene cosa intendesse con ciò, ma probabilmente egli sosteneva che da tale elemento discendessero per trasformazione tutti gli altri. Era molto probabilmente, la sua, una riproposizione su base razionale e filosofica di antiche teorie mitologiche che facevano di Oceano l’origine del Tutto (o almeno così riferisce Aristotele), ma era anche un primo grandioso tentativo di dare una spiegazione ragionevole ed empiricamente fondata all’antico dilemma sulla genesi del mondo (cosmogonia).
A Talete fecero seguito Anassimene e Anassimandro, i quali a loro volta avanzarono delle ipotesi sul principio alla base del Tutto. Per il primo esso era una sostanza primordiale chiamata apeiron (ovvero l’infinito), in cui erano contenuti in forma indistinta i quattro elementi alla base della realtà fisica (acqua, aria, terra e fuoco); per il secondo invece era l’aria o il soffio vitale (pneuma), il quale condensandosi diveniva un elemento sempre più pesante e rarefacendosi tornava verso lo stato originario.
Anassimene, discepolo diretto di Talete, introdusse inoltre nel suo discorso una forza immateriale (da lui chiamata Contesa) costituente il motore del processo di trasformazione dell’arché nella fusis e del ritorno di quest’ultima allo stato originario. Era tale forza infatti a portare gli elementi prima indistinti tra loro a separarsi e a dare vita a una lotta che generava la sopraffazione reciproca e il Caos, cosa per la quale essi erano puniti con l’annullamento e il ritorno all’Ordine originario (Cosmos). È facile notare come questo discorso possa per molti aspetti essere considerato una riproposizione, seppure in un contesto cosmico e ontologico, di quello – di cui abbiamo parlato in precedenza – che fondava la società sull’equilibrio, la giustizia e l’armonia. In entrambi i casi infatti, l’assenza di queste qualità portava all’annullamento inteso come punizione e morte.
Un altro pensatore importantissimo nel panorama filosofico dell’età arcaica – ma anche, attraverso i suoi continuatori, di quelle successive – fu Pitagora.
Nato verso il 570 a.C. a Samo, isola orientale dell’Egeo, egli si diede presto ai viaggi, entrando in contatto con varie civiltà del Vicino Oriente e in particolare con quella egiziana, e approdando infine in Magna Grecia presso la città di Crotone, dove fondò una setta i cui esponenti più importanti acquisirono presto una grande rilevanza politica. Tale setta svolse infatti una pesante azione di controllo e condizionamento della vita della cittadinanza in favore dell’oligarchia dominante. La vicenda di Pitagora dunque, è interessante anche perché pone in luce le possibili implicazioni politiche e sociali della filosofia e del sapere razionalistico, laddove – come in questo caso – esso era sentito come qualcosa di esoterico, ovvero di impenetrabile e nascosto alla maggioranza delle persone.
Mentre i filosofi ionici avevano individuato l’arché in un principio fisico, Pitagora lo individuò al contrario in un’entità astratta: il numero. Questo era probabilmente da lui inteso come un qualcosa di discreto, dotato cioè di una certa estensione, ed era simboleggiato con un sassolino. Ma era anche prima di tutto qualcosa di spirituale, di immateriale, che rifletteva la struttura e l’ordine dell’universo anziché la sua composizione fisica. Con Pitagora ebbe inzio quella lunga tradizione del pensiero occidentale che va alla ricerca dell’essenza matematica, ideale delle cose piuttosto che della loro origine materiale.
Non a caso lui e i suoi discepoli furono i primi a impostare lo studio della matematica e soprattutto della geometria in termini rigorosi, a basarle cioè su premesse e conseguenze logiche, andando così oltre gli atteggiamenti empirici alla base della geometria egiziana. Non a caso la tradizione attribuisce a Pitagora la scoperta del celebre teorema che ancora porta il suo nome. Così come narra che la crisi definitiva del pitagorismo fu provocata dalla scoperta (che per un certo periodo si riuscì a tenere celata) dell’incommensurabilità del rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato: un fatto che mandava in crisi il principio stesso alla base dell’aritmogoemetria pitagorica, ovvero l’idea che la realtà si fondasse su entità discrete, finite.
Ma il pitagorismo non fu un fenomeno puramente razionale, scevro di qualsiasi suggestione magica o religiosa. Esso si basava infatti, nei suoi aspetti morali, sull’idea della trasmigrazione delle anime dopo la morte in entità di maggiore o minore dignità, a seconda di quella che era stata la condotta di vita della persona: una concezione del destino individuale, chiamata metempsicosi, che Pitagora aveva probabilmente ripreso da antichissime dottrine misteriche, quelle orfiche, risalenti ancora ai periodi oscuri della storia greca.
Un fatto questo, che ci ricorda come, soprattutto nei periodi iniziali, quella che qui definiamo “filosofia” non fosse in realtà una disciplina del tutto razionale (quantomeno rispetto al significato noi oggi diamo a tale termine), bensì piuttosto un’intuizione personale in merito alla natura profonda delle cose, nella quale il ragionamento puro poteva mescolarsi ad altre forme di ricerca e di riflessione. Più che da un’astratta razionalità, la filosofia fu dunque caratterizzata dal fatto di essere il prodotto di un’indagine libera, vincolata in ultima analisi – anche quando si rifaceva a tradizioni precedenti – alla facoltà di giudizio del ricercatore.
Un altro aspetto che qui ci preme affrontare – tanto più qualora si consideri che questo scritto si occupa in modo particolare dell’evoluzione politica e civile del mondo greco – è il rapporto che sussisté tra i filosofi e la politica.
Quel che ci pare interessante osservare è come essi (secondo peraltro un indirizzo che rimase prevalente fino alla nascita della sofistica nel IV secolo) non si occuparono mai, se non in modo molto marginale, di problemi politici. La loro speculazione rimase infatti sempre essenzialmente cosmologica, gnoseologica e al limite teologica, senza mai divenire propriamente politica. Ciò fu certamente dovuto al fatto che l’oggetto specifico del loro interesse (almeno in questo primo periodo) rimanesse l’indagine sul Tutto in opposizione alle antiche teorie sulla nascita dell’Universo (delle quali Esiodo, con la sua Teogonia, ci fornisce un esempio) e più in generale alle credenze tradizionali sugli dei e sui fenomeni naturali. I filosofi si occupavano insomma di riformare la conoscenza dalle sue basi, mentre discipline come la storia e la medicina portavano avanti indagini più circoscritte – la seconda spesso proprio su temi politici. E tuttavia si deve anche notare come, in virtù della scarsa distinzione allora esistente tra i diversi rami della conoscenza, l’attitudine verso un determinato ambito di problemi fosse fondamentalmente il prodotto di una libera scelta, non fondata dottrinalmente, e come tale non vincolante.
Se quindi i filosofi in quanto tali, non si occuparono se non marginalmente di questioni politiche, ciò non si dovette assolutamente al disinteresse dei greci per questo tipo di argomenti (ché anzi, come vedremo, essi furono il primo popolo al mondo a renderlo oggetto di una riflessione approfondita e sistematica), bensì più semplicemente al fatto che esso non cadesse, almeno per il momento, nella sfera dei loro interessi primari.
D’altronde, i filosofi erano anche e prima di tutto dei “sapienti”, ovvero dei personaggi di spicco all’interno della comunità, le cui competenze spaziavano in quasi tutti i campi della conoscenza (Talete ad esempio, riuscì a prevedere un’eclissi di sole; Pitagora scoprì, come si è già ricordato, il teorema che porta il suo nome). E tra questi campi poteva ovviamente esservi anche quella che oggi chiamiamo politica, come attestano ad esempio i già citati versi di Senofane, nei quali egli, in virtù della propria sapienza, si contrapponeva ai vincitori delle gare atletiche, incapaci di fare veramente il bene della città!
Si può dunque presumere che la politica, come interesse e tema esplicito, entrasse nella sfera d’azione dei filosofi o in modo solo accidentale (in quanto essi erano sapienti e i loro giudizi quindi socialmente accreditati in ogni campo) o in modo del tutto marginale (per esempio nel senso che, alle volte – si pensi ai Pitagorici – le loro teorie potevano avere implicazioni di natura politica e sociale, senza per questo soffermarsi specificamente su un tale ambito di problemi).
Riguardo poi alle simpatie politiche di questi primi filosofi, è difficile o anche impossibile immaginare con precisione quali potessero essere. Certo, se pensiamo a Senofane e a Pitagora, non possiamo avere molti dubbi sul fatto che la loro concezione elitaria del sapere e della saggezza li indirizzasse le verso la nobiltà: ovvero verso l’eunomia, piuttosto che verso l’isonomia. Ma sarebbe arbitrario, in mancanza di prove, estendere questo discorso anche ai filosofi ionici (Talete, Anassimene e Anassimandro). Niente ci permette di escludere, infatti, che questi ultimi si facessero al contrario interpreti del fermento politico e sociale anti-nobiliare che stava maturando in molte città-stato greche, in particolare in quelle che – come in Ionia – avevano un’economia spiccatamente mercantile.
In ogni caso, bisogna ammettere che è difficile non scorgere una certa affinità di fondo tra la concezione aristocratica della vita, intesa come elevazione al di sopra del senso comune e superiore coscienza delle cose, e quella degli stessi filosofi, custodi un sapere per sua natura non facilmente accessibile ai più.
A conclusione di quanto detto in questo paragrafo, possiamo dunque dire che i Greci dell’età arcaica inventarono una nuova concezione del sapere. A differenza che in passato e nel Vicino Oriente infatti, esso iniziava ora ad assumere per loro un valore intrinseco, che cioè andava oltre la mera utilità che poteva derivarne, e a basarsi inoltre, anziché sulle consuetudini e le tradizioni religiose, sulla forza – del tutto umana – dell’intelletto.
Sarebbe tuttavia un grosso errore considerare il sapere teorico-speculativo dei Greci come un qualcosa di sterile e puramente fine a se stesso. L’assenza di un’utilità immediata era infatti compensata dal suo tradursi in saggezza, sapienza, discernimento: in altre parole, nella capacità da parte di chi lo possedeva di districarsi meglio degli altri nelle difficoltà e nelle insidie della vita – attitudine che poteva tornare molto utile anche alla comunità e che come tale rendeva i sapienti delle figure molto influenti.
Senza contare che le loro personali ricerche sulle natura delle cose e degli eventi contribuirono a cambiare in modo progressivo ma radicale anche la visione comune del mondo, facendolo apparire sempre di più come qualcosa di (almeno in parte) controllabile attraverso le forze umane, e innanzitutto attraverso quelle intellettive. L’eco delle loro speculazioni dunque, contribuì ad aprire nuovi orizzonti di azione e di pensiero anche tra la gente comune.
Inventando questo nuovo tipo di sapere, teorico o teoretico e apparentemente privo di utilità, i Greci avevano dunque scoperto delle nuove e più profonde potenzialità insite nel sapere stesso. In questa nuova accezione infatti, esso non serviva più tanto a fornire nozioni di utilità immediata, quanto piuttosto a formare gli individui in un senso più ampio, aiutandoli a emanciparsi dalle antiche visioni magiche e superstiziose della realtà e a prendere quindi in mano, sia singolarmente sia come civiltà, il proprio destino.