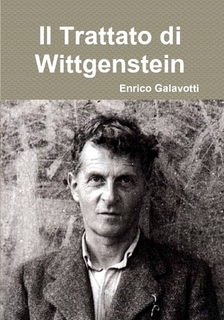TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
L'ETICA DI WITTGENSTEIN NEI QUADERNI 1914-16

Si tenta spesso di varcare abissi di pensiero troppo larghi e vi si cade.
I
I Quaderni del 1914-16 sono stati scritti da Wittgenstein mentre prestava servizio militare nell'esercito austriaco, nel corso della prima guerra mondiale. Il Trattato logico-filosofico è il prodotto finito (1918) di questi Quaderni, nei quali si parla sia di logica che di etica. Qui prenderemo in esame solo l'etica.
La logica di Wittgenstein è il tentativo di trovare un'alternativa coerente all'incoerenza per lui evidente dell'etica (intendendo, con questo termine, l'incapacità volitiva di trovare una soluzione soddisfacente agli antagonismi della società). L'arruolamento volontario nell'esercito austriaco rientrava probabilmente nell'esigenza di dare un senso a un'etica percepita come insignificante, inconsistente. Tuttavia il risultato di quell'esperienza fu a favore più della logica (col Trattato) che non dell'etica.
Che Wittgenstein stesse vivendo un processo di estraniazione dalla realtà è ben visibile in questi Quaderni, molto di più che non nel Trattato. "La mia difficoltà è solo una - enorme - difficoltà d'espressione" (Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 2009, p. 177). Ma la causa di ciò non viene individuata. Egli cerca piuttosto di trovarvi un rimedio, e pensa d'averlo trovato appunto nella logica, dove ha la pretesa, pur usando un linguaggio complesso, di ridurre al minimo le difficoltà espressive. La logica gli diventa una forma di terapia nei confronti di un'etica ammalata, la cui malattia è l'alienazione.
Gli sembra d'intuire che la soluzione possa venire da un recupero del passato, ma non la individua. Semplicemente scrive: "Quanto più una parola è vecchia, tanto più va a fondo" (p. 176). Per il resto il problema per lui non è quello di come recuperare questo pozzo senza fondo, tornando a bere l'acqua salutare d'un tempo, ma è quello di come produrre un'acqua minerale imbottigliata, nella speranza di non dover più attingere all'acqua del pozzo.
Che Wittgenstein fosse un egocentrico lo si comprende anche solo da questo semplice enunciato esistenziale: "I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo" (p. 189, ripreso in 5.6 del Trattato). Come se i limiti del mondo "personale" non fossero ben più grandi di quelli del proprio linguaggio! Come se si potesse ridurre il mondo al proprio "mondo personale"! Come se tutto potesse dipendere dalla sintassi di una logica astratta o da un'etica basata sul sì e sul no!
Il titolo che avrebbe voluto dare al suo libro più famoso non era quello passato poi alla storia, ma, più modestamente, "Il mondo che io ho trovato" (pp. 189-90), emulando, in questo, quello già noto di A. Schopenhauer, da lui letto, in quanto le due filosofie, per molti versi, si somigliano. Su uno di questi versi lo stesso Wittgenstein conviene esplicitamente: "il soggetto non c'è" (p. 190). Cioè un soggetto autonomo, libero di decidere non sembra poter esistere in presenza di qualcosa d'indefinibile e d'incomprensibile che lo sovrasta e lo condiziona in maniera irreparabile.
Wittgenstein tuttavia non arrivò mai a formulare il concetto di "volontà cieca e irrazionale", probabilmente perché le sue radici ebraiche o comunque mistiche (protestanti e cattoliche) glielo impedivano. Ma più volte arrivò a dire che se esiste un dio, questi non si rivela affatto al mondo.
Quel che c'è di davvero paradossale in lui è che il suo impulso al misticismo sembra essere direttamente proporzionale alla pretesa assolutistica della sua logica, che non vuol dipendere dalla realtà. Vi è in lui una sorta di sdoppiamento della personalità. Di regola, infatti, chi si rifugia nel misticismo, si tiene assai lontano dalla logica, o comunque da una logica autoreferenziale, in cui la parola "dio" non ha alcun senso e che nel suo Trattato, infatti, appare solo di sfuggita.
Wittgenstein invece, quando tratta di problemi logici, sembra aver ereditato l'agnosticismo o addirittura l'ateismo dei logici (Frege, Russell, Moore, Whitehead...), ma appena varca la soglia di questa disciplina, ecco subentrare il misticismo. Il bello è che lo dice espressamente, senza curarsi affatto dell'incompatibilità tra questo e la logica autosufficiente: "L'impulso al mistico viene dalla mancata soddisfazione dei nostri desideri da parte della scienza" (p. 190).
La sua logica appare come una sorta di teologia laicizzata o mascherata: è come se dopo aver reso la logica completamente avulsa dalla realtà, l'avesse fatto soltanto per dimostrare, contro gli stessi logici, che la verità non sta in questa scientificità assoluta o in questa perfetta coerenza formale, ma in tutto quello che sta al di fuori di essa.
Questo modo di procedere sembra avere una strana somiglianza con la teologia apofatica, all'interno della quale si usano argomentazioni cogenti per non far coincidere dio con la realtà, negando quindi qualsiasi valore alle prove catafatiche dell'esistenza di dio, per poi però arrivare a dire, non che l'ateismo è l'unica verità possibile, ma esattamente il contrario! Il teismo, nella teologia apofatica, è il risultato di una purificazione da quei condizionamenti della realtà che possono portare il credente a farsi delle rappresentazioni falsate della divinità. Per contemplare la divinità bisogna liberare la mente da ogni immagine, sicché alla fine non resta che il buio, luogo ideale della personale divinizzazione.
A grandi linee un percorso del genere lo si può notare anche in Kant, che nella prima Critica smontò tutte le prove razionalistiche della Scolastica, giungendo a un ateismo implicito (esplicitamente infatti fu costretto, essendo docente universitario, a dirsi agnostico), mentre nella seconda e terza Critica finì col dichiararsi favorevole al misticismo, come se avesse voluto far capire che la prima Critica era servita soltanto per depurare la fede dalle incrostazioni e dalle falsità di una teologia politicizzata, e quindi arrogante, presuntuosa, sommamente dogmatica.
Perché questo passaggio arbitrario dalla logica al misticismo? Perché sia in Kant che in Wittgenstein è troppo forte la consapevolezza dell'impotenza della scienza nei confronti dell'antagonismo sociale e, nel contempo, troppo poco sviluppata la consapevolezza di dover trasformare la logica in un'arma politica contro il sistema dominante. In entrambi i filosofi l'individualismo borghese domina incontrastato, benché non in forma esasperata, come negli irrazionalisti Kierkegaard e Nietzsche.
L'amore che Wittgenstein provava per il silenzio, per la solitudine e la contemplazione delle cose, ricorda da vicino quello dei monaci eremiti, sinaitici, esicasti, stiliti...: sono impressionanti le analogie con gli scritti dei "Padri del deserto", benché in lui l'esigenza e la consapevolezza di questa esigenza non venga vissuta in alcuna esperienza religiosa. Lo stesso interesse che, concluso il periodo dell'insegnamento alle scuole elementari, aveva nutrito, per qualche tempo, di entrare in convento, l'attesta eloquentemente. "Non potrebbe esservi qualcosa che non si lasci esprimere da una proposizione? (...) Non v'è un dominio fuori dei fatti?" - si chiede a p. 191.
La ricerca di un meta-linguaggio fa capolino in maniera costante in tutta la sua produzione, anche se non gli riesce di trovare una soluzione convincente. Un linguaggio che si giustifichi da solo, che non abbia bisogno d'essere logicizzato, che gli permetta di parlare "sopra il linguaggio" (p. 192), egli pensava d'averlo trovato soltanto nella musica. Gli riusciva però difficile pensare, e non a torto, che con la musica si potesse trovare "il senso del mondo".
"Il grande problema attorno al quale ruota tutto ciò che scrivo, è: Vi è, a priori, un ordine nel mondo? e, se sì, in che consiste?" (p. 193). È incredibile che un militare di trincea si mettesse a scrivere di logica e di misticismo, a questi livelli, tra un'azione bellica e l'altra. Certo è che nel bel mezzo d'una guerra mondiale, cioè nell'insensatezza più generale, non avendo egli alcuna consapevolezza dei meccanismi imperialistici sottesi a quella guerra, dobbiamo pensare che gli apparisse del tutto normale chiedersi dell'esistenza di un significato "aprioristico" del mondo. Quando si pensa che nei fatti non vi sia alcuna logica, è naturale che ci si chieda, volendo restare nell'ambito dell'etica, cioè rifiutando l'irrazionalismo, se per caso non esista una logica anteriore ai fatti.
In fondo il Trattato s'era posto come obiettivo proprio questa ricerca: individuare una coerenza logica formale indipendente dai fatti, capace anzi di spiegarli, a condizione ovviamente ch'essi fossero appunto "fatti" o "stati di cose", fenomeni in atto, e non espressioni del libero arbitrio, manifestazioni dell'etica o della psicologia, per le quali appunto occorreva un approccio mistico.
Wittgenstein non si preoccupava affatto d'aver elaborato una logica la cui coerenza formale fosse compresa tra la tautologia (che andava sempre affermata, cioè data per scontata) e la contraddizione (che invece andava sempre negata). Gli appariva del tutto normale che il realismo puro coincidesse con il solipsismo.
Posizioni del genere, a noi, possono apparire quanto meno ingenue o illusorie, sicuramente regressive rispetto alla logica hegeliana. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che dietro queste ingenuità vi era il dramma di una persona travagliatissima, segnata da esperienze tragiche in famiglia (tre fratelli si erano suicidati e un altro, pianista, perderà il braccio destro durante la guerra) e costantemente alle prese con gravi difficoltà relazionali (basta leggersi la biografia che di lui fece Norman Malcolm, edizione Bompiani, Milano 1988).
La tautologia lo affascinava in maniera particolare, "perché in essa ogni possibilità è ammessa in anticipo" (p. 196). "Essa non è un'immagine della realtà, in quanto RAPPRESENTA nulla. Essa è ciò che tutte le immagini - contraddicentesi l'un l'altra - hanno in comune" (ib.).
Un logico, che avesse a cuore di elaborare una teoria con cui interpretare la realtà, direbbe che qui siamo ai limiti dell'irrazionalismo, eppure i neopositivisti del Circolo di Vienna e gli accademici di Cambridge lo apprezzavano proprio per questo, ed erano disposti a transigere sulle sue tendenze mistiche. La tautologia, per lui, trovava la sua apoteosi nelle proposizioni assolutamente semplici, molecolari, atomiche, in grado di spiegarsi da sole, proprio perché indivisibili, quelle più idonee a spiegare il mondo, che deve per forza avere una "struttura fissa" (p. 204), comprensibile in maniera elementare. "Ciò che io non so, non lo so, ma la proposizione mi deve mostrare CHE COSA io so" (p. 205).
Il primo Wittgenstein arrivò a un soffio dal capire una cosa estremamente importante, ma che non sviluppò nel Trattato (anzi fece di tutto per negarla) e che poi invece se la ritroverà nella seconda parte della sua vita, come attestano le sue Ricerche filosofiche, pubblicate postume. "È forse che io so sì precisamente che cosa voglio dire, ma che poi faccio sbagli nell'esprimerlo? Oppure ANCHE questa insicurezza può essere inclusa nella proposizione?" (p. 210). Solo in un secondo tempo capirà che andava inclusa, in quanto facente parte organica del linguaggio umano, e se nel Trattato l'avesse fatto, non avrebbe tenuto così separata la logica dall'etica, cioè non avrebbe trasformato la logica in una scienza astratta, la cui fondatezza dipende da un'intrinseca coerenza formale, né avrebbe fatto dell'etica un qualcosa di mistico, anche se le idee mistiche non l'abbandoneranno per tutta la sua vita.
Se la logica non considera l'ambiguità, l'insicurezza, l'incertezza un valore, cioè un'espressione tipica del linguaggio umano, che riflette, a sua volta, un elemento incredibilmente fluido come la libertà, sarà sempre una logica destinata a fornire una conoscenza meramente tecnica, di tipo matematico, povera di contenuto esistenziale. La vita non è fatta solo di sì e di no, ma anche di forse, non lo so, dipende... In mezzo al bianco e al nero vi sono un'infinità di sfumature di grigio. Ma il primo Wittgenstein, quando parlava di colori, non lo faceva certo per parlare di sfumature o di combinazioni tra un colore e l'altro. I suoi esempi ricordano piuttosto quelle immagini a doppio senso, che fanno vedere cose diverse a seconda che ci si concentri su un colore piuttosto che su un altro.
Eppure aveva già capito che "le convenzioni del nostro linguaggio sono straordinariamente complicate. Ad ogni proposizione aggiungiamo mentalmente moltissime cose che non diciamo" (p. 213). Ora, perché il giovane Wittgenstein vedeva questo non come un pregio, ma come un difetto? La risposta va cercata nell'etica, cioè nella sua etica, nella grande difficoltà ch'egli aveva di vivere relazioni umane normali, eticamente significative, in cui l'identità non si ponesse da sé, ma in rapporto alla diversità.
II
A partire dal pensiero dell'11.6.1916 (p. 217) Wittgenstein entra nel vivo del misticismo. Questo a testimonianza che le pagine conclusive del Trattato non possono essere considerate casuali o estemporanee e neppure una forma di eccentricità. Esse anzi rivelano un dramma, non meno di quello in cui si pretende di elaborare una logica totalmente avulsa dalla realtà.
Wittgenstein ha portato la logica di Frege e Russell a un livello estremo, quasi nichilistico, nel senso che ha posto una sorta di condizione: o la logica ha senso quando è tautologica oppure è inutile. Cioè non è possibile trovare delle conferme da parte di una realtà del tutto contraddittoria come quella umana, per cui o a questa viene data un senso dall'esterno, oppure siamo destinati a fare ragionamenti insensati.
Tuttavia una logica tautologica (in cui la contraddizione non esiste, se non in via del tutto formale o come limite assoluto invalicabile) è inevitabilmente il riflesso di un'etica solipsistica. E quella di Wittgenstein è affetta da misticismo religioso. Non è come quella di Stirner; semmai assomiglia a quella di Kant o di Dostoevskij.
"Che so di Dio o del fine della vita?", si chiede. "Io so che questo mondo è. Che io sto in esso, come il mio occhio nel suo campo visivo. Che in esso è problematico qualcosa, che chiamiamo il suo senso. Che questo senso non risiede in esso ma fuori di esso" (p. 217). Quest'ultima affermazione, così lapidaria e dal sapore oracolare, è molto importante, poiché è da essa che si può capire come Wittgenstein escludesse che l'uomo possa trovare un senso nel mondo da questo stesso mondo, almeno finché l'uomo vive e finché il mondo sussiste.
Questa cosa la ripeterà, con non meno drammaticità, anzi con maggiore lucidità, anche nel Trattato: "Il senso del mondo deve essere fuori di esso. Nel mondo tutto è com'è, e tutto avviene come avviene; non v'è in esso alcun valore - né, se vi fosse, avrebbe un valore" (6.41). Questo perché ogni cosa che accade è puramente accidentale. Non vi è mai una necessità logica che dà senso alle cose, ma una arbitrarietà assoluta, nei cui confronti non è possibile fare nulla di significativo. Se c'è qualcosa che dà un senso logico alla realtà, essa non può far parte del mondo, per cui questo resta incomprensibile.
Difficile non vedere in tali ragionamenti un influsso di idee irrazionali, come p. es. quelle di Schopenhauer. Con la differenza che per Wittgenstein non c'è tanto una volontà irrazionale (metafisica) esterna all'uomo, ma è tutta interna alla sua coscienza: la volontà umana è "buona o cattiva"; questa volontà "compenetra il mondo" ed è essa che lo rende contraddittorio. L'uomo non riesce a dare un senso al mondo. Dunque questo senso, essendo necessariamente esterno, non può che essere "dio". L'uomo è, per dirla con Heidegger, "gettato" nel mondo da un dio che non lo aiuta a vivere, a superare le sue antinomie. "Io non posso guidare gli eventi del mondo secondo la mia volontà; al contrario, sono del tutto impotente. Solo in un modo posso rendermi indipendente dal mondo - e dunque, in un certo senso, dominarlo -: rinunciando a influire sugli eventi" (p. 217).
Sembra qui di leggere un testo orientale, induista o buddista o sufista. Viene qui teorizzata la necessità di distaccarsi dei beni terreni, dal desiderio di possederli, dall'esigenza di voler essere qualcuno. "Il mondo è indipendente dalla mia volontà" (ib.). Questo significa che se ciò che desideriamo si realizza, dipende solo da "una grazia del fato, poiché non c'è, tra volontà e mondo, una connessione logica che garantisca tale connessione..." (ib.).
Ora viene la frase più difficile da capire: "se il volere buono o cattivo ha un effetto sul mondo, lo ha solo sui limiti del mondo, non sui fatti, su ciò che non può essere raffigurato dal linguaggio ma solo mostrato nel linguaggio. In breve, il mondo allora deve perciò divenire un altro mondo" (ib.). Che cosa intende dire Wittgenstein per "limiti del mondo"? Intende probabilmente qualcosa di non analizzabile né formulabile con un linguaggio. Quindi qualcosa che va oltre la realtà concreta, percepibile coi sensi.
Che effetto può avere un'azione buona o cattiva su questi limiti? Sembra che qui Wittgenstein stia parlando dell'immortalità dell'anima, cioè del fatto che il vivere l'etica positivamente o negativamente avrà un effetto su di sé in un altro mondo, non in questo, perché questo è destinato a restare così com'è o a mutarsi prescindendo dalla singola volontà umana. Il senso del mondo lo si troverà in un altro mondo. Saranno come due vasi comunicanti: al diminuire di senso in questo mondo, aumenterà quello nell'altro.
Wittgenstein è qui convinto di poter frenare il proprio irrazionalismo teorico dando una veste religiosa alla propria etica individualistica. Pensa di potersi preservare dal suicidio o dalla follia proprio grazie al misticismo. Tutto viene rimandato all'aldilà, di cui però non si può dire nulla. "Credere in un Dio vuol dire comprendere la questione del senso della vita... vedere che i fatti del mondo non sono poi tutto... che la vita ha un senso" (p. 218). È, questa, un'esplicita professione di teismo. Quando parla di etica, Wittgenstein è come Kant, tradisce le proprie premesse logiche.
"Abbiamo la sensazione d'essere dipendenti da una volontà estranea" (p. 219). Se Wittgenstein fosse stato uno stretto discepolo di Schopenhauer o di Nietzsche non avrebbe posto dio e la volontà estranea su due piani diversi. Avrebbe detto che non esiste alcun dio che dà senso al mondo, e che la volontà estranea che lo domina è cieca e irrazionale. Invece il suo ragionamento è leggermente diverso: dio esiste, ma ciò che domina il mondo, inspiegabilmente, è una volontà irrazionale, del tutto umana, da cui si può cercare di liberarsi riducendo al minimo i propri desideri. Il fatto che l'uomo si trovi in questa situazione assurda, dipende da se stesso, ma anche dal fatto che, su questo pianeta, non c'è alcun dio che possa fare qualcosa, a meno che non si voglia considerare dio artefice di tutto, anche dell'impossibilità per l'uomo di soddisfare i propri desideri. Ma se fosse così, l'unica possibilità che l'uomo ha di diventare felice è quella di prendere le cose come sono e di non preoccuparsi di modificarle: deve prenderle come una forma di "prova da superare", alla stregua del Giobbe biblico o del sapiente Qoèlet, la filosofia dei quali tanto assomiglia alla sua.
Il credente Wittgenstein non ha bisogno di attendere la felicità dal destino. Gli basta essere "in armonia con il mondo" (p. 219). Se dio si vuol prendere gioco dell'uomo, facendogli vivere una vita senza senso, diventa "felice" chi è capace di stare al gioco, di non ribellarsi, né di desiderare qualcosa di diverso, né di temere alcunché, neppure la morte. Il criterio dell'etica può essere uno solo ed è tutto kantiano (e husserliano): "agisci secondo la tua coscienza comunque essa sia" (p. 220), secondo dei valori che vanno decisi di volta in volta. "La coscienza è la voce di Dio" (p. 219).
Questa è indubbiamente un'etica superficiale, eclettica, in cui vengono mescolate tra loro credenze di vario genere, che nessuna religione avrebbe fatto proprie tutte insieme. Vi è sicuramente una laicizzazione della vivibilità della fede: in Wittgenstein confluiscono elementi ebraici, protestanti, indo-buddisti (quest'ultimi probabilmente mediati da Schopenhauer) e tutti inglobati in un'esperienza molto soggettivistica, isolata. Wittgenstein si chiede se possa esistere un individuo che, per essere felice, eviti di desiderare. È possibile una "nolontà"? - sembra chiedersi.
A p. 224 afferma una cosa emulando direttamente Schopenhauer: "Il mondo della rappresentazione è né buono né cattivo; ad essere buono o cattivo è il soggetto che vuole". Se non ci fosse il desiderio o la volontà, non ci sarebbe neppure l'etica. Cioè senza volontà, l'etica dovrebbe essere simile alla logica: fare il bene dovrebbe essere automatico, scontato, come l'impossibilità di sbagliare sul piano logico. La coerenza morale e intellettuale dovrebbe essere il presupposto del mondo, la sua condizione, nel senso che dovrebbe esistere la possibilità d'essere felici anche se i propri desideri non si realizzano. Certo, si può desiderare il bene o il male, ma si deve anche ammettere la possibilità del "non desiderare", che non pregiudica affatto la possibilità d'essere felici.
L'etica di Wittgenstein è puramente intenzionale, come quella di Husserl, e deve trovare il proprio appagamento in questa mera intenzionalità. È un'etica atrofizzata, come spesso succede alle persone isolate. Un'etica del genere "non si lascia formulare" (p. 223). È tutta interiore. È distaccata dalla realtà, esattamente come il suo equivalente intellettuale, la sua sovrastruttura ideologica: la logica proposizionale o tautologica.
Non vi sarebbe neppure l'etica se il soggetto smettesse di "volere", precisa a p. 225: la colpa infatti viene introdotta nel mondo solo per mezzo di una volontà che vuole male. "Buono e cattivo sono predicati del soggetto, non proprietà del mondo": dipendono dalla volontà, non dalla materialità della vita. Non dipendono neppure dal pensiero, poiché questo, senza volontà, è come se non esistesse. Il vero enigma da studiare non è quindi il mondo ma l'essere umano, nei confronti del quale non ci si può porre obiettivamente (come se fosse un oggetto delle scienze naturali), e neppure psicologicamente, poiché questa scienza non è in grado di vedere l'io come "limite del mondo", cioè in maniera metafisica.
Quest'io è felice - conclude Wittgenstein gli ultimi pensieri etici che vanno dall'11.6.1916 al 13.8.1916 - solo quando, pur sapendo di non poter tener "lontana la miseria di questo mondo", si limita a una vita basata sulla "conoscenza" (p. 226). "Felice è solo la vita che può rinunciare ai piaceri del mondo" e che accetta i piaceri del mondo non come frutto della propria volontà, ma come "grazie del fato" (ib.).
Questa forma di solipsismo coincide - secondo Wittgenstein - col "realismo puro" (p. 227). La storia non aiuta a definire l'io filosofico (p. 228), poiché anche la storia è un concetto troppo astratto per un io che vuole porsi in maniera esistenziale e insieme metafisica. "L'uomo è il microcosmo" (p. 230), sottinteso ovviamente "dell'universo". "Io sono il mio mondo" (ib.). Per Wittgenstein il realismo non è che la trasformazione di un idealismo astratto in un idealismo concreto e quest'ultimo si chiama solipsismo. L'io s'identifica col mondo, che però non è il mondo reale, ma quello costruito artificiosamente dall'io logico, che è anche un io trascendentale, essendo un limite del mondo, il limite di un mondo troppo contraddittorio per essere accettato integralmente.
La descrizione di questo io, che Wittgenstein dà il 4.11.1916 (pp. 233-36), è straordinariamente somigliante a quella di Giovanni Gentile, un altro idealista soggettivo, che pretendeva di dare concretezza all'idealismo hegeliano puntando tutte le sue carte non sulla logica ma sullo Stato, anch'esso visto come qualcosa di assolutamente perfetto, al di sopra delle contraddizioni della società civile. "Il soggetto è il soggetto che vuole" (p. 234). "La volontà è una presa di posizione del soggetto verso il mondo" (ib.). L'io si autopone volendo. Questo sembra in contraddizione con quanto detto prima a proposito del non-desiderare. Qui infatti Wittgenstein si affretta a precisare che l'io non può "volere tutto" (p. 235): "la volizione non è un'esperienza" (p. 236), ma un atteggiamento interiore, un atto di coscienza.
Sintomatico però ch'egli concluda la parte etica dei suoi Quaderni parlando del suicidio. Questo io metafisico che vorrebbe essere se stesso ma che non vi riesce, che vorrebbe vivere in armonia col mondo ma le contraddizioni di questo glielo impediscono, che si sforza di non desiderare in un mondo di sofferenze ma che ammette di non poter non desiderare - è un io che alla fine si chiede che senso abbia la vita e se il suicidio non debba essere preso come ipotesi di non-vita, eticamente né buona né cattiva.
Introduzione alla filosofia del linguaggio
Fonti
- Gottlob Frege, Senso, funzione e concetto, ed. Laterza, Bari 2007
- Gottlob Frege, Ricerche logiche, ed. Guerini e Associati, Milano 1999
- Frege Gottlob, Scritti postumi, 1987, Bibliopolis
- Gottlob Frege, Logica e aritmetica, ed. Boringhieri, Torino 1965
- Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, 2009, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Ricerche filosofiche, 2009, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni di filosofia (1930-1933). Annotate e commentate da George E. Moore, 2009, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni sui fondamenti della matematica, 2002, Bollati Boringhieri
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la credenza religiosa, 1967, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Zettel. Lo spazio segregato della psicologia, 2007, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, 1990, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Ultimi scritti 1948-1951. La filosofia della psicologia, 2004, Laterza
- Wittgenstein Ludwig, Esperienza privata e dati di senso, 2007, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Della certezza. L'analisi filosofica del senso comune, 1999, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937, 1999, Quodlibet
- Wittgenstein Ludwig, Causa ed effetto-Lezioni sulla libertà del volere, 2006, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Note sul «Ramo d'oro» di Frazer, 1975, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni sui colori, 2000, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni filosofiche, 1999, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Pensieri diversi, 1980, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Diari segreti, 2001, Laterza
- Wittgenstein Ludwig, Libro blu e Libro marrone, 2000, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Lettere a Ludwig von Ficker, 1989, Armando Editore
- Wittgenstein Ludwig, Ludwig e gli amici. Lettere, 2010, Quattroventi
- Wittgenstein Ludwig, Vostro fratello Ludwig. Lettere alla famiglia (1908-1951), 1999, Archinto
- Wittgenstein Ludwig, Lettere a C. K. Ogden. Sulla traduzione del «Tractatus logico-philosophicus», 2009, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig; Bouwsma Oets K., Ludwig Wittgenstein. Conversazioni annotate da Oets K. Bouwsma, 2005, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni 1930-1932. Dagli appunti di John King e Desmond Lee, 1995, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Conversazioni e ricordi, 2005, Neri Pozza
- Wittgenstein Ludwig, Lecture on ethics, 2007, Quodlibet
- Wittgenstein Ludwig, La filosofia. Testo tedesco a fronte, 2006, Donzelli
- Wittgenstein Ludwig, The Big Typescript, 2002, Einaudi
- Rudolf Carnap, Analiticità, significanza, induzione, ed. Il Mulino, Bologna 1982
- Carnap Rudolf, Lo spazio. Un contributo alla teoria della scienza, 2009, Morcelliana
- Carnap Rudolf, Filosofia e sintassi logica, 1996, ETS
- Enriques Federigo; Carnap Rudolf; Schlick Moritz, Filosofia scientifica ed empirismo logico (Parigi, 1935), 1993, Unicopli
- Carnap Rudolf, Introduzione alla logica simbolica, 1978, La Nuova Italia
- Carnap Rudolf, La costruzione logica del mondo, Utet 1997
- A. Bonomi, La struttura logica del linguaggio, ed. Bompiani, Milano 1973
- Ludwig Wittgenstein, Colloqui al circolo di Vienna, Mimesis, 2011
- Wittgenstein e il Circolo di Vienna, ed. La Nuova Italia, Firenze 1979
- Friedrich Waismann, Ludwig Wittgenstein e il circolo di Vienna. Colloqui annotati, La Nuova Italia 1975
Siti
- it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
- www.youtube.com/watch?v=i5IVnlOJ8ec
- www.youtube.com/watch?v=1LYTYKgGVxE
- www.lettere.unimi.it/dodeca/piana01/tr_indice.htm
- plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/
- www.emsf.rai.it/percorsi_tematici/wittgenst/
Download