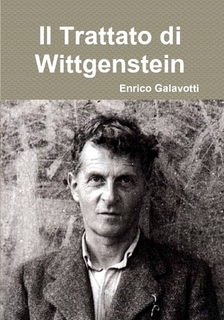TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
LA LOGICA DEL TRATTATO DI WITTGENSTEIN
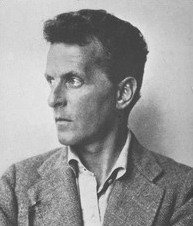
Incontrava enormi difficoltà nell'esprimersi e le sue parole mi riuscivano inintelligibili. (Norman Malcolm)
Premessa
Non mi sono mai interessato di logica, perché l'ho sempre avvertita come una disciplina molto astratta, poco attinente alla realtà. Ma siccome, insegnando filosofia, s'incontra anche L. Wittgenstein, considerato uno dei massimi filosofi del Novecento, ho deciso di leggermi estesamente quanto meno il suo famoso Trattato, di cui i manuali parlano con maggiore ampiezza, essendo stato elaborato in maniera sistematica, ed essendo esso facilmente collegabile alla corrente neopositivistica e agli studi di filosofia del linguaggio.
Non sono quindi un esperto in materia di logica e mi rendo benissimo conto che un testo del genere non può essere compreso sino in fondo senza prima essersi lette le opere di logica e di matematica di Frege e e Russell. Questo commento va preso come il tentativo di un'insegnante di filosofia di cercare di capire al meglio ciò che deve spiegare ai propri studenti. Se non vi sono riuscito, la responsabilità non può essere attribuita nemmeno in parte a un testo di così difficile comprensione come appunto il Tractatus logico-philosophicus, scritto in sette anni, mentre io mi sono limitato a circa sette settimane per leggerlo e commentarlo.
Il testo non è solo difficile in sé, ma anche perché - come scrive F. Ramsey - "alcuni dei suoi enunciati sono volutamente ambigui, poiché crede che abbiano simultaneamente un significato ordinario e un significato più complesso" (Wittgenstein, Lettere a C. K. Ogden, ed. Mimesis, Milano-Udine 2009, p. 122). Esso appare come un testo dogmatico, come una sorta di Bibbia o di Corano, oggetto di rivelazione. Ma è un testo "religioso" molto particolare, in quanto è come se avesse trasferito l'ideologia mistica nel campo della logica
Ho utilizzato la versione a cura di Amedeo G. Conte, dell'editore Einaudi (2009) che, per fortuna, include anche i Quaderni del 1914-16, che certamente aiutano a capire qualcosa di più. La traduzione in italiano non è grammaticalmente il massimo possibile (qualcuno potrebbe avere da ridire al vedere, p. es., usare la parola "contraddizione" con una sola "d"), ma alla mia età, ormai, si è disposti a transigere su questo e su molto altro: cosa che il giovane Wittgenstein non avrebbe certo fatto.
Quanto poi a definirlo, come fa questa versione, "il massimo filosofo del Novecento", mi pare senza dubbio un'esagerazione, non foss'altro perché Wittgenstein non ha mai avuto solide basi filosofiche. Semmai potremmo dirlo di Heidegger, che però dipende da Nietzsche. Wittgenstein ha dato certamente un contributo significativo alla logica, che è una delle scienze della filosofia, separandola però dai fatti, cioè rendendo i concetti di vero e di falso del tutto formali (fittizi), mentre, sul piano più propriamente filosofico, egli si situa su una linea che va da Kant a Schopenhauer, passando per Husserl e lambendo, a tratti, l'irrazionalismo di Nietzsche.
Spesso non ci si rende conto che un qualunque "grande" filosofo del Novecento resta sempre, rispetto ai Hegel, un nano, e questo proprio perché la filosofia è morta con Hegel, raggiungendo, con lui, il massimo vertice. Tutto quanto è venuto fuori dopo di lui, sul piano filosofico, è stato soltanto lo sviluppo di una parte del suo pensiero, che il più delle volte è stata estremizzata. L'unico che ha davvero capito come superare l'idealismo oggettivo di Hegel è stato il giovane Marx, quando scoprì l'idea di "prassi politico-rivoluzionaria". L'unico che ha davvero non soltanto capito, ma anche realizzato tale superamento è stato Lenin.
* * *
C'è della presunzione insopportabile nel primo Wittgenstein, che doveva avere una grande considerazione di sé, almeno sul piano intellettuale. Egli infatti era convinto d'essere talmente avanti rispetto agli altri filosofi (o logici, poiché in cui i due ambiti coincidono), da ritenere quasi impossibile che il suo Tractatus potesse essere capito. Eppure lui stesso, nella seconda fase del suo pensiero, arriverà a rettificarlo in molti aspetti, "umanizzando", per così dire, il suo pensiero.
Parla chiaramente di questa particolare difficoltà interpretativa nella Prefazione dello stesso Trattato: "Questo libro, forse, lo comprenderà solo colui che già a sua volta abbia pensato i pensieri ivi espressi - o, almeno, pensieri simili" (p. 23). Dunque figuriamoci come avrebbero potuto capirlo tutti gli altri! È incredibile che un filosofo arrivi a dire che la sua opera potrà essere compresa solo da un lettore che preventivamente la pensa come lui. È come se qualcuno chiedesse d'essere letto non perché ha qualcosa da comunicare, ma soltanto per chiarire a se stesso le proprie idee: questo atteggiamento, che sarà una costante nella sua vita, fa parte di una filosofia più generale chiamata solipsismo. Ed è paradossale che un filosofo del linguaggio formale come lui trovi così tanta difficoltà a comunicare. Impossibile non vedere qui un certo aristocraticismo intellettualistico.
La suddetta presunzione è infatti visibile anche nell'obiettivo che il Trattato si pone: quello di mostrare che la filosofia non è in grado di risolvere i propri problemi perché non è abbastanza logica. In altre parole, la filosofia dovrebbe parlare solo di ciò che ha già un senso logico: "su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere" (ib.). E qui, col verbo "parlare", Wittgenstein intende un'espressione logica, cioè chiara e distinta. E anche quando dice "si deve tacere", appare molto perentorio. Se una tale filosofia del linguaggio passasse come direttiva ministeriale, lo Stato violerebbe, ipso facto, la libertà di coscienza di qualunque cittadino. Come si può stabilire a priori ciò che può essere detto, perché sufficientemente comprensibile, da ciò che non può essere detto? Si pensi solo a quanta ricchezza culturale andrebbe perduta se si vietassero le espressioni ambigue, simboliche, metaforiche...! Che sono poi la specificità che ci differenzia dalle macchine, coi loro linguaggi stereotipati.
Davvero dunque non avrebbe senso porsi quei problemi per i quali non vi sono le condizioni sufficienti (che per Wittgenstein sono essenzialmente linguistiche) per risolverli? Marx diceva la stessa cosa in riferimento alle questioni economiche, ma lo diceva da rivoluzionario sconfitto politicamente, proprio per dare una giustificazione al suo successivo lavoro esclusivamente teorico, da economista. Wittgenstein invece lo dice dopo la sconfitta della sua Austria imperiale nel corso della prima guerra mondiale, anche se evidentemente doveva già averlo pensato prima: il manoscritto infatti fu terminato nel 1918 e pubblicato nel 1921.
Sono due posizioni praticamente rassegnate, che si preoccuperanno entrambe di dimostrare "scientificamente" come le cose devono andare a prescindere dalla volontà umana. "Ciò che è oltre il limite [per Wittgenstein la correttezza formale di una proposizione; per Marx la teoria del plusvalore] non sarà che nonsenso" (ib.). Entrambi erano convinti d'aver detto cose assolutamente "intangibili e irreversibili" (p. 24) sui fondamenti del loro rispettivo oggetto d'indagine. Salvo che, in entrambi, questa rimase una semplice esagerazione di maniera: nei fatti, se ci furono due intellettuali che non s'accontentarono mai dei risultati delle loro ricerche, furono proprio Marx e Wittgenstein. Qui però dobbiamo limitarci all'analisi del Trattato logico-filosofico.
PROPOSIZIONI n. 1
Wittgenstein esordisce ponendo all'attenzione, pur senza dirlo, la categoria della necessità, con cui si devono operare constatazioni di fatto, logicamente inoppugnabili.
Il mondo fatto di cose individuali, slegate tra loro e addirittura in opposizione reciproca, non interessa alla logica, che è invece interessata a cose che determinano fatti indiscutibili, che indicano non solo ciò che è, ma anche ciò che non è e che non può essere. Le intenzioni soggettive, le singole cose non determinano "fatti".
La logica ha bisogno di partire da quel che c'è, limitandosi a svolgere un lavoro interpretativo. I fatti devono essere semplicemente meglio compresi, non modificati. Se esiste contraddizione, questa è formale, richiesta tecnicamente dalla stessa logica, che ha bisogno di verificare l'opposto di ciò che afferma, come verità al negativo.
E' la logica che decide la coerenza dei fatti, non sono i fatti che decidono la coerenza della logica.
PROPOSIZIONI n. 2
I fatti, secondo Wittgenstein, sono determinati da un intreccio di cose, ma in maniera tale che all'interno di queste cose sono, in un certo senso, "pre-determinati". Lo stato di cose, da cui emergono i fatti, contiene varie possibilità di sviluppo, che però non sono infinite. Compito della logica è proprio quello di supporle tutte, per poter dare dei fatti un'interpretazione univoca. La necessità è dunque determinata dal fatto che le possibilità (delle configurazioni di forma) sono limitate.
Le cose non sussistono in sé, ma solo come parte di un tutto: in sé la possibilità di essere è puramente astratta. La logica del primo Wittgenstein vuole essere una gabbia nei confronti di ciò che può essere detto in maniera sensata. Il che, in sé, non deve essere visto come una pretesa sbagliata; lo diventa però quando c'è di mezzo l'essere umano. Una logica del genere è adatta a un linguaggio di tipo informatico o matematico o anche di tipo grammaticale, ma non è adatta a linguaggi tipicamente umani. Se si volesse applicare la logica del Trattato all'interpretazione di una poesia ne verrebbe fuori solo un'analisi linguistica relativa p. es. alle figure retoriche, alla versificazione scelta dal poeta, allo stile puramente formale. Gli aspetti psicologici, i riferimenti indiretti alla cultura e alla politica contemporanei al poeta, verrebbero esclusi a priori, in quanto opinabili o irrilevanti - come diceva Croce - ai fini di stabilire se una poesia è bella o no, è riuscita bene o male. In questa maniera però anche l'analisi formale del testo ne soffrirebbe, pur non sembrando all'apparenza.
Wittgenstein vuole porsi come logico di fronte alla realtà, come se questa fosse solo "naturale", cioè analizzabile secondo i criteri delle scienze esatte. Purtroppo per lui invece essa è anche "umana" e, per poterla davvero comprendere, bisogna porsi come "storici" o "politici" o "sociologi" o "psicologi" ecc. Se io guardo, nel mio spazio-tempo, una sedia, penso che serva per sedercisi, ma lo penso proprio perché sono in uno spazio-tempo determinato. Non è detto che sia "naturale" per l'uomo sedersi sopra una sedia: quando si è stanchi o si vuole mangiare qualcosa o fare conversazione, ci si potrebbe anche accovacciare sulle gambe, usare un cuscino per terra, sdraiarsi su un divano ecc. Le possibilità "umane", in realtà, sono infinite e non ha senso stabilirle tutte a priori, prima di poterle interpretare. Molte cose bisogna darle per scontate, altrimenti il tempo che ogni volta si perderebbe per riprecisarle sarebbe spropositato. Semmai dovremmo chiederci da dove proviene il legno con cui la sedia è stata fatta; se, per ottenerlo, si è rispettato l'ambiente; se si è pagato un prezzo giusto per ottenerlo; se, per lavorarlo, lo si è fatto in condizioni di proprietà privata o pubblica ecc.
La logica ha un senso solo in uno spazio-tempo molto ristretto e solo con oggetti strutturati in maniera tale per cui l'interpretazione sia sì intelligente, ma, in ultima istanza, univoca: come avviene p. es. nei gialli, quando si hanno a disposizione solo degli indizi, o come avviene nella progettazione di un database.
L'impostazione del Trattato, pur in un settore gnoseologico completamente diverso, è straordinariamente somigliante a quella del Capitale di Marx. Come questi, infatti, è partito, in maniera fenomenologica, dalla descrizione della "merce", quale semplice oggetto carico d'incredibile complessità, per arrivare a dimostrare la teoria economica del plusvalore; così Wittgenstein è partito dalla "proposizione semplice" per arrivare a dimostrare in che misura è possibile una ferrea logica linguistica. Entrambi hanno ridotto l'essenza umana ha una sua precisa caratteristica, rendendola prevalente: il bisogno materiale di esistere, l'uno, e il bisogno di comunicare per farsi capire, l'altro. Entrambi hanno cercato di dare un senso razionale a tali bisogni, senza rendersi conto ch'essi trovano il loro vero senso solo in un contesto sociale molto determinato (comunitario) in cui tutto viene condiviso, un ambito che va al di là di quegli stessi bisogni, presi separatamente, in quanto appunto li spiega nel loro insieme, cioè determina nel contempo la modalità di soddisfazione e di espressione più adeguata.
Marx ha vissuto quasi tutta la sua vita in una condizione in cui non era capace di soddisfare i suoi bisogni materiali di sussistenza; Wittgenstein invece ha vissuto quasi tutta la sua vita soffrendo di una certa incapacità comunicativa. In entrambi i casi ha prevalso una forma di egocentrismo, cui s'è cercato di supplire con un'attività intellettuale costantemente alla ricerca di una "oggettività delle cose". Menti illuminate, straordinariamente intelligenti, ma con un senso limitato della relazione sociale, cioè dell'integrità dell'essenza umana, che non può mai essere scomposta nei suoi elementi semplici, perdendo di vista la visione olistica dell'insieme. L'essere umano è un tutt'uno, un unicum, inscindibile nelle sue singole parti, poiché, quando si cerca di farlo, la successiva ricomposizione è sempre difettosa, è sempre mancante di qualcosa di essenziale.
Che questo sia vero, è dimostrato dal fatto che entrambi finiscono nella tautologia, cioè in quell'inevitabile vicolo cieco in cui ci s'infila quando si vuole usare in maniera tassativa la categoria della necessità. La tautologia di Marx era nota a lui stesso: se il valore di scambio è il presupposto del plusvalore, perché non ogni scambio produce plusvalore? La risposta a tale quesito Marx andò a cercarla sul versante economico, quando in realtà era di tipo culturale.
Quanto a Wittgenstein, è addirittura lui stesso che sostiene che "le proposizioni della logica sono tautologie" (6.1) e che quindi "non dicono nulla" (6.11). Infatti devono semplicemente limitarsi a "mostrare" la logica delle cose, affinché le proposizioni vengano accettate come un'evidenza.
La presenza di tautologie non ha mai impensierito più di tanto né l'uno né l'altro, anche se Marx, avendo maggiore senso storico di Wittgenstein, ha cercato di fare continue ricerche al fine di spiegarsi la loro origine. Questo infatti gli permise d'intuire che il protestantesimo era la religione più adatta allo sviluppo del capitalismo. D'altra parte lo stesso Wittgenstein, dopo averle osannate in gioventù, avrà forti ripensamenti nella seconda parte della sua vita, grazie al contatto con gli ambienti accademici di Cambridge.
Entrambi tenevano continuamente fede al valore di una struttura di base (la sostanza delle cose), in virtù della quale si poteva, con sufficiente razionalità, spiegare tutto il resto: per Marx era il plusvalore, con cui poteva spiegare oggettivamente l'essenza dello sfruttamento economico del capitalismo; per Wittgenstein era la proposizione che tiene unite logicamente le cose (o gli oggetti) coi loro significati. "La sostanza è ciò che sussiste indipendentemente da ciò che accade", quindi "è forma e contenuto" (2.024, 2.025). Marx non avrebbe accettato una frase del genere, perché l'avrebbe considerata idealistica. Per lui la sostanza andava cercata nell'economia e, una volta trovata, sarebbe stato impossibile sostenere che "gli stati di cose sono indipendenti l'uno dall'altro" (2.061). Quando Marx considerava vera questa indipendenza, lo faceva solo in via temporanea, per elaborare un ragionamento logico di tipo astratto, come quando p. es. parlava del capitalismo prescindendo dal colonialismo. Infatti anche quando tratta delle cinque formazioni sociali del genere umano (tra loro senza dubbio indipendenti nel modo di funzionare), ciò che più gli interessava erano in realtà le transizioni dall'una all'altra.
A dire il vero anche nel secondo Wittgenstein emerge la preoccupazione di capire i mutamenti di significato delle proposizioni in rapporto a determinati contesti semantici, evitando di cadere nell'illusione di "isolare" gli stati di cose per poter essere il più scientifico possibile nell'interpretazione.
Il Trattato, come spesso succede nei testi di logica pura, possiede un livello così elevato di astrazione che facilmente rischia di cadere nell'arbitrario, privo com'è di riferimenti alla storia concreta. Wittgenstein si sforza, in realtà, di parlare della relazione "io-mondo", ma lo fa in maniera puramente filosofica.
È interessante, in tal senso, cercare di capire cosa dice nelle tesi inerenti alle Proposizioni n. 2. Lo faremo però molto sinteticamente, poiché su queste proposizioni si è già detto, fin qui, abbastanza. L'ultima cosa da spiegare è il concetto di "immagine", che vedremo appunto a sintesi ultimata.
Diciamo anzitutto che tutte le Proposizioni n. 2, se si escludono quelle riguardanti il concetto di "immagine", sono state formulate con l'intento di spiegare quelle, assai poche a confronto, espresse nelle Proposizioni n. 1, le quali valgono come introduzione generale, e che sono più "filosofiche" che "logiche". Nelle Proposizioni n. 2 Wittgenstein si pone il compito di ridurre la filosofia a una questione di logica, ma lo fa dando alla logica una giustificazione filosofica, e la giustificazione che usa è una sorta di rappresentazione del mondo, che si conclude là dove parla di "immagine", con la necessità di chiarire il ruolo dell'io in questo mondo.
Ma ora vediamo la sintesi dei significati delle Proposizioni n. 2.
1. Anzitutto i fatti (del mondo), per essere compresi in maniera scientifica, devono essere sottoposti alle regole della logica, che sono regole linguistiche di tipo formale. Non ci può essere un uso inappropriato delle parole, proprio perché ogni singola parola deve giustificare se stessa (più avanti dirà: "all'interno di una proposizione"), altrimenti è meglio non usarla.
2. Ciò che va interpretato è quello che è, non quello che "dovrebbe essere". La categoria della "necessità" è fondamentale per essere rigorosi sul piano scientifico. Ciò che è, è ciò che deve essere all'interno di una serie determinata di possibilità.
3. Quello che è, va analizzato in tutte le sue forme astratte possibili, riducendo i fatti a oggetti semplici, come quando p. es. in una proposizione vanno ricercati il soggetto e il predicato. Senza questa scomposizione ai minimi termini, non c'è scienza e la logica resta ipotetica.
4. Tuttavia il problema non è solo quello di come scomporre le cose per poter interpretare adeguatamente i fatti, ma è anche quello d'individuare nelle cose la sostanza che le tiene unite indipendentemente dalla loro forma, in quanto le forme possono cambiare. Tale sostanza va individuata logicamente, in quanto fa parte della logica, ma non può essere spiegata concettualmente: semplicemente va data per scontata, come un qualcosa di indimostrabile, che rende però mostrabile e quindi decifrabile tutto il resto. Da questa concezione di "sostanza" emergerà poi il lato "mistico" della filosofia di Wittgenstein.
Una volta individuata la sostanza, si è in grado di capire perché ciò che non è, non è. È vero che le forme sono tutte possibili, ma va individuata quella necessaria, che rende impossibili tutte le altre (beninteso all'interno di un certo spazio-tempo, cui Wittgenstein vuole aggiungere, abbastanza inspiegabilmente, un terzo elemento: la cromaticità) (1).
5. Gli stati di cose, che determinano i fatti, sono indipendenti tra loro, per cui non è da escludere che, mutate le circostanze di spazio e tempo, risulti possibile ciò che altrove è necessario, e viceversa. Questa concessione al relativismo diventerà il perno fondamentale di tutte le ricerche del secondo Wittgenstein, il quale, proprio per questa ragione, non arriverà mai a pubblicare qualcosa di "definitivo".
* * *
Ma ora dobbiamo vedere l'ultima parte delle proposizioni n. 2: l'immagine. La rappresentazione che del mondo si fa il soggetto, Wittgenstein la chiama "immagine". Il problema che il soggetto deve risolvere è quello di come darsi un'immagine che corrisponda alla realtà. La corrispondenza deve avere una forma logica, cioè sensata, lasciando impregiudicato, al momento, se tale rappresentazione sia vera o falsa.
Questo è un punto debole nel ragionamento di Wittgenstein, come lo è spesso nei logici. Infatti, siccome si pretende di cogliere la realtà per quello che è (tralasciandone però le sue intrinseche contraddizioni sociali), il principale problema da risolvere non sta tanto nel come trasformare una realtà contraddittoria in una più coerente, ma come adeguarvisi, rendendola coerente alla propria logica. La logica non è al servizio della realtà, ma il contrario, e la verità che si cerca non è reale ma formale.
Wittgenstein si limita soltanto a dire che la verità o falsità di un'immagine dipende dal modo in cui essa si rapporta alla realtà, cioè che non è possibile sostenere l'idea di un'immagine vera "a priori", in quanto, per poterlo essere, l'immagine deve trovare una "concordanza" con la realtà. La realtà, di per sé, non può essere falsa, proprio perché essa sussiste. È solo l'immagine che può essere vera o falsa, a seconda del suo grado di "conformità".
Marx avrebbe detto che Wittgenstein non si poneva il problema di "trasformare" il mondo, ma solo di "interpretarlo": (2) e questo pur dopo un secolo da Hegel, pur dopo la diffusione delle idee socialiste e materialiste che portarono alla Comune di Parigi, alla prima e seconda Internazionale e alla rivoluzione d'Ottobre. D'altra parte anche Lenin, poco prima che Wittgenstein scrivesse il suo libro, aveva dovuto combattere contro gli idealisti della II Internazionale, che non avevano saputo impedire lo scoppio della I guerra mondiale.
Idealismo, di per sé, non vuol dire soltanto applicare arbitrariamente alla realtà le proprie idee o, al contrario, giustificare la realtà per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, o convivere pacificamente con la religione o, al contrario, distruggerla con l'anticlericalismo, ma anche e soprattutto rinunciare a risolvere le fondamentali contraddizioni sociali del proprio tempo. In tal senso si può definire "idealista" anche il Marx economista, ma solo nell'aspetto della rinuncia ad associare attivamente l'analisi economica alla prassi politica. L'idealismo, quando non porta all'irrazionalismo, è presente là dove si è rassegnati nel modo di agire pratico. Non conta nulla essere atei o materialisti o socialisti: tutto può essere una variante dell'idealismo, se politicamente non ci s'impegna per risolvere i problemi che affliggono le società divise in classi antagonistiche.
Non a caso è quando s'affrontano problemi del genere che le posizioni idealistiche, rifiutando di accettare la necessità di cambiamenti sostanziali, si trasformano in posizioni irrazionalistiche. L'idealismo, al massimo, può essere suddiviso in ingenuo ottimismo o in freddo cinismo, ma sempre idealismo resta. Esso infatti non andrebbe considerato come una corrente filosofica specifica, bensì come una "meta-categoria", cioè una sorta di discriminante tra l'atteggiamento politicamente rassegnato a non desiderare una trasformazione radicale del presente (anche a costo d'impedirla attivamente) e quello combattivo.
La cultura dominante, invece, ritiene che gli idealisti siano proprio quelli che non si rassegnano. Ma quelli che non si rassegnano andrebbero chiamati "rivoluzionari", mentre tutti gli altri sono appunto gli "idealisti", in buona o malafede. Sono idealisti quelli che attribuiscono valori assoluti alle istituzioni, alla proprietà privata, alla famiglia (3), alla coerenza delle idee, al primato della fede sulla ragione o della ragione sulla fede (4), alla gerarchia, al denaro e così via. Tutte le volte che ci si fossilizza su qualcosa e si perde di vista l'insieme, che ci fa essere integralmente e quindi autenticamente umani, si è necessariamente idealisti, cioè astratti, fanatici di qualcosa.
E che la logica sia, di regola, un qualcosa di astratto, lo dimostra anche l'introduzione di B. Russell al Trattato, che di tutti questi aspetti non si preoccupa minimamente, limitandosi a vedere il testo come un grande contributo appunto alla logica.
PROPOSIZIONI n. 3
Con la serie delle Proposizioni n. 3 Wittgenstein entra nel vivo della logica. Si noti anzitutto l'aspetto "idealistico" di tale asserzione: "Noi non possiamo pensare nulla d'illogico" (3.03), cioè qualunque cosa si pensi ha la possibilità (teorica) di realizzarsi. Essere "illogici" vuol dire essere "fuori del mondo", cioè avere, nei confronti dei "terrestri", dei parametri interpretativi o delle coordinate di spazio-tempo del tutto sconosciuti.
Viceversa, chiunque sia in grado di pensare, su questa terra, deve per forza essere dotato di una certa coerenza logica, a prescindere dal fatto che questa sia vera o falsa. "Ciò che è pensabile è anche possibile" (3.02), almeno in via ipotetica.
Perché questo modo di ragionare deve essere definito "idealistico"? Lo è semplicemente perché si parte dall'io e non dalla sua relazione con la realtà. Si vuol preventivamente mettere in chiaro ciò che, in una situazione normale, si dovrebbe invece dare per scontato, semplicemente dicendo che il carattere logico dei propri pensieri è dato dal contesto in cui si vive, a meno che, ovviamente, tale contesto non contenga elementi che urtano con una logica umana e naturale. Dire che ciò che si pensa è possibile che sia, non ha alcun significato in un contesto in cui questa possibilità è già una realtà. Ha invece senso là dove il contesto ha una logica fortemente contraddittoria, ma, in tal caso, si sarebbe dovuti partire dal contesto e non dall'io isolato.
Se Wittgenstein fosse partito dal contesto, si sarebbe accorto che da questo proviene non solo un senso logico (cioè umano e naturale) delle cose, ma, in talune situazioni, anche un senso illogico. Pertanto sarebbe stato meglio dire, affrontando la logica con una premessa storica, che, a seconda dei casi, vi sono situazioni favorevoli alla logica e altre che invece le sono contrarie.
Ovviamente Wittgenstein sa bene che la realtà sociale è contraddittoria, ma è convinto che se tenesse conto di tale realtà in maniera sociale, non riuscirebbe a costruire una logica formalmente corretta. Ecco perché preferisce definire "logica" anche una coerenza falsa: può farlo proprio perché affronta l'argomento in maniera puramente filosofica. Se l'avesse fatto in maniera etica, avrebbe dovuto dire che una coerenza falsa è illogica, in quanto tendenzialmente irrazionale. Invece così dà l'impressione che tra logica vera e logica falsa non vi sia una differenza fondamentale, eticamente preoccupante. E lo fa col rischio di sostenere, alla fine del suo ragionamento, che quanto è possibile, può essere vero, anche se è eticamente falso.
È vero che Wittgenstein esclude che un pensiero, da solo, possa decidere della verità di se stesso, ma questa costatazione a favore del realismo non è foriera di ulteriori sviluppi. La logica di Wittgenstein è come un castello che comunica col mondo esterno attraverso un ponte levatoio di cui s'è persa la chiave per abbassarlo. È una logica autoreferenziale. Stando chiusi dentro questo castello, ci s'illude che i propri enunciati risultino chiari proprio perché non prescindono mai dai cinque sensi. È tutto qui il "realismo puro" di Wittgenstein. Egli cioè s'illude che, dopo aver vissuto la propria vita al di fuori del castello, per continuare a viverla, restandovi dentro, senza aver più la chiave con cui abbassare il ponte, sia sufficiente ricordarsi delle esperienze pregresse.
È una logica rinunciataria, che vuole cercare il proprio appagamento in un contesto anomalo, solipsistico. All'interno del castello la felicità sarà raggiunta quando tutti la penseranno nella stessa maniera su qualunque cosa e il linguaggio, in un certo senso, diverrà inutile. È una situazione, quella che il suo Trattato prospetta, non molto diversa da quella delineata da G. Orwell nel suo romanzo 1984, là dove il "Grande Fratello" ammette di parlare soltanto di ciò che viene consentito e nei termini rigorosamente previsti. Anzi, per maggiore sicurezza e per essere più coerenti, non si dovrebbe parlare di nulla (come nelle comunità trappiste), ma servirsi soltanto di segni e di simboli, il cui significato è stabilito a priori, essendo univoco. E anche nel caso in cui si volesse dire qualcosa, il linguaggio dovrebbe essere così essenziale da dare ad ogni domanda solo due possibili risposte: sì e no, come nel linguaggio binario o come in quel gioco in cui il partecipante, ignaro di tutto, deve indovinare cinque elementi di un delitto che gli altri componenti gli dicono d'avere inventato mentre lui era fuori dall'aula: assassino, vittima, movente, arma e luogo del delitto. A costui infatti viene detto che, per scoprire tutti gli elementi, può fare quante domande vuole, ma solo a condizione che gli altri partecipanti possano rispondere sì, no, non lo so. Alla fine del gioco, quando avrà trovato i cinque elementi, il partecipante resterà malissimo, perché non si sarà accorto che tutti gli altri partecipanti avevano l'obbligo di rispondere sì a tutte le domande che finivano con le vocali chiuse e, i; no alle domande con le vocali aperte a, o; non lo so alle domande che finivano con la vocale u, o con qualsiasi consonante. In tal modo la storia del delitto verrà costruita dallo stesso partecipante ignaro di tutto! Giochi come questi, però, possono essere fatti solo una volta. Invece il Trattato ha in mente qualcosa di definitivo.
Naturalmente si è banalizzato, ma solo per far capire a quali rischi può andare incontro una logica come quella di Wittgenstein, che, non a caso, piacque subito ai neopositivisti di Vienna. Non ci si salva, infatti, da questi rischi paradossali, limitandosi a sostenere che una proposizione ha senso solo se corrisponde alla realtà. Nessuno dei partecipanti al suddetto gioco mentiva quando rispondeva sì, no, non lo so. Anche perché, in fondo, la corrispondenza, di cui parla Wittgenstein, è puramente formale, cioè povera di contenuto. La realtà, quella vera, non esiste nella logica del Trattato.
Se e quando si vuole una certezza univoca, inevitabilmente essa sarà priva di quelle sfumature che rendono così peculiare il linguaggio umano. Quando si afferma che "una proposizione può dire solo come una cosa è, non che cosa essa è" (3.221), si finisce con l'abolire tutte le scienze umane dal novero delle scienze in generale. Tant'è che le Proposizioni n. 3 sembrano indicare una logica grammaticale per le scienze esatte o naturali. Non dimentichiamo che Wittgenstein si mise a studiare, dopo il diploma di maturità, ingegneria aeronautica, cioè fisica e matematica, e solo dopo l'incontro con G. Frege si mise a studiare logica, seguendo le lezioni di B. Russell. Analizzare le Proposizioni n. 3 ha senso solo se vengono viste come una grammatica di base per le scienze esatte. In tal senso bisognerebbe aver chiaro, prima di esaminarle, che tipo di grammatica si pensa sia necessaria per interpretare la realtà.
Se prendiamo infatti una definizione del genere: "Solo la proposizione ha senso; solo nel contesto della proposizione un nome ha significato" (3.3), di primo acchito è impossibile non convenirne. Tutte le grammatiche scolastiche sono impostate in questa maniera. La parola "tavolo", p. es., ha certamente un suo senso a prescindere da qualunque proposizione, ma è solo all'interno di questa che acquista un significato preciso. Non basta dire, per definirlo adeguatamente, che "tavolo" è un sostantivo maschile (in certe lingue è di genere neutro), la cui etimologia rimanda a qualcosa di piatto, ecc. Le forme dei tavoli sono infinite: esistono persino espressioni metaforiche, come "tavolo di lavoro" (in cui si discute p. es. di pace o di diritti), che rendono difficile una definizione univoca.
Il linguaggio non è più chiaro quanto più semplici sono i vocaboli usati. Ogni parola è ambigua di per sé; anzi, quanto meno vocaboli esistono, tanto più è facile che vengano usati per indicare cose molto diverse tra loro. L'elasticità o duttilità delle parole è un vantaggio del linguaggio umano, che così può dire cose diverse usando le stesse parole. E non è affatto vero che un linguaggio diventa tanto più chiaro quante più parole diverse si usano. La complessità quantitativa delle parole è solo un'operazione astratta, intellettualistica: di per sé non serve alla comunicazione.
Nell'Odissea vi è un punto in cui Polifemo chiese a Odisseo (Οδυσσευς - Odusseus) come si chiamava e questi gli rispose usando la parola "Nessuno" (ουδεις - outis) come nome proprio, ma era in realtà il diminutivo del suo nome, che in greco significa anche e appunto "nessuno". Il ciclope non si meravigliò affatto della scelta di questo nome proprio, che evidentemente riteneva del tutto legittimo. Eppure quando chiamò i suoi compagni, dopo essere stato accecato, ed essi gli chiesero chi era stato, egli disse tranquillamente: "Nessuno", senza rendersi conto che i suoi compagni l'avrebbero inteso come pronome indefinito e non come sostantivo. Dunque, una medesima parola - ecco il senso del racconto - poteva essere usata in modi completamente diversi, a dimostrazione che le parole, in sé, a prescindere dal loro contesto di spazio-tempo, non hanno alcun significato preciso. Tutto è ambiguo, tutto è equivocabile, e chi è consapevole di questa prodigiosa facoltà del linguaggio umano, può avere facilmente la meglio su chi invece lo intende in maniera ingenua, senza sottintesi.
Lo stesso racconto ebraico del peccato originale fa risalire ogni cosa a un'interpretazione opposta data a medesime parole. Disse il serpente alla donna: "È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?". E la donna rispose: "Solo del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete". Al che ribatté il serpente: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male".
Ogni parola può quindi essere usata in maniera vera o falsa, oppure - e Wittgenstein lo preferirebbe - in maniera sensata o insensata: "sensata" per ottenere qualcosa di vero o di falso, e, nel caso in cui la soluzione sia falsa, resta sempre sensata, poiché s'è comunque ottenuto qualcosa di reale. Stando infatti alla sua logica, la falsità, connessa a qualcosa di etico, non esiste: nella logica tutto è vero, anche quando si ottiene il falso come soluzione; il falso è solo uno strumento formale per decidere il vero, che resta non meno formale. La coerenza è solo una forma di tecnicismo, un'operazione intellettualistica, dal sapore matematico, che serve solo per far quadrare i conti, ma che non può essere, stricto sensu, applicata alla realtà. D'altra parte applicare una mera coerenza logica alla realtà, dopo averla ottenuta proprio separandosi da questa realtà, potrebbe anche comportare conseguenze letali per l'etica: bisogna dare atto a Wittgenstein di non aver mai tentato un'operazione del genere, benché la trattazione dell'etica in chiave mistica non lo renda immune da un certo irrazionalismo.
Le cose infatti vanno prese per quello che sono, cioè prescindendo dalle intenzioni con cui sono state volute. Solo dagli effetti che procurano si può ragionare sull'opportunità di considerarle vere o false. Solo dopo che il ciclope uscì dalla grotta, i suoi compagni s'accorsero che la parola "nessuno" poteva essere usati in maniera ambigua. A quel punto però - direbbe Wittgenstein - la logica non c'entra più nulla e fa posto all'etica, oppure avrebbe detto che Polifemo si era lasciata ingannare perché non aveva saputo analizzare la parola "nessuno" in tutti i suoi possibili significati logici.
Il punto tuttavia è proprio questo, che la logica di Wittgenstein non serve affatto a trovare la verità delle cose, in quanto ogni cosa, per essa, ha la sua propria "verità": a priori tutte le scelte sono giuste. E' sufficiente aver compiuto il proprio dovere, anzi aver avuto la semplice intenzione di volerlo compiere.
Ma andiamo con ordine. Generalmente è soltanto in maniera molto astratta che i grammatici sostengono che "solo la proposizione ha senso". A guardare le cose d'appresso si dovrebbe invece dire che nessuna proposizione ha, in sé, un senso preciso se non si rapporta a una realtà determinata. Cioè non basta dire che una singola parola ha senso solo all'interno della proposizione che la contiene; anche questa ha senso solo in riferimento alla realtà che la contiene. È la realtà che, in ultima istanza, decide il senso di una proposizione - cosa che però difficilmente una logica formale può tollerare. Non c'è nessuna proposizione che abbia in sé, astrattamente o in maniera aprioristica, un significato univoco, a meno che non ci si voglia riferire a qualcosa dal contenuto poverissimo, di fronte a cui siano possibili soltanto due alternative: sì-no, on-off, acceso-spento, dentro-fuori, ecc.
Naturalmente Wittgenstein non era così sprovveduto da non ritenere possibile che medesimi nomi potessero avere significati diversi a seconda dei contesti semantici usati o che una medesima proposizione potesse subire significati molto diversi sulla base di talune variabili (p. es. di posizione delle parole, di punteggiatura, ecc.). Tuttavia egli aveva la pretesa di definire una logica che evitasse queste ambiguità (che lui considerava perlopiù accidentali e che tanto più andavano evitate quanto più nel linguaggio erano volute).
Per lui "non può mai indicare il carattere comune di due oggetti il designarli con lo stesso segno" (3.322). Di qui la critica a Frege. Questo significa che ogni nome (o meglio classi di nomi) deve avere un segno diverso e quindi un simbolo univoco, che di per sé può anche non avere alcun significato, ma che di sicuro l'acquista all'interno della proposizione. Le espressioni linguistiche vanno soltanto descritte (nel senso della loro correttezza formale), cioè non ci si deve cimentare nella significazione dei suoi singoli elementi (di qui la sua critica a Russell), proprio perché essi sono già stati scelti come univoci. L'importante per Wittgenstein era di creare un linguaggio segnico avente segni diversi per simboli diversi ed evitando che segni uguali venissero usati nella stessa maniera semantica. O, quanto meno (e qui è già costretto a fare ulteriori precisazioni, rendendosi probabilmente conto di dire cose molto restrittive), si sarebbe dovuto distinguere nella proposizione ciò che è essenziale, per la sua comprensione, da ciò che è accidentale. L'essenziale, p. es. nei simboli, indica ciò che essi hanno in comune per un uso analogo, per uno stesso fine (p.es. "~p" è uguale a "non p"). Nel senso che se nell'espressione linguistica vi sono eccezioni, queste devono rientrare in una regola generale. Su questo Wittgenstein era tassativo, essendo consapevole che, in caso contrario, il suo castello di carte sarebbe crollato di fronte alla prima contestazione. L'esempio che riporta della parola "è" è eloquente: "appare quale copula, quale segno di uguaglianza [in matematica] e quale espressione dell'esistenza" (3.323). Usarla nella stessa maniera, cioè con lo stesso segno, in una proposizione non poteva avere alcun senso.
Ora, quale lingua umana potrebbe sottostare a una regola del genere, in grado di sacrificare, in nome della chiarezza, l'economicità dell'alfabeto, dei segni, delle parole a una proliferazione incredibile di segni univoci, capaci di esprimere tutta la complessità del linguaggio umano? Probabilmente avrebbe fatto piacere a Wittgenstein una lingua come quella albanese, che dispone di almeno 27 termini differenti per indicare vari tipi di baffi e altrettanti per designare le sopracciglia.
Wittgenstein non sopportava la "confusione" (e neppure, di conseguenza, l'ironia di certe espressioni linguistiche, come p. es. quella che riporta: "Franco è franco") e addebitava ad essa quelle che lui riteneva le molte insensatezze della filosofia. Nel senso che se non ci si chiarisce preventivamente sull'uso delle parole, è inutile discutere con esse dei massimi sistemi: tanto vale, a questo punto (lo si potrebbe chiosare), assistere a una commedia pirandelliana, in cui l'ambiguità delle parole o delle espressioni è la principale fonte della loro ironia.
Mi chiedo se uno come Wittgenstein sarebbe riuscito a fare le parole crociate, là dove hanno definizioni ambigue del tipo: "L'inizio del percorso", "In fondo alla cantina", "Sono pari nella mano", ecc. Questo perché non solo singole parole possono essere usate ambiguamente, ma in talune proposizioni non vengono usate affatto nei loro molteplici sensi.
A questo punto però le alternative diventano due: o si crea un linguaggio per pochi studiosi (simile p. es. al cinese, che venne usato dagli imperatori proprio per distinguere gli intellettuali dal popolo), oppure si riducono al massimo gli argomenti da discutere o le loro finalità, come avviene appunto nei linguaggi di tipo matematico-informatico. Al di fuori di queste alternative, l'unica concessione (benevola) che si può fare al giovane Wittgenstein riguarda l'idea che, effettivamente, quando uno parla di argomenti elevati, non dovrebbe dare per scontato, solo perché si rivolge a un'utenza che possiede il suo stesso linguaggio, il significato delle espressioni che usa, ma, anche a costo di apparire prolisso, dovrebbe prima spiegare bene come intende usare certe espressioni o parole. La sua dovrebbe essere, per così dire, una preoccupazione pedagogica, da far valere al fine di evitare malintesi nel momento cruciale della soluzione dei problemi.
Ecco, se si esclude tale concessione, che viene fatta a un Wittgenstein che certamente non eccelleva in questo campo, in quanto il suo dire appare qui molto perentorio e criptico (5), è difficile pensare che la teoria del Trattato possa trovare applicazione nelle scienze umane o in campo artistico o in una società democratica. Naturalmente, oltre a tutte le scienze esatte, la logica di Wittgenstein può trovare facile applicazione nei test attitudinali per misurare il quoziente intellettivo, così tanto usati negli Stati Uniti. (6)
Quanto alla democrazia, è indubbio che questa vuole non solo la libertà di pensiero e di parola, ma anche la libertà d'interpretare in maniera opposta un'identica proposizione. È incredibile che un intellettuale veda come un difetto la possibilità di equivocare sul significato delle parole. Wittgenstein ambiva forse a creare un linguaggio militaresco o strettamente burocratico, ad uso dei poteri dominanti? La possibilità d'interpretare in maniera opposta singole parole o espressioni linguistiche è una risorsa cui nessun intellettuale rinuncerebbe in un regime dispotico.
È stata una fortuna per gli editori ch'egli, in tutta la sua vita, abbia pubblicato un unico libro, in quanto avrebbe sicuramente fatto diventare matti i traduttori. Egli infatti era convinto di non essere capito neppure dagli stessi intellettuali che conoscevano la lingua tedesca e che avevano la sua stessa sensibilità per la logica (come p. es. i neopositivisti). Quando decise di accettare la pubblicazione del suo Trattato in inglese, nel 1922, i problemi con i due traduttori, F. P. Ramsey e Ch. K. Ogden, furono enormi, anche perché l'idea di "traduzione" che aveva - stando all'enunciato 4.025 - era a favore della pura e semplice letteralità: cosa però in grado di funzionare solo a fronte di frasi molto semplici, dal significato quasi elementare (L. Wittgenstein, Lettere a C. K. Ogden, ed. Mimesis, Milano-Udine 2009). Questo ovviamente non gli impediva di credere che un testo complicato come il suo non potesse essere tradotto fedelmente in nessun'altra lingua: di qui la richiesta di pubblicare a fianco della traduzione anche l'originale.
L'ultima parte (a partire dall'enunciato 3.4) delle Proposizioni n. 3 è, in un certo senso, la più ambigua, e stranamente, dopo tanta pretesa di chiarezza e di esaustività. Wittgenstein cioè cerca di associare logica a geometria, cioè la proposizione a un luogo fisico, come se volesse far capire che il senso dell'esistenza dipende dal significato delle parole che si usano. Sembra essere preoccupato di aver ecceduto nell'astrazione. "Luogo geometrico e luogo logico concordano nell'essere ambedue la possibilità di un'esistenza" (3.411).
La proposizione logica diventa una sorta di deus ex-machina. Diventa possibile solo ciò che è logico, e ciò che è possibile è anche necessario. L'intellettuale è soddisfatto d'aver trovato la quadratura dei suoi ragionamenti. È appagato dal punto di vista intellettuale, e quindi anche sul piano esistenziale. "Come può l'uomo essere felice - si chiede nei Quaderni 1914-16 - se non può tener lontana la miseria di questo mondo? Mediante la vita di conoscenza. (...) Felice è solo la vita che può rinunciare ai piaceri del mondo. Per essa tutti i piaceri del mondo non sono che grazie del fato" (p. 226). Cioè, posto che, in luogo dell'impegno politico-sociale per risolvere le contraddizioni, è preferibile dedicarsi esclusivamente a un lavoro teorico, sul piano etico è possibile essere "felici" soltanto rinunciando a desiderare ciò che determina quelle stesse contraddizioni.
Ora, nelle proposizioni successive (4, 5, 6) deve soltanto dimostrarlo, anzi mostrarlo concretamente, in quanto l'unica di-mostrazione possibile è tautologica. In fondo, come disse il logico Henry Sheffer, "La Tautologia è Una e Wittgenstein è il suo Profeta!".
PROPOSIZIONI n. 4
Che Wittgenstein sia, a suo modo, un idealista è molto chiaro mettendo a confronto l'enunciato n. 3 con quello n. 4: "L'immagine logica dei fatti è il pensiero"; "Il pensiero è la proposizione munita di senso". Se questo non è un ragionamento idealistico, e quindi tautologico, che cos'è? Non l'aveva già scritta Hegel un'imponente Scienza della logica? A confronto di essa, quella di Wittgenstein appare ben poca cosa. Qual è la differenza fondamentale tra le due logiche? Se Wittgenstein fosse esistito prima di Hegel, questi avrebbe dato alla propria Logica la stessa impostazione? Evidentemente no. Il Trattato non poteva venir fuori che un secolo dopo, che è un tempo sufficiente per tentare di estromettere definitivamente da qualunque logica idealistica tutti quegli aspetti connessi alla mistica cristiana (cosa che poi a Wittgenstein, a motivo del proprio soggettivismo, riuscì solo in parte). Dopo un secolo di materialismo storico-dialettico non sarebbe stato possibile aggiungere qualcosa alla logica hegeliana conservandone l'impianto generale.
E allora che cosa ha fatto Wittgenstein nei confronti di quella logica? L'ha, per così dire, depurata, l'ha filtrata con un setaccio, nella convinzione di poterne conservare l'essenza. Ha fatto un lavoro alchemico, da laboratorio, ottenendo risultati molto particolari, applicabili solo in condizioni molto specifiche. Di quella logica infatti non ha preso i principi della dialettica applicandoli alla realtà sociale in maniera originale, come aveva fatto Marx, ma ne ha preso soltanto uno: il primato del pensiero sulla realtà, e l'ha svolto in maniera tale da offrire un contributo significativo a un aspetto particolare della logica, quello linguistico, che può trovare ulteriori applicazioni nelle scienze esatte e naturali, come p. es. la matematica, l'informatica, la grammatica, la fisica, la chimica, ecc., come una sorta di premessa metodologica fondamentale che ogni scienza deve acquisire per chiarire a se stessa i limiti epistemologici in cui può muoversi.
Wittgenstein è come un discepolo di Hegel con meno pretese, ma anche con la certezza che quella logica idealistica tedesca, nel suo rapporto con la realtà, s'era rivelata particolarmente deficitaria, in quanto non aveva saputo impedire un trend storico favorevole all'antagonismo sociale. Dalla grande illusione e disillusione dell'idealismo oggettivo hegeliano si era passati, dopo un secolo, alla catastrofe della prima guerra mondiale; se si voleva continuare a fare "logica", le alternative erano diventate poche: o si applicavano i principi della dialettica alla realtà sociale e ci s'impegnava concretamente ad abbattere il sistema oppressivo, oppure, se si voleva continuare a restare idealisti, ci si doveva concentrare su un aspetto molto particolare, più favorevole alla scienza che non alla filosofia, lontano da questioni etico-religiose e politico-sociali, anzi più vicino, sul piano etico, a posizioni soggettivistiche e relativistiche, mentre su quello intellettuale la tensione doveva essere volta a cercare una coerenza linguistica formale sul significato (quasi etimologico) delle parole e delle espressioni che si usano.
Altre soluzioni che vennero usate, non influenzarono per nulla la filosofia di Wittgenstein: lo storicismo crociano (una sorta di idealismo oggettivo applicato alla storia) e l'attualismo gentiliano (una sorta di traduzione totalitaria dell'hegeliana Filosofia del diritto), per quanto sarebbe interessante trovare dei paralleli tra tutte queste forme d'idealismo estremo. I principi di fondo che giustificano, in maniera idealistica, la "Storia crociana" e lo "Stato gentiliano" sembrano avere una strana somiglianza con quelli della Logica del Trattato.
Un'altra alternativa sarà quella heideggeriana, cioè il tentativo di fare del soggetto umano la chiave di volta per una nuova metafisica. Su questo aspetto il secondo Wittgenstein darà contributi significativi, sempre però all'interno della problematica del linguaggio, che sino alla fine della sua vita rimarrà il suo interesse prevalente.
* * *
Che il pensiero sia, in sé, una proposizione munita di senso, può dirlo giusto un grammatico, poiché una persona normale direbbe subito "dipende", dipende cioè dal significato che si dà alla parola "senso". Quanti discorsi, apparentemente logici, risultano, di fatto, del tutto insensati? Non si può dire invece il contrario, altrimenti i servizi di sicurezza non darebbero alcun peso ai codici cifrati. Il fatto è che, quando si sbaglia la premessa con cui definire una logica sensata, tutto il resto viene di conseguenza.
Sostenere che il pensiero è una proposizione munita di senso è come dire alla psicanalisi freudiana che non serve a nulla cercare di capire qualcosa di sensato dai sogni o dai lapsus verbali o da altri atti inconsci che, pur nella loro apparente illogicità, non sono affatto insensati, anzi rimandano a verità ancora più profonde di quelle di cui normalmente ci occupiamo, così profonde che spesso non siamo disposti ad ammetterle con disinvoltura. Sotto questo aspetto Wittgenstein sarebbe stato un pessimo analista, anche se usò la propria logica come una sorta di terapia: ad ogni più piccola ammissione da parte del paziente, l'avrebbe subissato di domande, chiedendogli di specificare il senso preciso di ogni singola parola, senza rendersi conto che, così facendo, sottraeva a se stesso il compito per cui veniva pagato dal paziente in cura. D'altra parte la psicologia non gli interessava affatto sul piano logico (cfr 4.1121), con non interessava a Frege e a Russell.
Cerchiamo di spiegarci meglio, poiché Wittgenstein non era così stupido da identificare linguaggio e pensiero. "Il linguaggio traveste il pensiero. Lo traveste in modo tale che dalla forma esteriore dell'abito non si può inferire la forma del pensiero rivestito" (4.002). Per lui il pensiero è più profondo del linguaggio, e questo, il più delle volte, non è in grado di adeguarsi al pensiero. Qui Wittgenstein ambisce a produrre una filosofia del linguaggio adatta a comprendere la logicità del pensiero. Egli vede l'uomo come un "essere pensante" che, invece di esprimersi fluentemente e con sensatezza, balbetta parole perlopiù incomprensibili. Ecco perché dichiara di non avere intenzione di affrontare alcun classico argomento filosofico, se prima non ci si chiarisce sul significato delle parole che si usano. Qui vien quasi da sorridere al pensare che se una ragazza, innamorata di lui, gli avesse detto: "Ti voglio bene", lui si sarebbe sentito indotto a chiederle anzitutto di precisare la parola "bene". Non avrebbe accettato che, in una situazione emotiva, si desse per scontato il significato di certe espressioni. Nei film di fantascienza quando un robot è costretto ad affrontare situazioni emotive, in genere va in cortocircuito, oppure si ribella a chi l'ha costruito.
Discutere, in via preliminare, di logica significa per il giovane Wittgenstein non preoccuparsi neppure se l'affronto di questo o quel problema sia corretto o sbagliato, vero o falso, ma significa chiedersi se davvero un determinato problema possa essere definito tale sul piano della logica. Se avesse dovuto scrivere un dizionario per adulti e non, come quello che fece, per bambini, avrebbe probabilmente usato un milione di parole diverse, senza però che con nessuna di esse si potesse affrontare un argomento non strettamente scientifico. Infatti per lui era la scelta esatta dei termini che giustificava la scelta dell'argomento da affrontare. A questo punto sarebbe stato quasi meglio dotarsi di un alfabeto pittografico, come quello egizio, i cui singoli segni rappresentavano molto fedelmente (seppur in maniera simbolica o stilizzata) l'oggetto di riferimento.
Wittgenstein apprezzava molto l'ideografia di Frege e Russell (3.325), posta a fondamento della matematica e della logica formale, anche se non la riteneva esente da grossolani errori. E nell'asserzione 4.016 non disprezza la "grafia geroglifica", benché, in un certo senso, dica una sciocchezza quando nello stesso enunciato sostiene che la "grafia alfabetica" sia nata da quella geroglifica, "senza perdere l'essenziale della raffigurazione". Lo spiega subito dopo: "Lo vediamo dal fatto che comprendiamo il senso del segno proposizionale senza che quel senso ci sia stato spiegato" (4.02). In realtà era proprio questa cosa che non si poteva fare leggendo i geroglifici egizi. Ecco perché a noi, abituati, sin dal tempo dei Fenici, a separare il contenuto dalla forma, i geroglifici sono apparsi del tutto incomprensibili per molti secoli. L'alfabeto geroglifico non ha affatto determinato quello che usiamo oggi: se un passaggio vi è stato, occorre vederlo verso il linguaggio iconografico dei bizantini o verso quello segnaletico delle nostre strade urbane. Neppure quelli semplici come l'alfabeto Morse o i segnali di fumo degli indiani d'America o quello delle bandierine o dei lampeggiamenti della marina possono derivare dai geroglifici, anche se essi si prestano magnificamente alla logica di Wittgenstein.
Persino quando parla di musica, egli si compiace ch'essa sia simile alla matematica e quasi vorrebbe ch'essa si producesse da sola, sulla base di una notevole serie di combinazioni di note. Tutte le sinfonie di tutti i musicisti del mondo sono già incluse nella tastiera del pianoforte: per creare un capolavoro si tratterebbe soltanto di produrre equazioni. In fondo è questa la "legge della proiezione" di cui parla nell'enunciato 4.0141. "La possibilità di tutte le similitudini, di tutta la figuratività del nostro modo d'espressione, risiede nella logica della raffigurazione" (4.015). Cioè la musica dipende dalla matematica e l'arte che non dipende dalla logica rischia l'insensatezza, esattamente come l'etica, la religione, la filosofia, la psicologia, ecc.
La logica della raffigurazione o della proiezione sta nel fatto che "la proposizione è un'immagine della realtà: infatti, io conosco la situazione da essa rappresentata se comprendo la proposizione. E la proposizione io la comprendo senza che mi si sia spiegato il senso di essa" (4.021).
Come si può facilmente vedere vi sono, nella logica di Wittgenstein, due momenti fondamentali per comprendere la realtà: uno soggettivo, l'altro oggettivo. Col primo la realtà viene compresa oggettivamente se il soggetto formula o comprende adeguatamente la proposizione che la rappresenta in maniera veridica; col secondo il soggetto presume d'essere oggettivo, in quanto non ha bisogno, soggettivamente, di comprendere il significato dei singoli componenti della proposizione (siano essi segni o simboli). Per comprendere la realtà non occorre calarsi in essa, affrontandone le contraddizioni, scoprendone i valori, ma la prima cosa da fare è quella di pre-definire scientificamente gli strumenti linguistici con cui interpretarla. Se non è idealismo questo, che cos'è? Wittgenstein è come un antropologo o un etnologo che si mette a studiare le forme comunicative di tipo logico di una comunità primitiva, presumendo di poter restare antropologo, senza cioè calarsi in uno stile di vita completamente diverso dal proprio. Inevitabilmente finirà con l'attribuire un senso logico alle forme espressive di quella comunità solo nella misura in cui esso si avvicinerà di più al nostro modo di ragionare, e questo, nonostante tutti gli sforzi che egli faccia d'inglobare la negatività nella positività. Gli ci vorranno non pochi anni prima di capire che questo modo di fare era completamente sbagliato.
Quando uno afferma che "la proposizione mostra il suo senso", cioè "come le cose stanno... E dice che le cose stanno così" (4.022), non sta forse facendo della tautologia? Solipsismo e tautologia sono i due gemelli inseparabili della logica del Trattato. Un discorso del genere potrebbe astrattamente essere giusto se si partisse non dal pensiero ma dalla realtà, la quale però va colta, anche logicamente, nei suoi aspetti contraddittori, di cui quelli antagonistici sono i primi a dover essere affrontati e risolti. Se non si pone il bisogno come presupposto fondamentale di ogni logica, anche le cose che più si pretendono inequivoche, diventano terribilmente ambigue. L'utilità di una qualunque logica che prescinda dal bisogno finisce col giustificare il sistema che produce bisogni senza volerli o saperli risolvere. Cioè proprio mentre pretende d'essere "sensata", la logica apologizza l'insensatezza del sistema cui inevitabilmente appartiene o a cui è costretta a fare riferimento.
Wittgenstein dice chiaramente che la sensatezza di una proposizione è tanto più forte quanto più essa è connessa alla realtà (4.03). Ma sulla modalità di questa connessione non dice nulla di significativo, proprio perché il concetto che ha di realtà è del tutto astratto, ipostatizzato, cioè posto a prescindere dal suo contenuto effettivo.
Certo, in teoria Wittgenstein può anche sostenere che non si possono fare confronti di veridicità tra due proposizioni opposte, ossia che entrambe possono essere vere se vengono prese come immagini di realtà differenti. Ma nei fatti questa posizione è solo apparentemente equidistante. Non partendo dalla realtà (coi suoi bisogni e le sue contraddizioni), se si mettono due proposizioni opposte sullo stesso piano di verità, una a favore del sistema dominante, l'altra no, a quale delle due, in ultima istanza, si dovrà per forza dare maggior credito? All'immagine che possiede tutti i mezzi necessari per esprimersi nel migliore dei modi, proprio perché riflette il sistema dominante, o a quella che vive ai margini e che, invece di avere le luci della ribalta, è illuminata da una candela? È una pura illusione quella di pensare che una proposizione possa prevalere su un'altra au fur et à mesure in cui manifesta la propria sensatezza.
Non è soltanto con la "verità" che si crea consenso, ma anche e soprattutto condividendo praticamente il bisogno e facendo di questo il principale motivo di contestazione del sistema. È la gestione collettiva del bisogno che dà corpo alla verità. Al di fuori di questo presupposto, qualunque discorso logico è autoreferenziale, incentrato soltanto su di sé, autistico, se si vuole, e non lo renderà certamente più obiettivo il ricorso sistematico alla matematica o alle scienze esatte e naturali.
Detto altrimenti, un enunciato del genere: "La proposizione può essere vera o falsa solo in quanto immagine della realtà" (4.06), è quanto di più ambiguo vi sia, poiché non viene detto nulla in merito alla "realtà". Se si prende la realtà così com'è e si pensa che di essa si possano modificare singoli aspetti, lasciando integro l'insieme che la costituisce, è evidente che la proposizione vera non sarà quella che mette in luce gli antagonismi irriducibili, ma, eventualmente, quella che li ritiene tutti componibili.
Wittgenstein ha sempre sostenuto che non esiste un'immagine della realtà vera in modo aprioristico, ma se si afferma che "la proposizione può essere vera o falsa solo in quanto immagine della realtà", e di questa realtà non si dice nulla, l'apriorismo è inevitabile. Che poi si voglia sostenere che una proposizione resta vera anche quando ammette situazioni reali contraddittorie, non cambia nulla: non si esce dall'idealismo. Né vi si esce dicendo che "la filosofia è non una dottrina, ma un'attività" (4.112). Certo, non sarà un idealismo nel senso classico del termine (quello per il quale la metafisica doveva prevalere su tutto), ma resta tale anche quando si sostiene che "lo scopo della filosofia è il rischiaramento logico dei pensieri" (4.112). Che la filosofia debba diventare quello strumento conoscitivo che, essendo indipendente dai fatti, permette, sul piano metodologico, alle altre discipline di darsi uno statuto scientifico, non era forse anche l'obiettivo, illusorio, dell'idealismo tedesco di un secolo prima?
Wittgenstein certamente conviene sul fatto che la realtà contraddittoria può apparire insensata, ma è anche convinto che tale insensatezza venga risolta facendo della negatività un aspetto positivo, appartenente alla realtà, lasciando impregiudicato il carattere vero o falso di questa negatività. La macchia nera sul foglio bianco non rappresenta la negatività, in quanto fa parte di una realtà che va presa così com'è (cfr 4.063). Infatti "La proposizione rappresenta il sussistere e non sussistere degli stati di cose" (4.1). Cioè anche se la logica non vuole esprimere giudizi di valore sulla realtà, limitandosi a stabilire la verità sulla base dei giudizi di fatto (il "sussistere" e "non sussistere" degli stati di cose), il modo di procedere è idealistico. Così come lo era quello di Marx Weber, che, in questo, gli assomiglia.
Il fatto di aver voluto togliere all'idealismo il suo carattere mistico o le sue pretese metafisiche, non è certo stato sufficiente per uscire in maniera definitiva da tutte le paludi idealistiche, a causa delle quali è letteralmente impossibile risolvere le contraddizioni portanti del sistema. L'idealismo di Wittgenstein, dopo le ripetute sconfitte della democrazia politica nel corso dell'Ottocento, dopo l'incompiutezza dell'idea di democrazia sociale in Europa, che ha portato alla catastrofe della prima guerra mondiale, doveva per forza abbassare le pretese dell'idealismo in generale, circoscrivendo il proprio ingenuo ottimismo ad un'attività più ristretta, volta a dare un semplice sostegno euristico alle scienze esatte e naturali, per le quali la coerenza fra teoria e prassi è più facilmente alla portata di mano (proprio perché dell'intelletto non della ragione, direbbe Hegel).
La logica filosofica di Wittgenstein vuol fare da supporto metodologico a scienze che, per tradizione, tendono a non fare voli pindarici, a non promettere rivoluzioni sociali e politiche, anche se, nella pratica, contribuiscono comunque a modificare la realtà. La trasformazione tecnologica che perseguono ha bisogno di darsi - nell'idea di fondo del suo Trattato - un'intelligenza logica, proprio per impedire - aggiungiamo noi - che le contraddizioni sociali possano nuocere a tale trasformazione progressiva (riformistica) della realtà.
Ecco perché la logica - secondo Wittgenstein - deve servire per attribuire il giusto spazio in cui una scienza esatta o naturale può muoversi, riducendo le pretese di onnicomprensibilità che spesso le scienze ambiscono ad avere. Vi sono aspetti "indicibili" e persino "impensabili" cui ogni scienza dovrebbe attenersi (cfr 4.113-116). E non è possibile attribuire a una scienza esatta o naturale più importanza che a un'altra (4.1122).
Wittgenstein sembrava voler contribuire indirettamente allo sviluppo della democrazia politica, favorendo una sorta di "democrazia culturale" in campo scientifico, evitando posizioni ideologiche e mantenendosi su un piano di "sana laicità". D'altra parte la stessa logica, in generale, ha ben consapevoli i propri limiti, per cui, se anche le altre scienze volessero adottarne i principi di fondo, possono stare tranquille ch'essa non cercherà mai di prevaricare, insegnando a loro, per così dire, il mestiere. La logica non vuole trasformarsi in una nuova teologia e non vuole svolgere i compiti della passata metafisica.
I limiti della logica è lui stesso che li presenta. E qui dobbiamo dire che la somiglianza col Kant della prima Critica è notevole, per quanto egli non faccia cenno di questo filosofo, se non in maniera molto marginale. Entrambe le logiche, infatti, vogliono porsi come premessa critica di fattibilità di un qualunque discorso scientifico. Diciamo che Wittgenstein non ha bisogno di ripetere l'iter kantiano con cui s'era dimostrato che né la teologia né la metafisica potevano ambire a dirsi scientifiche. Egli, di suo, aggiunge che il linguaggio non può "dimostrare" la verità dei propri asserti: può soltanto "mostrarla".
La logica astratta della realtà può essere spiegata in maniera formale, cioè prendendo in esame le proprietà, le relazioni, le strutture formali tra gli oggetti o gli stati di cose, ma non può spiegare il motivo per cui un dato oggetto è vero o falso: ne prende atto e cerca di spiegarselo. Punto. Per poter stabilire con sicurezza la verità o la falsità di una realtà, il soggetto dovrebbe porsi al di fuori del mondo - sostiene Wittgenstein -, guardando la storia come un fatto compiuto e non in divenire (cfr 4.12-4.122). Con ciò egli ribadisce, pur senza volerlo e pur riducendola al minimo, la propria posizione idealistica. Infatti è come se dicesse: dopo la catastrofe della prima guerra mondiale non è più possibile stabilire con sicurezza dove sussista la verità delle cose; limitiamoci quindi a cercare una sensatezza tra le nostre parole e la realtà, evitando pretese assolutistiche, prendendo atto che esistono, nella realtà, determinati nessi tra stati di cose contraddittori.
Tuttavia di questi nessi Wittgenstein non dice nulla. I nessi vanno interpretati secondo la logica formale, per cui all'uomo comune essi appariranno del tutto astratti, anzi astrusi, oppure del tutto banali, rispetto alla complessità dell'esistenza. Se ciò che viene "mostrato" non può essere "spiegato", se non in maniera formale, questo auto-limite che Wittgenstein si pone, è sconfortante, proprio perché se la vita ha un senso, la verità di questo senso non possiamo coglierla che in maniera superficiale o formale, cercando di trovare, astrattamente, le parole più giuste o meno sbagliate per interpretarla. Se esiste una correttezza formale tra pensiero, linguaggio e realtà, la speranza è quella che non si compiano, a motivo delle nostre ambiguità o insensatezze, errori gravi o tragici di cui pentirsi. Bisogna solo abituarsi a essere precisi nelle parole che si usano, onde evitare inutili o pericolosi malintesi.
Possiamo anche guardare la cosa da un altro punto di vista. Come dicevamo, Wittgenstein è arrivato a dire che nulla può essere dimostrato, ma solo "mostrato". La verità è un'evidenza che non si può dire, nel senso di "dimostrare": la si deve accettare appunto come una tautologia. Tuttavia se questo ragionamento fosse vero, egli avrebbe teorizzato, paradossalmente, la fine del linguaggio, cioè la necessità di vivere un'esperienza in cui il linguaggio si limita a "mostrare" ciò che essa è. È realistica questa prospettiva? Davvero di un'esperienza noi possiamo dire se è vera o falsa semplicemente osservandola per quello che essa è o per quello che dice di essere o che mostra di essere? Possiamo accontentarci di dire che una qualunque esperienza di vita comunque è, a prescindere dai suoi valori? O dovremmo forse arrivare a dire che probabilmente non c'è nulla a questo mondo che riesca a mostrarsi per quello che è, ovvero che non riuscirebbe a farlo neppure se lo volesse, neppure se fosse pienamente consapevole di quello che è? Esiste forse un'identità così autosufficiente da potersi autoidentificare senza il concorso dell'identità altrui? Davvero le istituzioni sono convinte di poter identificare qualcuno semplicemente chiedendogli di mostrare un documento di riconoscimento?
L'identità di sé non può mai essere data in maniera autoreferenziale, senza mostrarla nella sua strutturale interconnessione con l'identità altrui. Ecco perché è necessario affermare che il singolo, al di fuori di un collettivo di appartenenza, è una mera astrazione, e tutti gli sforzi che fa questo singolo per autodefinirsi sono solo una perdita di tempo.
In tal senso andrebbero riletti due episodi evangelici. Nel primo vengono a riferire a Gesù che, al di fuori del suo collettivo di appartenenza, vi erano i suoi parenti che l'aspettavano per riportarlo a casa. E quello risponde, come se agli astanti apparisse un alieno: "Chi sono i miei parenti? Ecco - rivolgendo lo sguardo al proprio collettivo - questi sono i miei parenti!". In tal modo faceva capire che il concetto di identità non può essere dato neppure in maniera naturale, ma solo in maniera sociale. In un lampo veniva distrutto il concetto di "famiglia" o se ne ridimensionava di molto il ruolo sociale. I rapporti naturali sono spontanei, soggetti a leggi di natura, ma l'identità è cosa consapevole, che si acquisisce da adulti. Ecco perché se la famiglia si pone in antitesi a un collettivo sociale, è anch'essa un'astrazione. Quando si usano i familiari come arma di ricatto per indurre il proprio avversario a cedere, bisogna resistere, confidando appunto nel fatto che tradire i propri compagni e mille volte peggio che rinunciare ai propri familiari.
L'altro episodio evangelico è quello che pone un collettivo socio-politico contro un altro collettivo analogo, ed è ben espresso dalla domanda che Gesù rivolge ai propri apostoli: "La gente chi dice che io sia?". E ogni gruppo aveva la sua risposta e nessuno quella giusta. E la confusione non era solo tra i suoi familiari, che lo consideravano "pazzo", ma anche tra i suoi discepoli, molti dei quali, non avendo ancora capito il concetto di democrazia, gli chiedevano di compiere un atto di forza alla stregua del Davide dittatore. Tuttavia, se del giudizio dei parenti stretti non si preoccupa affatto, non così nei confronti del giudizio degli altri partiti e movimenti politici, poiché è con questi che deve cercare un'intesa eversiva contro Roma. Non basta dunque sapere quel che si è; bisogna anche che questa consapevolezza trovi un punto di mediazione sul concetto di "liberazione" che hanno gli altri.
Ci siamo qui indubbiamente allargati, ma lo scopo era quello di vedere, con parole molto semplici, se nella filosofia di Wittgenstein possono esserci, di riflesso, sul piano politico, aspetti per noi significativi. Tuttavia, nonostante gli sforzi che si possono fare, non bisogna mai dimenticare ch'egli, nella prima fase del suo pensiero, non accettava affatto l'uso equivoco o indeterminato delle parole come parte costitutiva dell'essere umano. Nella sua pretesa di chiarezza cristallina, relativamente al modo come l'uomo deve esprimersi, vi è in lui un'ingenuità disarmante, un'immaturità di tipo adolescenziale, che si traduce, in definitiva, in una resa quasi incondizionata alla logica dell'interesse, che è indubbiamente quella dominante nelle società antagonistiche (la logica che sfrutta l'ambiguità delle parole per mistificare la realtà delle cose, la loro coerenza interna).
Wittgenstein ha voluto togliere alla logica ogni pretesa ideo-logica (cioè ogni impatto diretto sulla realtà) e, quando parla di ideo-grafia, intende qualcosa di assolutamente "neutrale", che non va a sindacare se una realtà extra-logica è vera o falsa. Egli cioè non si serve della logica per dire, p.es., che un qualunque discorso religioso è una falsità (come invece faceva Russell). La sua logica non si misura con la verità o falsità dei fatti concreti, ma sulla fondatezza della corrispondenza logico-formale tra enunciato e realtà (per cui anche una religione può essere vera), anzi, prima ancora, si fonda sulla coerenza interna degli enunciati, da cui quella corrispondenza dipende.
La proposizione, infatti, resta sempre più importante della realtà. In un certo senso si potrebbe addirittura dire che la proposizione costruisce la realtà, per cui ciò che è al di fuori di una certa logica, non sussiste. Come quando si fanno ricerche coi motori telematici. L'algoritmo più potente è risultato quello di Google: ora, può sussistere qualcosa che non sia indicizzato da questo motore? Non solo, ma anche se, su una determinata parola, tutto il web fosse indicizzato, sussisterebbe forse qualcosa di "significativo" dopo le prime dieci pagine che il motore offre come report? Stessa cosa vale per le trasmissioni televisive, la cui esistenza dipende non dai contenuti in sé ma dal calcolo percentuale degli ascolti. Gli stessi contenuti, per potersi trasmettere, devono sottostare a regole logiche abbastanza precise. Esistono regole persino sulla manipolazione delle immagini. Se avesse potuto vivere un altro mezzo secolo, probabilmente Wittgenstein sarebbe diventato un ingegnere informatico o si sarebbe comunque dedicato a formalizzare una comunicazione multimediale la più possibile corretta, efficace, funzionale. Sono noti i suoi interessi per il colore e il suono.
Egli era convinto che, avendo posto condizioni molto restrittive per qualificare "sensata" una proposizione, sarebbe stato difficile a una realtà irrazionale sostenere logicamente la propria insensatezza. Se s'impongono, in maniera risoluta, regole di gioco molto semplici e chiare, tutti i giocatori, anche i più riottosi, saranno indotti ad applicarle senza discutere (solo una scienza esatta può svilupparsi all'infinito). Il problema semmai è un altro: chi fa applicare queste regole? Un arbitro scelto da tutti i giocatori o imposto da un'autorità superiore? Nel Trattato Wittgenstein non risponde a queste domande. Pone soltanto le condizioni per cui, ad un certo punto, si arrivi a considerarle come inevitabili.
In tal senso lo schema che dà all'enunciato 4.31 sarebbe molto interessante verificarlo in rapporto a condizioni sociali, politiche o addirittura storiche. Si noti anzitutto che le otto possibilità di verità delle proposizioni elementari ne includono quattro il cui risultato è falso. La logica vuol prescindere dall'etica, per cui se due condizioni p e q sono entrambe vere, possono dare come risultato V o F. Ciò, se i logici l'accettano tranquillamente sul piano formale, può apparire abbastanza sconcertante nella vita reale. Come d'altra parte che da due condizioni false possa scaturire un risultato vero. Però sarebbe bene che gli storici adottassero questo schema: i politici, p. es., abituati come sono a cercare compromessi e a salvare le loro poltrone, lo fanno con più dimestichezza, anche se a volte si fissano su certe caratterizzazioni ideologiche, finendo col perdere la necessaria duttilità.
Non è tuttavia da escludere che lo schema possa funzionare adeguatamente anche sul piano etico. Chiederlo però a un logico, così abituato a ragionare in termini matematici, forse è un po' troppo. Proviamo dunque noi a vedere se lo schema può servire a interpretare l'esempio di un mendicante che chiede la carità: si è messo in un punto strategico, in modo tale che non può non essere visto. La variabile p (VF) è la prima colonna e riguarda lui; quella q (VF) è la seconda colonna e riguarda i passanti. Vediamo ora tutte le otto combinazioni comportamentali e il risultato che danno nella terza colonna.
V-V=V (è veramente un mendicante, i passanti hanno cuore e lui è soddisfatto
di ciò che, in quella giornata, ha ottenuto da loro e loro di ciò che gli
hanno dato);
F-V=V (non è un vero mendicante, ma i passanti si commuovono lo stesso, che
sappiano o no come stanno le cose, per cui lui è contento di ciò che ha
guadagnato e loro di ciò che gli hanno offerto);
V-F=V (è un vero mendicante, ma pochi ci credono o si commuovono; lui però
si accontenta lo stesso del poco che gli danno);
V-V=F (è un vero mendicante e la gente si commuove; tuttavia, nonostante le
offerte generose, la mendicanza è rimasta, per cui il mendicante è scontento
e lo sono anche i passanti);
F-F=V (non è un vero mendicante e la gente, che lo sa, non si lascia
commuovere, per cui il fatto di non ricevere nulla non può essere
considerato negativo);
F-V=F (è un falso mendicante, ma la gente, pur sapendolo, gli fa comunque
l'offerta, contribuendo così al perpetuarsi della falsità del suo
atteggiamento);
V-F=F (è un vero mendicante, ma i passanti non si commuovono, sicché l'etica
non trae alcun beneficio);
F-F=F (è un falso mendicante e i passanti lo ignorano e nessuno si chiede
perché stia lì a mendicare).
Ora, quale potrebbe essere il nostro atteggiamento se incontrassimo un mendicante? Esiste forse un'ulteriore possibilità non prevista da questo schema? In ogni caso il più resta ancora da fare e qui la logica è del tutto impotente. Si tratta cioè di analizzare la situazione dal punto di vista sociale e persino psicologico, altrimenti ci si ferma a una pura e semplice elencazione di possibilità. Quando si vedono i giovani mendicare, quando il concetto di "mendicanza" è realizzato attraverso un call-center o un sistema "porta-a-porta" per carpire la firma su un contratto, non ci si può non chiedere se chi sta mendicando sia in buona o in malafede o se la società in cui tutti si vive abbia davvero un senso e se abbiamo i mezzi e i modi per superare situazioni così eticamente riprovevoli. A che serve la logica se si limita a descrivere la realtà? Ci si deve accontentare di tautologie (che per Wittgenstein sono sempre vere, se ben formulate)? O dobbiamo piuttosto valorizzare le contraddizioni (che per Wittgenstein sono sì vere ma in senso del tutto formale)? È sufficiente criticare Frege e Russell da un punto di vista meramente logico?
Non è curioso che per Wittgenstein l'identità venga qualificata come "tautologica"? Tautologia significa autoreferenzialità, cioè distacco dalla realtà, che è contraddittoria; ci si distacca arbitrariamente dalla società, per poi dire che la coerenza sta in questa separazione. Non si fa dell'affronto della contraddizione il principale modo di caratterizzazione della verità, ma il principale ostacolo alla coerenza. Che cos'è questa se non una forma di idealismo? Mettere sullo stesso piano la tautologia con la contraddizione, come il bene col male, il vero col falso, è duro da accettare, anche perché, generalmente, se c'è una cosa vera, che non può essere formalizzata in uno schema meramente logico, questa è proprio la contraddizione.
Negli enunciati del gruppo 4 Wittgenstein s'è già distaccato completamente dalla realtà. I suoi criteri di verità e di falsità sono del tutto formali: sono già un "gioco linguistico", benché questa espressione la userà nella sua seconda fase per trasformare la sua logica da rigida a flessibile. Una persona comune facilmente arriverebbe a sostenere che le posizioni tautologiche vengono in genere usate per mistificare quelle contraddittorie. Se io dico: "una sedia è una sedia e un tavolo è un tavolo", impongo a chi mi ascolta ad usare quei due oggetti diversi in maniera sempre diversa, quando invece il loro uso è sempre relativo a circostanze di spazio-tempo e di tipologia umana (per dei bambini, p. es., anche una sedia può far le veci di un tavolo). Se non permettiamo alla contraddizione tutta la dialetticità possibile, il pensiero inevitabilmente s'impoverisce. Non è vero che la tautologia "non sta in alcuna relazione di rappresentazione con la realtà" (4.462). Tutti i regimi dittatoriali sono tautologici! Tant'è che tutti negano la contraddizione o la travisano a bella posta. Ed è singolare che un logico così aperto alla comunicazione, così esperto in filosofia del linguaggio, parteggi per la tautologia, considerando certa la sua verità proprio in quanto non dimostrabile.
A dir il vero ci sono dei momenti in cui Wittgenstein si sforza di considerare tautologia e contraddizione come due forme di "casi-limite" (una sorta di egocentrismo assoluto, da cui non si può ricavare nulla, se non appunto la verità di tutte le altre opzioni che stanno in mezzo a questi due limiti). Mettendo a confronto tautologia, proposizione e contraddizione, egli afferma esplicitamente che la soluzione migliore è quella della proposizione argomentativa, che permette appunto di accettare una verità dimostrata, razionale, mentre le altre due opzioni estreme o la danno per certa o per impossibile in maniera scontata.
Tuttavia, alla prova dei fatti, negando consistenza reale alla contraddizione, ovvero accettandola solo come strumento formale della logica, Wittgenstein finisce, inevitabilmente, su posizioni tautologiche, che peraltro risultano essere le più coerenti a quelle solipsistiche, tant'è che la forma generale della proposizione, da lui scelta, è tipicamente autoreferenziale: "E' così e così" (4.5). Sarebbe stato più naturale scrivere, rapportandosi alla realtà: "E' così, quando non è altrimenti". Questo perché il criterio della verità, in ultima istanza, non lo dà la teoria ma la pratica, coi suoi bisogni. L'essere umano è un ente di natura assolutamente pieno di bisogni, cui deve cercare di dare soddisfazione, e la contraddizione è la prova che deve superare. Chi si sottrae a questo compito, rifugiandosi nel proprio individualismo, inevitabilmente ragiona in maniera tautologica e questa può anche portare alla follia.
Quando, in 5.101, riporta lo schema di tutte le funzioni o fondamenti di verità di ogni possibile proposizione elementare del tipo "se..., allora...", Wittgenstein mette la tautologia al primo posto e la contraddizione in ultimo. Per lui sono tutte "funzioni di verità", anche quelle che la danno per scontata o la rendono impossibile. Tutto diventa assolutamente relativo, il che però è una contraddizione in termini, in quanto nessuna "relatività" può essere "assoluta".
Sostenere che "tutte le proposizioni sono generalizzazioni delle proposizioni elementari" (4.52) è tautologico, in quanto non è affatto vero che la verità del complesso sta nella scomposizione dei suoi elementi semplici. La verità di un tavolo non sta nel legno di cui è fatto. Se proprio volessimo scomporlo, scientificamente, nei suoi elementi costitutivi (lasciando perdere, per un momento, le sue funzioni operative), dovremmo quanto meno ripercorrere, a ritroso, l'iter del legno lavorato e vedere da quale albero è stato ricavato e in che maniera è stato realizzato. E forse dietro un semplice tavolo scopriremmo rapporti coloniali vergognosi, rapporti di sfruttamento economico e di devastazione ambientale. Se proprio vogliamo scrivere di logica riguardo a un tavolo, facciamolo sino in fondo, cioè sino al punto in cui lo stesso tavolo diventa argomento della nostra logica, sino al punto in cui arriviamo a chiederci se era davvero così indispensabile abbattere gli alberi che lo compongono per trattare un argomento del genere, ovvero trattare un argomento così astratto, quando, concretamente, i mezzi che ci permettono di farlo sono stati estorti con la forza, con una forza tale che impediscono ai proprietari dell'albero di parlare dello stesso argomento.
Di sicuro non arriveremmo a dire, concludendo il nostro discorso, che "la proposizione elementare è una funzione di verità di se stessa" (5). Non c'è nulla su questo pianeta che sia "funzione di verità di se stesso", neppure compiendo un'astrazione tale che ci porti fuori di esso. La logica del primo Wittgenstein è solo una gigantesca illusione, come è illusorio pensare che il socialismo, per nascere, abbia bisogno delle forze produttive del capitalismo, o che le transizioni da una formazione sociale a un'altra siano avvenute sulla base della sola categoria della "necessità". La necessità ha senso solo dopo che sono state operate determinate scelte, non prima. L'esigenza di operare delle scelte di campo può essere dettata dalla necessità, ma non esiste una necessità che obblighi a prendere determinate decisioni, anche se le decisioni comportano, a loro volta, delle necessità. Se le decisioni sono necessarie, non c'è scelta.
Peraltro non è neppure vero sul piano grammaticale che il senso di una proposizione sia determinato dagli elementi semplici che la compongono. Questo modo di ragionare è puramente tecnicistico e non corrisponde alla realtà. Non è la sintassi che spiega il senso della proposizione, se non appunto in maniera formale, come quando si fa l'analisi logica e grammaticale. Una sintassi senza semantica produce affermazioni che spesso non hanno alcun riscontro con la realtà. Se io dico "Questo libro di logica sul tavolo non ha senso", non riesco a capire, sintatticamente, se esso non ha senso perché sta sul tavolo o perché tratta l'argomento della logica in maniera insensata. Non esiste testo (sensato!) senza contesto semantico di riferimento (che è sempre di spazio-tempo).
PROPOSIZIONI n. 5
Se quanto sostiene Wittgenstein in merito alle "funzioni di verità", di cui parla dall'enunciato 5.1 in avanti, fosse così semplice, noi oggi, a distanza di mezzo secolo dalla sua morte, dovremmo avere dei traduttori simultanei perfetti da una lingua all'altra, dovremmo altresì avere dei linguaggi informatici interpretabili in maniera univoca dai motori di ricerca. Invece il linguaggio umano resta ancora incredibilmente complicato: ci danniamo di fronte alle ambiguità, perdiamo la testa a decifrarle o a racchiuderle in camicie di forza, oppure occupiamo il nostro tempo a produrle per difendere interessi di parte; in ogni caso sono proprio queste ambiguità che caratterizzano meglio il nostro essere. Il Trattato, che tanto esaltò i circoli neo-positivistici di tutta Europa e non solo, fu concluso ch'egli aveva 29 anni, e le sue assurdità gli si possono perdonare. Il miglior Wittgenstein infatti è quello delle Ricerche filosofiche.
Tutti gli enunciati del gruppo 5 sono un'apologia della tautologia. Stabiliti i principi di metodo, ora Wittgenstein passa ai contenuti veri e propri, ed è un fiume in piena, e lo sarà anche per gli enunciati del gruppo 6. Qui, se non si hanno fondate nozioni di logica, è davvero meglio tacere, per cui procederemo coi piedi di piombo, evitando di fare passi falsi, a meno che non ci venga voglia di saltellare come gli astronauti sulla Luna, limitandoci a fare semplici osservazioni a titolo di conferma di quanto fin qui già detto. D'altra parte siamo in buona compagnia: lo stesso Wittgenstein ha ammesso nella Prefazione di aver letto soprattutto Frege e Russell per elaborare il suo Trattato. Quando un logico ritiene che tutto quanto i filosofi han scritto prima di lui abbia un valore prossimo allo zero, non può poi pretendere che chi lo interpreta faccia eccezione. Pertanto, vista la nostra totale inadeguatezza, ci accingiamo a interpretare gli enunciati del gruppo 5 senza particolari patemi d'animo. Se poi qualcuno ritiene che questo atteggiamento sia poco logico, non si lamenti che i lettori di questa superscienza si contano sulle dita di due mani.
* * *
Anzitutto bisogna sostenere che, se in campo logico l'enunciato 5.12 è vero ("la verità di una proposizione 'p' segue dalla verità di un'altra, 'q', se tutti i fondamenti di verità della seconda sono fondamenti di verità della prima"), nella vita reale non è affatto detto che sia così, e se la logica deve servire per interpretare la realtà, allora dobbiamo prima chiederci quale sia questa realtà da interpretare.
Wittgenstein infatti presume d'aver trovato "il fondamento della teoria della probabilità" (5.1). Giustamente fa notare che ciò è possibile nella misura in cui "le funzioni di verità possono ordinarsi in serie". E nel suo schema (5.101) le funzioni di verità sono 16, non una di più, non una di meno. Tutta la realtà deve poter essere compresa all'interno di queste funzioni ipotetiche d'interpretazione, incluse quelle tautologiche e contraddittorie, che dovrebbero riferirsi, secondo lui, a una verità scontata o a una impossibile.
Nella sua Introduzione Russell fa capire che potrebbero esserci altre funzioni di verità, ma aggiunge che per Wittgenstein tutto in realtà rientra in quelle 16 possibilità, delle quali si possono qui fare alcuni esempi astratti: se è vero p, allora è vero anche q, e se è vero q, allora è vero anche p; può essere vero p o q, ma non ambedue insieme; se è vero p, allora è vero non-q, oppure il contrario, e così via.
Russell sostiene che, su questo specifico punto, per la cui comprensione si rimanda alla sua stessa Introduzione, Wittgenstein era arrivato a elaborare qualcosa di inedito. Da dove gli veniva questa perspicacia? Probabilmente dal fatto che aveva affrontato il tema delle funzioni di verità più come grammatico che come matematico. Grammatica e matematica possono assomigliarsi in maniera straordinaria, tant'è che in entrambi i casi, per risolvere i problemi, si finisce col parlare di "analisi logica". Lo si capisce dal suo presupposto di partenza, enunciato al n. 5: "La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari" (le quali si giustificano da sole). Questo è un metodo - simile appunto a un ragionamento di tipo matematico - usato da tutti gli insegnanti che in Italia impartiscono nozioni di grammatica. È un metodo di origine aristotelica, e consiste nel fatto che la verità di una proposizione sta nella verità delle sue singole parti e, di queste, anzitutto in quella più semplice, basata su un soggetto e un predicato, che in grammatica si chiama "principale" o "reggente", cioè funzione di tutte le altre. Individuata questa, il resto vien da sé. La grammatica viene insegnata stabilendo un primato assoluto della sintassi sulla semantica, al punto che quest'ultima trae il proprio significato da quella, e se vi sono altri significati, non è compito della grammatica individuarli.
Ora, se c'è una cosa che nella vita reale non funziona è proprio quella di stabilire la verità dei fatti dalla verità dei loro singoli elementi. La scomposizione in "fattori primi" è il metodo più sbagliato per individuare la verità dell'insieme. La vita umana dimostra esattamente il contrario, e cioè che la comprensione adeguata dei suoi singoli aspetti è davvero possibile solo se si possiede anzitutto una comprensione adeguata dell'insieme che li racchiude. L'approccio olistico (integrato) è antecedente a quello analitico, tant'è che quando si vuol partire dalla sola analisi, si finisce col produrre una verità sintetica (o finale) del tutto formale, che non corrisponde all'insieme esaminato, ma solo a un suo singolo aspetto, spesso esagerato, o comunque a un modo particolare (forzoso) di osservare quell'insieme. Questo, p. es., è molto evidente quando si emettono delle sentenze nei tribunali, dove ci si focalizza sui singoli reati previsti dal codice, facendone una chiave di lettura di tutta la personalità dell'accusato, sia al fine di minimizzarne la pericolosità, sia, al contrario, per ingigantirla.
Su tale questione ho già scritto un libro e non ho intenzione di ripetermi (7). Qui posso solo aggiungere che quando Wittgenstein dice che "i fondamenti di verità dell'una [proposizione] sono contenuti in quelli dell'altra; p segue da q" (5.121), sta semplicemente dicendo che, in grammatica, la principale può essere in qualunque momento trasformata in una subordinata, se, nel contempo, si procede in maniera inversa. Il ragionamento infatti è sì logico, ma di tipo ipotetico o astratto, indipendente dalla realtà, per cui alla fine è sufficiente che i conti tornino, cioè che i requisiti logici che tengono in piedi la sintassi di una proposizione vengano rigorosamente rispettati. Questo modo di ragionare proviene appunto da Aristotele e da allora non ce ne siamo più liberati. È la base della logica razionalistica di tutta la cultura occidentale.
Le 16 ipotesi di cui parla nell'enunciato 5.101 sono già incluse nelle 8 dell'enunciato 4.31. E non il contrario! È come se fossero una loro espansione. Infatti le 8 si potrebbero applicare a una proposizione priva di subordinata (quelle più elementari), mentre le 16 possono essere applicate a qualunque tipo di proposizione, avente subordinate di I, II III grado. Wittgenstein dà l'impressione di voler partire dal semplice per arrivare al complesso, ma in realtà il complesso è solo una semplicità a un livello, paradossalmente, più elevato: si tratta infatti di una riduzione intellettualistica della complessità umana a schemi logici precostituiti.
Wittgenstein doveva essersi particolarmente esaltato per questa sua scoperta, poiché arriva a paragonare la funzione di verità di una proposizione semplice all'atto creatore del dio ebraico-cristiano (5.123). E arriva addirittura a sostenere che se una proposizione semplice è vera, è impossibile (esistendo un dio!) che non vi siano oggetti reali corrispondenti. Con ciò - lo intuisce chiunque - egli non fa che anticipare il misticismo di cui era affetto, a dimostrazione che, anche quando si pretende di cacciarlo dalla porta grazie alla supponenza della logica, esso rientra sempre dalla finestra se la casa continua a reggersi su fondamenta di tipo idealistico.
Astraendo completamente dalla realtà, Wittgenstein ha poi buon gioco nell'affermare che le relazioni tra le proposizioni sono tutte interne (5.131), cioè tutte conseguenti, legate in modo necessario e in maniera tale che ci si può sufficientemente "giocare", come quando in matematica si cambia di posto ai numeri a condizione di ottenere lo stesso risultato. L'importante è sostenere che la proposizione semplice o elementare è autosussistente, in quanto non ha bisogno d'altro per essere dimostrata come vera (di qui la sua critica alle "leggi d'inferenza" di Frege e e Russell).
La tautologia qui è evidentissima. Wittgenstein rifiuta recisamente che la verità di una proposizione semplice possa dipendere da "nessi causali" (5.136 e ss.) o da dimostrazioni pratiche. La logica deve anticipare la realtà, altrimenti è impossibile un'interpretazione scientifica. Tuttavia "anticipare" non significa "prevedere": "Gli eventi del futuro non possiamo arguirli dagli eventi presenti" (5.1361). Significa piuttosto "anteporsi", "stare prima". Wittgenstein vuole qui smontare i logici che hanno ambizioni che vanno oltre la logica.
La questione della probabilità è trattata estesamente in questo gruppo 5 di enunciati, poiché ogni logica che si rispetti non può prescinderne. Qui infatti non siamo in presenza di una filosofia etica, che molti giudicherebbero opinabile, ma di una filosofia scientifica, cui non si può vietare il diritto di fare "previsioni". Vediamo però che Wittgenstein tratta l'argomento in maniera molto particolare. Infatti per lui qualunque "previsione" è una forma di superstizione (5.1361). Questo è abbastanza singolare dopo aver fatto di tutto per ingabbiare gli eventi reali in pre-condizioni ipotetiche, dal carattere onnicomprensivo. Il suo ebraismo o misticismo sembra qui prevalere sul suo razionalismo.
Da un lato pare ch'egli non voglia attribuire al futuro la facoltà di confermare in maniera decisiva la verità delle sue proposizioni teoretiche: di qui la valorizzazione del libero arbitrio (5.1362). E' come se dicesse che la verità di una proposizione deve autogiustificarsi, altrimenti, se dobbiamo dipendere dalla realtà, rischiamo di non poter attribuire una verità certa e definitiva ad alcuna proposizione (sarà poi questo l'argomento delle successive Ricerche filosofiche). Al massimo è disposto ad ammettere che all'interno delle proposizioni vi sono graduatorie di verità, per cui, posta una, l'altra ne discende. Se vi sono "nessi causali" sono tutti interni alla logica della proposizione, non nei suoi legami esterni col mondo.
Dall'altro però, quando si tratta di giustificare l'autoreferenzialità delle proposizioni, su quali di queste compie la sua scelta? Guarda caso proprio su quelle tautologiche e contraddittorie, cioè su quelle che rendono con certezza la verità un'evidenza e quelle che, con non meno sicurezza, la escludono a priori o la affermano negativamente, in quanto, per lui, sia un risultato vero che un risultato falso sono entrambi sensati. In sostanza è come se facesse un ragionamento del genere: se ammettiamo di poter stabilire delle certezze nei confronti della tautologia e della contraddizione (quest'ultima non è che un'antinomia insolubile), per quale motivo dovremmo far dipendere una verità teoretica da una realtà pratica? La fondatezza di quelle 16 funzioni di verità (di cui al 5.101) è tutta dipendente o relativa a solo due di esse, che si trovano tra loro agli antipodi. Le tante verità, tra loro relative, dipendono da due estremi assoluti, il cui intrinseco valore è paradossale, in quanto non comunicano nulla di davvero significativo.
Perché Wittgenstein fa questo ragionamento così astratto e forzoso? Perché appunto vuol sostenere che all'interno del ventaglio (range) che si è dato, i cui estremi sono tautologia e contraddizione, ogni proposizione elementare è vera, ma non più vera di un'altra altrettanto elementare, sicché non si può inferire una maggiore probabilità di conferma pratica. Se si vuole una teoria scientifica indipendente dalla realtà, si deve poi pagarne il prezzo, che, in tal caso, è appunto quello di non poter fare previsioni con sicurezza o con un tasso di probabilità significativo.
Tra due proposizioni semplici la percentuale di verità, in rapporto alla realtà, è sempre del 50%, in quanto ognuna pretende d'averne il 100%, anzi, nella filosofia di Wittgenstein, ognuna è costretta ad avere una percentuale del genere. Che poi la probabilità non si realizzi, ciò non dipende dalla verità o falsità della proposizione, ma appunto dal libero arbitrio. Pertanto va salvaguardata la verità teorica anche se sommamente contraddetta dalla pratica, o comunque va salvaguardata la possibilità di formulare verità teoriche a prescindere da un contesto reale di riferimento.
Wittgenstein non aveva alcuna intenzione di farsi mettere in crisi da qualsivoglia teoria della probabilità. D'altronde era partito tenendo rigorosamente separata la realtà dalla logica: ora non poteva smentirsi. Certo, avrebbe potuto dire che la realtà è insensata quando non è logica. Invece qui ha preferito sostenere che il fatto che la realtà sia o no insensata non pregiudica la logicità di una determinata teoria. Dopodiché lasciava a ognuno di trarre le proprie conclusioni. Si parla di probabilità - diceva - quando non si hanno certezze, ma lui presumeva d'averne, e di assolute, sul piano logico e non si preoccupava minimamente che tali sue certezze non trovassero riscontri reali. Anche dopo il Trattato, pur concedendo ampio spazio al valore dell'ambiguità linguistica, si preoccupò continuamente di "mostrare", senza "spiegare", i limiti di tali ambiguità.
Wittgenstein aveva una fiducia cieca nelle proposizioni semplici (atomiche), e nel Trattato spesso pretende che vengano capite senza tante spiegazioni. Eppure di semplice, anche in una frase banale come questa: "Mangio quella mela sul tavolo", non vi è nulla, poiché, nella fattispecie, non si capisce se ad essere sul tavolo è la mela o io stesso. La semplicità, il più delle volte, non è che una convenzione che ci è data dall'esperienza, dall'abitudine, dalle tradizioni culturali..., e che diamo per scontata quando parliamo, e la diamo tanto più acquisita quanto più sentiamo di appartenere a un contesto che ci è familiare, perché quotidiano, in cui il linguaggio viene considerato solo uno dei mezzi espressivi, non l'unico e non necessariamente il più importante.
Tutta questa esagerata accentuazione del lato linguistico dell'espressività umana (cioè della stretta identificazione della comunicazione con la sua espressione orale e scritta) rimanda a una sorta di dissociazione tra io e comunità. L'io non capisce più il mondo, non sa più che cos'è, e comincia a chiedersi - sbagliando - se questa incomprensione di sé e di altro da sé, percepita in modo alienante, non dipenda da un difetto di comunicazione, cioè da un limite sovrastrutturale. Si riduce il problema di una vivibilità significativa del valore a una questione linguistica, e tale questione viene ridotta a quella della formulazione della proposizione più semplice, la cui interpretazione appaia univoca. In tal modo il valore etico diventa un valore logico, in ultima istanza un mero sillogismo. Qui la logica è come una sorta di arca perduta o di vello d'oro o di pietra filosofale di cui andare ansiosamente alla ricerca. Vi è nel Trattato, in un certo senso, un affronto dei problemi che rasenta il genere mitologico.
Wittgenstein è come la sfinge che parla per enigmi e aforismi (così somiglianti nello stile a quelli di Nietzsche!), il sacerdote di una nuova religione che critica questo o quello studioso di filosofia o di logica, ma che in concreto non dice nulla, non risolve problemi pratici come facevano i matematici della Grecia classica o dell'India o del mondo arabo ecc., quand'erano alle prese con lo zero, l'infinito, ecc. Nel Trattato abbiamo a che fare con una disciplina, la logica, che presume d'esser vera come la matematica e che è sicura d'essere più vera di qualunque disciplina umanistica, ma che, di fatto, non aiuta a comprendere la storia o la realtà sociale, in quanto non può accettare l'idea che la contraddizione sia il motore di ogni cosa.
Per Wittgenstein la contraddizione è il limite oltre il quale la logica, se vuole restare tale, non può andare. La contraddizione non è che un negativo artificioso, che si deve sempre prevedere per non rischiare di dover ammettere, di fronte agli inevitabili ostacoli che s'incontrano, che non ci si era pensato. È solo un espediente tattico o tecnico, un accorgimento formale, un esercizio retorico: "La proposizione positiva deve presupporre l'esistenza della proposizione negativa, e viceversa" (5.5151). E qui si parla di "esistenza", non di "possibilità": le due cose vengono messe sullo stesso piano assiologico. Con Wittgenstein non si è in presenza di quei logici indù che trovarono i numeri negativi per risolvere il problema dei debiti (se da 3 tolgo 4 il debito che ho è -1). Egli infatti usa la logica in maniera così astratta proprio per non aver problemi pratici da affrontare.
La differenza fondamentale tra lui e Frege o Russell stava, a suo dire, nel fatto ch'egli non cercava mai di dare alle proposizioni logiche un senso che non dipendesse dalla logica stessa. Se si scinde completamente la logica dalla realtà, non c'è nulla in campo logico che non sia possibile e che sia quindi ingiustificato. "La logica deve curarsi di se stessa. Un segno possibile deve anche poter designare. Tutto ciò che nella logica è possibile è anche legittimo... In un certo senso nella logica noi non possiamo errare" (5.473). Incredibilmente, ogni volta che criticava i suoi maestri, egli si rifaceva alle tesi di Occam, un logico francescano dell'Inghilterra medievale, secondo il quale tutto ciò che in logica è possibile, è anche necessario. "Che la logica sia a priori consiste nell'impossibilità di pensare illogicamente" (5.4731). "Non possiamo dare ad un segno il senso errato" (5.4732). Il segno, con cui si organizza tecnicamente la proposizione, decide il senso del simbolo. Come se il simbolo non fosse il prodotto di una cultura, ma il sottoprodotto di una scelta intellettualistica! Come se i segni potessero sussistere, nel rappresentare i corrispettivi simboli, a prescindere da una cultura di riferimento! Segni e simboli, nella logica del Trattato, coincidono, ma dal punto di vista dei segni: sono loro che hanno il coltello dalla parte del manico.
"Ogni possibile proposizione è formata legittimamente" (5.4733). È evidente che per giungere a questo autoconvincimento, un soggetto deve astrarsi completamente dalla realtà, deve rinunciare a qualunque giudizio di sensatezza che parta da valutazioni etiche o politiche o ideologiche che dir si voglia. Deve concentrarsi unicamente sui segni (o simboli formali), come i matematici si concentrano sui numeri, usando peraltro tutti i segni possibili in rapporto ai numeri, al fine di spiegare meglio la verità delle operazioni matematiche. Sotto questo aspetto però Wittgenstein faceva il contrario del matematico: usava i segni per arrivare a conclusioni logiche inoppugnabili, simili a quelle matematiche ma che non avevano bisogno di dimostrazioni di tipo matematico, in quanto la matematica stessa dipendeva, secondo lui (ma anche secondo Frege e Russell), da verità o dimostrazioni logiche. Qualunque segno trova il suo senso logico semplicemente se glielo si dà: nulla acquista senso ricevendolo dall'esterno e il logico deve prenderne atto; tutto può acquisire il senso che il logico decide, anche se nella realtà non ne ha alcuno. D'altra parte se c'è qualcosa che non ha un senso logico è proprio la realtà. Quando Wittgenstein dice che "la logica deve curarsi di se stessa" vuole appunto dire che non può essere aiutata da un mondo insensato.
Tuttavia, vien qui da chiedersi: se la logica dovesse "limitarsi a curare se stessa", indipendentemente dalla realtà, in che misura potrebbe davvero migliorare se stessa? E anche quando riuscisse a farlo, davvero riuscirebbe ad essere utile anche all'etica? Ovvero, se si pensa che la logica non debba aver rapporti con l'etica, perché parlare nel Trattato anche di quest'ultima e perché farlo in maniera così drammatica? Se si pretende di autoperfezionare il proprio pensiero, restando isolati (magari a Skjolden, sulla sponda di un fiordo norvegese!), non si può poi aver la pretesa d'influire sulla realtà, né ci si può irretire quando questa non è conforme alla propria logica.
Noi possiamo avvicinarci alla verità in una maniera tale che mai nessuno, prima di noi, vi sia riuscito. E tuttavia, finché nella società permangono forme di antagonismo sociale, una qualunque persona che lotti fattivamente contro queste contraddizioni avrà il privilegio, pur senza aver elaborato sofisticati pensieri astratti, d'essersi avvicinata alla verità meglio di noi. Sul piano pratico vi sarà sempre qualcuno migliore di chi si limita a pensare, proprio perché la discriminante per stabilire il tasso di verità di una persona è la sua capacità d'impegnarsi praticamente per impedire gli atteggiamenti rinunciatari di fronte ai problemi: il che non vuol dire "eliminare le contraddizioni", ma soltanto l'idea o la percezione che sia impossibile risolverle.
Qui, nel Trattato, è come se vedessimo su una rotaia del binario la logica viaggiare alla velocità che vuole, senza doversi fermare ad alcun semaforo, del tutto incurante del fatto che sull'altra rotaia la vita può viaggiare soltanto a condizione di rispettare determinate regole. In tali condizioni come può "l'onnicomprensiva logica" essere "lo specchio del mondo" (5.511)? Per Wittgenstein lo è nel senso che dal "mondo" non può aspettarsi qualcosa che essa già non possieda: "Se sono date le proposizioni elementari, con ciò sono date anche tutte le proposizioni elementari" (5.524). Non è la logica che deve aspettarsi dal mondo gli input per modificarsi, ma è il mondo che deve sentirsi in debito cognitivo nei confronti della logica (da notare che su questo il secondo Wittgenstein dirà esattamente il contrario).
Una cosa non è "possibile" solo perché esiste un suo "precedente" - come secondo Wittgenstein intendeva Russell -, ma lo è perché è già presente, come "necessità", nel simbolo stesso che la rappresenta e che prescinde dalla realtà (5.525). Se non fosse così, non si potrebbe avere alcuna sicurezza che il possibile si trasformi in realtà: resterebbe un'evanescenza e questo, in logica, è inammissibile, in quanto qui si parla di "funzioni di verità" anche quando si ha a che fare con proposizioni da considerarsi negative con certezza. In tal senso "si può descrivere completamente il mondo mediante proposizioni perfettamente generalizzate; dunque, senza prima coordinare alcun nome a un determinato oggetto" (5.526). Più chiaro di così, questa volta, nel suo ingiustificato idealismo, non poteva essere.
Il giovane Wittgenstein non si "calava" nella realtà, ma la "piegava" ai propri schemi mentali. Se vogliamo dare all'ideologia un connotato negativo, l'abbiamo trovato anche per quanto riguarda la logica. Il concetto di "identità", infatti, per Wittgenstein non dipende da "una relazione tra oggetti" (5.5301). Se gli oggetti sono "identici", non dice nulla la loro relazione, per cui il segno di = andrebbe evitato. E, a maggior ragione, andrebbe evitato se essi sono diversi. Sicché "il segno dell'eguaglianza non è parte costitutiva essenziale dell'ideografia" (5.533). Wittgenstein tendeva a negare valore persino alle equazioni matematiche: "La proposizione della matematica non esprime un pensiero" (6.21). Forse perché è fatto di numeri? No, perché è fatta di equazioni, cioè di proposizioni che risultano vere solo perché lo dicono altre proposizioni. La matematica per Wittgenstein è certamente "un metodo logico", ma non ha nulla a che fare con una logica trascendentale di tipo filosofico o metafisico, che deve condurre alla tautologia, cioè a proposizioni autoevidenti.
Essendo un egocentrico, Wittgenstein non credeva che l'identità possa essere determinata soltanto dal proprio rapporto con la diversità. Semplicemente per lui l'identità si autopone e, nello stesso momento, si autonega, se questo può servire per stabilire una funzione di verità (8). Ogni identità è alterità di se stessa: se questo non è solipsismo, tautologia, contraddizione puramente formale, idealismo soggettivo, irrazionalismo in fieri, che cos'è? Qui Wittgenstein non sta facendo semplicemente della "logica", ma sta investendo la logica di un pathos quanto meno esistenziale, non senza addentellati drammatici. Tutte le certezze teoriche (ereditate dall'idealismo filosofico classico) distrutte dalla catastrofe della prima guerra mondiale, egli cerca di recuperarle in maniera esasperata, facendo del soggetto il perno attorno a cui far girare il mondo intero. Heidegger, pur senza interessarsi di logica, si comporterà nella stessa maniera.
Il fatto che Wittgenstein tenda a negare che un soggetto possa essere più importante di una proposizione, lasciando così credere che la sua logica sia la più oggettiva possibile, non significa affatto ch'essa lo sia davvero. È del tutto ingenuo pensare che l'oggettività possa essere data estraniandosi da una realtà sommamente contraddittoria quale è il mondo. Wittgenstein può anche ritenere che non sia il soggetto a "pensare" un oggetto, quanto piuttosto la proposizione che "mostra" soggetto e oggetto, ma questo modo di procedere oggettivistico è solo una forma di presunzione intellettualistica, in quanto, se anche potesse esser vero che la proposizione, in ultima istanza, decide l'identità, essa, nel Trattato, non può certo essere vista come la risultante di una relazione reale tra elementi opposti, che si attraggono e si respingono costantemente.
Nella logica di Wittgenstein non vi è dialettica reale ma fittizia, come quella dei sofisti greci. È in questa maniera che va interpretata, p. es., la seguente asserzione: "qui si tratta non d'una coordinazione d'un fatto e d'un oggetto, ma della coordinazione di fatti per coordinazione dei loro oggetti" (5.542). Cioè l'intelligenza dei fatti, e quindi dei soggetti che li compiono, sta nell'interpretazione preliminare da darsi agli oggetti che usano. Questo modo di procedere è tipico dell'idealismo, per il quale l'interpretazione migliore della realtà è data dal filosofo più intelligente, quello che presume di saper guardare le cose in tutti i loro aspetti.
Per giustificare questo, però, Wittgenstein si sarebbe potuto risparmiare il disegno del cubo in 5.5423. È ridicolo dimostrare la propria superiorità servendosi di un esempio così elementare. Peraltro un cubo può anche essere visto aprendolo e spianandolo su una superficie piana, oppure dividendolo in sezioni come in quello inventato da Rubik. Non ha senso usare un'immagine geometrica per indicare che le cose "umane" possono essere guardate da varie prospettive. È la realtà, coi suoi bisogni (indefinibili una volta per tutte, in quanto perennemente mutevoli), che decide da quale prospettiva deve essere guardata. Se uno sostiene che la logica è più importante della realtà (5.551), è già fuori strada. Se "la logica è prima d'ogni esperienza - d'ogni esperienza che qualcosa è così" (5.552), come d'altronde voleva Kant; se cioè vanno trovati degli a priori che non dipendono dalla realtà; se si pensa che siano appunto questi a priori a dare alla logica la propria interna coerenza, non si è fatto un passo avanti rispetto all'idealismo oggettivo hegeliano, ma, anzi, due passi indietro, anche se si può capire l'esigenza di chi, non vedendo nel mondo alcuna logica, si preoccupi in tutti i modi di dargliene una.
A questo punto però sorge un problema: come possiamo interpretare il mondo così complesso attribuendo a ogni oggetto (o classi di oggetti) un segno o un simbolo diverso? Wittgenstein si chiede questo a partire dall'enunciato 5.55 ed esclude subito a priori che si possa rispondere a una domanda del genere guardando il mondo: "La logica è prima d'ogni esperienza" (5.552). Essa è antecedente a "come" una cosa avvenga, altrimenti il "cosa" sarebbe inintelligibile. Secondo Wittgenstein è il soggetto che deve interpretare il mondo e non (anche) il contrario. Il soggetto deve poter stabilire una forma segnica, senza sapere se le possa corrispondere qualcosa di oggettivo (5.5542).
Wittgenstein in realtà non si preoccupava molto della difficoltà di tale questione. Infatti era partito dal presupposto che non esiste una non-logica: qualunque affermazione ha il proprio senso; "nella logica noi non possiamo errare", aveva detto in 5.473; è impossibile "pensare illogicamente" (5.4731); "ogni possibile proposizione è formata legittimamente e, se non ha senso, è solo perché noi non abbiamo dato un significato ad alcune delle sue parti costitutive" (5.4733). La sua prospettiva era rovesciata rispetto a quella di Frege e Russell e sicuramente più ambiziosa. Infatti se nella logica ci si nasce, ovvero - parafrasando misticamente - se "in principio era il logos", allora si tratta soltanto di formulare pensieri logicamente corretti, affinché appaiano del tutto sensati. La sensatezza di ciò che diciamo è in relazione alla correttezza formale (sintattica) della proposizione semplice.
Non è certo per caso che Wittgenstein volesse intitolare il suo libro La proposizione. Egli aveva un concetto così autoreferenziale della proposizione elementare che prescindeva, in un certo senso, persino dalla sua particolare forma logica (5.555). Questa convinzione probabilmente gli veniva da una notevole difficoltà comunicativa: non voleva assolutamente capacitarsi del fatto che nel linguaggio umano non esiste alcuna proposizione la cui chiarezza sia cristallina. È la mancanza di relazioni sociali normali, o comunque è l'assenza della disponibilità a lasciarsi determinare da tali relazioni, che fa sorgere probabilmente la convinzione di non essere mai capiti in maniera adeguata. Wittgenstein non era certo il tipo che, vedendo un interlocutore incapace d'intenderlo su qualche aspetto, arrivasse a dire che non si era spiegato bene (lo dice Ramsey nelle sue lettere, quando lo vedeva alterarsi se gli si chiedeva di ripetere spiegazioni già date). Anche noi italiani per vent'anni abbiamo avuto un politico così egocentrico che, quando diceva cose assolutamente antidemocratiche, attribuiva ai giornalisti il fatto d'averlo frainteso.
L'enunciato 5.6 è la quintessenza del suo solipsismo: "I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo". L'egocentrismo non è tanto in sé, quanto nel fatto che il giovane Wittgenstein non prevede anche il contrario, e cioè che il linguaggio dipende dalle relazioni sociali. Il fatto che un linguaggio sia particolarmente astratto può dipendere anche dall'incapacità di avere delle normali relazioni sociali. Lo si usa come forma di mascheramento, dietro cui si nasconde una scarsa umanità.
Com'è possibile sostenere che "la logica pervade il mondo" (5.61), quando, se c'è una cosa di cui il mondo difetta, da almeno 6000 anni, è proprio la logica? È da quando sono nate le civiltà che la logica ha smesso d'essere "naturale". E, in sua vece, gli uomini si sono dati una miriade di leggi scritte, come se la scrittura potesse dare più certezze di una semplice trasmissione orale delle conoscenze.
L'unica speranza che, involontariamente, Wittgenstein offre per superare i limiti della sua logica è che questa non può escludere alcuna possibilità (nella realtà), una volta che questa è emersa alla considerazione della logica. Se noi davvero non possiamo escludere logicamente alcuna possibilità, allora forse possiamo sperare che si realizzi un'esperienza in grado di piegare alle proprie esigenze umane ogni tipo di logica, lasciando agli uomini soltanto il compito di decidere cosa sia "umano" e cosa no.
Infatti non è sufficiente autolimitarsi, dicendo: "Ciò che il solipsismo intende è del tutto corretto; solo, non si può dire, ma mostra sé" (5.62). Non basta dire che l'egocentrismo non si può autogiustificare in maniera razionale, ma può soltanto mostrarsi come tale, lasciando all'interlocutore la decisione se credere o no alle sue "funzioni di verità". Per risolvere gli antagonismi sociali ci vuole qualcosa di più, non solo sul piano pratico, ma anche su quello logico, dimostrando razionalmente come e perché essi vanno superati.
La prova del fuoco Wittgenstein, con la sua logica, non l'ha superata. Egli infatti ha dichiarato che del soggetto non si può parlare nel suo Trattato (5.631): ciò in quanto è troppo contraddittorio perché possa essere affrontato in maniera sensata dalla logica proposizionale. Il "suo" soggetto non può neppure autointerpretarsi, perché per poterlo fare in maniera adeguata dovrebbe porsi "al di fuori del mondo". Come se, solo per il fatto di porsi in un orizzonte extraterrestre, il singolo, da solo, riuscirebbe a capire meglio le cose e se stesso!
In tali condizioni il solipsismo coincide davvero col "realismo puro" (5.64)? E non invece con un incipiente irrazionalismo? Quello stesso scaturito dal "soggetto metafisico" (5.641) di idealistica memoria?
PROPOSIZIONI n. 6
L'enunciato n. 6, essendo la summa summarum del senso della logica
proposizionale, va discusso. E lo faremo riportando la spiegazione del suo
significato tecnico da parte di B. Russell. Lo dice a pag. 11 della sua
Introduzione: ![]() dove il
primo termine sta per tutte le proposizioni atomiche, il secondo per
qualsiasi insieme di proposizioni e il terzo per la negazione di tutte le
proposizioni contenute nelle parentesi tonde. "L'intero simbolo
dove il
primo termine sta per tutte le proposizioni atomiche, il secondo per
qualsiasi insieme di proposizioni e il terzo per la negazione di tutte le
proposizioni contenute nelle parentesi tonde. "L'intero simbolo ![]() significa tutto ciò che può essere ottenuto facendo una qualsiasi scelta di
proposizioni atomiche, negandole tutte, facendo poi una qualsiasi scelta
dall'insieme di proposizioni ora ottenuto, insieme con alcune delle
proposizioni originarie - e così via, indefinitamente". In questa formula
Wittgenstein - secondo Russell - sarebbe stato in parte debitore di Sheffer,
per il quale "tutte le funzioni di verità si possono ottenere a partire
dalla negazione simultanea (ossia a partire da 'non-p e non-q')" (ib.). Poi
Russell parla di altre cose che non c'interessano, essendo troppo tecniche.
significa tutto ciò che può essere ottenuto facendo una qualsiasi scelta di
proposizioni atomiche, negandole tutte, facendo poi una qualsiasi scelta
dall'insieme di proposizioni ora ottenuto, insieme con alcune delle
proposizioni originarie - e così via, indefinitamente". In questa formula
Wittgenstein - secondo Russell - sarebbe stato in parte debitore di Sheffer,
per il quale "tutte le funzioni di verità si possono ottenere a partire
dalla negazione simultanea (ossia a partire da 'non-p e non-q')" (ib.). Poi
Russell parla di altre cose che non c'interessano, essendo troppo tecniche.
Ciò che ha detto è sufficiente per capire che la logica di Wittgenstein si muove in un terreno tutto suo, dove le contraddizioni non sono quelle della realtà, ma quelle ch'essa stessa deve darsi (formalmente), al fine di elaborare qualcosa di sensato. Siamo nell'autoreferenzialità assoluta. E qui - si badi bene - Wittgenstein non sta parlando semplicemente del modo come risolvere un'espressione algebrica, anche se arriva a dire (e l'odierna informatica ha dovuto dargli ragione), che per fare calcoli sono sufficienti due numeri: 1 e 0, in quanto il resto dipende - diciamo oggi - dalla velocità del calcolatore; ma sta parlando espressamente di "funzioni di verità", cioè ha una pretesa etica e gnoseologica sulla base di una logica del tutto astratta.
Quanto a semplificare le cose Wittgenstein era un campione. Egli riduceva praticamente tutta la matematica a un'operazione logica, dove i numeri sono soltanto gli esponenti di espressioni linguistiche. Qui però, nelle Proposizioni n. 6, la cosa è diversa. Sin dall'inizio del Trattato, in verità, egli aveva usato la logica non limitandosi a dare un contributo alla matematica o alle scienze esatte e naturali. La sua pretesa era quella d'interpretare il mondo. I limiti del suo linguaggio determinano quelli del mondo, che coincide col "suo" mondo. Non esiste un mondo oggettivo, indipendente dal soggetto, con una propria logica da scoprire; esiste anzitutto il soggetto che deve interpretare il mondo, che in sé è solo contraddittorio. Sembrano due posizioni, in ultima istanza, equivalenti. Invece sono molto diverse, poiché in una si ascolta la realtà, nell'altra solo se stessi; in una ci si lascia coinvolgere, nell'altra la si aggiusta.
Le proposizioni n. 6 sono come il pettine cui devono giungere i nodi di tutti i discorsi fatti nelle proposizioni precedenti: il loro valore non può essere soltanto logico, ma anche metafisico.
Le funzioni di verità indipendenti dalla realtà, per essere vere, devono soddisfare condizioni di inoppugnabilità, e questo è possibile solo se sono tautologiche. Il cerchio esistenziale di Wittgenstein sembra chiudersi (anche se vedremo, alla fine di questo gruppo di proposizioni, che non sarà così) tra due estremi: il solipsismo e la tautologia, di cui la contraddizione non è che un aspetto formale. Lo dice espressamente a partire da 6.1: "Le proposizioni della logica sono tautologie... non dicono nulla", che abbia un qualche senso per la realtà. Sono per così dire funzioni vincolanti di verità o costrittive, non la "verità", poiché nella logica anche la negazione è verità. Una frase del genere: "Tutte le rose sono o gialle o rosse" (6.111), è sbagliata (insensata), poiché per la logica è anche possibile che nessuna rosa abbia uno di quei due colori. La logica, per poter sussistere in maniera coerente, deve sempre riservarsi la possibilità di accettare il contrario di ciò che sembra apparentemente scontato, non tanto per giocare a fare il "bastian contrario", quanto perché la possibilità che p sia non-p va sempre tenuta presente, qualunque ragionamento si faccia.
Se si parte dal presupposto che le definizioni sono tautologiche, tutto, alla fine del ragionamento, dipende da come si usano i simboli. Se il segnale dell'obbligo di dare la precedenza lo stacco dal suo palo all'incrocio, e lo uso come triangolo rovesciato, per indicare che la mia macchina ferma costituisce un pericolo per la viabilità, sto facendo una cosa sbagliata, che però è vera come l'altra. L'ideale per Wittgenstein sarebbe stato di usare lo stesso segnale senza rovesciarlo, semplicemente cambiandogli collocazione. Ma avrebbe comunque apprezzato il fatto che l'uso di quel segnale di pericolo non vuol dire in sé proprio nulla. In tal senso sarebbe interessante che i logici s'occupassero anche di codici stradali, cercando p.es. di capire il motivo per cui avvengono incidenti nonostante il rispetto delle regole. L'idea d'imponderabilità o imprevedibilità non può non essere prevista dalla logica, soprattutto in campo assicurativo: il miglior codice, in ultima istanza, resta sempre quello del buon senso. Non solo, ma una logica agganciata alla realtà, dovrebbe saper proporre nuove regole, in grado di rispondere a bisogni reali. Una p.es. potrebbe essere questa: negli incroci urbani gli autoveicoli più pesanti (camion, betoniere ecc.) dovrebbero sempre dare la precedenza a quelli più leggeri, prescindendo dalla regola generale del codice. Questo per disincentivare l'uso urbano dei mezzi pesanti: la logica diventerebbe tanto più sensata quanto più eco-logica.
Le proposizioni logiche - sostiene Wittgenstein, e non solo lui - sono riconoscibili come "vere" dall'uso corretto dei loro simboli, a prescindere dai riferimenti a realtà specifiche. Se mai è l'uomo che deve abituarsi all'idea che medesimi simboli, a seconda della loro collocazione, possono significare cose molto diverse. La logica anzi è così rigorosa che non si azzarda a giudicare di verità o di falsità quanto non appartiene al suo mondo (6.113), che è un mondo di "forme" e di "inferenze" rigorose (6.1224). Le proposizioni non-logiche possono essere, in sé, sia vere che false. Cioè, come la logica non è interessata a trovare conferme o smentite nella realtà, in quanto il suo rigore ne prescinde, così la realtà non può aver la pretesa di dire alla logica come deve ragionare (6.1222). Queste cose bisognerebbe dirle ai teorici dei linguaggi informatici, che si stanno scervellando a produrre linguaggi sempre più dinamici e performanti, uno diverso dall'altro, con algoritmi sempre più complessi, per produrre alla fine gli stessi risultati. "Semplificare" dovrebbe essere la parola d'ordine in campo informatico. Ma come farlo all'interno di un sistema sociale dove la competizione antagonistica è la regola fondamentale?
La critica più dura a Russell viene fatta proprio in questo gruppo di proposizioni. Qui si tende infatti a rovesciare il senso della logica: per essere vera essa non ha bisogno di cercare verità generali inconfutabili, ammesse dalla realtà. "Una proposizione non generalizzata può anzi essere altrettanto tautologica quanto una generalizzata" (6.1231).
Qui sarebbe bene rendersi conto che se Wittgenstein ha ragione, tutta la logica a lui precedente fa la figura di un nano a confronto di un gigante. Pochi (p.es. l'americano E. L. Post) avevano avuto il coraggio di dire che la verità sta nella tautologia; nessuno che la verità vi risiede proprio perché la tautologia non dice nulla, nulla di significativo né dal punto di vista logico né, tanto meno, da quello esistenziale. Su questo il giovane Wittgenstein voleva essere molto chiaro: "in logica non possono mai esservi sorprese" (6.1251); "processo e risultato sono equivalenti" (6.1261). Le difficoltà comunicative non possono essere psicologiche, ma semmai grammaticali o segniche.
Il logico non deve affatto curarsi del senso semantico della proposizione, ma solo di quello sintattico. Si pensi a cosa possa voler dire insegnare la grammatica con un metodo del genere. Oggi ci lamentiamo ch'essa è tutta impostata sulla sintassi e assai poco sulla semantica. Ma se passasse la linea di Wittgenstein al Ministero della Pubblica Istruzione, noi avremmo a che fare con una sintassi addirittura priva di parole: una sintassi costituita soltanto di segni e di simboli. La correttezza formale della sintassi dovrebbe diventare una naturale conseguenza della logica, in cui tutto appare tautologico, cioè vero di per sé, entro i limiti della correttezza formale stabilita a priori. Prima di rispondere a una qualsivoglia domanda dei nostri studenti, dovremmo chiedere di definire il significato delle parole che usano, dovremmo farlo fino al punto in cui non diventa scontato per tutta la classe il modo in cui ogni parola può essere rappresentata da un simbolo.
Per trovare affermazioni analoghe a quelle del Trattato, a questi livelli, bisogna andarle a cercare in filosofi vicini all'irrazionalismo, p. es. in Stirner, Kierkegaard, Nietzsche..., per i quali espressioni come "la verità è la soggettività e questa è quella" erano la regola. Certo Wittgenstein avrebbe obiettato che nel suo Trattato la soggettività sparisce, essendo sostituita da regole formali, oggettivamente utilizzabili. In realtà un'obiezione del genere non significa nulla: la sua logica resta sempre un'elaborazione astratta di un individuo isolato, e purtroppo sappiamo come dall'irrazionalismo teorico si passi facilmente a quello pratico.
In Wittgenstein il soggetto sta tutto dentro la logica, salvo naturalmente ciò che di lui non può essere esaminato logicamente. La logica è una sorta di divinità ipostatizzata, cui l'uomo deve adeguarsi senza fare obiezioni. Non è un dio come lo intendevano i pagani, che lo pregavano per ottenere che qualche desiderio venisse esaudito; è un dio nel senso che ogni giorno l'uomo deve chiedersi come potergli essere formalmente conforme, affinché i suoi ragionamenti siano sintatticamente corretti. "Se noi conosciamo la sintassi logica di un qualsiasi linguaggio segnico, sono già date tutte le proposizioni della logica" (6.124) (9). Qui, rispetto alla logica positivistica e neopositivistica, siamo su un altro pianeta. Wittgenstein avrebbe messo in dubbio ogni certezza, se questa non fosse stata rigorosamente formulata a prescindere dalla realtà concreta, fattuale.
Dunque si può facilmente capire perché egli non parli mai di "dimostrare" logicamente la fondatezza delle proposizioni. Se le funzioni di verità stanno nella tautologia, è sufficiente "mostrarle", per credere nella loro fondatezza: non serve "di-mostrarle". "La dimostrazione della logica è solo un ausilio meccanico per riconoscere più facilmente la tautologia ove questa sia complicata" (6.1262). Cioè si può discutere sino al punto in cui, di fronte alle cose ridotte a semplicità vi si crede spontaneamente, in quanto evidenti di per sé. Non ha senso, per Wittgenstein, dimostrare logicamente la verità di una proposizione usandone altre: la catena sarebbe infinita, come quella di cui i teologi scolastici parlavano per dire che se essa fosse possibile non esisterebbe alcun vero dio.
Qui è come se Wittgenstein avesse trasferito sul piano della logica lo stesso modo di procedere che avevano i teologi apofatici medievali, i quali facevano ragionamenti logici per sostenere che, alla fine di essi, la verità non stava nel ragionamento in sé, ma nell'evidenza. Il ragionamento era soltanto una specie di setaccio, un filtro utilizzato per ripulire la mente da tutte le false rappresentazioni della realtà. La verità, per loro, stava solo in ciò che si contempla dopo essersi depurati: "La logica è trascendentale" (6.13). La differenza tra Wittgenstein e gli apofatici sta però nel fatto ch'essi non svolgevano questo processo interiore nella loro individualità, poiché sapevano benissimo che, in tal caso, avrebbero rischiato di vedere solo fantasmi. Esiste un limite invalicabile all'evidenza, quello di non poter essere auto-evidente al soggetto che, chiuso in sé, la contempla. Sotto questo aspetto l'uso di strumenti logici, in luogo di quelli teologici, non può certo recare maggiori aiuti, offrire maggiori certezze. In sé la logica è un'illusione non meno della teologia. È solo l'umano che conta, e quello vissuto in un ambito egocentrico è sicuramente più povero di umanità.
Wittgenstein vuol fare della logica una sorta di auto-evidenza, un dio che s'impone da sé: "Ogni tautologia mostra da sé che è una tautologia" (6.127), senza aver bisogno dell'aiuto di altre proposizioni. La logica deve arrivare a un punto in cui si auto-giustifica, e senza neppure l'ausilio della matematica, poiché questa è fatta di proposizioni la cui verità dipende da altre proposizioni, come succede nelle equazioni. Le equazioni hanno senso solo se ogni espressione è valida di per sé, ma questo solo il linguaggio lo può dire, prima ancora di accingersi a fare calcoli. Il calcolo serve soltanto a confermare l'esattezza di una intuizione logica, non matematica. Le intuizioni a priori di cui parla Wittgenstein sono molto somiglianti a quelle kantiane, ed è sulla base di esse che egli pensa, paradossalmente, di dare scientificità sia alla matematica che alla fisica. È interessante notare che laddove parla di meccanica newtoniana (6.341), fa capire che si può relativizzare di molto il modo di percepire la realtà, p. es. prendendo come base su cui elaborare delle figure una griglia composta non di quadrati (i pixel che usiamo oggi in informatica), ma di triangoli o di esagoni (quest'ultimi come le celle di un alveare). "Alle differenti reti corrispondono differenti sistemi di descrizione del mondo" (ib.). E tutti sono legittimi: non si può scegliere una rete in luogo di un'altra. Chissà, forse la forma esagonale, in luogo di quella quadrata, avrebbe aiutato meglio a definire, nei nostri monitor, le figure tonde o la profondità delle immagini in generale.
È la proposizioni in sé che - nel Trattato - è una forma di dimostrazione di se stessa. In tal senso "tutte le proposizioni della logica sono paritetiche" (6.127), cioè non può esserci - come invece voleva Frege - un "grado dell'evidenza quale criterio della proposizione logica" (6.1271). Tautologia e solipsismo potrebbero anche voler dire, politicamente, autosufficienza sociale, autogestione del bisogno, autonomia decisionale in ogni aspetto della vita quotidiana, come avviene in certe comunità che si isolano dai mercati, dagli Stati e persino dalle società civili. Poi però bisogna vedere come viene gestita l'evidenza al loro interno: se è una forma di plagio collettivo, una forzatura imposta da qualche leader, o un processo in cui la libertà di coscienza viene tutelata in qualunque momento. Un'evidenza che si auto-impone, prescindendo dal consenso, è un'altra forma di dittatura, anche più alienante di quelle vissute nei mercati, nelle società e negli Stati.
* * *
La parte finale del Trattato, a partire dall'enunciato 6.362, va analizzata separatamente, poiché risulta essere riassuntiva di tutto il libro e, nel contempo, perché è quella che un logico tradizionale farebbe più fatica ad accettare, essendo intrisa di un marcato misticismo.
Anzitutto Wittgenstein è convinto che quanto "può descriversi può anche avvenire" (6.362). Questa affermazione è importante, perché indica la superiorità del pensiero logico sulla realtà. Tuttavia egli non indica il modo pratico che permette tale realizzazione, in quanto, essendo il mondo "indipendente" dalla volontà del soggetto (6.373), se e quando si realizza un suo desiderio, ciò va attribuito, secondo lui, alla "grazia del fato", non esistendo affatto, tra volontà e mondo, "una connessione logica che garantisca ciò" (6.374).
La logica garantisce una "necessità logica" o una "impossibilità logica" (6.375), ma non può garantire una connessione logica tra se stessa e il mondo, poiché qui entra in gioco la volontà, il libero arbitrio. Fin qui il ragionamento sembra del tutto coerente. Tuttavia il primo Wittgenstein non ha mai rinunciato alla pretesa di definire La coerenza logica in maniera del tutto indipendente dalla realtà. Per lui il mondo, a motivo delle sue intrinseche contraddizioni, non è in grado di fornire alcuna coerenza. Ne è così convinto che arriva a dire che "ciò che la legge di causalità deve escludere [sottinteso: per motivi logici] non può neppure descriversi" (6.362). Quindi tutto ciò che non manifesta una certa coerenza, o che non può essere formalizzato da segni e simboli logici, non può neppure essere detto: non si hanno parole sensate per descriverlo, se non appunto dicendo che è logicamente insensato. E non serve a nulla, per cercare di descriverlo, semplificare al massimo le cose, scegliendo la legge del più semplice col procedimento dell'induzione, poiché ciò ha un valore soltanto sul piano psicologico (6.3631).
Cioè ci s'illude che possano essere chiarite o chiarificate cose che, in realtà, non hanno alcun senso. "Che il sole domani sorgerà è un'ipotesi; e ciò vuol dire: Noi non sappiamo se esso sorgerà" (6.36311). Non c'è un motivo logico per cui debba farlo: semplicemente diamo per scontato che lo farà, tant'è che ai poli - si può aggiungere - per sei mesi l'anno danno per scontato che non lo farà. Non esiste "una necessità cogente, per la quale qualcosa debba avvenire poiché qualcos'altro è avvenuto" (6.37). Vi è solo una "necessità logica", che però è formale, connessa a segni e simboli artificiali. "Tutta la moderna concezione del mondo si fonda sull'illusione che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni dei fenomeni naturali" (6.371).
A Wittgenstein è sempre piaciuto il paradosso: fa parte delle nature solipsistiche. "Legge naturale", per lui, non vuol dire assolutamente nulla: è paragonabile a dio o al fato, a qualcosa d'intangibile (6.372). Egli non vede alcuna "necessità logica" nelle leggi naturali, proprio perché sono indipendenti dal soggetto; né, tanto meno, vede tali leggi all'interno dei processi storici, che per lui sono troppo insensati o troppo indeterminati per essere naturali.
"Il senso del mondo dev'essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene come avviene; non v'è in esso alcun valore - né, se vi fosse, avrebbe un valore... ogni avvenire ed essere-così è accidentale" (6.41). Quando Wittgenstein vuole dare alla sua logica una connotazione etica o politica, si arrende subito. La sua logica vuole essere coerente indipendentemente dalle contraddizioni del mondo. E, in questa maniera, non s'accorge d'avere lo stesso atteggiamento fatalistico dei credenti, che prima contestava. Alla fine la sua logica si riduce a qualcosa di puramente formale, accademico, e lo dimostra il fatto che tutte le sue proposizioni "sono di pari valore" (6.4). Nel mondo non vi sono "valori" più necessari di altri, che meglio di altri rispecchino delle leggi di natura, per cui anche nella logica ogni proposizione formalmente corretta è sensata. Non esiste un criterio pratico per stabilire quando un'affermazione è sensata: non esiste una tradizione culturale consolidata, un riferimento comunitario, una contraddizione irrisolta che possa aiutare la riflessione umana a essere più "coerente" di altre; le leggi della coerenza sono tutte interne alla logica.
Wittgenstein esclude addirittura che si possa parlare di "etica" in maniera "logica" (alla Spinoza, per intenderci): non vi possono essere "proposizioni dell'etica" (6.42). "L'etica non può formularsi. L'etica è trascendentale. (Etica ed estetica sono tutt'uno)" (6.421). Cioè l'etica non può essere "detta" in maniera logica, ma solo "mostrata" in maniera esistenziale e, in tal caso, certamente sarebbe irrilevante un'etica basata su "pena e premio" (6.422). Wittgenstein è kantiano, in quanto un'azione etica deve essere basata sul "dovere per il dovere", ma siccome ha tendenze irrazionalistiche, preferisce non affrontare l'argomento, lasciando che il soggetto decida da sé la propria etica.
"La volontà quale fenomeno interessa solo la psicologia" (6.423). "Se il volere buono o cattivo altera il mondo, esso può alterare solo i limiti del mondo, non i fatti, non ciò che può essere espresso dal linguaggio" (6.43). Grande illusione, questa, del giovane Wittgenstein! Ha forse senso o è forse possibile che la logica si riservi un proprio spazio d'intangibilità teorica, a dispetto delle contraddizioni del mondo, e quindi dei suoi fatti concreti? Si può avere una concezione del "fatto" così astratta? Davvero il mondo, in sé, resta intonso a prescindere dal modo in cui vi si vive l'etica?
Quando parla di "etica" Wittgenstein è molto nebuloso, come se nel suo passato non fosse stato abituato a farlo, come se non riuscisse neppure a trovare le parole adatte. Il timore di apparire equivocato lo induce o a esagerare a bella posta le proprie affermazioni o a tacerle del tutto: un atteggiamento, questo, tipico delle persone con scarse relazioni sociali. In questo campo resta ancora più paradossale di quando fa il logico, salvo poi cadere in banalità disarmanti, giustificabili al massimo nell'antico mondo greco, come p. es. quando dice che "La morte non è evento della vita... vive eterno colui che vive nel presente..." (6.4311). Vengono qui in mente le parole di Epicuro: "Se la morte c'è, non ci sono io e viceversa: dunque, di che preoccuparsi?". Parole che molti, banalmente, pongono a fondamenta del proprio ateismo, senza chiedersi, con ciò, se abbia davvero senso parlare di "morte" e non di "trasformazione". Per non parlare del fatto che, sul piano psicologico, può anche accadere, in taluni casi, che la morte appaia un evento della vita più importante della vita stessa.
Possibile che una persona così intelligente debba vedere l'insensatezza del mondo come un fatto naturale? E, per giunta, così radicale da determinare un'insensatezza dell'intero universo? Dire che "la risoluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori dello spazio e del tempo" (6.4312), è dire cosa del tutto mistica. Un logico che pretende di fondare la logica a prescindere dalla realtà, e che poi quando parla di realtà, lascia introdurre elementi delle classiche religioni, ha certamente perduto buona parte della propria credibilità. Wittgenstein andò volontario in guerra, non tanto per spirito patriottico, quanto per dare un senso a una vita che non l'aveva e si comportò anche in maniera valorosa. Finita la guerra, durante la prigionia, poi, dopo la liberazione, dopo la rinuncia spontanea ai beni paterni, mentre faceva il maestro elementare, in mezzo a litigate furibonde coi genitori dei suoi alunni, che cosa impedì a Wittgenstein di trovare un senso alla propria vita? Da un lato voleva apparire freddo come intellettuale, dall'altro si sentiva assolutamente lacerato come uomo, anzi come credente, poiché in lui le questioni religiose, nonostante tutto, restano una costante, al punto che, dopo la sua esperienza fallimentare come insegnante, fu lì lì per diventare monaco.
Forse, più che Occam, più volte citato nel Trattato, avrebbe dovuto imitare l'Areopagita o qualche teologo apofatico, per i quali "dio è ciò che non è". Lui stesso lo scrive: "Dio non rivela sé nel mondo" (6.432). Questa sua frase avrebbe potuto dirla qualunque esicasta. Salvo che per un particolare: la conclusione dell'esicasta non era l'agnosticismo, ma la divinizzazione (theosis), cioè l'illuminazione interiore, personale, non il brancolare nel buio. Viceversa Wittgenstein arrivò alla conclusione che il mondo è insensato e che la soluzione della sua insensatezza, sul piano pratico, può avvenire soltanto al di fuori del mondo. "I fatti appartengono tutti soltanto al problema, non alla risoluzione" (6.4321).
All'enunciato 6.5 sembra di leggere Marx quando, dopo la sua sconfitta come politico rivoluzionario, arrivò a dire che "l'umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere" (in Per la critica dell'economia politica). Wittgenstein invece scrive, sentendosi uno sconfitto come filosofo, in quanto la sua logica non è in grado d'incidere sulla realtà e il mondo continua a restargli del tutto insensato (persino "abbandonato" da dio, che è un dio che si "nasconde"): "D'una risposta che non si può formulare, non può formularsi neppure la domanda". E così il cerchio si chiude. La logica è soltanto un'oasi in un mare di sabbia, o forse soltanto il miraggio di chi non riesce a soddisfare la sua indicibile sete.
PROPOSIZIONE n. 7
Questa proposizione finale: "Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere", in assoluto è la più importante di tutto il Trattato, la sua estrema sintesi. Dal sapore, peraltro vagamente tautologico, com'è giusto che sia in un filosofo come Wittgenstein, in quanto, se di una cosa "non" si può parlare, è naturale che la si debba tacere, non foss'altro che per opportunità o buona educazione.
Va detto, tuttavia, che il giovane Wittgenstein la intendeva in altro modo. In realtà avrebbe dovuto essere scritta diversamente, mettendo in chiaro i suoi sottintesi: "Su ciò [della vita reale] di cui [logicamente] non si può parlare [rispettando la sintassi segnica formale], si deve tacere [lasciando cioè l'etica al di fuori della logica]". Sembra un ordine perentorio, che un maestro dà ai propri discepoli, come faceva Pitagora, che, per darsi un'aria di sacralità, si nascondeva dietro un paravento, mostrandosi solo agli eletti.
Se nella vita si dovesse parlare soltanto di cose logiche o in maniera logica, esisterebbero soltanto automi, non esseri umani; ci sarebbe solo scienza, non coscienza, solo discipline scientifiche, non artistiche o umanistiche: quindi niente etica né estetica né psicologia, ecc., oppure ogni scienza dovrebbe sottostare alle forche caudine della logicità, quindi dovrebbero essere solo descrittive o a-valutative. Una società del genere, per dimostrare d'essere perfetta, dovrebbe persino censurare tutte quelle parti del Trattato in cui si parla esplicitamente o implicitamente di misticismo, in quanto il fatto stesso che se ne parli è un cattivo segno, è un indizio di problema irrisolto.
Un assioma come quello della Proposizione n. 7, messo a disposizione di un regime dittatoriale, porterebbe alla morte del pensiero o alla creazione di una letteratura clandestina o alla formazione di circoli culturali illegali. Nessuno quindi potrebbe essere autorizzato a formulare un'espressione del genere, a meno che il "ciò" in questione non riguardi delle situazioni personali, oggetto di privacy, come quando diciamo che alcuni aspetti della nostra vita privata costituiscono dei "dati sensibili", da proteggersi scrupolosamente, anzi legalmente. Ma Wittgenstein non si riferiva certamente a questo: le sue pretese erano di ben altro livello, che qui addirittura arrivano a sfiorare quello politico.
In realtà non c'è proprio nulla di cui non si possa dire qualcosa, proprio perché non è detto che solo la logica possa accampare la pretesa di dire cose sensate. Dai tempi di Aristotele abbiamo la pretesa di avere una logica ultrasensata: e che cosa abbiamo ottenuto? Solo guerre e devastazioni. Con quella logica sillogistica e così, in fondo, tautologica, non abbiamo risolto definitivamente neppure un problema inerente agli antagonismi sociali.
La parte finale del Trattato dà l'impressione di porsi come un grido d'allarme, un appello all'umanità. È come se il giovane Wittgenstein chiedesse di potersi incontrare con qualcuno che avesse trovato un senso praticabile della propria vita, pur essendo incapace di "dirlo", cioè di formalizzarlo logicamente. È come se da un lato gli piacesse chiedersi il motivo per cui gli uomini non sanno spiegarsi razionalmente il fatto d'aver trovato un senso alla propria vita, e dall'altro però non fosse capace di chiedersi se il suo mancato incontro con questi uomini fosse dipeso di più dalla loro incapacità comunicativa o non piuttosto dalla sua incapacità ad ascoltarli.
In ogni caso è proprio sulla domanda se sia possibile non essere ingannati da un linguaggio non-ingannevole, che si colloca la svolta intellettuale del secondo Wittgenstein, che arrivò in un certo senso a capire ciò che dal punto di vista umano avrebbe dovuto dare per scontato, e cioè che tale possibilità non esiste proprio perché non deve esistere, in quanto pensare di poter elaborare un linguaggio non-ingannevole è, in ultima istanza, un controsenso. Un linguaggio ingannevole non è un limite ma una risorsa, anzi un indice della libertà umana, seppure al negativo. La coerenza di per sé non è un valore, o almeno non lo è di più dell'incoerenza: non esiste un criterio formalmente corretto che possa dirci con sicurezza quando una certa coerenza è sensata e quando non lo è. Il fatto che la logica abbia leggi del tutto diverse dal senso comune, non depone a favore della logica, ma del senso comune, e se qualcuno pensasse di dover ridurre questo a quella, andrebbe probabilmente considerato come un individuo pericoloso.
"Secondo la legge di Mosè questa donna, colta in flagrante adulterio, va lapidata" (Gv 8,4ss). Se si desse ascolto a una logica stringente, si diventerebbe spietati, e non tanto perché si può non diventarlo ammettendo eccezioni alla regola, quanto perché si finirebbe col non chiedersi mai se una determinata regola abbia davvero senso. L'unica regola fondamentale cui dobbiamo attenerci è quella di soddisfare i bisogni rispettando la libertà di coscienza e le esigenze riproduttive della natura. Tutto ciò che va al di là di questo, pretendendo di porsi come "regola generale", o è inutile o è nocivo. Pertanto dobbiamo rifiutare l'invito di salire la "scala" che Wittgenstein ci propone (6.54). Neppure se fossimo discepoli di Giovanni Climaco o di Giovanni della Croce ci sentiremmo indotti a seguirlo. Già sappiamo infatti che, giunti in cima, non troveremmo altro che un baratro profondissimo. Piuttosto è lui che deve discendere da quella scala e appoggiare finalmente i piedi per terra. Il mondo non viene visto "rettamente" dall'alto, ma standoci dentro.
Note
(1) Inspiegabilmente perché la cromaticità è solo una delle proprietà delle due fondamentali strutture di spazio e tempo. Ve ne sono sicuramente altre: p. es. la tridimensionalità, la velocità della luce e del suono, la simultaneità e la successione cronologica, l'imponderabilità e la ciclicità degli eventi ecc. È impossibile pensare a uno spazio-tempo in cui non siano coinvolti i cinque sensi e altro ancora d'immateriale.
(2) Il che non significa che quando uno affronta i bisogni altrui non possa farlo in maniera idealistica: basta guardare cosa fanno le missioni religiose nei paesi del Terzo mondo, ove sfruttano il bisogno di quelle popolazioni per imporre una determinata confessione, dove cioè la risoluzione di bisogni particolari serve appunto per non pregiudicare i meccanismi del sistema coloniale che producono proprio quei bisogni.
(3) La famiglia ha senso come concetto "biologico", ai fini della riproduzione, ma, per come si è sviluppata, nell'ultimo mezzo millennio, nelle società avanzate, essa è un'istituzione debolissima nei confronti delle altre due che si sono volute potentissime: Stato e Mercato. Molto più coese erano le famiglie patriarcali o, meglio ancora, le comunità di villaggio pre-schiavistiche.
(4) Anche la ragione ha motivi per credere in ciò che non si può dimostrare in laboratorio o scientificamente. La fede è un concetto umano "rubato" dalla religione.
(5) Si pensi solo alla formula che usa per sintetizzare la forma generale di una proposizione che voglia dirsi sensata e che Russell ha dovuto spiegare a pagina 11 dell'Introduzione. Davvero Wittgenstein voleva farsi capire o dava per scontato che non avrebbe potuto esserlo, se non da un altro logico identico a lui?
(6) Avvezzo alla sua logica, il detenuto di quel famoso enigma si risparmiò facilmente la condanna a morte. Il giudice infatti gli chiese, per dargli un'ultima possibilità di salvezza, di fare una dichiarazione prima di morire, premettendo che, se avesse detto la verità, l'avrebbero impiccato, mentre se avesse detto il falso, l'avrebbero fucilato. Quello si salvò semplicemente dicendo: "Io morirò fucilato". Infatti, se avesse detto la verità, gli sarebbe spettata la forca, per cui non avrebbero potuto fucilarlo; ma se mentiva, non avrebbero potuto fucilarlo lo stesso, poiché, in tal caso, avrebbe detto la verità.
(7) Grammatica e Scrittura. Dalle astrazioni dei manuali scolastici alla scrittura creativa www.lulu.com/shop/enrico-galavotti/grammatica-e-scrittura/paperback/product-15122979.html (pdf)
(8) Anche qui sarebbe interessante mettere a confronto la sua logica con quella di Gentile, un altro idealista soggettivo come lui, che però, in luogo della proposizione semplice come totem non da adorare, aveva posto lo Stato.
(9) Se le lingue straniere, nelle scuole, s'insegnassero secondo determinati schemi logici, mettendo a confronto tutta la loro logica fondamentale con quella della lingua italiana, probabilmente si apprenderebbero prima (nella loro struttura generale), cioè prima ancora di parlarle. Di ogni lingua, infatti, bisognerebbe anzitutto trovare la sua logica interna e, a tale scopo, sarebbe sufficiente usare segni e simboli. Uno schema del genere, essendo del tutto astratto, potrebbe servire per imparare facilmente qualunque lingua. Infatti - scrive Wittgenstein - "è possibile... dare in anticipo una descrizione di tutte le proposizioni logiche 'vere'" (6.125). Poiché ogni lingua ha la sua propria logica, che prescinde dalle proprie parole, la grammatica dovrebbe astrarre da proposizioni già compiute, ma dovrebbe far capire come costruirle, senza neppure usare delle parole, ma solo simboli.
Introduzione alla filosofia del linguaggio
Fonti
- Gottlob Frege, Senso, funzione e concetto, ed. Laterza, Bari 2007
- Gottlob Frege, Ricerche logiche, ed. Guerini e Associati, Milano 1999
- Frege Gottlob, Scritti postumi, 1987, Bibliopolis
- Gottlob Frege, Logica e aritmetica, ed. Boringhieri, Torino 1965
- Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, 2009, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Ricerche filosofiche, 2009, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni di filosofia (1930-1933). Annotate e commentate da George E. Moore, 2009, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni sui fondamenti della matematica, 2002, Bollati Boringhieri
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la credenza religiosa, 1967, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Zettel. Lo spazio segregato della psicologia, 2007, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, 1990, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Ultimi scritti 1948-1951. La filosofia della psicologia, 2004, Laterza
- Wittgenstein Ludwig, Esperienza privata e dati di senso, 2007, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Della certezza. L'analisi filosofica del senso comune, 1999, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937, 1999, Quodlibet
- Wittgenstein Ludwig, Causa ed effetto-Lezioni sulla libertà del volere, 2006, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Note sul «Ramo d'oro» di Frazer, 1975, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni sui colori, 2000, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Osservazioni filosofiche, 1999, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Pensieri diversi, 1980, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Diari segreti, 2001, Laterza
- Wittgenstein Ludwig, Libro blu e Libro marrone, 2000, Einaudi
- Wittgenstein Ludwig, Lettere a Ludwig von Ficker, 1989, Armando Editore
- Wittgenstein Ludwig, Ludwig e gli amici. Lettere, 2010, Quattroventi
- Wittgenstein Ludwig, Vostro fratello Ludwig. Lettere alla famiglia (1908-1951), 1999, Archinto
- Wittgenstein Ludwig, Lettere a C. K. Ogden. Sulla traduzione del «Tractatus logico-philosophicus», 2009, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig; Bouwsma Oets K., Ludwig Wittgenstein. Conversazioni annotate da Oets K. Bouwsma, 2005, Mimesis
- Wittgenstein Ludwig, Lezioni 1930-1932. Dagli appunti di John King e Desmond Lee, 1995, Adelphi
- Wittgenstein Ludwig, Conversazioni e ricordi, 2005, Neri Pozza
- Wittgenstein Ludwig, Lecture on ethics, 2007, Quodlibet
- Wittgenstein Ludwig, La filosofia. Testo tedesco a fronte, 2006, Donzelli
- Wittgenstein Ludwig, The Big Typescript, 2002, Einaudi
- Rudolf Carnap, Analiticità, significanza, induzione, ed. Il Mulino, Bologna 1982
- Carnap Rudolf, Lo spazio. Un contributo alla teoria della scienza, 2009, Morcelliana
- Carnap Rudolf, Filosofia e sintassi logica, 1996, ETS
- Enriques Federigo; Carnap Rudolf; Schlick Moritz, Filosofia scientifica ed empirismo logico (Parigi, 1935), 1993, Unicopli
- Carnap Rudolf, Introduzione alla logica simbolica, 1978, La Nuova Italia
- Carnap Rudolf, La costruzione logica del mondo, Utet 1997
- A. Bonomi, La struttura logica del linguaggio, ed. Bompiani, Milano 1973
- Ludwig Wittgenstein, Colloqui al circolo di Vienna, Mimesis, 2011
- Wittgenstein e il Circolo di Vienna, ed. La Nuova Italia, Firenze 1979
- Friedrich Waismann, Ludwig Wittgenstein e il circolo di Vienna. Colloqui annotati, La Nuova Italia 1975
Siti
- it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
- www.youtube.com/watch?v=i5IVnlOJ8ec
- www.youtube.com/watch?v=1LYTYKgGVxE
- www.lettere.unimi.it/dodeca/piana01/tr_indice.htm
- plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/
- www.emsf.rai.it/percorsi_tematici/wittgenst/
Download