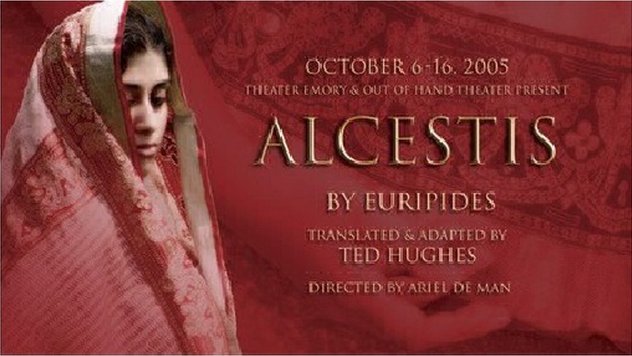
ALCESTI DI EURIPIDE
tra ospitalita' e autosacrificio
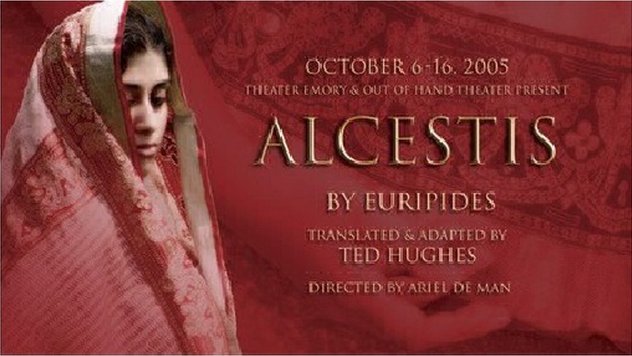
|
|
C'è dell'ateismo nell'Alcesti di Euripide (1).
Già nell'incipit viene infatti detto che all'origine della
tragedia (che è però a lieto fine) vi è un comportamento sbagliato, o
eccessivo, dello stesso Zeus, che uccise Asclepio (l'Esculapio romano,
padre della medicina), figlio di Apollo, per aver osato resuscitare un
morto: un atto gravissimo di insubordinazione nei confronti di Zeus, in
quanto neppure lui si permetteva una cosa così contronatura. Il fatto
della morte doveva appunto servire per distinguere in maniera
irreversibile il destino degli uomini da quello degli dèi. Asclepio
peraltro era diventato così bravo in medicina che riusciva a curare
molte persone in punto di morte, sicché Ade, il Signore dell'oltretomba,
aveva cominciato a lamentarsi presso lo stesso Zeus. La società greca era verticistica: dovevano essere rispettate le gerarchie, le consuetudini e si guardavano con sospetto le innovazioni tecniche e scientifiche che potevano compromettere un assetto sociale conservativo. Asclepio sembra qui rappresentare l'esigenza di una certa autonomia gestionale da parte di quei ceti sociali che, privi di grandi proprietà agrarie e di schiavi, cercavano di emanciparsi attraverso il proprio ingegno. Egli era - diremmo oggi - una sorta di "libero professionista". E siccome Apollo aveva sterminato i Ciclopi che avevano forgiato il fulmine scagliato da Zeus contro Asclepio, la vertenza era finita davanti al consesso degli dèi, il cui tribunale emetteva sentenze inappellabili (2). Zeus, alla fine, aveva ordinato ad Apollo di lavorare per un anno al servizio di Admeto, re di Fere, in Tessaglia. Una sorta di legge del contrappasso: la colpa era quella di far diventare immortali gli uomini; la punizione quella di doversi sentire umilmente mortale per un tempo definito. Admeto comunque non era un comune mortale: non solo perché re, ma anche perché aveva partecipato alla conquista del Vello d'oro e alla caccia del cinghiale Calidonio. Non sarebbe stato decoroso, per una divinità, umiliarsi eccessivamente. Anche in questo caso le gerarchie andavano rispettate, pur avendo egli avuto come pena l'ordine di sorvegliare le mandrie di Admeto, il quale, siccome volle trattarlo con tutti i riguardi, ebbe la fortuna di avere sempre, dalle proprie vacche, dei parti gemellari. Admeto s'era poi sposato, aiutato da Apollo, con la principessa Alcesti, figlia di Pelìa, re di Iolco, superando una certa prova di abilità, anche se poi era stato punito da Artemide con dei serpenti velenosi messi nel letto nuziale, per essersi dimenticato di farle un sacrificio, e anche quella volta era stato aiutato da Apollo, il quale, dopo aver fatto ubriacare le tre Moire (3), aveva estorto loro una promessa molto impegnativa: Admeto non sarebbe morto se, nel giorno fatidico, avesse trovato uno disposto a sostituirlo. (4) Se la cosa fosse riuscita, si sarebbe ripetuta la causa che aveva mandato Zeus su tutte le furie, quella che veniva a compromettere un ordine stabilito, uno status quo, questa volta con la complicità, diretta o indiretta, delle stesse divinità (Apollo e le Moire). La cosa strana, nella tragedia, è che non viene spiegato chiaramente il motivo per cui Admeto dovesse morire prima dei suoi genitori. Semplicemente Admeto si limita a dire al corifeo che questa sua sventura non gli era piovuta addosso all'improvviso: da tempo sapeva di dover morire prematuramente, ma, data la sua giovane età e la bella vita che viveva, non riusciva ad accettarlo. È da presumere quindi che Euripide dia per scontate alcune cose che il pubblico già ben conosceva: una in particolare, il torto religioso arrecato ad Artemide. Apollo qui sembra comportarsi come un mestatore, un sobillatore: lo faceva davvero per amore degli uomini o solo per una vendetta personale? Voleva aiutare Admeto dall'eccessiva permalosità di Artemide o voleva servirsi di lui per raggirare le disposizioni divine? Naturalmente non si trattava, per Admeto, di una perenne immortalità, ma solo di un destino posticipato di almeno una decina d'anni; cosa comunque non priva di eccezionalità, se è vero che nel mito di Orfeo ed Euridice si tentò invano un'impresa analoga (ed è lo stesso Admeto a ricordarlo ad Alcesti). (5) D'altra parte Admeto è convinto di poter beneficiare di questa inaspettata promessa da parte di Apollo, per quanto sub condicione, in maniera relativamente facile, confidando nel fatto che almeno uno dei due genitori, già anziani, si sarebbe sacrificato. Tuttavia, quando Thanatos, il Raccoglitore di morti, si presentò alla reggia per riscuotere il "tributo", il padre di Admeto, Ferete, e la madre Periclemene non ebbero alcuna intenzione di sacrificarsi per il figlio. E qui - data anche la centralità del dialogo tra padre e figlio - è difficile non vedere una netta contrapposizione intergenerazionale. Il figlio non sembra capacitarsi che il padre Ferete non voglia riconoscere in lui un destino diverso, ben più straordinario di quello che gli era stato riservato dallo stesso padre, che pur lo aveva reso erede di tutto. Admeto vede nei suoi i genitori una sorta di egoismo ingiustificato, data la loro tarda età, come se questi avessero amato il figlio soltanto come loro legittimo successore ed erede universale, non come "figlio" senz'altro. Sembra qui di assistere a uno scontro tra genitori aristocratici, strettamente vincolati ai valori dominanti del loro ceto, e un figlio che invece vorrebbe emanciparsi da questi valori, o almeno stemperarli in altri di natura più soggettiva, più intimistica o esistenziale, in cui i sentimenti giochino un ruolo più significativo. Admeto aveva solo 24 ore di tempo per cercare qualcuno disposto a morire per lui: andò anche in un campo di battaglia, dove si scontravano a morte Focesi e Locresi, ma non trovò nessun moribondo disponibile a ripetere la frase solenne: "Io muoio per Admeto". Scoraggiato da tanta indifferenza, tornò a casa, pronto ad accettare il suo destino, ma proprio in quel momento vide la moglie Alcesti che, con una coppa di veleno, aveva deciso di sacrificarsi per lui. Euripide sta dalla parte del sesso debole, in una società fortemente maschilista come la sua e, quando sono di mezzo i valori, lo trasforma in un sesso forte. La donna rappresenta l'altruismo in una società dominata dall'egoismo maschile, un egoismo così forte che condizionava chiunque, persino la madre dello stesso Admeto. Per ottenere lo scambio delle persone ci voleva il sacrificio di una donna capace di un grande amore (i servi o gli schiavi non vengono neppure interpellati a riguardo, benché nella tragedia non mostrino risentimenti nei confronti dei loro padroni). Sembra qui anticipato il mito cristiano - delineato da Paolo di Tarso - secondo cui il Cristo, che amava gli uomini di un amore sconfinato, avrebbe accettato di morire volontariamente per loro, al fine di placare l'ira divina, offesa sin dai tempi del peccato d'origine. Il dialogo tra i due, Alcesti e Admeto, è più corto di quello tra Admeto e Ferete, e anche meno intenso. D'altra parte Admeto deve soltanto prendere atto di una scelta compiuta (stranamente, anzi, il dialogo col padre viene messo dopo, a cose fatte, anche se, forse proprio per questo, ha un effetto drammaturgico accattivante). Admeto non può convincere la moglie a ripensarci, non c'è una discussione sull'opportunità del gesto suicida. Non è stata presa una decisione comune, che peraltro Admeto non avrebbe mai accettato. (6) L'unico vero argomento su cui s'incentra il dialogo tra i due è la promessa che lui le deve fare di non risposarsi. Alcesti infatti era convinta che se l'avesse fatto, la matrigna non avrebbe amato i suoi due figli come aveva fatto lei. Quindi - è da presumere - una promessa da mantenere almeno finché i figli non fossero divenuti adulti. Ovviamente Admeto non ebbe difficoltà ad accettare questo lutto perenne in cambio di un sacrificio così enorme. E non manca di prendersela con gli dèi, che uccidono senza pietà (uno di dolore, l'altra fisicamente) "due miseri, di nulla colpevoli". Si augura soltanto che lei venga a consolarlo nei suoi sogni, perché non potrà certo accontentarsi della fredda effigie che da un artista si farà fare per metterla nel letto. Mentre si svolgono le esequie, entra in scena Eracle che, dovendo portare a termine la sua nona fatica (quella delle cavalle di Diomede, mangiatrici d'uomini), chiede ospitalità per una notte. I servi non fanno neppure in tempo a sconsigliarlo di chiedere una cosa del genere in un momento di lutto, perché Admeto, appena sopraggiunto, insiste che resti. Lo fa non solo perché sa che è un dio, ma anche perché sa che trattare bene gli dèi "buona sorte" può valere. In fondo l'unica cosa che separa gli uomini da loro è l'immortalità, o meglio, visto che tutte le anime finiscono nell'Ade, la possibilità di accedere all'Olimpo. Nel mondo greco il destino teorizzato dagli aristocratici doveva conservare un'idea di aldilà in cui la felicità fosse riservata soltanto agli dèi, per cui sulla Terra chi ne fruiva - le classi magnatizie - non poteva certo perderla. In un certo senso questa tragedia doveva suggerire l'idea che una qualche trasgressione alla regola doveva pur esserci, seppure pro tempore. Se non si poteva far nulla contro l'onnipotente Zeus, si poteva però limitare il potere di qualche dio minore. Significativo comunque resta il fatto che in tutta la tragedia è la morte ad essere considerata la più grave sciagura del genere umano: cosa che, non a caso, diventerà il medesimo tema nella teologia petro-paolina. Il dialogo con Eracle resta però abbastanza artificioso, poiché, da un lato, essendo un dio, Eracle non può fingere di non sapere della decisione di Alcesti di voler morire per il marito; dall'altro, però, Admeto non gli dice che la moglie è già morta, poiché teme che Eracle rifiuti l'ospitalità, certamente inopportuna in quel momento: cosa che esporrebbe Admeto all'accusa, a quel tempo molto grave, di xenofobia. Essendo un sovrano, ha una certa reputazione da difendere. Admeto dunque prova a tergiversare, quasi ingannando Eracle, ovvero confermando che Alcesti morirà al suo posto per poterlo salvare (come se in una società maschilista fosse una cosa relativamente normale), ma mentendo sul motivo del lutto di quel giorno: gli dice infatti ch'era morta un'orfana a lui molto cara, in quanto l'aveva ospitata nella sua reggia dopo che aveva perduto il padre (sembra qui esserci un riferimento alla tragica morte di Pelìa). Eracle si convince ed Euripide introduce un altro dialogo, il più significativo di tutti, quello tra Admeto e suo padre Ferete, che entra in scena nel momento in cui si sta compiendo la cremazione di Alcesti, chiedendo che alcuni doni vengano sepolti con le sue ceneri. Il padre esordisce approvando il comportamento di lei, che non solo ha permesso al marito di campare più a lungo, ma che ha anche impedito che i genitori di lui vivessero una vecchiaia distrutta dal dolore. Non solo, ma afferma ch'essa ha dato lustro al sesso femminile, compiendo una cosa che nessun altro uomo, in quel momento, aveva voluto fare. Admeto però gli risponde subito con molto sdegno, rinfacciandogli che nessuno dei due genitori ha mai pensato, neppure per un momento, di sacrificarsi al suo posto. Pur essendo anziani, si erano comportati - a suo dire - come vili ed egoisti, in quanto avrebbero lasciato morire il figlio e avevano considerato la morte di Alcesti quasi come una cosa dovuta. Admeto non si spiega la ragione di questo atteggiamento indifferente, rassegnato al destino, quando, nel concreto, vi era una sicura via d'uscita. Non se lo spiega perché i genitori non avevano alcun motivo di lamentarsi di qualcosa nel suo comportamento verso di loro: Admeto li aveva sempre rispettati e riveriti. Avevano ottenuto già tutto dalla vita e, per loro, non sarebbe costato granché andarsene anzitempo nell'Ade. Sembra proprio uno scontro generazionale, poiché, ad un certo punto, Admeto se la prende con gli anziani in generale, che "fanno voti di morire e non fanno che lagnarsi della vecchiaia e della vita troppo lunga: se poi la morte s'avvicina, nessuno vuole più morire...". Ferete reagisce prontamente, facendo capire che insulti del genere Admeto li può rivolgere a uno schiavo, non a suo padre. Peraltro - gli fa notare - non esiste legge ricevuta dagli avi (come consuetudine) o dalla polis (come diritto-dovere) che imponga uno scambio di persone del genere, quando uno è in punto di morte. Anche potendo, nessuno può pretendere di ottenere un favore così grande: ognuno deve affrontare il proprio destino. E, nei confronti di Admeto, la sorte non era stata affatto avara, visto che dalla vita aveva ottenuto molto di più di ciò che un comune mortale potesse desiderare. Lui stesso, in quanto padre, se si fosse trovato nella medesima situazione, non avrebbe chiesto al figlio di morire per lui. A tutti infatti piace vivere, quando dalla vita si ottiene ciò che si desidera, anche perché la vita sulla Terra è infinitamente più breve di quella nell'Ade. Eticamente e giuridicamente Ferete sentiva d'aver fatto tutto quanto era in suo potere per far felice suo figlio. Non si vuol sentire in colpa per non aver compiuto un gesto di estrema generosità. Anzi, rimprovera il figlio di viltà e codardia per aver voluto sfuggire a una sorte segnata e per aver preteso che altri pagassero per lui. Addirittura scende in congetture che avrebbe potuto risparmiarsi: "Sei stato bravo - gli dice - a trovare il sistema per non morire mai, se ti riesce di persuadere a morire per te, di volta in volta, la moglie di turno". E lo accusa d'essere un bellimbusto, uno sciagurato. La difesa, fino a quest'ultima insinuazione, pareva essere stata impeccabile. Se anche non aveva voluto compiere il supremo gesto di sacrificio, Ferete non meritava d'essere attaccato così aspramente. In fondo era stata una sua scelta personale, che non avrebbe dovuto guastare il rapporto di paternità e figliolanza. Admeto avrebbe dovuto capirlo, evitando inutili risentimenti. Lo stesso coro glielo fa capire. Il resto del dialogo, composto di battute secche, molto corte, non aggiunge nulla di più agli argomenti già usati per l'accusa e la difesa. Solo quando Ferete dice che Alcesti è stata una "pazza" a morire per un figlio così egoista, scatta in Admeto la richiesta esplicita di andarsene e di non partecipare ai funerali. Ferete è molto indignato e arriva addirittura ad accusarlo di assassinio morale, e spera che Acasto, fratello di lei, gliela faccia pagare. Admeto è infuriato: se potesse l'ammazzerebbe. Si limita invece a disconoscere entrambi i genitori e a giurare che non presterà alcuna assistenza quando saranno malati e moribondi. Minaccia addirittura - ma sembra più che altro una spacconata - il ripudio della reggia, cioè l'idea di andarsene. Un dialogo, questo, davvero impressionante e molto moderno, dove le posizioni sono così distanti e l'odio reciproco è così forte che pare un miracolo che non siano venuti alle mani. Viene qui in mente un analogo episodio del vangelo di Marco (3,31ss), quando Gesù, intento a parlare con i propri discepoli, viene interrotto da alcuni che gli dicono che sua madre e i suoi fratelli erano venuti a cercarlo; al che lui rispose, scandalizzando sicuramente qualcuno che lo stava ascoltando: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli e le mie sorelle?". Poi, indicando i suoi discepoli, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli e le mie sorelle". Diversa ovviamente è l'ambientazione (popolare e non aristocratica) e la motivazione (politica e non privata). A voler essere obiettivi, è difficile dar ragione all'uno o all'altro, anche se Euripide, considerando il buon esito della tragedia, sembra propendere per Admeto, in quanto riottiene la vita di Alcesti per un altro suo merito personale: quello di considerare l'ospite, cioè l'estraneo, più importante dei propri genitori. Infatti, come aveva ottenuto da Apollo - grato dell'ospitalità ricevuta - un premio insperato, così ottiene da Eracle - ancora più grato di Apollo - un premio ancora più insperato. Eracle infatti - e sarà il dialogo col servo di Admeto a rivelarcelo - si era comportato in maniera davvero poco dignitosa per un dio (e, se vogliamo, anche per una tragedia). Un ospite peggiore di lui il servo non l'aveva mai visto: da un lato non aveva insistito granché, constatando quella situazione funerea, a declinare la richiesta di ospitalità e, dall'altro, una volta ottenutala, si era comportato come un prepotente coi servi, bevendo e gozzovigliando a volontà, cantando a squarciagola. Dalla confessione del servo veniamo a sapere un particolare in più di Alcesti: "temperava l'ira di suo marito, e ci tirava fuori da tanti e tanti guai". Cioè difendeva la causa degli oppressi! Quindi una donna paziente, molto equilibrata, una "santa", si potrebbe dire con un'espressione popolare. Eracle però, nei confronti del servo, si comporta come un razzista: lo considera un minus habens, un deprivato mentale, appunto in quanto servo. E gli spiega ciò che dovrebbe essere considerato una banalità sconcertante, e cioè che tutti gli esseri umani devono prima o poi morire, per cui non vi è alcun bisogno di affliggersi in maniera esagerata per la morte altrui. La filosofia di vita che dovrebbe avere il servo è quella del "carpe diem": "bevi, limita il conto della vita all'oggi, al quotidiano: il resto è dalla sorte". E lo diceva lui che era un semidio, figlio di Zeus e della donna Alcmena, con cui Zeus volle avere a tutti i costi una relazione "extraconiugale". Eracle aveva desiderato l'immortalità e Zeus gliel'aveva concessa previo il superamento di dodici fatiche. Il servo comunque gli rivela che la defunta non era un'estranea, ma la stessa Alcesti, e quando Eracle viene a saperlo, trasecola, si vergogna e si chiede come può rimediare a ciò che aveva fatto. Tra sé e sé decide di scendere nell'Ade, di bloccare Thanatos e di rapire l'anima di Alcesti, al punto che se non ce la farà, scenderà ancora più giù, "nel regno senza sole di Kore e di Plutone", per richiederla. Questa tragedia non vuole essere un inno al supremo sacrificio di sé, ma un inno all'ospitalità nei confronti dello straniero, uomo o dio che sia, conosciuto o sconosciuto. Il fine è l'ospitalità e il mezzo, per valorizzarla, è il sacrificio per amore. Qui c'è dell'etica mescolata alla politica. Il nuovo dialogo, tra Admeto e il coro, è straziante e commovente. Admeto sembra ai limiti del suicidio, sembra non aver più voglia di abitare nella reggia, e considera sua moglie più felice di lui, poiché non soffre il rimorso d'aver indotto qualcuno a compiere un gesto che non avrebbe dovuto, e - si può aggiungere - se anche Alcesti può aver violato il proprio destino di morte, suicidandosi, l'ha fatto soltanto per amore, non per egoismo. Si preoccupa del giudizio della gente, che lo accuserà d'essere un infame, per non aver avuto il coraggio di morire e per avere per di più chiesto una cosa impensabile, assolutamente esagerata. Dunque a che serve vivere, se di questa vita non si può in alcun modo essere felici? Inutilmente lo consola il coro, con le sue parole di saggezza popolare. Lo consola invece Eracle che, quando rientra in scena, gli chiede di prendere in custodia, come ancella, una donna che si è portato con sé, almeno finché lui non avrà terminato di compiere la sua fatica: è una donna che dice di aver vinto in una legittima gara sportiva. Admeto si scusa di non avergli detto subito che la defunta era sua moglie e di non averlo quindi messo sull'avviso dal non compiere azioni sconvenienti, ma gli spiega d'aver taciuto per un gran rispetto dell'ospitalità. Quanto alla donna, preferisce non tenerla in casa, in quanto, essendoci molti uomini, non è sicuro di garantirne la castità, né lui può pensare di portarla nel suo talamo, visto che ha promesso ad Alcesti di non risposarsi. Poi, iniziando a guardarla, resta un po' scosso, perché, pur essendo velata, la vede simile nel fisico a sua moglie, e inizia a turbarsi. A questo punto Eracle, che fino a poche ore prima si era comportato come uno screanzato e che di lì a poco sarebbe dovuto andare a uccidere il re dei Bìstoni, ora è tutto premuroso, toccante, anche se si permette di consigliargli un nuovo matrimonio. Sembra fare la parte del ruffiano, cioè di un sensale che combina matrimoni difficili, complicati, oppure del sofista, per il quale tutto è relativo. E Admeto è lì lì per cedere davanti al dio, lui che aveva promesso poco prima un lutto eterno. Eracle lo invita a prenderle la mano e lui lo fa, mostrando una certa debolezza di carattere. Eracle si comporta come una sorta di prestigiatore, di illusionista. Quando Admeto cede, toccando la mano della donna, Eracle le scopre il volto, lasciando di stucco il povero Admeto, che pensa a un imbroglio degli dèi, a un fantasma dell'Averno, anche perché con Alcesti non può parlare di nulla: la donna per tre giorni dovrà restare muta e scordarsi di tutto ciò che ha visto nell'aldilà. Admeto infatti è tornato ad essere felice, nonostante "l'invidia degli dèi". (7) La scena finale dovette colpire alquanto il pubblico, poiché ispirò non pochi dipinti, mosaici e rilievi funerari. Note (1) La storia di questo mito non è raccontata solo da Euripide, ma anche da Diodoro Siculo, Apollodoro, Eliano, Frinico, Igino e Fulgenzio: vi sono tracce persino nell'Iliade di Omero e nelle Eumenidi di Eschilo, a testimonianza della sua particolare antichità, al punto che alcuni critici vi hanno intravisto una transizione dalla fiaba al mito. La tragicommedia, ispirata a un omonimo dramma di Frinico, drammaturgo della generazione precedente, venne rappresentata per la prima volta ad Atene nel 438 a. C., permettendo a Euripide, che ne aveva presentate altre tre, di conseguire il secondo posto, dietro al grande Sofocle. L'alternanza di toni aulici e grotteschi dovette comunque apparire un po' sconcertante a un pubblico tradizionalista, abituato a Eschilo e Sofocle. (2) Da notare che, secondo il mito, Apollo bersagliò di frecce, fino a renderla una specie di puntaspilli, la donna di cui s'era invaghito e che l'aveva immediatamente tradito con un giovanotto di nome Ischi. Poi, preso dai rimorsi, era sceso nell'Ade e aveva tolto dal cadavere di lei un bambino ancora in vita: era appunto Asclepio, che da adulto apprese l'arte di guarire dal centauro Chirone. Asclepio era in grado di resuscitare i morti e di uccidere i vivi con due fiale del sangue della Medusa. Infatti "fàrmacon" in greco vuol dire sia medicina che veleno. (3) In origine la Moira, dea del destino, era una sola (in Omero è dea della sventura e della morte); più tardi fu suddivisa in tre personaggi (dette Parche dai Romani): Cloto, la filatrice del filo della vita, Lachesi, la misuratrice della sua lunghezza, e Atropo, colei che lo taglia. A partire da Euripide la Moira lascerà progressivamente il posto ad Ananke (destino, necessità) e a Tyche (fortuna), divinità preponderanti nell'immaginario dei Greci di età ellenistica. (4) Un'altra versione vuole che sia stata proprio Artemide a promettere che Admeto, in punto di morte, si sarebbe potuto salvare se avesse trovato qualcuno disposto a sacrificarsi, come se lei sapesse in anticipo che solo la moglie di lui avrebbe accettato di farlo. (5) Nel Convito Platone arriva ad anteporre Alcesti al mitico Orfeo, in quanto la prima avrebbe offerto la propria vita in cambio di quella dell'amato, col duplice risultato di salvare Admeto e se stessa, mentre Orfeo, disceso nell’Ade per sottrarre la sua Euridice alla morte con l'incanto della propria musica, non solo avrebbe fallito, ma sarebbe andato incontro a una maggiore disperazione e alla personale rovina. Tuttavia, arriva a dire una frase quanto meno inquietante: "Pensi forse che Alcesti sarebbe morta per Admeto, […] senza credere di lasciare un immortale ricordo del proprio valore, giunto fino a noi?". Forse l'unico vero confronto che può essere fatto con questo mito è quello di Psiche, la favola platonizzante del latino Apuleio, che fa fare a Psiche un viaggio nell'aldilà, in cerca di un'autentica realizzazione personale, ove l'assistenza del divino Eros è determinante. (6) Una decisione così repentina i mitografi (cfr le Metamorfosi di Ovidio) la spiegano rievocando inquietanti trascorsi dell’eroina Alcesti, che sarebbe stata coinvolta, in un modo o nell'altro, con le sorelle nell’uccisione del padre Pelìa, ordita con l'inganno da Medea, che s'era voluta vendicare di alcuni torti subìti dal marito Giasone. La celebre maga aveva convinto le ingenue figlie dell'anziano re di poterlo ringiovanire e sanare, immergendolo, smembrato, in un calderone pieno di un filtro bollente da lei stessa preparato. Alcesti dunque sarebbe stata afflitta da forti sensi di colpa, che avrebbe cercato di compensare compiendo un transfert dal padre al marito. (7) Da notare che, secondo una versione, fu la stessa dea degli Inferi, Persefone, che rimandò sulla Terra Alcesti, ritenendo inconcepibile un sacrificio del genere. |
Testi di Euripide
Altri testi
Vedi anche Alcesti, Baccanti, Ecuba, Ippolito, Medea, Eraclidi, Andromaca