STORIA DEL MEDIOEVO
Feudalesimo e Cristianesimo medievale
L'EPOPEA NORMANNA NELL'ITALIA MERIDIONALE
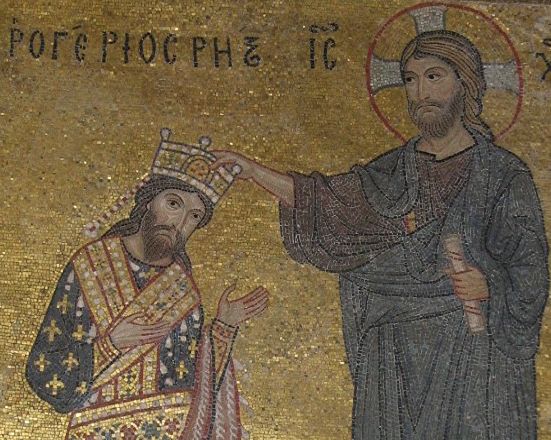
La storia dell’epopea normanna nell’Italia meridionale inizia con un condottiero, figlio di un nobile della bassa Normandia: si chiamava Rainulfo Drengot, di cui si conosce solo con certezza l’anno di morte, il 1045.
Uno dei suoi quattro fratelli, Osmondo, aveva ucciso una persona vicina al duca Riccardo II di Normandia e perciò, con l'accusa di tale assassinio, era stato bandito dal regno.
A questo punto i cinque fratelli Drengot, insieme ad una masnada di 250 guerrieri, composta da altri esiliati, militari senza terra e avventurieri senza scrupoli, decisero di trasferirsi in Puglia (1017), ove erano molto forti gli scontri tra gli ultimi longobardi rimasti nel Mezzogiorno e i bizantini, e quindi molto richiesti servigi di tipo militare.
Un principe longobardo, Melo (o Mele) di Bari (970-1020), voleva liberare la Puglia dalla presenza bizantina, con l’appoggio del papato, ma nell’insurrezione decisiva del 1011 era stato sconfitto, perdendo la città di Bari, e, in conseguenza di ciò, si era rifugiato dai principi longobardi di Benevento, Salerno e Capua, da dove, nel 1015, si era recato in Germania, presso l’imperatore Enrico II, per chiedere aiuto militare, ma ottenendo soltanto il titolo di Duca di Puglia.
Melo allora ritornò in Italia, intenzionato ad assoldare i cavalieri mercenari normanni, che fecero così la loro comparsa sulla scena politica italiana. Senonché la battaglia combattuta a Canne (1018) contro i bizantini fu per loro un vero disastro: decimate le truppe, il loro capo, Gilberto, fratello di Rainulfo, cadde in battaglia. Melo si rifugiò presso l'imperatore Enrico e morì due anni dopo in Germania.
Rainulfo intanto era diventato il nuovo capo delle rimanenti milizie normanne, che si ritirarono dalla Puglia in Campania. Qui, senza alleati e circondati da nemici, riuscirono a trarre vantaggio dalle forti rivalità che dividevano i principi longobardi. Rainulfo, in un primo tempo, si mise al servizio di Pandolfo IV, un principe longobardo che dal 1016 al 1022 era diventato padrone di Capua, una realtà statale autonoma, all'interno del Sacro Romano Impero Germanico, favorevole alla politica estera bizantina.
Capua aveva già raggiunto il suo apogeo verso la fine del X secolo, al tempo del principe Pandolfo I Testadiferro (961-981), che, con la conquista del Principato di Salerno (978), era riuscito a creare quella che verrà chiamata Langobardia Minor; egli inoltre, venendo in aiuto di papa Giovanni XIII, esule da Roma tra il 965 ed il 966, aveva ottenuto l'elevazione di metropolia per la chiesa capuana.
I normanni di Rainulfo avevano iniziato a saccheggiare, in nome di Pandolfo IV, i territori vicini a Capua, ma di tanto in tanto preferivano vendere i loro servigi militari a chi offriva di più, anche perché temevano che se un qualsiasi principe longobardo avesse riportato una vittoria decisiva sull’altro, questo avrebbe potuto giocare a loro svantaggio. Sostenendo ora l'uno ora l'altro, essi fecero sì che nessuno fosse sconfitto del tutto.
Inoltre Pandolfo IV era caduto in disgrazia agli occhi dell’imperatore tedesco Enrico II e del papato, proprio perché alleato di Bisanzio. Gli venne sottratto il principato di Capua e rischiò quasi d’essere giustiziato. Tuttavia, con l’aiuto di Rainulfo, di Guaimario III di Salerno e dei bizantini, egli riuscì di nuovo a conquistare il principato nel 1026, tenendolo fino al 1038.
Riottenuta Capua, Pandolfo IV, nel 1027, sconfisse e depose Sergio IV principe di Napoli, che però, proprio con l’aiuto inaspettato di Rainulfo, ritornò nel suo ducato. In cambio dell’appoggio militare, egli offrì a Rainulfo l'ex roccaforte bizantina di Aversa, a nord di Napoli, insieme al titolo di conte, permettendo così che si creasse il primo insediamento normanno nell'Italia meridionale (1030-1045).
Tuttavia Rainulfo, per non legarsi a un unico alleato, sposò la figlia del duca di Amalfi e nipote di Pandolfo IV di Capua. Questi atteggiamenti ambivalenti dei normanni appaiono sconcertanti, ma erano dettati dal fatto ch’essi ambivano sì a costruirsi un regno autonomo, ma si rendevano conto di non avere ancora forze sufficienti per farlo.
Intanto Pandolfo IV cominciò l'opera di espansione del proprio territorio, a spese soprattutto dell'abbazia di Montecassino, che s’era posta a fianco dell’imperatore tedesco e del papato. Conquistò anche Gaeta.
Questo atteggiamento indispose l’imperatore tedesco Corrado II, che decise di prendere Capua e di darla a Guaimario IV di Salerno, ostile ai bizantini, insieme al titolo di principe. Inoltre Corrado fece di Aversa una contea di Salerno, togliendole l’autonomia rivendicata dai normanni, pur confermando a Rainulfo il titolo di conte. Pandolfo IV nel frattempo era fuggito a Costantinopoli, cercando la protezione dei suoi vecchi alleati.
Rainulfo aveva cominciato a capire che nell’Italia meridionale né i longobardi né i bizantini avevano alcun futuro, essendo molto più potenti gli imperatori germanici, i quali però non si decidevano a intervenire in maniera decisiva, in quanto gli era impedito dallo Stato della chiesa, che ambiva anch’esso a conquistare l’intero Mezzogiorno.
Ecco perché egli cercò d’ottenere i favori di Corrado II, battagliando contro i bizantini e formalizzando la propria indipendenza da Napoli e dai suoi precedenti alleati longobardi.
Conquistò anche il principato del suo vicino Pandolfo IV e, con l’approvazione di Corrado II, lo unì al proprio, costituendo così l'entità politica più vasta di tutto il Mezzogiorno d'Italia.
Nel 1039 Rainulfo fu al fianco del principe longobardo Guaimario IV di Salerno (1013-1052) e dell'imperatore Corrado II. Il principe aveva già conquistato Sorrento e voleva espandersi nel Meridione e, a tale scopo, aveva cercato l’alleanza normanna. Grazie ai normanni e all’imperatore Corrado II, Guaimario era riuscito a ottenere il riconoscimento della sovranità su Capua, Amalfi, Gaeta e il ducato di Napoli, che giuridicamente era ancora un presidio bizantino.
Ma come arrivarono i normanni d’Altavilla in Italia?
Guglielmo d’Altavilla, detto Braccio di Ferro, insieme al fratello minore Drogone lasciò la Normandia e raggiunse il Mezzogiorno d'Italia verso il 1035, in risposta alle richieste di aiuto avanzate proprio da Rainulfo Drengot. L’aiuto non era per sé ma per il generale bizantino Giorgio Maniace, ch’era stato inviato dal basileus Michele IV in Sicilia allo scopo di riconquistarla ai musulmani. L’esercito di Maniace riuscì in breve a occupare la parte orientale dell’isola, ma a causa di contrasti interni con un altro generale bizantino, l’impresa era fallita.
Fu a questo punto che i longobardi e i normanni, presenti in quell’esercito, cercarono di approfittarne per annettersi la Puglia bizantina.
Guaimario IV approvò l'elezione a conte di Puglia di Guglielmo d’Altavilla, ottenendo in cambio l'acclamazione popolare a Duca di Puglia e Calabria (1043), in aperta opposizione alle rivendicazioni bizantine.
Guaimario garantì ai normanni il dominio diretto su Melfi e nel 1044, insieme a Guglielmo, iniziarono la conquista della Calabria.
Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita, Guaimario incontrò molte difficoltà nel conservare i suoi possedimenti contro le rivendicazioni degli imperatori tedeschi e anche dei normanni, fino a quel momento suoi fedeli vassalli.
Rainulfo Drengot, che aveva continuato a tenere il dominio di Aversa, morì nel 1045, senza lasciare figli, e il suo feudo, contro le proteste di Guaimario IV, passò al nipote Asclettino II, figlio di suo fratello Asclettino I. Già nel 1042, dopo la vittoria del suo alleato normanno Guglielmo d'Altavilla, Rainulfo aveva ottenuto la sovranità su Siponto e il Gargano, ex territori bizantini.
Queste contese spinsero Aversa ad allearsi con Pandolfo IV, tornato dal suo esilio di Costantinopoli per combattere Guaimario nel 1042. La guerra contro Pandolfo durò cinque anni, durante i quali Guaimario IV rafforzò la propria posizione attraverso un rapido riconoscimento, nel 1046, della propria sovranità da parte del fratello del defunto Guglielmo, Drogone d'Altavilla, al quale concesse in sposa la sorella Gaitelgrima. L'obiettivo era chiaramente quello di mantenere i normanni dalla sua parte e in posizione di vassallaggio.
Nel 1047 l'imperatore Enrico III, figlio di Corrado, rese suoi vassalli i Drengot e gli Altavilla: fu una svolta per i normanni.
Guaimario e Drogone d'Altavilla continuarono a mantenere solidi rapporti di alleanza, costituendo insieme una potenza politica e militare invisa a molti. Drogone infatti cadde assassinato nel 1052, probabilmente ad opera di una congiura bizantina. Stessa sorte toccò subito dopo allo stesso Guaimario, che fu assassinato nel porto di Salerno dai suoi quattro cognati, che occuparono la città con le armi ed elessero principe Pandolfo V (1050-1057).
A questo punto il fratello del principe ucciso, il duca Guido di Sorrento, si rivolse ai due normanni, Umfredo di Puglia e Riccardo d'Aversa, che insieme a lui assediarono i congiurati in Salerno. Le famiglie dei quattro fratelli caddero presto nelle mani dei loro nemici e gli assassini di Guaimario si decisero a negoziare il loro rilascio rimettendo in libertà Gisulfo, figlio ed erede di Guaimario.
Guido accettò la loro resa poco dopo e fece giuramento di non ricorrere a vendette o ritorsioni. Diversamente, i normanni, che non si ritennero sottoposti al giuramento di Guido, massacrarono Pandolfo V con i suoi scagnozzi, e i quattro fratelli insieme ad altri trentasei familiari, uno per ciascuna coltellata ritrovata sul corpo di Guaimario. In questo, i normanni si dimostrarono leali a Guaimario fin oltre la morte. Essi conquisteranno il principato di Capua nel 1059.
L'eredità di Guaimario includeva il dominio su Salerno, Amalfi, Gaeta, Napoli, Sorrento, Puglia, Calabria e in maniera alterna su Capua. Egli fu senz'altro l'ultimo grande principe longobardo del sud Italia, che seppe con abilità servirsi del favore papale ed imperiale d'occidente, e della spada dei normanni.
Dopo la sua morte l’Italia meridionale sarà tutta conquistata dai normanni. Dalla primitiva base di Aversa, nel volgere di un secolo, i normanni saranno in grado di creare il grande Regno di Sicilia. Il ducato di Napoli sarà l'ultimo territorio a cadere in mano normanna, con la capitolazione del duca Sergio VII di Napoli nel 1137.
Parte prima - Parte seconda - Parte terza - Parte quarta - Parte quinta