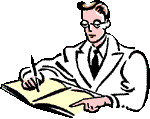|
|
IL DIRITTO ALLA
CULTURA
|
|
INTERVENTI DI DAIMON 1-2-3-4-5-6-7
NOTE INEDITE SU COPYRIGHT E COPYLEFT (2005) di WU MING
1. I due corni del falso dilemma
2. Nascita del copyright e censura: contro il "mito delle origini" liberista
3. Google Print e affini: rete, gratuità e battaglie di retroguardia
1. I due corni del falso dilemma
Partiamo dalla fine: il copyleft si basa sulla necessità di coniugare due esigenze primarie, diremmo due condizioni irrinunciabili del convivere civile. Se smettiamo di lottare perché si soddisfino questi bisogni, smettiamo di auspicarci che il mondo migliori.
Non vi è dubbio che la cultura e i saperi debbano circolare il più liberamente possibile e l'accesso alle idee dev'essere facile e paritario, senza discriminazioni di censo, classe, nazionalità etc. Le "opere dell'ingegno" non sono soltanto prodotte dall'ingegno, devono a loro volta produrne, disseminare idee e concetti, concimare le menti, far nascere nuove piante del pensiero e dell'immaginazione. Questo è il primo caposaldo.
Il secondo è che il lavoro deve essere retribuito, compreso il lavoro dell'artista o del narratore. Chiunque ha il diritto di poter fare dell'arte e della narrazione il proprio mestiere, e ha il diritto di trarne sostentamento in un modo non lesivo della propria dignità. Ovviamente, siamo sempre nel campo delle condizioni auspicabili.
E' un atteggiamento conservatore pensare a queste due esigenze come ai corni di un dilemma insolubile. "La coperta è corta", dicono i difensori del copyright come lo abbiamo conosciuto. Libertà di copia, per costoro, può significare solo "pirateria", "furto", "plagio", e tanti saluti alla remunerazione dell'autore. Più l'opera circola gratis, meno copie vende, più soldi perde l'autore. Bizzarro sillogismo, a guardarlo da vicino.
La sequenza più logica sarebbe: l'opera circola gratis, il gradimento si trasforma in passaparola, ne traggono beneficio la celebrità e la reputazione dell'autore, quindi aumenta il suo spazio di manovra all'interno dell'industria culturale e non solo. E' un circolo virtuoso.
Un autore rinomato viene chiamato più spesso per presentazioni (a rimborso spese) e conferenze (pagate); viene interpellato dai media (gratis ma è tutto grasso che cola); gli si propongono docenze (pagate), consulenze (pagate), corsi di scrittura creativa (pagati); ha la possibilità di dettare agli editori condizioni più vantaggiose. Come può tutto questo... danneggiare le vendite dei suoi libri?
Parliamo ora del musicista/compositore: la musica circola, piace, intriga, intrattiene; chi l'ha scritta o chi la esegue ne ha un "ritorno d'immagine", e se sa come approfittarne viene chiamato a esibirsi più spesso e in più occasioni (pagato), ha la possibilità di incontrare più persone e quindi più committenti, se "si fa un nome" gli si propongono colonne sonore di film (pagate), serate come DJ (pagate), "sonorizzazioni" (pagate) di eventi, feste, mostre, sfilate; può addirittura trovarsi a dirigere (pagato) un festival, una rassegna annuale, cose del genere; se parliamo di artisti pop, mettiamoci anche i proventi del merchandising, come le T-shirt vendute via web o ai concerti...
Ecco il "dilemma" risolto nei fatti: si sono rispettate le esigenze dei lettori (che hanno avuto accesso a un'opera), degli autori/compositori (che ne hanno avuto ritorni e tornaconti) e di tutto l'indotto della cultura (editori, promoter, istituzioni etc.).
Cos'è successo? Perché il sillogismo è franato in modo tanto repentino sotto i colpi degli esempi? Perché tale sillogismo non mette in conto la complessità e la ricchezza delle reti e degli scambi, il passaparola incessante da un medium all'altro senza soluzione di continuità, le possibilità di diversificazione dell'offerta, il fatto che il "ritorno economico" per l'autore può percorrere diversi tragitti, alcuni (apparentemente) tortuosi.
E' a causa di questa incapacità di figurarsi la complessità che l'industria culturale (soprattutto quella discografica) ha perso i primi cinquanta treni dell'innovazione telematica, vivendo le nuove opportunità tecnologiche come minacce anziché come sfide, reagendo in modo scomposto a Napster e a tutto quello che è seguito. Cominciano a muoversi adesso, a cavalcare la tigre dopo che Steve Jobs ha dimostrato che si può fare, ma nel frattempo sono andati allo scontro con eserciti di potenziali clienti, la cui fiducia è persa per sempre. Anti-marketing.
Qual è l'ultima cosa che dovrebbe fare uno che produce e vende musica? Sicuramente criminalizzare chi li ascolta, trascinare in tribunale chi la ama etc. Ne valeva la pena? Secondo noi no. Il "diritto d'autore" (attenzione, però, a non prendere sul serio quest'espressione semi-truffaldina!) come lo abbiamo conosciuto è ormai un freno al mercato. Al contrario, il copyleft (che non è un movimento né una "ideologia", è semplicemente il vocabolo-ombrello per una serie di pratiche, istanze e licenze commerciali) incarna tutte le esigenze di riforma e adeguamento delle leggi sul copyright, in direzione di uno "sviluppo sostenibile".
La "pirateria" è endemica, è irreprimibile, è marea montante portata dal vento dell'innovazione tecnologica. Certo, i potentati dell'industria dell'intrattenimento possono continuare a far finta di niente, come la Casa Bianca ha fatto finta che non ci fossero effetto-serra, riscaldamento globale e sconvolgimenti climatici in corso. In entrambi i casi, chi nega la realtà verrà travolto. Ostìnati a non ratificare il Protocollo di Kyoto, ostìnati a non investire su fonti energetiche rinnovabili e alternative al petrolio, ostìnati a non voler risolvere i problemi ambientali, e prima o poi t'arriva tra capo e collo l'uragano Katrina (e ce n'est qu'un debut!).
2. Nascita del copyright e censura: contro il "mito delle origini" liberista
Torniamo all'ABC, mettendo in fila fatti noti e più volte ricordati. La storia del copyright comincia in Inghilterra nel XVI° secolo. La diffusione della stampa, la possibilità di distribuire tante copie di uno scritto, galvanizza chiunque abbia qualcosa da dire, soprattutto di politico. C'è un boom di pamphlet e giornali. La Corona teme la diffusione di idee sovversive e decide di affidare a qualcuno il controllo di quel che si stampa.
Nel 1556 nasce l'ordine degli Stationers [editori-tipografi-librai], casta professionale a cui viene concesso in esclusiva il "diritto di copia" [copy right], e quindi ha il monopolio delle tecnologie di stampa. Chiunque voglia stampare qualcosa deve passare al loro vaglio. Fino a quel momento era diverso, chiunque poteva farsi stampare copie di un'opera letteraria o teatrale, l'autore non si preoccupava perché non deteneva i diritti (che non esistevano), la cosa importante era che le opere circolassero e aumentassero la fama dell'autore, che in quel modo avrebbe intercettato i desideri di più committenti (mecenati privati, enti culturali di vario genere come teatri etc.) Da lì in poi, invece, un'opera potrà andare in stampa solo se otterrà il visto (in pratica, il placet della censura di stato) e sarà segnata sul registro ufficiale - attenzione a questo dettaglio! - a nome di uno stationer. Quest'ultimo diverrà il proprietario dell'opera nell'interesse dello stato.
Tutta la mitologia "liberista" sul copyright come diritto naturale, che nasce spontaneamente grazie alla crescita e alle dinamiche del mercato... sono tutte fandonie! L'origine remota del copyright sta nella censura preventiva e nella necessità di restringere l'accesso ai mezzi di produzione della cultura (leggi: restringere la circolazione delle idee).
Trascorre un secolo e mezzo e in questo periodo l'autorità della Corona subisce attacchi inauditi: la ribellione scozzese del 1638, la "Grande Rimostranza" parlamentare del 1641, lo scoppio della guerra civile nell'anno successivo, la rivoluzione di Cromwell con tanto di decapitazione del re... Alla fine degli anni cinquanta del XVII° secolo nel Paese torna la monarchia, ma la situazione rimane instabile e finalmente il Parlamento riesce a imporre alla Corona una Dichiarazione dei diritti. Da quel momento, la monarchia inglese sarà una "monarchia costituzionale".
Era necessario elencare questi eventi per far capire quanto si modifichi, in centocinquant'anni, l'atteggiamento nei confronti del sovrano, quindi anche della censura preventiva, e di conseguenza anche del potere degli stationers. Nei confronti di questi ultimi c'è sempre più insofferenza, così si decide di abolire il monopolio sul diritto di stampa.
Gli stationers verrebbero colpiti dove fa più male, cioè nel portafogli, quindi reagiscono con rabbia. Iniziano a fare pressioni perché l'imminente nuova legge riconosca i loro legittimi interessi e si volga comunque a loro vantaggio. Ecco la nuova argomentazione: il copyright appartiene all'autore; l'autore, però, non possiede macchine tipografiche; tali macchine le possiede lo stationer; ergo: l'autore deve comunque passare attraverso lo stationer. Come regolare tale "passaggio"? Semplice semplice: l'autore, nel proprio interesse a che l'opera venga stampata, cederà il copyright allo stationer per un periodo da stabilirsi.
Alla foce, la situazione resta più o meno invariata. A cambiare è la sorgente, il presupposto giuridico. La giustificazione ideologica non si basa più sulla censura, ma sulle necessità del mercato. Tutte le conseguenti mitologie sul diritto d'autore derivano dallo stratagemma argomentativo della lobby degli stationers: l'autore è di fatto costretto a cedere i diritti, ma è costretto... per il proprio bene.
I contraccolpi psicologici saranno devastanti, si arriverà a una variante della "Sindrome di Stoccolma" (l'amore del sequestrato per il proprio rapitore), autori che si mobilitano in difesa di uno statu quo che si fonda sul loro stare ai piedi del tavolo in attesa degli avanzi e di una carezza sulla testa, pat! pat! wuf!
La legge è il celebre "Statute of Anne" - capostipite di tutte le leggi e gli accordi internazionali sul diritto d'autore, fino alla Convenzione di Berna del 1971, al Digital Millennium Copyright Act, al Decreto Urbani et cetera - ed entra in vigore nel 1710. E' la prima definizione legale del copyright come si è continuato a intenderlo fino a oggi, o meglio, fino a stamattina, perché dopo mezzogiorno qualcuno ha cominciato ad avere dei dubbi. I dubbi derivano dal fatto che oggi la "copia" è possibile a molte più persone, forse a quasi tutti.
Buona parte di noi ha in casa gli eredi domestici delle tecnologie di cui gli stationers avevano il monopolio. Per fare la copia di un'opera non è più necessario passare attraverso un ordine professionale. Gli eredi degli stationers vengono scalzati dalla rivoluzione microelettronica iniziata negli anni Settanta, dall'avvento del digitale, dalla "democratizzazione" dell'accesso al computing. Prima la fotocopiatrice e l'audiocassetta, poi il videoregistratore e il campionatore, poi il masterizzatore cd e il peer-to-peer, infine le memorie portatili tipo i-Pod... Come si può pensare che sia ancora valida la giustificazione ideologica del copyright, quella che diede forma allo Statute of Anne?
E' chiaro che va tutto rivisto, questo processo cambia faccia, cervello e cuore dell'intera industria culturale! Occorrono nuove definizioni dei diritti di chi crea, di chi produce, di chi mette a disposizione. Se una "opera dell'ingegno" può giungere al pubblico senza la mediazione di un editore, di un discografico, di produttori televisivi o cinematografici, sono questi ultimi a dover interrogarsi su come proseguire, a dover inventarsi qualcosa, a dover ridefinire il proprio ruolo imprenditoriale e la propria ragione sociale. Cercare di mantenere con la minaccia della galera un monopolio che non ha più basi significa imbucarsi in un vicolo cieco, è un comportamento da Ancien Régime, da autocrazia zarista. Per fortuna qualcuno comincia a rendersene conto.
3. Google Print e affini: rete, gratuità e battaglie di retroguardia
Google Print, Creative Commons, copyleft etc. sono progetti e concetti diversi, ma in realtà vanno tutti nella stessa direzione, come vanno nella stessa direzione biblioteche e librerie. Nelle prime si accede al libro gratuitamente, nelle seconda lo si acquista, ma non c'è scontro tra le due opzioni: i paesi dove si vendono più libri sono anche quelli in cui più si frequentano le biblioteche. E' normale: più il libro circola, più lo si legge, più ritorno positivo c'è per l'editoria. Il download libero e gratuito di un testo e la sua "navigabilità" in stile Google Print hanno una finalità comune e ambiscono allo stesso risultato: entrambi vogliono rendere i prodotti culturali accessibili on line, e questo può favorire la vendita di libri.
La parola-chiave è proprio "biblioteche". si parla di una lunga tradizione di gratuità dell'accesso, soltanto di recente messa in discussione (e la battaglia è ancora in corso).
Che si parli di biblioteche di mattoni o biblioteche di elettroni, sempre biblioteche sono. Se invece il download è a pagamento, allora si tratta di librerie, su per giù come quelle che siamo abituati a conoscere, non è difficile immaginare la modalità di prelievo del diritto d'autore, è una cosa piuttosto semplice. Detto questo: Seth Godin, uno dei più grandi filosofi del marketing, dice che se un e-book a pagamento viene comprato da tot persone, lo stesso e-book, reso gratuito, verrà scaricato da tot moltiplicato per quaranta. L'informazione utile si ottiene invertendo il dato: su quaranta persone che scaricano un e-book gratis, ce n'è una disposta a comprarlo. La somma di quegli "uno su quaranta" corrisponde allo "zoccolo duro" dei lettori, quelli che comprano per primi, che fanno partire il passaparola. Sono i connettori, gli "evangelisti", i buzzers. Ogni mossa va fatta avendo in testa questo insieme di persone. Godin, poi, fa così: le nuove uscite (elettroniche e cartacee) sono a pagamento. Poco prima di una nuova pubblicazione, mette scaricabile gratis quella precedente. E' una strategia di lancio formidabile. Gli editori che si oppongono a Google Print sono come quegli studios cinematografici che, venticinque anni fa, denunciarono i produttori di videoregistratori e videocassette, dicendo che la registrazione domestica violava il copyright. Il famoso caso "Universal contro Betamax".
La Universal arrivò fino alla Corte Suprema e perse... per fortuna sua. Negli anni a seguire, l'industria cinematografica ha realizzato la maggior parte dei suoi profitti non nelle sale ma grazie all'home video. E' sopravvissuta alla crisi delle sale grazie al VHS e poi al DVD. Se Universal e compagnia avessero vinto, a quest'ora sarebbero morti e sepolti. Ma hanno perso, e quindi si sono salvati.
Si potrebbe citare anche l'assurda battaglia dei discografici contro l'introduzione sul mercato delle musicassette, negli anni '70, preludio alla guerra senza quartiere contro il download, quando (iTunes lo ha dimostrato) bastava fornire agli utenti un canale di accesso legale a questa risorsa.
Anche questa degli editori è una battaglia suicida contro un'innovazione potenzialmente vantaggiosa. Per il loro bene, gli editori devono perdere. Vincendo, si assesterebbero una formidabile martellata nei cosiddetti.
(stralci di corrispondenza privata e risposte a interviste inedite in
italiano. da carmillaonline.com del 6 Novembre 2005)
www.wumingfoundation.com
SENTENZA ANTICOPYRIGHT E CYBERAGONIA DEL DIRITTO D'AUTORE
Se il copyright attuale è antiumanesimo, sopraffazione economica e morale dell'uomo sull'uomo con la scusa dell'arte, ben venga l'anticopyright. Essere giusti non significa sempre accettare lo status quo.
Le quattro sentenze anticopyright emesse dallo scrivente il 15 febbraio 2001, che assolvevano quattro extracomunitari venditori per strada di cd contraffatti per stato di necessità, sono state una rivoluzione globale e personale. Da quell'atto di coraggio, in apparenza stridente con il ruolo di un giudice ma comprensibile perché dietro quel ruolo istituzionale c'è il fondatore del movimento Antiarte 2000, è nato uno scossone tra gli oligopoli produttori di arte ad altissimo costo ma soprattutto un plauso incondizionato in rete.
Subivo, intanto, in seguito a un'interrogazione parlamentare un'azione disciplinare ministeriale per quelle sentenze ritenute "abnormi", fortunatamente conclusa con un proscioglimento. Il CSM ribadiva la correttezza dei principi esposti in quelle pronunce e insieme la libertà e l'indipendenza della magistratura soprattutto in rapporto alla facoltà di portare avanti nuove visioni del mondo e della giustizia. Ed è così che l'entusiasmo è aumentato e con esso la voglia di approfondire quella cyberrivoluzione che avevo intuito e portato avanti nel mio verdetto.
La sentenza è rivoluzionaria perché abbatte in re il sistema del copyright rilevando che:
La norma repressiva di base, la protezione penalistica - e non meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di cd per strada o scaricano MP3 da Internet. Anche grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e hanno permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno appena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei produttori è quantificato su "minimi diffusissimi"[1].
La rivoluzione era quella annunciata dal mondo delle cose concrete, dai popoli che bypassano le norme repressive e indicano comportamenti dettati dalle stesse tecnologie riproduttive dei beni immateriali, prendendosi a piene mani quello che i produttori-distributori vorrebbero vendere a prezzi esorbitanti.
Emerge dalla sentenza questa sete spasmodica delle masse di usufruire liberamente dei prodotti dell'arte e della cultura, senza ingombri economici, culturali, censori. C'è voglia globalizzata di accedere in maniera totale e inebriante ai beni immateriali che danno gioia, elevano gli animi, dissuadono i giovani dalle droghe artificiali e dalle azioni malefiche. C'è voglia di ubriacarsi, liberamente e fraternamente, alle fonti delle arti, della cultura, delle idee, spazzando via le pastoie dei grassatori del copyright. Copyright che, è dimostrato, si è sviluppato nei secoli solo per far arricchire produttori e distributori, oltre a qualche star, a scapito della massa degli artisti e soprattutto degli usufruenti tutti dell'arte e della cultura.
La sentenza anticopyright nasceva da una consapevolezza dello scrivente che già da anni studiava la disgregazione della proprietà intellettuale. Elaborando il MANIFESTO "IPERTRANSAVANGUARDIA DEL MEDIOEVO ATOMICO" (poi ANTIARTE 2000), pubblicato nel 1997[2], già in quel tempo esprimevo l'idea che l'autore è solo il portavoce di un messaggio d'arte universale, che egli esprime in nome dell'Umanità; dal che deriva che non ha la proprietà intellettuale delle sue opere ma il mero possesso (detentio) delle forme artistiche, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà né assoluta né relativa sul prodotto. Quest'idea era già nell'aria tanto che Joost Smiers arrivava addirittura a considerare la proprietà intellettuale un autentico furto[3].
Il concetto fu esplorato più a fondo nella Dudda: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE. Quella dichiarazione venne elaborata dallo scrivente e firmata nel novembre 2002 da una serie di artisti, intellettuali, rappresentanti di associazioni culturali presso il Museo del Cinema di Roma, nel corso di un sit in per salvare il Museo che rischiava di essere cacciato dalla sua sede per farne al suo posto un centro commerciale.
Nel preambolo alla DUDDA si affermava un principio chiave per il ribaltamento radicale degli attuali rapporti tra produttori-distributori di arte e cultura da una parte, creativi e massa dei fruitori dall'altra. Si asseriva il primato dell'arte e della cultura sull'economia che rende la tutela del diritto all'arte e al sapere dell'uomo prioritaria di fronte ad ogni altro interesse materiale ed economico. Attraverso quest'ultima via veniva ribadito il principio già espresso nella sentenza anticopyright, là dove si afferma il nuovo cybervangelo connesso al diritto di accesso totale all'arte e alla cultura:
Anche la New Economy depone nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e, quindi, usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte che impongono prezzi alti, contrari a un'economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice[4].
L'azione degli oligopoli produttivi appare, quindi, in contrasto con l'art. 41 della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici[5].
Nel preambolo alla DUDDA veniva espressa un'altra chiave di rivoluzione del copyright, posta a base di un ribaltamento sociale epocale in cui Internet diventa strumento di realizzazione finale - in chiave realmente democratica - dei principi della Rivoluzione Francese. Si affermava che "il riconoscimento da parte della specie umana del diritto alla creatività e al sapere, fondato su Liberté, Egalité, Fraternité, costituisce il fondamento della coesistenza della vita nel Mondo". Si aggiungeva "che un concreto diritto di accesso all'arte e alla cultura - inteso in rafforzativo quale diritto a non essere esclusi - è fondamentale per l'elevazione dell'Uomo, il che si realizza sostituendo l'attuale modello gerarchico a Piramide della società con la nuova struttura Sferica di platonica memoria".
Dal che si ricava il superamento di fondo dell'ideologia sottesa al Decreto Urbani. Vediamolo questo decreto, approvato il 18 maggio 2004 dall'aula del Senato, prima cercando di vedere cos'è il sistema informatico attaccato e come funziona.
Il P2P incriminato, ovvero il peer to peer, offre letteralmente uno scambio di informazioni alla pari, attraverso cui tutti possono scaricare dati e farli scaricare ad altri, senza nessun tipo di limitazione e/o obbligo di sorta. Le reti P2P sono gestite e mantenute dagli stessi client/server, qualunque essi siano, che si "preoccupano" di tenerci collegati ad un determinato numero di computers e, quindi, di mandare le nostre ricerche alla rete.
Le reti P2P non sono solamente luoghi dove scambiare files, ma ci si può scambiare qualsiasi tipo di informazione dal che è evidente la loro forza comunicativa e rivoluzionaria dal punto di vista del sapere fraterno fra gli uomini. Basti pensare che in questo momento migliaia di computer si scambiano informazioni in maniera del tutto trasparente e senza regole precise, tutto ciò grazie a questo protocollo (peer to peer).
Le reti P2P cambieranno in modo sostanziale il nostro modo di comunicare, possibilmente rivoluzionando parte del nostro sistema economico-sociale di cui la cosiddetta "piaga" dello scambio di musica on-line che l'industria discografica non riesce a fermare è solo la punta di un iceberg.
Il peer to peer, che oggi è anche sviluppo, ricerca scientifica, è stato, dunque, fatto oggetto di sanzionamento amministrativo e penalistico da parte del decreto Urbani approvato. Rispetto alla precedente formulazione sono attenuate le sanzioni, ma esse sono state estese a tutte le opere dell'ingegno.
E' riconosciuta la liceità dell'uso personale. Per chi immette e scarica per uso personale copie pirata, la sanzione amministrativa (passata da 1.500 a 154 euro come previsto dalla legge sul diritto d'autore), sale a 1.032 in caso di reiterazione. Resta la confisca dei materiali e la pubblicazione della condanna sui giornali per chi duplica cd e dvd non per scopo personale.
Sanzioni penali, invece, per chi fa commercio o trae profitto dall'illecita attività (reclusione da tre mesi a sei anni). Lo scambio di brani musicali e audiovisivo (file-sharing) è consentito solo a condizione che si tratti di file dotati degli appositi avvisi informativi, previsti dalla legge sul diritto d'autore. Se il file non sarà provvisto di avviso, chi lo immette commetterà un reato.
Viene introdotto un prelievo del 3% per i produttori, destinato alla Siae, sul prezzo di listino dei masterizzatori. Se la quota non è versata, ne deriva una sanzione doppia (6%) per i produttori. E' affidato all'autorità giudiziaria e non al ministero dell'Interno il compito di intervento per violazioni per via telematica (come previsto da art. 15 Costituzione). E' stato eliminato il rafforzamento sulla funzione di controllo dei provider.
Andando non contro ma oltre il Decreto Urbani, noi dell'Antiarte affermiamo che gli omini hanno diritto di scambiarsi informazioni, arte, cultura soprattutto attraverso Internet senza che chicchessia possa limitare il loro potere, essendo prioritaria la tutela di quel diritto di scambio rispetto a beceri interessi economici degli oligopoli produttori-distributori non di arte - là sono i creativi titolari di diritti - ma di copie puramente materiali.
E' un falso problema quello secondo cui copiare le opere senza compenso comprometta la sopravvivenza economica degli artisti, perché questi guadagnano proprio dalla diffusione in sé della propria arte e cultura. E' quello il loro intento primario, spirituale ed anche materiale, ovvero il profitto della diffusione su scala quanto più ampia possibile della propria arte e cultura, essendo il lucro un elemento succedaneo e conseguenziale.
La diffusione dell'immagine di un creativo, soprattutto via Internet, di per sé è fonte di guadagno sia come omesso investimento personale(l'opera si diffonde senza che l'autore spenda alcunché), sia come profitti occulti e conseguenziali perché la nuova industria dell'arte e cultura, o quella vecchia decrepita, lo gratificheranno anche economicamente per poter avere la sua opera, i suoi discorsi, le sue apparizioni mediatiche.
Il nuovo mercato senza produttori-distributori squali sarà proprio di una società aperta dove i vecchi produttori, ridotti plebiscitariamente via Internet a misura d'uomo, dovranno solo riciclare i loro investimenti che assumeranno altre forme.
Intanto non c'è più il mercato dominante dei produttori-distributori che impongono prezzo e tirannia nello scambio dell'arte-cultura, ma ci sono i mercati. Lo stesso prodotto artistico-culturale viene smerciato nelle varie tecnologie parallele.
La prima via è Internet col che si consentirà a chiunque di fruire di quel prodotto, di vederlo, scaricarlo nel computer a prezzo pressoché zero. Nella sentenza anticopyright si afferma al riguardo:
Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o di gift economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si passa da relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo e dal commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono talmente rapide che il possesso diventa una realtà ormai superata"[6].
A questo si aggiungerà la possibilità di riprodurre l'opera con mezzi tecnologici interni(una stampante) o esterni (tipografie che si specializzeranno in confezioni dei prodotti personalizzate, soprattutto digitalizzate e a bassissimo costo)[7].
La seconda via è quella tradizionale dove un produttore riproduce l'opera in serie per poi distribuirla tra librai, edicole etc.. Il prodotto probabilmente costerà di più rispetto al precedente ma, chi è preso dal furor d'aver libri e soprattutto avrà i soldi per comprarlo, lo comprerà.
Vi sarà, comunque, un plafond nei ricavi economici. Quando verrà sfondato il tetto stabilito dalla legge, la somma eccedente sarà messa in un fondo di solidarietà per gli artisti deboli(emergenti, giovani, poveri, anziani, malati, etc.).
Quanto alla SIAE essa svolge allo stato una funzione passiva, limitandosi a intervenire in intermediazione per proteggere i diritti morali ed economici degli autori. Dovrebbe essere, invece, rigenerata per assumere una funzione propulsiva dell'arte e della cultura, soprattutto proteggendo gli autori deboli, i talenti etc. attualmente bistrattati e trascurati dal mercato famelico e piramidale che porta avanti sempre gli stessi creativi, i più "forti socialmente" e neppure i migliori talora.
Dovrebbe la SIAE coi compensi sforanti delle star creare dei fondi di solidarietà per gli artisti deboli, onde ridistribuire il lucro equamente tra tutti i creativi, proprio per eliminare lo squilibrio tra gli affermati e i non.
Dovrebbe la SIAE incrementare gl'interventi sociali e istituzionali a favore delle forze creative emergenti, controllare la distribuzione dei finanziamenti pubblici, anche questi spesso destinati ai forti e ai ben agganciati politicamente(spesso sempre gli stessi) a scapito degli artisti puri, che hanno in orrore ricorrere ai maneggi, frustrati dalla mancata attribuzione di fondi che in uno stato democratico dovrebbero a rotazione, d'embleé, spettare a tutti.
La SIAE dovrebbe combattere contro le ingiuste tassazioni statali, che aiutano a portare alle stelle i prezzi dei prodotti artistici[8].
Insomma alla SIAE, trasformata in SIA, società di solo difesa degli autori(e non più degli editori), affidiamo il compito nuovo e luminoso di indebolire i creativi forti e rafforzare i deboli, tenendo presente che se i primi emergono ciò è col sacrificio della massa degli artisti, che si vedono precluse le vie alte del successo o quanto meno della decente manifestazione della loro opera.
Nel nuovo progetto la SIAE "riciclata" sarà diretta a tutelare realmente gli
autori, soprattutto quelli fragili, e non più i produttori e i distributori
com'è adesso. Oggi la SIAE combatte i cosiddetti pirati che usufruiscono di
musica, libri etc. senza pagare diritti; domani garantirà la libera diffusione
del sapere e attaccherà i nuovi pirati, ovvero i produttori-distributori che
tralignino, superando i plafond di lucro stabiliti
per legge.
Tornando all'oggi, quanto alla borsa per acquistare arte e cultura, ciò di cui non si tien conto nei decreti alla Urbani è che, se davvero una persona volesse comprare tutti i prodotti di cui necessita il suo spirito(libri, musica, film, video etc.) nelle vie cosiddette legali, ci vorrebbero enormi patrimoni che non ci sono. E, allora, perché privarsi di questa ricchezza enorme di arte-cultura che fa così bene agli uomini, è panacea ai nostri giovani dissuadendoli dalle vie dei paradisi artificiali?
Tutto quanto detto è in linea a con l'articolo 6 della DUDDA dove si afferma; "All'autore dell'opera è riconosciuto il diritto morale d'autore e il mero possesso a nome altrui (detentio) delle forme artistiche, con un ridotto diritto di sfruttamento commerciale, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà assoluta sul prodotto artistico". Ergo l'autore ha solo diritti provvisori e limitati. Se egli si allea con partners produttori-distributori tradizionali, potrà operare lo sfruttamento della sua opera al di sopra del costo zero ma per mera concessione graziosa dell'Umanità. Egli dovrà, comunque, concedere che chiunque non abbia la somma necessaria per acquistare il prodotto o, pur avendola non voglia spenderla(per lo meno in vista della massa di prodotti da acquisire), l'acquisisca in via informatica, digitalizzata etc..
Concludendo è evidente che, a fronte dello scontro titanico oggi in atto tra il cyberspazio e l'ulespazio[9], i movimenti per la libertà e l'uguaglianza reali dell'uomo passano attraverso la fratellanza internettiana che abbatterà la tirannia attuale dei produttori-distributori impregnati di old economy. Questa comunità è stata annunciata nella sentenza anticopyright che sottende un nuovo principio metacostituzionale: il prevalere del Sapere sull'Economia. Ed oggi il Sapere dei Saperi è Internet. Solo attraverso il cyberspazio iperaperto - che è comunicazione galattica - è possibile compiere quel grande salto di qualità che permetterà di realizzare in concreto, e non a chiacchiere costituzionalizzate, i principi della Rivoluzione Francese per realizzare l'Utopia dell'Uomo Libero, Eguale e soprattutto Fraterno.
Di fronte a queste evidenze i decreti alla Urbani sono solo sassi che saranno travolti dall'Oceano di Internet. I più grandi megastore del mondo oggi non possono rivaleggiare con la ricchezza del catalogo disponibile sui sistemi di file sharing. E la gente lo vuole quel catalogo universale perché così si arricchisce dentro. E lo manterrà quel catalogo malgrado le leggi pro copyright che sono contro il popolo, contro il mondo assetato d'arte, di sapere e di cultura. Il fatto stesso che si sia parlato di "repressione simbolica" da parte del legislatore nel caso del decreto Urbani dimostra non tanto un pudore interno quanto la sotterranea consapevolezza di combattere una battaglia perduta.
Quel decreto o altri cento decreti emessi nel mondo in quella linea inutilmente repressiva non riusciranno ad arrestare il popolo d'Internet, emblema della popolazione mondiale soggiogata da una legge sul copyright che non risponde ai tempi e che non vuole più.
Nessun decreto è concepibile che riesca a metterci tutti dentro; men che mai che qualcuno vada dentro com'è capitato recentemente - horribile dictum - in Grecia per un compratore per strada di cd contraffatto; nessun decreto riuscirà a fermare la nostra voglia di sapere e di cultura per il bene stesso dell'Umanità.
Gli argini molto chiari innalzati contro la dissoluzione del copyright non crolleranno: sono già crollati!
Per Ulteriori Approfondimenti si veda il sito www.antiarte.it
1) G. FRANCIONE, DECALOGO DAL MANIFESTO "IPERTRANSAVANGUARDIA DEL MEDIOEVO
ATOMICO"(POI ANTIARTE 2000)pubbl. sulla rivista Dismisura(Anno XXV, n° 115-117
gennaio 1997), p. 108.
2) DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE(DUDDA) firmata al Museo del
Cinema di Roma Via Portuense 101 l'11 novembre 2002
NOTE
[1] La sentenza riporta la situazione al 2001. Napster è tramontato ma poi
sono apparsi i
suoi cloni.
[2]Vedi allegato A).
[3]Vedi Joost Smiers, La proprietà intellettuale è un furto, artic. pubbl. su
http://www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Settembre-2001/0109lm28.01.html.
Smiers è direttore del centro di ricerche e professore ordinario all'Università
delle arti, Utrecht (Paesi Bassi). In particolare è autore di Etat des lieux de
la création en Europe. Le tissu culturel déchiré, L'Harmattan, Parigi, 1999.
[4]Nel saggio di G. Francione, Hacker, i Robin Hood del Cyberspazio, Lupetti,
Milano 2004, si avanza l'ipotesi di una "legittima difesa economica". Vedi anche
la rivista Tutto da capo, Lupetti, maggio 2004.
[5]Per una lettura integrale della sentenza vedi
www.antiarte.it/eugius/sentenza_anticopyright.htm
[6]Vedi New economy in
mediamente.rai.it/biblioteca .
[7]Un esempio della nuova produzione anticopyright è offerto dal sito animalista
Nuova Etica, diretto da Massimo Tettamanti(dottore in chimica) e Marina Berati
(ingegnere elettronico). Nuova Etica si propone di distribuire gratuitamente,
romanzi, saggi, poesie e materiale informativo sugli animali creando libri e
opuscoli. Ognuno può scaricare dal sito la versione elettronica delle
pubblicazioni, in formato PDF, e farne l'uso che vuole. In una seconda procedura
è anche disponibile la versione stampata e rilegata, nel normale formato dei
libri da libreria. In questo caso i gestori chiedono solo la copertura delle
spese di stampa e spedizione, senza alcun sovrapprezzo, perché la distribuzione
resta sempre e comunque gratuita. Vedi
www.nuovaetica.org/
[8] In Spagna Zapatero ha tagliato l'Iva su libri e cd(notizia del 30 aprile
2004). L’industria discografica ha espresso soddisfazione per le misure
annunciate dal nuovo governo. «Un buon inizio», hanno commentato, anche perché
l’Iva drasticamente ridotta
permetterà di porre un limite al «trattamento discriminatorio» nei confronti dei
dischi rispetto a libri. "Non si capiva perché per i dischi il compratore
dovesse pagare il 16% di Iva e per libri soltanto il 4%".
[9]Termine di neo conio dello scrivente indicante lo spazio materiale(dal greco
ulè, materia).
Gennaro Francione www.antiarte.it
Carl William Brown - www.daimon.org/lib/forum_no_copyright.htm