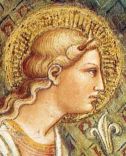|
|
LA QUESTIONE DEL NATALEMITI E LEGGENDE DI QUESTA FESTIVITA' |
|
SCENE DEL PRESEPE: UN TEMA SACRO
TRATTATO IN CHIAVE ANCHE MONDANA
LA NOBILE SFILATA DI ELEGANTISSIMI PERSONAGGI IN VIAGGIO VERSO BETLEMME
I - II
Presepe - Stella cometa - Babbo Natale - Albero - Strenna - Epifania - Vischio

Ravenna, S. Apollinare Nuovo,
Particolare dell'adorazione dei Magi,
che raffigura Melchiorre con il caratteristico berretto frigio.
La più antica versione pittorica del presepe è invece quella conservata nella cappella della catacomba di Priscilla a Roma e risale al III secolo.
Il tema della Natività ricorre frequentemente nell'iconografia bizantina, attestata nei mosaici dell'arco trionfale di S. Maria Maggiore a Roma o in quelli di S. Apollinare Nuovo a Ravenna, e si propaga nella scultura del romanico e del gotico, come nel famoso pulpito del Battistero di Pisa, ad opera di Nicola Pisano.

Giovanni da Modena, Affreschi della cappella Bolognini
Preparativi per il viaggio dei Magi.
Ma il soggetto diventa ‘alla moda’ soprattutto nel 1400, allorché le famiglie mercantili lo prescelgono, forse allo scopo di sottolineare i loro rapporti con l’Oriente, come accade per volontà dei Bolognini, nel primo decennio del XV secolo, nella quarta cappella (a sinistra) della chiesa bolognese di San Petronio, allorché questi ricchi commercianti incaricano Giovanni da Modena di affrescare il viaggio dei Magi e l'Epifania.L’artista colora con intenzione quasi favolistica la narrazione dell'evangelista Matteo e traduce in immagini le sue parole: "Dov’è il Re dei Giudei nato da poco? Perché noi abbiamo visto la Sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo." Il racconto si avvia proprio a partire dalla scoperta di questo segno d'una predestinazione superiore. La stella cometa guida i Magi per i paesaggi notturni dell'Oriente e della Palestina: un fondo di scuro cielo caratterizza infatti le scene di viaggio, ma i raggi luminosi rischiarano gli scenari rocciosi, ove tra le coste rupestri scorre il corteo dei saggi re e dei servitori con cavalli e dromedari.
La fantasia di Giovanni da Modena combina i repertori dei bestiari e degli erbari medievali, veste impeccabili personaggi di preziosi tessuti e diademi, e non disdegna affatto, per un’innata predisposizione all'ironia e all'umorismo, di proporre l'insofferente moto di un cammello spazientito o l'audace inquadratura di una figura umana vista di spalle.

Giovanni da Modena, Affreschi della cappella Bolognini
La scena dell'adorazione.
Nell'incontro con Erode l'artista s'impegna a chiarire i turbamenti emotivi degli uomini: il re, vestito d’un abito pieghettato con bordature di ermellino, lascia che il più anziano dei Magi gli stringa una mano assai rigida e incomunicativa. Alle sue spalle il muto terzetto degli scribi si scambia inquietanti occhiate di sospetto, mentre gli altri due re palesano imbarazzo e stordimento scostando la corona dal capo.
L'excursus favoloso immaginato dal pittore continua a rinverdire i ricordi dei codici miniati fino alla scena dell'Epifania, ove l'esibizione dei personaggi è numericamente piuttosto contenuta, eppure non dimentica di presenze più umili, i pastori, avvertiti anch'essi dal segno della predestinazione divina della grande nascita, secondo la trattazione, questa volta, dell'evangelista Luca.

Gentile Da Fabriano, Adorazione dei Magi, Uffizi, Firenze
Nel 1423, Palla Strozzi, uno degli uomini più abbienti di Firenze, commissionò a Gentile da Fabriano L’adorazione dei Magi (Firenze, Uffizi), per la propria cappella di famiglia in Santa Trinità. La scena riflette, anche in questo caso, il clima cortese che domina la cultura del gotico internazionale: i Magi hanno le sembianze di elegantissimi principi; giungono insieme ad un corteo di personaggi che sfilano attraverso le campagne di un universo fiabesco; gli abiti delle donne sfoggiano tessuti e motivi ornamentali di produzione islamica, secondo i dettami di una moda esotica assolutamente disinibita rispetto a possibili contaminazioni: ciò che interessa è il calligrafismo dei disegni e non il loro contenuto simbolico. Peraltro l'iconografia dell'adorazione dei Magi costituisce di per sé una riprova dei contatti ideologici e sociali tra la cultura giudaica e quella persiana. Proprio le teorie Zoroastriane avevano diffuso la dottrina del Salvatore venturo.

Benozzo Gozzoli, Palazzo Medici-Riccardi, Firenze
Rappresentazione della parete Est
Eppure questo messaggio di pace ha in sé qualcosa di fittizio ed ostentato, una dimensione assai distante dalla sapienza degli antichi magi, tramandata dalla cultura della tolleranza un tempo vigente tra persiani e giudei: si avverte quello scarto tra immaginazione fiabesca e realtà che tanto bene ha saputo esprimere Salvatore Quasimodo nella sua poesia, Natale.

Benozzo Gozzoli, Palazzo Medici-Riccardi, Firenze
Rappresentazione della parete Ovest
Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende,
e l' asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v' e' pace nel cuore dell' uomo.
Anche con Cristo, e sono venti secoli,
il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino
che morirà poi in croce fra due ladri?
di Fabia Zanasi