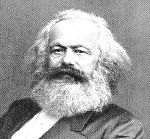|
|
MARX-ENGELS
|
|
TEORIE SUL PLUSVALORE
Commento all'APPENDICE del vol. III
(Storia dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma 1993)
MARX E IL CAPITALE PRODUTTIVO D’INTERESSE
Premessa
Raramente ci si rende conto che allo sfruttamento del Terzo mondo non partecipa soltanto l’industria occidentale, ma l’intero occidente.
Per “Terzo mondo” s’intendono i paesi cosiddetti “in via di sviluppo (sottinteso: capitalistico)”, cioè quei paesi che, resisi formalmente o politicamente indipendenti, a partire soprattutto dal secondo dopoguerra, restano economicamente dipendenti dalle economie di Stati Uniti, Europa occidentale (che oggi sta inglobando anche quella centro-orientale) e Giappone (oltre a certe aree avanzate dell’Asia: Taiwan, Hong Kong, Singapore, Sud-Corea ecc.).
Usa, Europa (Germania, Francia, Regno Unito, Italia) e Giappone, i tre principali centri dell’imperialismo mondiale, costituiscono, con l’aggiunta del Canada, quell’organo internazionale chiamato G7 (diventato G8 nel 1998, quando si è permesso alla Russia di non assistere più come spettatrice alle sue sedute), che determina il trend dell’economia mondiale. Nei paesi del G8 vive circa il 15% della popolazione mondiale che produce il 52% del prodotto lordo e il 69% delle esportazioni di beni e servizi (dati del 2007).
Naturalmente ai paesi del Terzo mondo vanno aggiunti quelli del cosiddetto “Quarto mondo”, definiti tali in quanto poverissimi, incapaci di qualunque forma di sviluppo borghese.
Oggi dal nucleo dei paesi terzomondiali vogliono decisamente uscire sia la Cina che l’India, ma anche il Brasile.
In particolare la Cina ha già superato il pil di nazioni come Italia, Francia, Regno Unito, Canada… Ma per essere in grado di “gestire l’economia mondiale” non è sufficiente avere un pil molto alto: occorre anche entrare nelle “grazie politiche” dei paesi cosiddetti “occidentali”, sottostare a certe regole in virtù delle quali detti paesi vogliono tutelare i loro acquisiti privilegi. I paesi occidentali vogliono continuare a gestire in maniera politica un potere economico che col tempo è andato sempre più indebolendosi, soprattutto in rapporto ai trend produttivi delle potenze asiatiche.
Da notare che fino al crollo del “socialismo reale” si consideravano paesi del “Secondo mondo” quelli appunto a orientamento socialista, prescindendo dal loro prodotto interno lordo. Oggi questa distinzione non ha più senso.
Vendendo a caro prezzo le proprie merci in tutto il mondo o ricavando sottocosto le proprie materie prime prevalentemente dai paesi sottosviluppati, di fatto l’occidente sfrutta il Terzo mondo proprio in quanto “occidente”, nel senso che, pur esistendo gradi e forme diverse di sfruttamento, nell’insieme il soggetto che opprime è unico (per quanto sui mercati mondiali si stiano affacciando i colossi asiatici).
In altre parole, è vero che un operaio occidentale viene sfruttato da un imprenditore occidentale, che peraltro lo paga con un salario in cui intrinsecamente esiste una quota derivata dallo sfruttamento di lavoratori non-occidentali, proprio in forza del rapporto di scambio non equo tra noi e il Terzo mondo. Ma è anche vero che se questo operaio sfruttato versa una parte, risparmiata, del suo salario, in una banca occidentale, acquistando fondi azionari o obbligazionari emessi dai paesi terzomondiali (che ovviamente hanno interessi appetibili), detto operaio diventa, a sua volta, nel suo piccolo, uno sfruttatore finanziario delle condizioni di sottosviluppo di un qualche paese del Terzo mondo (di cui peraltro non è neppure tenuto a sapere nulla). Cioè egli, mentre viene sfruttato nel mondo occidentale, può percepire, allo stesso tempo, un interesse derivato da uno sfruttamento diretto delle condizioni lavorative nel Terzo mondo.
Marx naturalmente non aveva esposto le cose in questi termini, ma ne aveva poste le basi teoriche essenziali per poterle capire, e infatti Lenin esaminò le dinamiche dell’imperialismo mondiale proprio in questa direzione.
Quando Marx scrive che il capitale produttivo d’interesse è denaro che crea più denaro, secondo la formula D-D’ (che supera quella capitalistica originaria: D-M-D’ in cui M è la merce venduta), egli in sostanza faceva capire che il capitalismo finanziario tendeva ad assumere un’importanza centrale, sempre più preponderante, nel sistema capitalistico, proprio perché il profitto che si realizza nella forma dell’interesse è più facile, meno rischioso, soprattutto meno faticoso, anche se di recente si è scoperto, a proprie spese, che i rischi non sono affatto pochi: basti pensare ai bond argentini, alle azioni della Parmalat, della Cirio, della Bipop, della Federconsorzi…, della Bank of Credit And Commerce International (la più grande banca “criminale” della storia), della Enron (il più grosso crack nella storia del mercato statunitense), alla bolla speculativa del web, detta "New Economy", agli inizi del duemila, … sino alla recentissima crisi dei mutui ipotecari americani, che hanno scosso le borse di mezzo mondo.
Le aziende più significative sono quotate in borsa e quindi si muovono a livello internazionale, ma più si muovono a livello internazionale e meno possono essere controllate dagli azionisti, specie da quelli piccoli. L’attività delle aziende sembra essere fatta apposta per arricchire soltanto i loro manager e i grandi azionisti (di cui i maggiori sono le stesse banche): il successo di queste aziende dipende da un rapporto di fiducia nei confronti di operatori che sul piano etico non hanno alcun titolo per meritarsela.
Tutti dunque aspirano a diventare quel tipo di imprenditore il cui reddito proviene unicamente dall’interesse percepito sui propri investimenti finanziari.
Sono infatti due le forme feticistiche con cui il sistema borghese illude i propri cittadini: una è quella tecnologica (il possesso degli ultimi ritrovati illude sulle capacità di determinare il proprio destino, di controllare la realtà, di dominare la natura, di risolvere i guasti ambientali causati dalla stessa tecnologia, ecc.); l’altra è quella finanziaria (il possesso di capitali da investire in titoli, azioni, obbligazioni… illude sulla possibilità di vivere di rendita o comunque sulla possibilità di vivere non soltanto del proprio lavoro, ma anche e soprattutto sfruttando il lavoro altrui).
Marx, che non ha mai attribuito alla tecnologia alcunché di feticistico, pur non avendo mai messo in discussione la necessità storica di una rivoluzione tecnico-scientifica, era convinto che questa malattia mortale del capitalismo raggiungesse nel capitale produttivo d’interesse la sua massima espressione. Infatti, essendo un capitale completamente scisso dalla immediatezza di un rapporto di lavoro, la sua redditività (una produttività che si autovalorizza) risulta avere un che di magico.
Marx diceva queste cose per criticare quegli economisti borghesi che sostenevano l’inesistenza dello sfruttamento del lavoro proprio in virtù del fatto che anche il lavoratore poteva beneficiare di interessi monetari.
Premessa - Il feticismo - Il valore della cultura nel capitalismo finanziario - Trasformazioni del capitale - Economia e cultura - L'emancipazione borghese - Conclusione