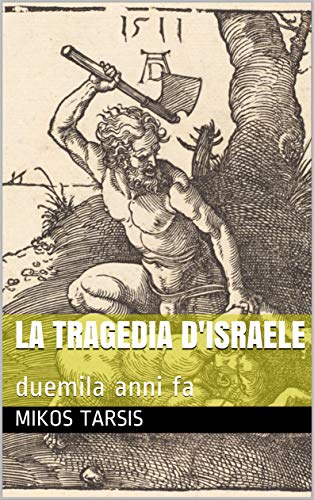
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
LA TRAGEDIA D'ISRAELE
duemila anni fa
1) Introduzione - 2) Storia di Israele (Dal primo censimento romano alla distruzione di Gerusalemme) - 3) Storia della corruzione del Tempio - 4) Israele e la catastrofe di duemila anni fa - 5) I vangeli e la passione di Gesł - 6) Il tributo a Cesare e la diarchia dei poteri - 7) Sull'umanitą del Cristo - 8) Paolo di Tarso e la spoliticizzazione del Cristo - 9) Ebraismo e cristianesimo: due forme di ateismo? - 10) Il tradimento del cristianesimo primitivo - 11) L'opposizione di principio fra Stato romano e Chiesa cristiana - 12) Conclusione
1) Introduzione
Forse è giunto il momento di chiedersi se per caso gli ebrei non abbiano fatto bene a eliminare uno che pretendeva d'essere considerato alla stregua d'una divinità. La stessa pretesa la contestavano agli imperatori romani, che proprio allora cominciavano a manifestarla. Perché mai avrebbero dovuto fare un'eccezione nei confronti di Gesù Cristo?
Una cosa infatti è averla come privato cittadino: uno può anche essere pazzo e non per questo essere pericoloso. Un'altra invece è pensare di poter organizzare un'insurrezione in nome di quella pretesa.
Certo, anche un privato cittadino può diventare, in nome del suo dio o della propria figliolanza divina, una sorta di «giustiziere della notte» contro i peggiori criminali. I film americani sono pieni di figure del genere, che non credono nella giustizia dello Stato e che, pur non dichiarandosi delle divinità (perché dai tempi di Cristo, per fortuna, non son passati invano duemila anni di storia), di fatto si comportano come se lo fossero.
Tuttavia un soggetto di questo tipo resta infinitamente meno pericoloso di un leader politico che, propagandando la sua ideologia come l'unica verità esistente, riesce a convincere migliaia, decine di migliaia, se non milioni di persone. Quanti lutti e devastazioni ci saremmo risparmiati bloccando sul nascere, con le buone o con le cattive, personaggi come Hitler e Stalin?
Alcuni potranno obiettare che Cristo non voleva compiere alcuna insurrezione, né anti-romana né anti-giudaica, proprio perché non entrò a Gerusalemme in groppa a un cavallo ma a un asino, essendo un messia del tutto pacifico. Ma un'obiezione del genere non regge.
Se il Cristo non voleva liberare la Palestina dai Romani, qualcosa però di eversivo lo voleva fare, altrimenti avrebbe dovuto limitarsi a restare un privato cittadino. Se la sua rivoluzione era solo di tipo «religioso», resta il fatto che pretendeva d'essere considerato una «divinità». Sin dal primo vangelo, ove pur s'è teorizzato il «segreto messianico», se ne parla in maniera molto esplicita. Mentre si trovava sotto le grinfie di Caifa, costui gli chiese: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». «Io lo sono! – rispose Gesù – E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte (Mc 14,61 ss.).
Insomma il problema resta: è ridicolo pensare che i capi-giudei l'abbiano ammazzato perché «invidiosi» (15,10) delle sue prerogative, anche se questa è la tesi principale del Vangelo di Marco (15,10). Semmai, se proprio vogliamo spezzare una lancia a favore di Caifa, perché temevano ch'egli potesse utilizzare le proprie capacità per distruggere tradizioni ebraiche consolidate (sulla cui liceità o legittimità Caifa non era però disposto neppure a discutere). Ci riferiamo alle questioni, più volte dibattute nei vangeli, del Tempio, del sabato, dei cibi impuri, della legge mosaica, ecc.
In fondo un messia poteva decidere d'entrare a Gerusalemme in groppa a un asino solo per ostentare un falso buonismo, per scelta tattica, non per convinzione etica. Chi potrebbe accusare l'ebreo di non aver accettato di credere nella sincerità di una persona che dichiarava d'essere «divina»?
Possiamo addirittura arrivare a dire – sempre per fare un favore al giudaismo istituzionale di quel tempo – che il Cristo meritava d'essere eliminato anche se, in nome della propria «divinità» avesse voluto fare un'insurrezione anti-romana. Infatti, che senso avrebbe avuto liberarsi di un imperatore figlio di dio per sostituirlo con un proprio messia divino? Anche nel caso in cui questo messia, in forza della propria divinità, avesse compiuto straordinari prodigi, o addirittura avesse abbattuto l'impero, nulla in realtà avrebbe potuto assicurare ch'egli non si sarebbe mai servito dei propri poteri contro gli stessi ebrei.
Qui insomma bisogna rendersi conto che qualunque pretesa di considerare il singolo superiore al popolo, va guardata con sospetto, anche nel caso in cui questo singolo fosse davvero un dio.
Ma ci sono altre due cose da considerare. Prima abbiamo detto che, poiché il Cristo pretendeva d'essere considerato una divinità, un ebreo avrebbe anche potuto pensare ch'egli volesse sostituire il proprio potere politico-religioso a quello dei sommi sacerdoti.1
In tal caso Roma (impersonata da Pilato) l'avrebbe giustiziato soltanto per un tragico malinteso, cioè per non aver capito in tempo come servirsene per gli interessi dell'impero, essendosi lasciata condizionare, nell'interpretazione dell'evento Gesù, dalla lettura che ne davano i sommi sacerdoti. Cristo non sarebbe stato un «politico rivoluzionario» ma un semplice «riformatore religioso», un novello Battista, benché nella Palestina d'allora si facesse poca differenza tra politica e religione.
D'altra parte, anche se non ci fosse stato questo condizionamento, non si può dar torto a Pilato: era nel suo diritto temere che la pretesa religiosa alla divinità potesse unirsi a una pretesa politica, che necessariamente si sarebbe posta in maniera alternativa a quella degli imperatori.
Ovviamente stiamo ragionando per assurdo, poiché da tempo l'esegesi laica sa bene che Pilato giustiziò il Cristo proprio in quanto pretendente al trono d'Israele in funzione antiromana (l'attesta il titulum della croce). E quella volta essere «contro Roma» voleva appunto dire essere avversi a ogni tendenza imperialistica; Pilato sperimentò di persona che voleva anche dire essere ostili – come di fatto lo erano gli ebrei – a ogni rappresentazione religiosa del potere politico contraria a quella ufficiale di Israele. Ma se avessero vinto i nazareni, avrebbe dovuto constatare un'avversione a qualunque nesso tra religione e politica.
Il secondo ragionamento da fare riguarda l'idea secondo cui il Cristo andò a Gerusalemme non per fare un'insurrezione contro Roma e contro il Tempio, bensì per farsi crocifiggere, dimostrando così che gli ebrei non avrebbero più potuto rivendicare alcun primato etico-religioso o storico-politico nei confronti dei pagani.
In sostanza la tesi (di derivazione paolina) che i vangeli sostengono è che gli ebrei non potevano non uccidere il Cristo, proprio perché non avrebbero mai potuto accettare che un uomo si facesse dio. Questa versione ufficiale delle cose, oltre che irrazionale, in quanto fa dipendere la verità dal martirio, è profondamente antisemita, in quanto condanna, senza riserve, un intero popolo, con tutta la sua cultura, a una maledizione eterna, dalla quale può sperare di liberarsi solo a condizione che smetta d'essere se stesso.
*
I vangeli non sono testi storici ma manifesti di teologia politica. Che un testo di storia non possa avere più pretese di obiettività di uno di teologia-politica lo dimostra lo scrittore ebraico Flavio Giuseppe, che pur raccontando con tanti particolari la storia d'Israele dello stesso periodo dei vangeli, non dice nulla di più di quanto già non si sappia dall'intero Nuovo Testamento (in riferimento ovviamente al cristianesimo e soprattutto al movimento nazareno, che son due cose ben diverse).
I testi di Flavio in cui si parla di Gesù Cristo sono stati manomessi dai cristiani, ma questo non significa che gli originali fossero favorevoli al movimento nazareno; anzi, visto che Flavio scriveva per compiacersi i Romani, è molto probabile ch'egli avesse posto i nazareni sullo stesso piano degli zeloti, cui attribuisce la causa fondamentale della disfatta della Palestina. Semmai si può pensare ch'egli abbia parlato del movimento nazareno e quindi del suo fondatore come di un evento del tutto politico, cioè privo di quegli aspetti mistici e miracolistici così macroscopici nei vangeli.
Se ci pensiamo i primi imperatori romani avrebbero potuto utilizzare i testi di Flavio contro Israele in maniera molto più facile che non gli stessi vangeli, che pur sono ampiamente antisemiti.
Il punto infatti è proprio questo, che per i cristiani gli imperatori erano uomini comuni, che di messianico o di divino non avevano proprio nulla, e per loro l'unico vero dio era padre di un figlio morto e risorto. Poteva l'impero utilizzare questa visione delle cose? Pur essendo politicamente conservatori, ideologicamente i vangeli erano eversivi, e non solo perché negavano d'esistere a tutti gli dèi pagani. Il fatto stesso che Cristo separi la funzione di Cesare da quella di dio nell'episodio del tributo, per un romano, ligio alle istituzioni (per le quali non si faceva molta distinzione tra civile e religioso, tant'è che l'imperatore era anche pontifex maximus), doveva apparire sconcertante, e infatti ci metteranno tre secoli prima di accettarlo. E ce ne vorranno altri millecinquecento prima di capire che il Cristo si poneva sia contro Cesare che contro qualunque dio.
Invece per l'opportunista Flavio il suo imperatore era, nel contempo, «dio e cesare», e tutti quelli che avevano cercato di opporsi a lui erano stati responsabili della distruzione di Israele e minacciavano la stabilità dell'impero. Molto meglio di Flavio fu Filone Alessandrino che, pur essendo ebreo, si limitava a fare il pagano in maniera filosofica.
Insomma noi purtroppo abbiamo a che fare con testi talmente pieni di manomissioni che è impossibile risalire a un originale autentico. Ecco perché conviene considerare il Nuovo Testamento una falsificazione di tipo teo-politico, cui occorre contrapporre una versione dei fatti di tipo umano-politico.
I vangeli hanno usato la politica in maniera regressiva e hanno potuto farlo infarcendola di contenuti mistici. Sarebbe stato sufficiente fare un testo storico i cui protagonisti ammettessero di aver sbagliato a interpretare teologicamente la tomba vuota. Invece i protagonisti degli eventi che vi si raccontano hanno mentito e i loro seguaci hanno aspettato che morissero per mettere per iscritto le loro falsità.
A questo punto la storia non esiste più, nel senso che chi poteva raccontarla non ha voluto farlo e chi l'ha raccontata l'ha ridotta a politica teologica. Sicché, allo stato attuale delle fonti, il problema non può più essere quello di dimostrare la «verità storica», ma solo quello di mostrare che la versione dei fatti del Nuovo Testamento può essere falsa proprio in quanto s'è trasformato il «Gesù storico» in un «Cristo teologico».
Se ci limitassimo a fare confronti di tipo storico non si riuscirebbe a scrivere più di uno o due libri sull'argomento. Gli esegeti laici invece devono imparare a superare il cristianesimo ab intra (da politici), dando per scontato alcuni presupposti: non basta più farlo ad extra (da storici), negandoli in via preliminare.
Bisogna rileggersi i vangeli parola per parola e vedere dove un ipotetico detto umanistico-politico è stato trasformato in testo teologico-politico. Non serve a niente il metodo delle concordanze / discordanze tra Flavio e il Nuovo Testamento nella speranza di trovare qualcosa di veridico circa il cristianesimo. Flavio può essere utile per capire qualcosa della storia di Israele del I secolo, ma non bisogna dimenticare che i suoi testi è come se fossero stati scritti da Vespasiano o da Tito in persona. Possiamo forse basarci sui testi di Tacito, che stava ovviamente dalla parte di Cesare, per capire i germani? O sui testi di Alcuino per capire Carlo Magno? Molto più credibile di Flavio è l'autore dei Maccabei, che pur non va esente da fantasticherie.
Se è opportuno usare il suddetto metodo, è sufficiente porre in relazione le versioni dei vangeli di Marco e Giovanni, che sono quelle fondamentali, tra loro in opposizione, salvo ovviamente le interpolazioni.
Gli evangelisti non solo non hanno voluto scrivere dei testi storici, ma hanno anche fatto in modo d'impedire agli storici di contestarli sotto il punto di vista dell'attendibilità dei fatti narrati, in quanto, come nel 1984 di Orwell, hanno avuto la possibilità di riscrivere la storia come pareva loro.
Se è così, allo storico non resta che smentire il Nuovo Testamento sul piano etico (quello dell'umanesimo laico) e politico (quello del socialismo democratico), cominciando a mostrare con vari ragionamenti (in cui si possono usare le stesse categorie cristiane ma con significati opposti), che il Cristo era ateo e democratico e comunista.
Cioè il limite epistemologico che occorre porsi è quello di trovare delle argomentazioni logiche che provino in che maniera nei fatti narrati dai vangeli è intervenuta una mano redazionale di tipo mistificante. Per contestare un'argomentazione mistica l'esegeta laico deve convincersi che ne basta un'altra di tipo realistico. Si lascerà poi decidere al lettore quale delle due è più convincente.
In ogni caso molto più importanti di Flavio sono i testi di Qûmran, ancora non tutti pubblicati, perché da questi abbiamo capito con sicurezza che gli aspetti sacramentali del cristianesimo petro-paolino sono stati ereditati dal rapporto con gli esseni, quel rapporto che il Cristo, mentre operava in Giudea, aveva rifiutato allorquando fece la prima insurrezione a Gerusalemme, cacciando i mercanti dal tempio e probabilmente mirando a rovesciare dal trono i sommi sacerdoti. Rifiutò l'essenismo del Battista perché troppo religioso, troppo legato ad aspetti giuridico-morali e incapace di fare vera politica, anche se i suoi primi discepoli venivano da quell'ambiente.
Ancora più importante è però la rivisitazione del rapporto tra cristianesimo e fariseismo. Il cristianesimo infatti è un prodotto in cui l'elemento farisaico ha giocato un ruolo fondamentale. Al tempo di Gesù i farisei non erano un partito conservatore come i sadducei, ma ambiguo (la parte minoritaria era sicuramente democratica), anche se nei vangeli vengono presentati come ipocriti. È dunque probabile che Gesù abbia cercato sino all'ultimo un'intesa coi farisei, che forse nell'ambito dei Dodici erano rappresentati da Giuda. L'intesa fu trovata dopo la sua morte, ma in chiave mistica, grazie a Paolo.
In sintesi. Se sulla morte del Cristo diamo la colpa ai soli Giudei, come fanno i vangeli, che in questo sono nettamente antisemitici, non riusciremo a comprenderne la causa. Né si può pensare ch'era destinato a morire perché i Romani erano troppo forti. Nella foresta di Teutoburgo, qualche anno prima, alcune legioni romane erano state completamente distrutte dai Germani e da allora gli imperatori posero il Reno a confine dell'impero. Perché mai la stessa cosa non sarebbe potuta avvenire in Palestina? I Romani non riuscirono mai a sottomettere i Parti. Per me quella morte va spiegata anche con un motivo che i seguaci di Gesù, ben presenti durante il processo orchestrato da Pilato, non ebbero mai il coraggio di ammettere e di cui non fecero mai autocritica, se non, con la teologia paolina, rifacendosi alle conseguenze del peccato originale, secondo cui l'uomo è incapace di compiere il bene con le proprie forze. Il motivo stava appunto nel fatto che il suo movimento non ebbe il coraggio di assumersi delle responsabilità personali, si fidò troppo della clemenza delle autorità, non accettò l'idea che in certi casi occorre la “spada” per risolvere l'ingiustizia. È vero, dopo la sua morte aumentò il coraggio, fino ad accettare il martirio, ma venne finalizzato a realizzare una teologia-politica che di rivoluzionario non aveva più niente, se non l'idea di separare lo Stato (Cesare) dalla Chiesa (Dio), non riconoscendo agli imperatori e al paganesimo alcun tipo di “culto”.
(torna su)2) Storia di Israele
Dal primo censimento romano alla distruzione di Gerusalemme
La stragrande maggioranza delle notizie che abbiamo della Palestina del primo secolo proviene dai testi di Giuseppe Flavio, un militare ebreo che al tempo della guerra giudaica del 66-74 d.C. passò dalla parte dei Romani e contribuì alla disfatta del proprio popolo. A titolo di favore per i servizi resi l'imperatore Vespasiano gli permise di raccontare la storia di quelle vicende, cosa che egli fece pubblicando due volumi: Guerra Giudaica (Mondadori 1982) e Antichità Giudaiche (Utet 2006)
È evidente che, per questa ragione, Giuseppe Flavio non può essere considerato uno storico attendibile, sia perché odiava a morte il partito zelota, che fu il protagonista principale di quella guerra, sia perché, per poter pubblicare i propri testi, non poteva mettere i Romani in cattiva luce, almeno non più di quanto gli permettesse di fare il suo rapporto servile nei confronti di Roma.
D'altra parte anche gli Atti degli apostoli non possono essere considerati un testo storicamente affidabile, anzi, per molti versi, lo sono ancor meno di quelli di Flavio. I motivi sono semplici: i cristiani avevano in odio i capi giudei per aver fatto giustiziare il loro messia; inoltre il cristianesimo petro-paolino si poneva in netta antitesi all'ebraismo in generale, non avendo alcun interesse a realizzare una liberazione politico-nazionale della Palestina. Peraltro tutte le affermazioni di Flavio riguardanti il coinvolgimento di Cristo e del suo movimento alla lotta di liberazione nazionale, sono state in varie maniere interpolate da redattori cristiani.
Questa ricostruzione sintetica si è avvalsa soprattutto del testo di S. G. F. Brandon, Gesù e gli Zeloti, Rizzoli, Milano 1983.
*
Secondo il Vangelo di Luca la nascita di Gesù viene a coincidere col censimento ordinato dai Romani il 6 d.C., allorché la Giudea venne incorporata per la prima volta entro il loro impero. Il censimento doveva servire per la ripartizione dei tributi, cosa che porterà, di lì a poco, alla nascita del partito di opposizione anti-romana degli zeloti. Secondo invece il Vangelo di Matteo, Gesù sarebbe nato pochi anni prima della morte di Erode il Grande, che avvenne il 4 a.C.: una data importante per il popolo ebraico, in quanto dal 129 a.C., dopo essersi liberati, grazie ai Maccabei, della dominazione seleucide, gli ebrei avevano goduto dell'indipendenza nazionale.
Erode era stato odiato dagli ebrei per la sua origine idumea e per il suo filo-paganesimo, e tuttavia, sotto il suo regno, la Palestina non era stata costretta a pagare il tributo a un governo straniero né a vedere truppe straniere sul proprio territorio. Ma Erode non poteva decidere, senza il consenso imperiale romano, chi avrebbe potuto succedergli. Infatti suo figlio Archelao dovette recarsi a Roma e, proprio in quella occasione, gli ebrei si ribellarono alle truppe romane del comandante Sabino, ch'erano state inviate per mettere al sicuro l'ingente patrimonio dello stesso Erode. Gli ebrei, soprattutto i farisei e gli zeloti, volevano piena indipendenza nazionale, anche dagli erodiani.
Uno dei capi di questa sommossa era stato Giuda, figlio di Ezechia, che aveva occupato il palazzo erodiano di Sepphoris in Galilea, impadronendosi dei beni e delle armi. E come Ezechia era stato giustiziato, nel 47 a.C., dal giovane Erode, quando ancora questi era al servizio di suo padre Antipatro, prefetto del palazzo di Ircano, ultimo sovrano asmoneo, così Giuda venne fatto giustiziare, insieme ad altri duemila (crocifissi), dal governatore romano della Siria, Varo, accorso in aiuto delle truppe romane stanziate a Gerusalemme, nel 4 d. C. Poco prima di morire, Erode aveva fatto giustiziare due farisei, Giuda e Mattia, che avevano incitato il popolo a distruggere la grande aquila dorata che il re aveva fatto innalzare sulla porta principale del Tempio di Gerusalemme.
L'imperatore Augusto decise di porre la Giudea e la Samaria sotto il diretto controllo di Roma, di cui appunto il censimento del 6 d.C. doveva costituire eloquente dimostrazione, dopo che aveva constatato quanto Archelao, nominato etnarca di quei territori nel 4 a.C. (fino al 6 d.C.), non fosse all'altezza della situazione.2 D'altra parte Roma temeva enormemente che tra le due province di Egitto e Siria fosse presente un territorio, quale appunto la Palestina, in stato di aperta ribellione.
L'incarico tecnico del censimento venne affidato a P. Sulpicio Quirinio, legato della Siria, cui veniva ora annessa la provincia di Giudea e Samaria. Procuratore di Giudea e Samaria era però Coponio, che governava quella provincia con pieni poteri, ivi incluso quello delle sentenze capitali.
La reazione degli ebrei al censimento fu immediatamente ostile: un certo Giuda di Galilea (il Galaunita, della città di Gamala), appoggiato da un fariseo chiamato Saddok, provocò una rivolta, nonostante il sommo sacerdote Joazar cercasse di dissuaderli. Due figli di questo Giuda, Menahem e Eleazar, diverranno capi della grande guerra anti-romana che scoppierà nel 66 d.C. Questi rivoltosi facevano parte del partito degli zeloti, che rappresentava l'ala progressista del fariseismo. Alcuni di questi zeloti si ritroveranno nel partito nazareno del Cristo (Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13).
Il partito zelota era radicale, estremista, teocratico, non disposto a transigere sui princìpi e non alieno all'uso di strumenti terroristici e di guerriglia urbana: molto difficilmente un episodio come quello della conversione di Levi-Matteo al discepolato del Cristo, avrebbe potuto trovare posto negli «Annali» delle loro attività. Eppure proprio la presenza di elementi zelotiani all'interno del partito nazareno deve farci pensare che dopo la sconfitta degli zeloti, in occasione del censimento, chi ne raccolse l'eredità politica fu proprio quello del Cristo, anche se lo stesso partito zelote si riprenderà proprio dopo il fallito tentativo insurrezionale dei nazareni (una parte del movimento zelote confluirà anche tra gli Esseni).
Intorno al 9 d.C. a Coponio successe Marco Ambibulo, cui seguì Annio Rufo (12-15 d.C.). Intanto Quirinio, legato di Siria, aveva deposto il sommo sacerdote Joazar, contro il quale il popolo si era rivoltato, e aveva nominato Ananus (suocero del famoso Caifa dei vangeli) suo successore. L'interferenza politica dei Romani in questa prestigiosa carica religiosa era cosa del tutto inedita per i Giudei. Il successivo procuratore, Valerio Grato (15-26 d.C.), deporrà e nominerà non meno di quattro sommi sacerdoti, assegnando infine la carica a quel Caifa che risulterà protagonista principale dell'esecuzione del Cristo. Questo spiega il motivo per cui il clero del Tempio era caduto enormemente in discredito presso le popolazioni politicamente impegnate a lottare contro Roma (non a caso durante la cacciata dei mercanti dal Tempio, da parte del Cristo, nessuno intervenne per fermarlo).
Poi fu la volta di Pilato, nominato prefetto della Giudea nel 26 d.C.: vi rimase in carica fino al 36, cioè fin qualche anno dopo la morte del Nazareno. Pilato, che risiedeva a Cesarea Marittima, non era mai piaciuto ai Giudei, perché troppo arrogante. Il primo incidente diplomatico, quando egli tentò di introdurre a Gerusalemme, di notte, le insegne dell'imperatore, che i Romani già consideravano alla stregua di un dio, era avvenuto proprio all'inizio del suo mandato.
I Giudei erano ormai prossimi alla rivolta quando Pilato preferì rimuovere le immagini profane per evitare il bagno di sangue che ne sarebbe conseguito. È però probabile che Pilato avesse ordito una provocazione del genere, ch'era senza precedenti, su suggerimento di Seiano, il potente favorito di Tiberio, noto per le sue posizioni antisemite.
La seconda provocazione di Pilato è relativa al momento in cui fece esporre nel palazzo di Erode a Gerusalemme degli scudi dorati che recavano i nomi dell'imperatore e delle persone che gli avevano dedicato quegli scudi (probabilmente nell'iscrizione vi era un riferimento alla «divinità» dell'imperatore). I nobili della città protestarono presso l'imperatore Tiberio che, per evitare incidenti, ordinò di rimuovere gli scudi contestati e di farli appendere nel Tempio di Augusto a Cesarea.
Un terzo incidente lo si ebbe quando Pilato, senza consultare le autorità civili ebraiche, impiegò parte del sacro tesoro del Tempio di Gerusalemme per finanziare la costruzione di un acquedotto che avrebbe portato acqua nella città: scoppiarono delle rivolte che vennero soffocate nel sangue dai Romani.
Il quarto episodio riguardò lo stesso Gesù Cristo, preceduto dall'arresto di alcuni rivoltosi coinvolti in un'azione eversiva, di cui v'è traccia persino nei vangeli, pur sempre molto reticenti nel mostrare gli aspetti politici del Nazareno. Non dimentichiamo che Gesù fu crocifisso con altri due sediziosi e barattato con un altro ancora (Barabba). La data varia dal 29 al 33 d.C.
Infine, sotto la direzione di un loro leader, alcuni samaritani tentarono di radunarsi sul monte Garizim, a loro sacro, probabilmente per preparare una rivolta contro i Romani. Pilato prevenne la sedizione inviando l'esercito: molti samaritani vennero uccisi e i capi della rivolta furono giustiziati. Ne seguì una formale protesta dei samaritani presso Vitellio, all'epoca legato della provincia romana della Siria, che diede loro ascolto e rimandò Pilato a Roma, sostituendolo con Marcello.
Rimosso Pilato dal suo incarico, Vitellio si recò a Gerusalemme durante una Pasqua, forse quella del 36 d.C., per ripristinare l'ordine nella nazione dei Giudei. L'unica cosa che fece però fu quella di sostituire il sommo sacerdote Caifa con Jonathan ben Anano (36-37). L'anno dopo, per ordine di Tiberio, radunò le truppe a Tolemaide in vista di una spedizione punitiva contro Aretas, re di Petra. E su richiesta dei Giudei evitò di far passare le proprie truppe attraverso la Giudea. Tuttavia, quando tornò a Gerusalemme depose anche il sommo sacerdote Jonathan, sostituendolo con Theofilo ben Anano (37-41).
Intanto giunse notizia della morte dell'imperatore Tiberio: Vitellio impose agli ebrei un giuramento di fedeltà a Gaio (Caligola), nuovo imperatore (37-41 d.C.), che diede prova del suo apprezzamento per l'appoggio ottenuto, per la successione a Tiberio, da parte di Agrippa I, nipote di Erode il Grande, permettendo a quest'ultimo, nel 39 d.C., di ottenere la tetrarchia ch'era stata di Filippo, morto nel 34 d.C., insieme col titolo di re e, successivamente, anche la tetrarchia di Erode Antipa, deposto ed esiliato da Gaio in Spagna.
La luna di miele tra Roma e gli ebrei durò tuttavia molto poco. A Jamnia, sapendo che l'imperatore era ossessionato dall'idea di far accettare politicamente la propria divinità, i gentili, per ingraziarselo, fecero erigere un altare per offrirgli dei sacrifici. Gli ebrei della città reagirono immediatamente distruggendolo. Per vendicarsi Gaio ordinò al legato di Siria, Petronio, di erigere una colossale statua dorata di Zeus all'interno del Tempio di Gerusalemme, com'era stato fatto nel 167 a.C. dal re Antioco Epifane.
Petronio si recò in Giudea, nel 39-40 d.C., con un esercito di due legioni e un forte contingente di truppe ausiliarie. Intanto Agrippa era riuscito a convincere Gaio a desistere da un proposito che avrebbe provocato un massacro generale. In cambio Gaio chiedeva che le comunità di gentili presenti in Palestina potessero erigere tranquillamente qualunque altare pagano. Il suo improvviso assassinio scongiurò la ribellione armata dei Giudei.
Agrippa era abbastanza stimato dalla popolazione ebraica e persino dai Romani, tanto che il nuovo imperatore Claudio, per premiarlo della fiducia mostrata contro le follie di Caligola, gli concesse di governare anche in Giudea, il che lo portava ad amministrare un'estensione territoriale equivalente a quella dell'antico regno di Erode il Grande, anche se sotto l'egida di Roma. Claudio intanto, nel 41 d.C., fu costretto a proibire l'immigrazione di molti Giudei verso Alessandria, fuggiti da Israele per l'insostenibilità della situazione fiscale e il processo di concentrazione della proprietà.
Stando agli Atti degli apostoli, Agrippa fece assassinare Giacomo, fratello di Giovanni, e incarcerare Pietro, che fu poi fatto evadere. Prima di questi fatti era stato eliminato Stefano, che accusava apertamente i sacerdoti giudei di aver fatto giustiziare Gesù. Pietro fu sostituito, alla guida della comunità cristiana di Gerusalemme, dal fratello di Gesù, Giacomo detto «il Minore» nel Nuovo Testamento.
Avendo intenzione di consolidare il proprio regno e temendo che i Romani potessero rimuoverlo in qualunque momento, Agrippa chiedeva un appoggio esplicito da parte delle autorità giudaiche. E per questo in due occasioni si rese sospetto alle autorità romane. La prima quando tentò di ricostruire le mura settentrionali di Gerusalemme, da cui erano entrate le truppe sia di Pompeo nel 63 a.C. che di Erode e Sossio nel 37 a.C. (e da dove entreranno anche quelle di Tito nel 70 d.C.): gli venne impedito quando Vibio Marso, legato di Siria, informò del pericolo l'imperatore Claudio. La seconda occasione fu quando invitò cinque principi, vassalli di Roma, ad una riunione a Tiberiade, per rafforzare delle intese politiche nelle province orientali dell'impero.
Agrippa morì improvvisamente nel 44 d.C., quando il figlio era ancora troppo giovane per succedergli: il che indusse Claudio ad amministrare direttamente tutti i suoi territori. Solo qualche anno dopo alcune parti del regno di Agrippa, che non riguardavano la Giudea, vennero assegnate al figlio Agrippa II.
La seconda amministrazione romana fu un disastro per le sorti della popolazione ebraica. Il procuratore Cuspio Fado (44-46 d.C.), il primo succeduto ad Agrippa I, fece giustiziare Tholomaios, che aveva provocato disordini ai confini con la Nabatea e l'Idumea. Poi fu la volta di Theudas, un predicatore politico che invitava i Giudei ad attraversare il Giordano per rifugiarsi in una zona desertica della Transgiordania, da dove si sarebbero organizzati in funzione anti-romana: fu catturato e decapitato, e con lui molti altri.
Sotto il procuratore (ebreo apostata) Tiberio Alessandro (46-48 d.C.), succeduto a Fado, vennero crocifissi due rivoltosi zeloti, Simone e Giacomo (o Giacobbe), figli di Giuda il Galileo. Sempre al tempo di Tiberio Alessandro ci fu in Giudea una grave carestia, che per due anni ebbe conseguenze disastrose per buona parte della popolazione, non più in grado di pagare le tasse; e sotto il suo successore, Ventidio Cumano (48-52 d.C.), si ebbe una nuova strage di Giudei durante le feste di Pasqua, in prossimità del Tempio di Gerusalemme, semplicemente perché gli ebrei radunati nei cortili per il culto reagirono immediatamente a un gesto osceno fatto da un soldato romano di servizio sul tetto del portico del Tempio.
Il secondo incidente si ebbe quando fu assalito e depredato un servitore dell'imperatore sulla strada che conduceva a Beth-oron. Il procuratore inviò truppe a saccheggiare i villaggi vicini, arrestandone i capi. Durante le operazioni un soldato romano bruciò una copia della Torah. Gli ebrei furono così furiosi che Cumano si risolse a giustiziare il soldato.
Il terzo incidente segnò la fine del mandato palestinese di Cumano. Tutto ebbe inizio con l'uccisione di alcuni galilei, in viaggio verso Gerusalemme, da parte degli abitanti di un villaggio samaritano. I Galilei chiesero vendetta a Cumano, che però non fece nulla. Allora i Galilei chiesero aiuto ai Giudei e questi si misero al seguito di un certo Eleazar, figlio di Deinaios, del partito zelota, che riuscì a massacrare alcuni samaritani. A questo punto Cumano intervenne con la forza, eliminando molti rivoltosi giudei. I Samaritani però si rivolsero a Quadrato, legato di Siria, perché svolgesse un'indagine. Questi fece giustiziare vari giudei catturati da Cumano e inviò a Roma in catene i sommi sacerdoti Gionata e Ananias, e il comandante del Tempio, Ananus. Grazie all'intercessione di Agrippa, questi ebrei ottennero un verdetto favorevole; viceversa Cumano fu esiliato e un suo tribuno giustiziato in pubblico.
L'imperatore Claudio pensò di sostituire il procuratore Cumano con l'ex-liberto Antonio Felice (52-60 d.C.), il quale scandalizzò subito gli ebrei, sposando Drusilla, sorella di Agrippa, dopo aver costretto al divorzio il marito di lei. Subito dopo tentò di stroncare i numerosi movimenti messianici di quel periodo, e riuscì anche a catturare Eleazar, inviandolo a Roma, e a far crocifiggere molti zeloti al suo seguito, che i Romani peraltro cominciarono a chiamare col nome di «sicari», in quanto eliminavano clandestinamente con una spada corta, in occasione di feste religiose, quegli ebrei di alto rango che collaboravano coi Romani. Fu così p. es. che uccisero il sommo sacerdote Gionata.3
Al tempo di Felice un pericoloso sovversivo di origine egiziana aveva raccolto una turba di circa quattromila persone con cui si preparava ad entrare con forza a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Felice non si lasciò prendere di sorpresa e riuscì a uccidere quattrocento rivoltosi e a farne prigionieri altri duecento. L'egiziano riuscì a fuggire e i suoi seguaci continuarono a incitare i Giudei a far guerra contro i Romani.
Quando Nerone subentrò a Claudio, il procuratore Antonio Felice fu sostituito con Porcio Festo (60-62 d.C.), il quale si trovò subito in urto coi Giudei, non avendo fatto nulla per impedire ad Agrippa II di costruire un palazzo che dominava dall'alto il Tempio di Gerusalemme. La cosa si risolse grazie alla mediazione dell'imperatrice Poppea, e Nerone sostituì Festo con Lucceio Albino (62-64 d.C.).
Lucceio non era ancora arrivato in Giudea, quando Agrippa II aveva nominato il sadduceo Ananus sommo sacerdote, il quale, senza chiedere alcuna autorizzazione ai Romani, convocò il Sinedrio al fine di processare e far lapidare Giacomo (il Giusto), fratello di Gesù Cristo e capo della comunità cristiana di Gerusalemme. L'azione suscitò le proteste di molti uomini influenti della città e Albino, al suo arrivo, sostituì immediatamente Ananus con Joshua ben Damneo (o Damnaios) (63 d.C.).
Albino fu persona particolarmente venale e corrotta, ma il suo successore, il procuratore Gessio Floro (64-66 d.C.), fu peggio. Costui infatti era particolarmente avido (metteva mano al tesoro del Tempio) e infliggeva ingiusti castighi, manifestando apertamente il proprio disprezzo per il popolo ebraico: p. es. non si accontentava di sedare le rivolte ma dava anche ordine alle truppe di saccheggiare le città. Fu lui, dopo essere stato costretto a ritirarsi da Gerusalemme, a riferire a Cestio Gallo, legato di Siria, che la Giudea era in rivolta.
In effetti Eleazar, comandante del Tempio e figlio del sommo sacerdote Ananus, con alcuni seguaci zeloti che si opponevano a Roma e ai collaborazionisti giudei, persuase i sacerdoti sadducei, nonostante l'opposizione dell'alto clero, a interrompere il sacrificio quotidiano offerto a favore dell'imperatore e del popolo romano, che si svolgeva presso il Tempio di Gerusalemme. Era non solo una rottura tra alto e basso clero, ma anche una provocazione esplicita nei confronti di Roma.
Gli zeloti arrivarono persino a distruggere la casa del sommo sacerdote Ananias e i palazzi dei dinasti erodiani Agrippa e Berenice, e a incendiare gli archivi pubblici per impedire il recupero dei debiti (di qui il loro successo presso le componenti rurali). Occuparono anche la fortezza Antonia.
Nell'estate del 66 d.C. registriamo anche l'attacco zelota alla guarnigione romana della fortezza di Masada, presso il Mar Morto, che viene occupata dal partito degli zeloti capeggiato da Menahem, un figlio di Giuda il Galileo, per ricavare armi in abbondanza e per difendersi in una roccaforte ben costruita.
Menahem arma un suo esercito e partendo da Masada marcia verso Gerusalemme, intenzionato a diventare capo dello zelotismo: al suo arrivo, gli zeloti costrinsero addirittura le truppe di Agrippa II ad arrendersi, mentre alla guarnigione romana non restava che rifugiarsi nelle tre torri erodiane. Il sommo sacerdote Ananias e suo fratello Ezekias furono giustiziati. Ma Menhaem entrò in conflitto con i rivoluzionari di Eleazar, che, non volendo riconoscerlo come «messia galileo», lo uccisero a tradimento. I seguaci di Menhaem tornarono a Masada, dove elessero loro capo Eleazar ben Jair, parente di Menhaem. Intanto Eleazar massacrava gli ultimi Romani rimasti in città.
Al sentire che a Gerusalemme non esisteva più alcuna guarnigione romana, scoppiarono dei pogrom antisemiti a Cesarea, Filadelfia, Gerasa, Pella, Gadara, Tolemaide, Gaza e in molte altre città del Vicino Oriente. Così nell'ottobre-novembre del 66 d.C. Gerusalemme e tutta la Palestina erano in rivolta. Il legato della Siria Cestio Gallio, su richiesta di Gessio Floro, entrò in Palestina con la XII Legione, arricchita anche da altri reparti di rinforzo, per normalizzare la situazione.
Partito da Antiochia con le sue truppe, Gallio distrugge e saccheggia alcune città della Galilea e della Samaria, incontrando scarsa resistenza, infine arriva ad assediare Gerusalemme. Qui tuttavia indugia, temendo di non avere forze sufficienti per tenere in mano un'intera città; pur essendo già riuscito ad aprire una breccia nelle mura del Tempio, ordina ai suoi soldati di ritirarsi sul monte Scopus e poi d'interrompere l'assedio. La cosa lascia stupiti gli zeloti, che però ne approfittano subito, inseguendo la legione in ritirata e distruggendone totalmente la retroguardia.
Gerusalemme rimane completamente in mano dei Giudei, che eleggono Giuseppe ben Gorion e il sommo sacerdote Ananus comandanti supremi della città liberata dai Romani, con l'incarico speciale di organizzare i lavori per l'innalzamento delle mura più esterne.
Con la disfatta della XII Legione anche il resto della Palestina tornava in mano dei rivoltosi; vengono eletti dal Sinedrio vari capi che presidiano tutte le maggiori città: proprio in questo periodo Giuseppe Flavio viene inviato a governare la Galilea, mentre Giovanni Zebedeo, con la sua Apocalisse, chiede ai giudeo-cristiani della diaspora di appoggiare la rivolta con tutte le loro forze.
Intanto a Roma l'imperatore Nerone (nel 67 d.C.) sostituisce il legato di Siria, Cestio Gallio, col generale veterano Vespasiano e lo incarica, coadiuvato da Tito, figlio di Vespasiano, di disperdere i ribelli. Il generale viene inviato ad Antiochia, la capitale della Siria, per assumere il comando delle legioni V e X. Nel frattempo Tito viene inviato ad Alessandria per condurre la XV legione dall'Egitto alla Siria e unire le sue forze a quelle del padre: in tutto tre legioni, un certo numero di coorti ausiliarie, truppe fornite da re locali, amici dei Romani, per un totale di circa sessantamila uomini.
L'attacco alla Palestina avviene da nord, come già aveva tentato Cestio Gallio. Le truppe romane prima danno man forte alla città di Sepphoris, la più grande della Galilea, che era rimasta fedele a Roma. Poi attaccano tutte le altre città della Galilea in mano ai ribelli giudei, bruciando ogni cosa, trucidando tutti i giovani e riducendo gli altri in schiavitù. Giuseppe Flavio, dopo un tentativo di resistenza nella città di Jotapata, è costretto a fuggire e infine si consegna ai Romani in cambio della vita e della promessa di aiutarli contro gli zeloti.
Mentre Vespasiano si assicura, non senza qualche rovescio di entità limitata, il controllo delle città della Galilea, a Gerusalemme il partito degli zeloti, appoggiati dagli Idumei, mette a morte molte personalità influenti della città, accusate di collaborare coi Romani (il tradimento di Flavio aveva avuto un certo peso su queste accuse): anche il sommo sacerdote Ananus, che si era opposto agli eccessi dell'estremismo zelota, viene giustiziato dai rivoltosi. Intanto la comunità monastica di Qûmran, presso il Mar Morto, viene completamente distrutta dai Romani nel 68 d.C. Di essa si ritroverà la biblioteca solo nel 1947.
Nel corso di questi eventi e mentre Vespasiano si preparava a marciare per assediare Gerusalemme, giunse notizia che a Roma Nerone era morto e Galba gli era succeduto. Ma dopo circa sette mesi soltanto, Galba venne ucciso e salì al trono il suo rivale Ottone. Dopo poco tempo Vitellio, che era stato legato della provincia di Siria, s'impadronì del potere a Roma e la situazione divenne caotica. Di questa situazione gli ebrei non seppero approfittare per stringere alleanze con forze straniere.
Nel luglio del 69 d.C. Vespasiano viene nominato imperatore e quindi ritorna a Roma per assumere la carica, sicché le operazioni militari rimangono sotto il comando del figlio Tito. Il 69 d.C. passò alla storia come l'anno dei quattro imperatori: Galba, Ottone, Vitellio e, infine, Vespasiano, che prevalse sugli altri.
Tito raccoglie le tre legioni precedentemente comandate dal padre, aggiunge a queste la ricomposta XII Legione e, attraversando la Samaria, raggiunge abbastanza facilmente la zona di Gerusalemme. All'interno della città il potere è detenuto da almeno tre capi zeloti: Giovanni, figlio di Levi, detto anche Giovanni di Gischala, un galileo ch'era fuggito dalla sua terra al tempo della conquista di Vespasiano: ora governava il centro della città; Simone, figlio di Ghiora, che presidiava la cinta esterna e infine Eleazar, che gestiva il Tempio.
All'inizio la scarsità di viveri fece nascere alcune contese tra i vari partiti. Giovanni, fingendo di offrire un sacrificio, mandò uomini a massacrare Eleazar e i suoi, impadronendosi così del Tempio. La città si divise allora in due fazioni.
Gerusalemme a quel tempo aveva ben tre cinta di mura che erano state rinforzate e ulteriormente protette durante i mesi in cui i Giudei avevano controllato indisturbati la città: non sarebbe stato facile conquistarla. Intanto Giuseppe Flavio, che si trovava al seguito dell'esercito di Tito, teneva discorsi vicino alle mura della città per convincere i suoi connazionali ad arrendersi e a disertare dalla guerra, voluta, secondo lui, dal partito estremista degli zeloti.
I Romani, forti della loro esperienza di assedio delle città, impedirono agli abitanti di fuggire e li costrinsero alla resa per fame. Giovanni di Gischala venne catturato e imprigionato a vita; Simone figlio di Ghiora, un altro capo zelota, sarà giustiziato durante le celebrazioni della vittoria sui Giudei. Dopo il Tempio, anche il resto della città di Gerusalemme venne abbondantemente distrutto e dato alle fiamme: le mura della città furono completamente rase al suolo tranne alcune torri strategiche. I morti furono centinaia di migliaia: soltanto i prigionieri portati a Roma furono 97.000. Giuseppe Flavio parla addirittura di 1,1 milioni di morti, su una popolazione complessiva di circa 2,5 milioni. Tacito sostiene che i morti a Gerusalemme furono circa 600.000.
Chi descrisse con dovizia di particolari tutte queste cose fu Giuseppe Flavio, il quale però non fa mai alcun riferimento al movimento nazareno o cristiano. Anzi nei suoi testi tutti i riferimenti al Cristo o ai cristiani sono chiaramente interpolati, per cui essi non hanno alcun valore per riuscire a capire il contenuto politico del messaggio del Nazareno e dei suoi seguaci, né il ruolo che i cristiani ebbero nel corso della guerra giudaica. Si può soltanto presumere che, proprio in forza di quelle manomissioni, il messaggio del Cristo non era affatto di tipo etico-religioso come la chiesa cristiana ha sempre voluto far credere, a partire dalle tesi petro-paoline.
Non è infatti da escludere che Flavio vedesse i cristiani della prima ora in cattiva luce, proprio in quanto all'interno del movimento nazareno vi erano sicuramente degli elementi provenienti dall'area zelota. Sicché le interpolazioni cristiane nei suoi scritti possono anche essere intese nel senso che Flavio parla bene non del «Gesù storico» ma del «Cristo della fede», proprio perché nelle parti omesse dai cristiani ne parlava politicamente male.
È interessante tuttavia osservare che, secondo la tradizionale storia della Chiesa, durante la guerra del 66-74 i cristiani fuggirono a Pella, oltre il Giordano, evitando così di compromettersi con la rivolta. Come noto i Sinottici (Mc 13,1-36; Mt 24,1-51; Lc 21,5-28), scritti dopo il 70, contengono riferimenti alla distruzione del Tempio e alla guerra giudaica, fatti passare come eventi profetizzati dal Cristo. In ogni caso la comunità cristiana di Gerusalemme scomparve definitivamente dopo il 70 e nessuno dei suoi documenti ci è stato conservato (le lettere di Paolo, pur essendo state scritte prima, non contengono alcun riferimento alla storicità del Cristo e del movimento nazareno).
Negli anni successivi alla distruzione del Tempio, fino al 74 d.C. le operazioni di rastrellamento e di distruzione dei centri di resistenza dei ribelli continuarono con l'assedio e l'assalto alle fortezze di Masada, Macheronte, Herodium... Erano infatti rimaste attive delle roccaforti o delle fortezze in mano ai Giudei. Uno degli ultimi episodi della guerra giudaica fu l'assedio e la conquista della fortezza di Masada, avvenuto verso il 74 dopo Cristo. Quando i Romani riuscirono a prendere e ad entrare nella cittadella fortificata, trovarono che i soldati ebrei avevano ucciso tutte le donne e i bambini e si erano suicidati tutti quanti per non subire l'onta di cadere nelle mani del nemico (i morti furono 960). Gli ultimi zeloti rifugiatisi in Egitto furono sterminati.
Al tempo di Traiano, tra il 115 e il 117 d.C., si ebbe una seconda rivolta dei Giudei, questa volta della diaspora. La repressione romana fu violenta e secondo le cronache provocò centinaia di migliaia di morti. Eusebio riporta anche che a Cirene il leader locale Andrea (o Lukuas) venne acclamato come Messia dalla popolazione.
Una ribellione dei Giudei ancora più grave ebbe luogo nel periodo 132-135 d.C., al tempo in cui l'imperatore Adriano aveva deciso di intraprendere una politica di massiccia ellenizzazione e romanizzazione della Palestina, che culminò con due provvedimenti gravissimi per i Giudei: la proibizione della circoncisione sia ai pagani che ai Giudei e la decisione di ricostruire la città santa di Gerusalemme col nome di Aelia Capitolina.
Scoppiò così una guerra tra Giudei e Romani, l'ultimo grande conflitto che richiamava la grande aspettativa messianica giudaica. Capo della rivolta anti-romana questa volta fu Simon bar Koseba, un leader che il rabbino Aquiba, un esponente molto importante dell'ebraismo di quel tempo, aveva addirittura riconosciuto come Messia. Simon bar Koseba era chiamato anche Simon bar Kokhba, un nome di battaglia messianico che significava «figlio della stella», secondo la profezia di Nm 24,17.
Dopo un anno dall'inizio della rivolta l'esercito giudaico aveva completamente annientato almeno una legione romana, forse due. In Palestina non c'erano più truppe romane, Gerusalemme era stata conquistata ed era stata insediata un'amministrazione ebraica. La rivolta arrivò a un passo dal successo e fallì principalmente perché a bar Kokhba vennero meno i suoi alleati.
Secondo un suo disegno grandioso, le truppe avrebbero dovuto ricevere il sostegno di forze provenienti dalla Persia, dove risiedeva un gran numero di ebrei che godevano del favore della casa regnante. Ma proprio nel momento in cui Simon bar Kokhba aveva più bisogno del loro aiuto, la Persia subì l'invasione di tribù bellicose scese dalle montagne del nord, che richiese l'intervento dei soldati persiani e lasciò Simon privo dell'aiuto sperato.
Intanto in Siria, fuori dei confini della Palestina, i Romani si riorganizzavano sotto la guida dell'imperatore Adriano, che aveva come comandante in seconda Giulio Severo, in precedenza abile governatore della Britannia. L'esercito romano composto di dodici legioni, per un totale di circa ottantamila soldati, invase di nuovo la Palestina e con una tattica a tenaglia costrinse bar Kokhba a rifugiarsi a Beitar, il suo quartier generale, a pochi chilometri da Gerusalemme (135 d.C.).
La seconda rivolta giudaica fu così ancora una volta repressa nel sangue, Gerusalemme, già abbondantemente distrutta al tempo della prima guerra giudaica, venne completamente spianata e divenne colonia romana col nome di Aelia Capitolina. Agli ebrei fu persino proibito di entrare nella nuova città, ricostruita completamente secondo il modello greco, e nel luogo dove sorgeva l'antico Tempio, distrutto dalle truppe di Tito e mai più ricostruito, venne eretto un Tempio in onore di Giove.
La guerra del 132-135 d.C. segnò la fine delle speranze messianiche del giudaismo e la scomparsa di tutta la tradizione apocalittica giudaica. Da quel momento l'ebraismo verrà a coincidere con il rabbinismo di tradizione farisaica, che sostanzialmente è rimasto fino ad oggi.
(torna su)3) Storia della corruzione del Tempio
Gli storici greci Ecateo e Aristea che visitarono la Palestina al tempo della restaurazione, intorno al 300 a. C., rimasero profondamente colpiti dallo sfarzo che accompagnava le apparizioni in pubblico del sommo sacerdote, e dal numero spropositato di oltre 700 sacerdoti che prestavano servizio al Tempio.
Tutti erano chiamati a compiere sacrifici sia a livello comunitario, sia a livello privato. Naturalmente, con il tempo, i tributi raddoppiarono, quando non triplicarono.
Esisteva anche una decima per i poveri, da versare soltanto ogni tre anni, in quanto la Palestina pullulava di gente di misere condizioni, la cui povertà crebbe ulteriormente tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo.
I sacerdoti si appropriavano della decima parte «del raccolto e dei frutti degli alberi», «di montoni e di pecore e di tutti i prodotti della pastorizia». Per chi non pagava in natura, era prevista «una quinta parte aggiuntiva». Una voce significativa nel complesso delle entrate del Tempio di Gerusalemme era rappresentata dalle imposte. Già nell'Antico Testamento viene fatta menzione del denaro versato alla «tenda dell'incontro», per espiare colpe di natura religiosa.
Il Tempio riceveva entrate anche in conseguenza di voti e di tutte le eventuali offerte sacrificali che avevano luogo in ogni momento dell'anno.
Anche i re d'Israele, la cui residenza era collegata alla casa di Jahwè da una porta (e lo resterà, senza sostanziali mutamenti, per quasi quattro secoli), facevano omaggi al Tempio di Salomone, ma non mancavano di attingere alle casse di questo edificio di culto, la cui ricchezza costituì sempre un forte stimolo ai saccheggi dei sovrani di turno, israeliti e non (anche Nabucodonosor vi mise le mani). Occasionalmente pervennero al Tempio offerte da parte di sovrani stranieri (p. es. i principi di Adiabene).
Comunque erano soprattutto le schiere innumerevoli dei pellegrini ad arricchire i sacerdoti con le elemosine prescritte. Al tempo dei re, ogni ebreo maschio doveva recarsi tre volte l'anno al Tempio. Dopo la diaspora era possibile fare offerte unicamente nei luoghi in cui sorgevano appositi magazzini per lo stoccaggio dei tributi e delle elemosine.
Durante la Pasqua si recava a Gerusalemme un numero di pellegrini doppio degli abitanti della città, e le imposte pagate per avere un banco presso il mercato che si teneva nello spazio antistante il Tempio, finivano nelle tasche del sommo sacerdote.
A Gerusalemme si tenevano anche altri mercati: della frutta, del grano, del legno, del bestiame, e persino una vendita all'incanto di schiavi.
Alcune offerte (in natura o in denaro), come quelle per la pace o per l'espiazione di una colpa o di un peccato, se ritenute particolarmente sante, finivano del tutto, o in parte, nelle casse del clero.
Più di un milione di Giudei, dispersi dalla diaspora, per tutta la durata del secondo Tempio (ma anche, in parte, dopo la sua distruzione), continuarono a inviare denaro in Palestina. Quasi ogni città aveva una cassa per la raccolta del «denaro sacro». Da alcune terre, come Babilonia o l'Asia Minore, affluiva tanto denaro da attirare non solo i predoni, ma anche le autorità romane.
I santuari ebraici svolgevano addirittura la funzione di banche, utilizzando le loro cospicue ricchezze per fornire prestiti effettuati a un tasso d'interesse corrispondente a quello vigente nei paesi confinanti: il 12% nell'Egitto dei Tolomei, dal 33% al 50% in Mesopotamia, ecc. La Bibbia, naturalmente, tace di tutto ciò.
Lo storico ebraico Flavio Giuseppe documenta nei dettagli l'avidità dell'alto clero che si rifiutava di riconoscere gli altri templi dedicati al culto di Jahvè, come quello di Geroboamo a Bethel, un tempio statale analogo a quello di Gerusalemme, o i due santuari al di fuori della Palestina, quello di Elefantina e di Leontopoli, o quello, ancora, di Samaria. Si trattava, peraltro, di luoghi di culto in grado di esercitare una forza di attrazione che, soprattutto per quanto concerneva i Giudei allontanati dalla diaspora, era modesta.
Il basso clero, invece, viveva in condizioni d'indigenza, doveva versare la decima parte delle offerte e non poteva fare con certezza affidamento sul resto, spesso preda di ladri senza scrupoli. Al tempo di Neemia, allorché vi erano 4289 sacerdoti, ripartiti in 24 classi, le entrate del Tempio erano così ingenti che si dovettero costruire in altre città nuovi magazzini per le scorte.
Neemia stesso esigeva «annualmente la terza parte di una moneta d'argento per il mantenimento della casa di Dio», «legna da ardere per il tempio del Signore», «i primi prodotti dei campi e primi frutti degli alberi... i nostri primogeniti e primi nati del nostro bestiame», e via dicendo.
È naturale che, col tempo, s'allargò progressivamente la schiera dei nemici di questo clero ricco e potente che, a partire dal periodo dei re, aveva fatto in modo di definire i propri privilegi fin nei minimi dettagli. Con questo clero ebbero rapporti molto tesi i leviti, che svolgevano l'ufficio di cantori, guardiani delle porte e amministratori del Tempio, di servitori dei sacerdoti e a volte di loro rappresentanti.
Il popolo sfruttato si rifiutava di pagare ai leviti le decime sul grano e sul vino, mentre i sacerdoti, a partire dall'età ellenistica, cominciarono a prelevare una parte delle decime spettanti ai leviti, per accrescere la propria ricchezza ormai divenuta proverbiale.
(torna su)4) Israele e la catastrofe di duemila anni fa
Chi scrisse i vangeli cristiani ebbe netta la percezione che con l'esecuzione capitale del leader del movimento nazareno si era compiuto un delitto le cui conseguenze sarebbero state nefaste. E siccome quei testi furono scritti dopo l'occupazione di Gerusalemme da parte delle legioni di Vespasiano, nel 70, gli autori di quei testi ritennero che quell'evento catastrofico fosse una diretta conseguenza di quella crocifissione. Sicché essi attribuirono alla «giustizia divina» la punizione degli ebrei colpevoli, inaugurando così l'antisemitismo come arma ideologica contro l'ebraismo in generale, considerato in sé e per sé.
Oggi è forse venuto il momento di dire che la vera catastrofe fu in realtà compiuta dagli stessi cristiani, cioè da quella parte di ebrei seguaci di Cristo, appartenenti al movimento nazareno. Essa è consistita in una serie di operazioni ideologiche e politiche che sono state fatte passare come del tutto naturali e legittime. Vediamo quali.
1. Anzitutto si è attribuita al leader politico Gesù una unigenita, cioè esclusiva, «figliolanza divina», trasformando l'insolita scomparsa del suo cadavere dal sepolcro in una sicura «prova» della «resurrezione», in cui però si deve credere esclusivamente per fede (di qui l'inutilità di esibire la sindone). Nel proto-Vangelo di Marco dice l'angelo alle donne in visita al sepolcro: «È risorto, non è qui» (Mc 16,6). Cosa che, in altre parole, voleva dire non solo che la misteriosa scomparsa si poteva interpretare come un ridestamento miracoloso del cadavere voluto da dio o dal suo spirito, ma anche che il Cristo sarebbe risorto anche senza che le donne e gli apostoli trovassero una tomba vuota.
In particolare è al centurione romano ai piedi della croce che viene attribuita espressamente la testimonianza di fede circa la figliolanza divina del Cristo (Mc 15,39). Con essa i cristiani potevano far capire all'impero romano che sarebbero stati disposti a un compromesso: avrebbero rinunciato a qualunque rivendicazione politica, se in cambio si fosse riconosciuta la natura divina del Cristo. Il che, in sostanza, era come chiedere di accettare una diarchia di poteri istituzionali tra Stato e Chiesa (cosa che però avverrà soltanto con Costantino, poiché fino a lui i cristiani verranno sempre considerati sleali o inaffidabili nei confronti degli interessi superiori dello Stato).
Negli altri vangeli e negli Atti degli apostoli la testimonianza di fede viene agevolata dai racconti, del tutto inventati, di apparizione del Cristo risorto e della sua ascensione in cielo. Si tratta ovviamente di racconti elaborati dopo aver rinunciato definitivamente a credere in una parusia più o meno imminente del Cristo.
In questo modo si è fatta passare la decisione ebraica di condannare Gesù come un gesto altamente sacrilego e quindi – in assenza di un pentimento da parte delle istituzioni e di una pronta conversione al cristianesimo – del tutto imperdonabile. Il che ha reso l'antisemitismo ancora più legittimato.
2. Dopo aver detto che Gesù aveva caratteristiche divine, lo si è trasformato in un superuomo in grado di compiere qualunque prodigio, rendendo così ancora più inspiegabile la decisione ebraica di condannarlo.
Paradossalmente però proprio il tentativo di rendere ancora più colpevole l'incredulità degli ebrei al cospetto dei tanti (presunti) miracoli del Cristo, si ritorce contro gli stessi cristiani, in quanto rende tale incredulità del tutto giustificata: infatti non per il fatto di apparire uno straordinario taumaturgo, Gesù poteva essere considerato il messia politico liberatore della Palestina e tanto meno l'unigenito figlio di dio.
3. Oltre a ciò gli autori dei vangeli hanno deciso di spoliticizzare Gesù al massimo. Infatti il tipo umano che hanno creato è lontanissimo non solo dai modelli ebraici tradizionali di leader politico-religiosi-nazionalistici, ma anche da qualunque tipologia di leader politico-rivoluzionario, che a quel tempo era necessariamente anti-romano. In questa destoricizzazione della figura di Gesù il ruolo di san Paolo è stato determinante.
L'unica immagine «politica» che si dà del Cristo è quella di un sacerdote che vuole opporsi alla classe sacerdotale ebraica dominante, la quale non lo riconosce nella sua autoaffermazione divina e neppure nel suo tentativo di superare l'ideologia mosaica. Di qui la necessità, espressa dai Sinottici, di collocare l'epurazione del Tempio non all'inizio della carriera politica di Gesù (come fece giustamente Giovanni), bensì alla fine.
4. L'altra immagine politica che si dà di lui è quella relativa al rapporto con le istituzioni romane. L'episodio del tributo a Cesare (Mc 12,13 ss.) è emblematico: Gesù accetta di pagare le tasse allo Stato romano, riconoscendo quindi il dominio già effettivo delle legioni sulla Palestina, a condizione però che lo Stato, rappresentato dall'imperatore, accetti di non considerarsi di natura «divina», cioè di non porsi in maniera ideologica, in quanto esiste già un unico figlio di dio.
Gesù in sostanza viene fatto passare per un credente favorevole a un regime di separazione tra Chiesa (cristiana) e Stato (pagano). In questa maniera la comunità cristiana potrà far vedere che lo Stato era oppressivo, nei suoi confronti, senza una vera ragione, semplicemente perché non accettava il suddetto regime di separazione, quindi non perché aveva da temere politicamente qualcosa da parte dei cristiani, per i quali il vero regno di pace, libertà e giustizia da desiderare non appartiene a questo mondo, bensì a quello ultraterreno della fine dei tempi. In tal senso i vangeli sono stati scritti per essere accettati dai Romani. Significativo è appunto – come già detto – l'episodio marciano del centurione che, dopo aver tecnicamente preparato il momento dell'esecuzione capitale, riconosce che Gesù era veramente «figlio di dio». Un'attestazione del genere non viene fatta neppure dalle donne al cospetto della tomba vuota, le quali anzi – nella prima chiusa di Marco – fuggono spaventate, a riprova che la fede nella divinità del Cristo va al di là persino della tomba vuota. Infatti nell'ideologia paolina (che Pietro, ad un certo punto, farà propria) Cristo non è risorto perché la tomba era vuota, ma perché non poteva morire come un uomo, cioè finendo in putrefazione, essendo figlio di dio.
5. Il governatore Pilato quindi viene fatto passare per un politico poco intelligente, debole di carattere, il quale, pur avendo capito che Gesù non era politicamente meritevole di morte, preferì lasciarsi strumentalizzare dalle intenzioni omicide della classe sacerdotale, mosse dall'«invidia» (Mc 15,10) per la grande popolarità del Nazareno e dalla preoccupazione con cui scardinava talune interpretazioni della legge mosaica. Pilato sarebbe stato vittima delle circostanze e avrebbe agito per opportunismo, non per convinzione.
6. L'interpretazione totalmente mistificata degli eventi accaduti al leader del movimento nazareno, e persino al suo stesso movimento, di cui p. es. nulla viene detto se abbia partecipato o no alla resistenza anti-romana successiva alla crocifissione di Gesù, ha ottenuto due risultati sconvolgenti, che perdurano a tutt'oggi:
a) si è tolta alla politica del Cristo qualunque carattere di eversione nei confronti dell'imperialismo romano, e quindi si è tolta all'intera vicenda del processo-farsa organizzato da Pilato l'intenzione di eliminare un personaggio politicamente molto scomodo, il quale infatti era pronto a compiere un'insurrezione armata nei giorni immediatamente precedenti alla cattura, che non a caso erano stati scelti in concomitanza alla festività pasquale, quella più idonea a compiere azioni eversive;
b) si è tolta all'ideologia politica del Cristo qualunque riferimento alla prassi sociale pre-schiavistica, cioè al recupero dell'esperienza del comunismo primitivo. L'unica possibile «comunione» che nell'ambito del cristianesimo è possibile vivere è quella di tipo sacramentale-eucaristico (cioè di tipo mistico), mentre, per quanto riguarda gli aspetti più propriamente sociali, si rimanda al passo degli Atti degli apostoli (2,42 ss.), in cui Luca parla di condivisione del bisogno reciproco, di equa distribuzione dei beni. Non si fa mai alcun cenno, in questo passo o altrove, alla necessità di eliminare la proprietà privata dei fondamentali mezzi produttivi che assicurano la sussistenza alla comunità; anzi, si dà per scontato che la povertà, nell'orizzonte terreno, non potrà mai essere definitivamente superata.
Particolarmente significativo è l'episodio (riportato in Gv 12,4 ss.) in cui si fa dire a Gesù, rivolto a Giuda, dopo che questi aveva protestato per lo spreco del profumo costoso usato dalla sorella di Lazzaro, che i poveri li avrebbero sempre avuti con loro, per cui non sarebbe stato con la vendita di quel profumo che avrebbero risolto il problema della povertà.
Un altro episodio significativo è quello di Pietro che, di fronte ai poveri che gli chiedono la carità, nei pressi del Tempio, viene trasformato da Luca, negli Atti degli apostoli (3,6), in un nuovo Cristo dai poteri divini, il quale, volendo far capire che più importante della vittoria sulla povertà è l'acquisizione della fede nella figliolanza divina del Cristo, decide di compiere un miracolo di guarigione.
7. Oltre all'interpretazione mistificante operata ai danni dell'ideologia politico-rivoluzionaria del Cristo, se n'è operata un'altra nei confronti del tradimento di Giuda. Infatti questo tradimento è stato visto in rapporto alla cosiddetta «economia salvifica» che dio-padre voleva realizzare, con la mediazione del proprio figlio, a vantaggio degli uomini, impossibilitati a liberarsi delle loro colpe a causa del peccato originale. Il tradimento è stato appunto utilizzato per dimostrare che gli uomini, da soli, non sono in grado di ritornare al paradiso perduto, all'eden originario.
Se Cristo, infatti, viene fatto passare per l'agnello sacrificale che dio-padre (dal comportamento, in tal senso, molto veterotestamentario) avrebbe preteso per riconciliarsi col genere umano (quell'umanità voluta dallo stesso figlio), è evidente che il tradimento di Giuda non poteva avere in sé alcunché di sconvolgente: esso era del tutto previsto dalla «prescienza divina» (come la chiama Pietro in At 2,23) e il Cristo non poteva che accettarlo passivamente, essendo convinto che dio-padre ha sempre ragione e che la sua volontà non può mai essere messa in discussione.
Poste le cose in questi termini, è evidente che per gli apostoli rimasti in vita, dopo la crocifissione del loro leader, non si poneva neppure il problema se continuare o meno il suo messaggio politicamente eversivo. La scelta fu quella di rinunciare alla rivoluzione anti-romana. Alcuni dubbi vi possono essere soltanto sulla figura dell'apostolo Giovanni, che nel IV Vangelo (il più politicizzato di quelli canonici e, per questa ragione, il più manipolato) appare in antitesi a Pietro e che nell'Apocalisse appare in antitesi a Paolo.
8. Questa scelta a favore della rassegnazione venne particolarmente motivata dal fatto che si era trovata vuota la tomba in cui era stato deposto il corpo di Gesù. Interpretando quella strana scomparsa come una sicura resurrezione, gli apostoli (in particolare Pietro) ritennero che la scelta migliore fosse quella di attendere passivamente il ritorno del Cristo, che avrebbe necessariamente dovuto «trionfare» sia contro i sacerdoti che contro Roma.
Dopo che nell'immediato ci si accorse che non era avvenuta alcuna parusia eclatante, si decise di accettare l'idea di Paolo di Tarso di posticiparla alla fine dei tempi, facendola coincidere con il cosiddetto «giudizio universale». Poi s'inventarono tutti i racconti di apparizione di Gesù risorto e di ascensione al cielo.
Paolo fu il principale protagonista della netta spiritualizzazione del Cristo, il principale ideatore della sua totale divinizzazione e dell'idea di dover rinunciare definitivamente a una liberazione nazionale della Palestina.
9. L'ultima interpretazione mistificante – anche questa dalle conseguenze devastanti – fu quella di far passare il Cristo come l'artefice di una nuova religione, tutta ruotante attorno a un cardine fondamentale: Gesù Cristo è l'unigenito figlio di dio ed egli sapeva di esserlo, sapeva a cosa sarebbe andato incontro rivelando agli uomini la propria identità, ma non per questo poteva impedire a se stesso di fare quel che doveva fare per il bene dell'umanità; anche perché, comportandosi così, mostrava di adempiere alla volontà del dio-padre.
Dove sta la mistificazione in questa versione dei fatti? Sta nell'idea di far credere, da un lato, che la figliolanza divina fosse una esclusiva prerogativa del Cristo; e, dall'altro, ch'egli fosse un credente in dio, cioè in un'entità astratta, superiore ed esterna all'uomo.
Quando nei vangeli viene detto che gli ebrei volevano lapidarlo perché «si faceva come Dio» (Gv 10,33), in realtà volevano farlo perché negava l'esistenza di un dio onnipotente e onnisciente, creatore e signore del cielo e della terra. Cristo era sostanzialmente un ateo, come Buddha, Socrate, Confucio e non pochi filosofi del mondo greco-romano a lui coevo o precedente. Che fosse un ateo lo dimostra nell'episodio del Vangelo di Giovanni in cui ricorda agli ebrei, intenzionati a lapidarlo, che anche in un salmo è scritto: «Voi siete tutti dèi» (10,34).
10. In conclusione: perché la crocifissione del Cristo può essere definita un evento catastrofico? Per due ragioni fondamentali:
a) stando ai vangeli egli ha tolto definitivamente agli uomini la possibilità di credere in un superamento effettivo dello schiavismo o del servaggio su questa Terra in favore di un recupero della prassi del comunismo primitivo; cioè in sostanza i cristiani hanno illuso il genere umano di poter essere interiormente liberi anche vivendo in una condizione schiavile o servile;
b) di conseguenza egli ha tolto agli uomini la convinzione d'essere gli unici artefici del loro destino, ovvero li ha indotti a credere che senza la cosiddetta «grazia divina» la loro volontà è del tutto impotente.
Se il Cristo dei vangeli fosse davvero stato quello effettivamente esistito, gli ebrei non avrebbero avuto tutti i torti a farlo fuori. Egli infatti, col proprio atteggiamento politicamente rassegnato, si rendeva responsabile della soggezione della Palestina nei confronti di Roma.
Oggi quindi vanno considerati superati o comunque totalmente da rivedere non solo religioni come l'ebraismo e il cristianesimo, non solo atteggiamenti pregiudizievoli come l'antisemitismo o l'anticlericalismo fine a se stesso, non solo la ricerca di religioni opposte all'ebraismo e al cristianesimo, non solo l'esigenza di fare dell'ateismo una bandiera politica. Va considerato superato anche l'atteggiamento di chi, di fronte agli antagonismi sociali, si attende dall'alto una loro soluzione.
(torna su)5) I vangeli e la passione di Gesù
Nei racconti evangelici della «passione di Gesù» c'è una contraddizione così macroscopica che poteva essere sostenuta solo a condizione che i protagonisti dei fatti fossero o scomparsi o ridotti al silenzio. La folla di Gerusalemme, che lottava contro i Romani non meno di quella samaritana o galilaica, avrebbe chiesto la condanna del Cristo appunto perché «messia politico». Una folla completamente reazionaria e asservita all'imperialismo romano, e proprio quella ebraica!
Alle origini del cristianesimo un credente poteva accettare una versione del genere solo perché sapeva di non appartenere ad una comunità avente finalità eversive. Il cristianesimo infatti ha scaricato completamente sugli ebrei la causa della condanna di Gesù, scagionando persino una crudele marionetta dell'imperialismo romano come Pilato, che è stato trasformato in una mera vittima delle circostanze (lui che poteva abbastanza tranquillamente esserne il regista).
La cosa più ridicola, inoltre, è che mentre la folla chiede la condanna a morte del messia-Gesù, la stessa folla chiede anche la liberazione di un altro messia politico, Barabba, che i vangeli peraltro descrivono come un terrorista (Lc 23,18) o un ladrone (Gv 18,40). Qual era dunque l'intenzione degli evangelisti? Semplicemente quella di far credere che la folla ebraica di Gerusalemme, qua talis, aveva assunto una posizione assurda, disumana (quando proprio da quella folla erano emersi i primi discepoli di Gesù!).
È evidente che quando i vangeli furono scritti o quando vennero accettati come «canonici», nessuno era più in grado di smentirne il contenuto, neppure nelle sue singole parti. Gli evangelisti infatti sono tutti preoccupati di mascherare che la scelta di liberare Barabba, in luogo del Cristo, fu determinata proprio da un atteggiamento politico estremista, col quale non si riuscì a comprendere che la politicità del Cristo aveva un respiro strategico di molto superiore a quella dei terroristi (zeloti?) capeggiati da Barabba.
Agli evangelisti interessava unicamente mostrare che il Cristo non era un politico e che quindi l'odio nei suoi confronti nasceva da motivazioni del tutto irrazionali, incomprensibili, assai più vicine al fanatismo religioso che non alla lotta politica. Gli ebrei della capitale sarebbero stati una massa di pazzi scatenati, del tutto ignari di quello che facevano: una folla ingenua, manipolata dalle autorità religiose, le quali provavano «invidia» verso un personaggio così popolare come Gesù (Mc 15,10; Mt 27,18).
Il cristianesimo primitivo ha cercato una sorta di giustificazione al fallimento delle proprie aspettative rivoluzionarie; solo che, così facendo, ha creato un forte pregiudizio antisemita, che ancora oggi tarda a morire. Invece di puntare sul fatto che, al momento della «passione», il popolo ebraico si era anzitutto comportato come un «popolo qualunque» (con le sue correnti di «destra», di «centro» e di «sinistra»), si è preferito sottolineare l'ebraicità di questo popolo, dando a questa caratteristica una connotazione decisamente negativa.
Questo modo di fare la storia è a dir poco fazioso e pregiudizievole. I cristiani non hanno mai voluto fare una vera autocritica, e se l'hanno fatta, essa di certo non appare nei documenti, molto selezionati, del Nuovo Testamento. Essi hanno dissimulato la loro incapacità rivoluzionaria scaricando sugli ebrei una responsabilità che, in quanto «ebrei», non hanno mai avuto, poiché il Cristo è stato crocifisso sia dai Romani persecutori, sia dagli ebrei collaborazionisti, sia dai «cristiani» che non hanno fatto nulla di decisivo per salvarlo.
*
Una delle cose più curiose dei Sinottici è l'aver fatta propria, da un lato, la tesi di Pietro secondo cui il Cristo «doveva morire» e, dall'altro, di aver considerato l'ebraico come un «popolo maledetto da dio». Paolo addirittura arriverà a sostenere che dio si servì dell'odio che i Giudei nutrivano nei confronti del Cristo al fine di far perdere loro il primato sui Gentili. Che cos'è questa se non un'astratta metafisica?
Se gli ebrei assassini avessero accettato l'idea di resurrezione, probabilmente non ci sarebbe stato alcun motivo, per i cristiani, di rompere con loro, né di considerare i pagani in maniera paritetica. Che cos'è questo se non un opportunismo politico?
I primi seguaci di Gesù, nell'ambito della comunità post-pasquale, avevano forse dei motivi validi per polemizzare con gli ebrei, se si esclude l'argomento della resurrezione? No, tanto è vero che nel primo concilio apostolico, a Gerusalemme, il dibattito fu impostato esclusivamente sulla questione della circoncisione e di altre usanze ebraiche che, secondo Paolo e altri suoi seguaci, non potevano essere imposte ai pagani neo-convertiti al cristianesimo. Meno che mai dopo l'esecuzione capitale del Cristo.
Sul piano politico gli ebrei divenuti cristiani di Gerusalemme attendevano ancora, esattamente come tutti gli altri ebrei non collaborazionisti con Roma, la restaurazione del regno davidico: la differenza stava soltanto nel fatto che i primi aspettavano l'imminente e gloriosa parusia del Cristo (nella convinzione che fosse davvero risorto). Essi non vedevano di buon occhio la predicazione di Paolo ai pagani perché avevano l'impressione che Paolo perdesse il suo tempo e, soprattutto, ch'egli lo facesse proprio perché non credeva più nella restaurazione del regno d'Israele. In pratica gli ebrei cristiani tenevano nei confronti di Paolo lo stesso atteggiamento ch'egli aveva tenuto nei confronti degli ebrei ellenisti al tempo dell'assassinio di Stefano.
(torna su)6) Il tributo a Cesare e la diarchia dei poteri
Se l'episodio narrato da Mc 12,13 ss. fosse effettivamente nato dalle preoccupazioni politico-religiose che le autorità giudaico-romane avevano di costringere Gesù a chiarire esplicitamente la propria posizione nei confronti del potere costituito, è assai dubbio che la sua collocazione spazio-temporale offerta dall'evangelista possa rispecchiare la verità dei fatti.
Durante la seconda (o terza) pasqua di Gesù a Gerusalemme (stando ai vangeli), le autorità giudaico-romane sapevano già bene che del movimento nazareno non potevano fidarsi. Considerando anzi l'importante tema in questione, è più probabile che l'episodio sia accaduto agli inizi della sua attività pubblica, subito dopo che la popolarità acquisita attraverso la predicazione aveva costretto il potere a intervenire (cf Mc 6,14).
Resta tuttavia impossibile credere che da parte dei movimenti ebraici anti-romani ci potessero essere dei dubbi sulla illegittimità del tributo a Cesare. Una domanda di questo genere non poteva che apparire oziosa e la risposta scontata: se qui non lo sono, la ragione va cercata nell'interesse apologetico dell'autore della pericope (Matteo e Luca, come noto, copiano da Marco).
In effetti, quando Marco scrisse il vangelo, la comunità cristiana aveva già rinunciato, da tempo, a realizzare l'obiettivo politico della liberazione nazionale dal dominio romano, e aveva anzi cominciato a maturare l'esigenza di farsi accettare da Roma. A tale scopo era indispensabile che la comunità dichiarasse la propria lealtà nei confronti dell'imperatore, senza però venir meno alla propria identità religiosa, che si era costruita opponendosi in maniera più o meno radicale al giudaismo.
In questo senso il brano in oggetto può essere sorto sotto l'influenza del movimento legato al più grande riformatore giudaico: Paolo di Tarso, il quale, per la prima volta, riuscì a unificare il rispetto (gius-politico) delle istituzioni di governo pagane con la difesa ad oltranza del nuovo concetto cristiano di «dio-padre», che voleva porsi in alternativa sia alle concezioni religiose elleniche che a quelle ebraiche tradizionali. Paolo infatti trasformerà il Cristo nell'unico vero «figlio di dio», venendo così a scontrarsi col monoteismo assoluto dei Giudei, col politeismo pagano e col processo di deificazione in atto da parte degli imperatori romani.
Il fatto che, per queste ragioni, il cristianesimo primitivo venisse duramente osteggiato da pagani ed ebrei, non poteva non suscitare l'impressione (oggi come allora) ch'esso rappresentasse un movimento rivoluzionario. In realtà la diarchia dei due poteri, civile e religioso, sostenuta da Paolo, aveva lo scopo non di abbattere l'imperialismo di Roma, bensì di confermarlo, seppure con la rivendicata autonomia della realtà ecclesiale (il che, per quei tempi, era politicamente inaccettabile da parte dei Romani, abituati a servirsi della religione come instrumentum regni).
Con la svolta costantiniana, infatti, si capirà che la novità culturale del cristianesimo poteva essere tranquillamente accettata, in quanto essa non si sarebbe mai trasformata in una transizione politica verso l'uguaglianza sociale o la democrazia. Sotto questo aspetto ci si potrebbe chiedere se questa pericope possa costituire il fondamento gius-politico della concezione bizantina della diarchia dei poteri.
Ora, prima ancora che qualcuno dica che stiamo forzando i testi, ci teniamo a precisare, in via preliminare, che l'episodio in oggetto va considerato assolutamente privo di attendibilità storica, per tutta una serie di ragioni che vedremo al momento della sua analisi (qui basti dire che solo in chiave del tutto strumentale alla posizione cristiana post-pasquale i redattori han potuto mettere insieme farisei ed erodiani). Tuttavia, se anche il Cristo avesse formulato, in nuce, una teoria di tipo «diarchico», è assai improbabile ch'egli, con essa, volesse rivendicare la mera autonomia della sfera religiosa dalle ingerenze della sfera politica. Questo semmai può essere considerato un obiettivo democratico e anche culturalmente rivoluzionario del cristianesimo primitivo, essendo in netta controtendenza alla deificazione, allora emergente, della figura imperiale; ma è altresì facile rendersi conto che se il Cristo politico si fosse limitato a questo, egli non sarebbe certo stato più «rivoluzionario» dell'apostolo Paolo, il quale affermava la diarchia non per abbattere il potere istituzionale di Cesare ma, al contrario, per confermarlo.
Neppure ha senso sostenere che il Cristo abbia voluto affermare la diarchia solo in maniera tattica o provvisoria, in attesa di realizzare una rivoluzione politico-nazionale vera e propria: farisei, zeloti, esseni o battisti non avrebbero accettato neppure formalmente alcun confronto paritetico fra Dio e Cesare.
In realtà la preoccupazione principale del Cristo, quella per cui si trovarono d'accordo nell'eliminarlo sia i Romani che i capi-giudei, dovette essere quella di rovesciare il governo di Pilato, ridimensionando di molto, nel contempo, le pretese integralistiche dei Giudei.
Mc 12,13: Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso.
Qui interviene un duplice potere: quello ufficiale (galilaico) di Erode Antipa, e quello popolare dei farisei, entrambi mandati dagli scribi di Gerusalemme. Luca, che era un seguace dell'ex-fariseo Saulo di Tarso, preferisce limitarsi a citare «scribi e sommi sacerdoti»; Matteo invece, che odia mortalmente l'ipocrisia dei farisei, fa di quest'ultimi i responsabili principali dell'interpellanza (anche perché, a ben guardare, non avrebbe avuto senso accusare di «ipocrisia» o «malizia» gli erodiani).
Come noto, infatti, gli erodiani erano dei collaborazionisti (Erode era un vassallo di Roma) ed è ben strano che qui siano «inviati» dagli scribi, che pur essendo ostili a Gesù sin dall'inizio dei vangeli, non avrebbero accettato di compromettersi ufficialmente con gli erodiani: in via di principio essi rifiutavano il dominio di Roma come potenza occupante, anche se, di fatto, vi si adattavano, in attesa della venuta di un messia liberatore. Così erano anche i farisei, che però riscuotevano un certo consenso negli ambienti popolari delle sinagoghe, essendo stati duramente perseguitati sotto il regno di Erode il Grande.
La presenza degli erodiani può far pensare che in origine l'episodio sia avvenuto in Galilea, ove prevalentemente essi risiedevano, ma sarebbe stata davvero improbabile un'interrogazione pubblica di questo genere direttamente rivolta a Gesù: era sufficiente interpellare i suoi discepoli, i quali avrebbero risposto che il tributo i nazareni lo pagavano, seppure obtorto collo. Chi si rifiutava di farlo non veniva interpellato, ma ricercato dai funzionari del fisco.
Se d'altra parte il potere giudaico avesse voluto sincerarsi di persona dell'effettivo pagamento del tributo da parte di Gesù, avrebbe inviato solo gli scribi (come risulta da Mc 3,22 per un'altra questione): e in ogni caso al Sinedrio interessava che Gesù pagasse anzitutto la tassa al Tempio (cf Mt 17,24 ss.) non quella a Roma. Solo Lc 23,2 dirà che davanti a Pilato, al momento del processo, accuseranno falsamente Gesù di «impedire di dare i tributi a Cesare». Cosa che se fosse stata vera, avrebbe offerto a Pilato un motivo in più per procedere all'arresto motu proprio, senza aspettare che glielo consegnassero grazie a un tradimento.
Nella versione di Mt 22,16 sono stati i farisei a prendere autonomamente l'iniziativa dell'interpellanza e ad invitare gli erodiani ad assistere al dibattito. Non è la prima volta che questi due gruppi politico-religiosi, notoriamente nemici per questioni di ordine politico, si trovano d'accordo nei vangeli (sempre sul piano politico, ma per motivi diversi) nel complottare contro Gesù (cf Mc 3,6).
Tuttavia, gli stessi farisei (si veda ad es. una figura democratica come quella di Nicodemo) potevano anche non essere convinti della necessità di pagare il tributo a Cesare, ed è quindi assai dubbio che, rivolgendosi a Gesù in maniera così ufficiale, avrebbero cercato di «coglierlo in fallo nel discorso». La domanda se pagare o no le tasse a Cesare, un fariseo avrebbe potuto tranquillamente porla a Gesù in privato, per capire s'egli si riteneva il messia tanto atteso oppure no.
Qui invece appare evidente che dietro la domanda delle due rappresentanze politiche si nasconde una decisione negativa presa già in precedenza nei confronti del leader nazareno, e se questa cosa può apparire normale pensando agli erodiani, non lo è affatto pensando ai farisei, le cui intenzioni qui appaiono esageratamente prevenute. Mettendo farisei ed erodiani sullo stesso piano, gli evangelisti dimostrano di ragionare col senno del poi, per giunta ideologicamente viziato.
Nel racconto, in un certo senso, Gesù appare già come un «vincente», in quanto, nei confronti degli erodiani, afferma un primato del religioso ch'essi negano, mentre nei confronti dei farisei afferma un valore autonomo, di principio, della politica di Roma, che i farisei erano disposti ad accettare solo de facto, in quel momento, e che soltanto dopo la distruzione di Gerusalemme saranno costretti ad accettare anche de jure.
È singolare il fatto che nella pericope Gesù assuma una posizione contraria più alle aspirazioni indipendentistiche dei farisei che non al collaborazionismo smaccato degli erodiani (contro il quale avrebbe potuto trovare l'appoggio degli stessi farisei). E questo nonostante che l'intenzione redazionale sia quella di mostrarlo al di sopra delle parti.
Mc 12,14: E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi gli uomini in faccia, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?».
Qui i farisei e gli erodiani sembrano voler strappare a Gesù una dichiarazione che dia motivo d'accusarlo presso le autorità romane (o filo-romane) o di screditarlo davanti al popolo ebraico (che qui si suppone nemico di Cesare). La forma usata nei due falsi elogi di questo versetto, sembra essere attribuibile, la prima, agli erodiani, la seconda ai farisei. L'ipocrisia dei farisei non può essere identica a quella degli erodiani, nei cui confronti la popolazione ebraica non può avere che parole di condanna.
I farisei, che avrebbero potuto trovare in Gesù un loro alleato, appaiono inevitabilmente più ipocriti degli erodiani, per i quali il messia era già venuto nella persona di Erode. Considerando che il movimento facente capo a Gesù era divenuto sempre più consistente e sempre più capace di opporre una valida resistenza alla politica filo-romana di Erode, i farisei avrebbero dovuto preferire una risposta negativa al pagamento del tributo. Standosene invece alleati coi loro rivali, dimostrano di preferire una risposta negativa soltanto per consegnare Gesù al potere del tetrarca. Sinceramente parlando, un atteggiamento del genere appare molto improbabile in un gruppo politico che non aveva affatto scelto di stare dalla parte di Erode, né, tanto meno, da quella di Cesare.
La posizione sfavorevole dei farisei nei riguardi di Gesù è peraltro contraddetta da Lc 13,31, ove si afferma che alcuni di loro avvisarono Gesù di fuggire dalla Galilea perché Erode voleva eliminarlo. Tra l'altro, stando ai racconti di tutti gli evangelisti, essi non compariranno mai nei racconti della Passione, anche se certamente la maggioranza degli scribi presenti nel Sinedrio aderiva al partito farisaico.
L'ipocrisia degli erodiani si pone qui a un livello alquanto superficiale, tanto che la loro domanda non potrebbe neppure essere definita come una forma di capziosità: infatti se volevano porla per mettere alla prova una persona scomoda come Gesù, non l'avrebbero fatto in Giudea ma in Galilea, e non alla fine della sua predicazione ma all'inizio.
Più profonda invece è l'ipocrisia redazionale. In effetti, il fatto che qui i farisei vogliano verificare se Gesù ha il coraggio di dire no al tributo in presenza degli erodiani, è emblematico dell'odio che i primi cristiani dovevano provare, dopo la morte di Gesù, nei confronti degli stessi farisei, dimostratisi poco affidabili al momento della tentata insurrezione e del processo, allorché appunto essi assunsero una posizione piuttosto attendista e assai poco responsabile.
In realtà per un fariseo di sane tradizioni ebraiche, il tributo a Cesare non andava assolutamente pagato. Ciò su cui bisognava discutere, per loro, era semmai l'effettiva consistenza del potere giudaico, in virtù del quale gli ebrei avrebbero dovuto opporsi a tale ingiusto fiscalismo. Tuttavia, proprio su questo punto la loro posizione era poco convincente, cioè troppo pessimista per costituire un valido polo di aggregazione.
I farisei erano stati coraggiosi nel passato, ai tempi di Erode il Grande, quando avevano pagato con la vita il loro rifiuto di ellenizzare la cultura ebraica. Ma al tempo di Erode Antipa e di Pilato, la loro popolarità era venuta meno, mentre rimaneva costante in loro l'illusione di poter sopravvivere in virtù di una certa «rendita politica». È evidente, in questo senso, che già da molto tempo essi dovevano sapere che Gesù non aveva alcuna intenzione di pagare il tributo a Cesare e che, alla prima occasione, egli sarebbe stato intenzionato ad offrire al popolo ebraico l'opportunità di una coerenza pratica rispetto alle generali aspettative di liberazione nazionale. Lo scetticismo dei farisei si evidenziava soprattutto nel fatto ch'essi non ritenevano ancora maturi i tempi per una rivoluzione antiromana.
Al tempo di Gesù esisteva un solo partito per il quale era più che doveroso il rifiuto di pagare il tributo a Cesare: quello degli zeloti, i quali, dopo essersi rifugiati nel deserto, conducevano una guerriglia armata a scopi eversivi. Barabba era uno di loro e così gli altri due estremisti crocifissi con Gesù, giustiziati per aver partecipato a una rivolta pasquale nella Città Santa. E sicuramente tra gli apostoli militavano alcuni ex-zeloti.
I farisei invece avevano abbandonato il terreno eversivo dell'insurrezione, e si erano adattati a una resistenza di tipo soprattutto morale, che non dispiaceva ai ceti sociali medi: di qui la loro relativa popolarità, che però aveva iniziato a entrare in crisi quando si erano acuiti i termini dello scontro giudaico-romano. Già il movimento del Battista li aveva in qualche modo surclassati.
Nei confronti di Gesù i farisei hanno sempre tenuto un comportamento ambiguo, perché da un lato si rendevano conto, memori della loro precedente esperienza, che senza un'opposizione all'imperialismo romano, la Giudea non sarebbe mai stata libera; dall'altro però temevano che il protagonista di questa liberazione dovesse essere un movimento, quello nazareno, estraneo all'ufficialità istituzionale della cultura ebraica (non solo perché esso violava il sabato, ma anche perché contestava talune interpretazioni e applicazioni della legge mosaica, non praticava più certe tradizioni ecc.).
I farisei erano conservatori a livello ideologico, ma – a differenza dei sadducei – sul piano politico cercavano di essere o di apparire progressisti. Essi sapevano bene che né gli erodiani né gli zeloti erano i loro veri antagonisti, ma unicamente il movimento nazareno, che non era né vergognosamente collaborazionista come gli erodiani né irriducibilmente estremista come gli zeloti, e nei confronti del quale, col tempo, poteva anche diventare necessario trovare un'intesa.
La domanda relativa al tributo, riportata in questo versetto, appare assurda anche per un'altra ragione. Se Gesù avesse risposto negativamente, le alternative, per lui, sarebbero state due: 1) essere immediatamente arrestato, 2) diventare esplicitamente messia. Ora, un messia che si fa arrestare così ingenuamente, è poco credibile. Ma è forse credibile che un individuo decida di diventare messia solo dopo aver risposto a quella domanda? Peraltro che senso avrebbe avuto porre una domanda del genere (in quelle modalità) a un individuo che non avesse già chiaramente manifestato una caratterizzazione messianica? Ma se il Cristo impressionava per la sua carica messianica (non a caso gli riconoscono l'onestà e la schiettezza nella sua predicazione), possibile che su una questione di così capitale importanza, gli avversari non sapessero già come la pensava? possibile ch'egli non avesse già manifestato la sua opinione? ed è forse possibile (come vedremo) ch'egli, in tale contesto, assumesse una posizione così ambigua?
In realtà gli erodiani da tempo sapevano che il Cristo era un personaggio molto scomodo (certamente non meno di quel Battista che Erode aveva fatto giustiziare): in Mc 3,6 essi si trovano pienamente d'accordo coi farisei sulla decisione di farlo morire. O meglio, gli erodiani lo vogliono morto per motivi politici, in quanto Gesù gode di troppa popolarità; i farisei invece lo vogliono morto per motivi ideologici, in quanto, con la sua predicazione mina le fondamenta dell'establishment e delle tradizioni giudaiche. È altresì da escludere che gli erodiani volessero morto Gesù semplicemente perché chiedeva di non pagare le tasse: la decisione di costituire un movimento politico, quello nazareno, non era nata col proposito precipuo di non pagare le tasse ai Romani, anche se certamente questo era un obiettivo della liberazione nazionale, un modo per opporsi allo straniero invasore.
Gli inquirenti pongono la questione del tributo in due modi diversi: 1) in rapporto alla liceità del fatto, 2) in rapporto alla sua necessità. Si può in un certo dire che, mentre per i farisei è in dubbio la liceità del fatto, per gli erodiani si tratta soltanto di costatarne la necessità.
La visione politica degli erodiani è più schematica e semplicistica, in quanto si avvale dei soli rapporti di forza: che Gesù pagasse o no le tasse, restava comunque una persona politicamente indesiderabile. Qui l'autore del racconto ha voluto far risaltare una forma d'ipocrisia che nella fattispecie era impossibile. Non ha infatti senso che essi, pur sapendo benissimo quanto Cesare fosse forte, ne chiedessero a Gesù la conferma, onde assicurarsi una dichiarazione di sottomissione. Un messia che pretende d'essere «veritiero» e «imparziale», non avrebbe mai dato loro alcuna soddisfazione e un partito collaborazionista come il loro non avrebbe avuto bisogno di appurare se il Cristo fosse o no un «vero» messia.
In pratica è come se gli avessero detto: «La tua verità e la tua imparzialità hanno valore solo nella misura in cui paghi le tasse a Cesare». Uno zelota, a questo punto, avrebbe potuto sostenere esattamente il contrario: «Chi è costretto a pagare le tasse a un governo straniero non potrà mai pretendere d'essere pienamente veritiero e imparziale».
Nel contesto tuttavia l'autore cristiano vuole dimostrare un'altra cosa, e cioè che Gesù è veritiero e imparziale anche se paga tranquillamente le tasse a Cesare, e non perché egli ha in mente di non pagarle quando verrà il momento opportuno (quello dello scoppio rivoluzionario), quanto perché il versamento del tributo allo straniero non va più considerato in contraddizione con la liberazione meramente spirituale dell'individuo (quella propagandata dal movimento petro-paolino).
Di conseguenza, un Gesù che agli occhi degli erodiani accettasse di esporsi, pagando il tributo a Cesare e smettendo così di rappresentare un pericolo pubblico, nel racconto cristiano non ha neppure bisogno di compromettersi, in quanto può versare il tributo senza problemi di coscienza: gli erodiani sono «maliziosi» senza ragione; la loro domanda nasce da un puro e semplice malinteso...
Sinceramente parlando, le due suddette forme della domanda sarebbero state più appropriate se fossero state attribuite a un unico gruppo politico, quello appunto farisaico, ancora indeciso su quale coerenza tenere nei confronti dei propri ideali di liberazione. Ma, di nuovo, una domanda del genere i farisei avrebbero dovuto porla all'inizio della sua predicazione, quando ancora non sapevano la sua risposta, ch'era appunto la seguente: «il tributo va pagato fin quando è possibile farne a meno».
I farisei amavano discutere sui princìpi: per loro una cosa diventava necessaria, reale, solo quando ne veniva dimostrata sul piano concettuale la giustezza. E ovviamente obbedivano a Cesare per necessità, non per virtù, pagandogli le tasse controvoglia, nella convinzione di non avere alternative praticabili.
Per questa ragione assai difficilmente avrebbero potuto considerare Gesù come loro messia, s'egli li avesse convinti della giustezza di pagare le tasse a Cesare, e se si aspettavano che cercasse di convincerli della non liceità di quel pagamento, non si capisce perché loro abbiano chiesto agli erodiani di assistere al dibattito. «Cogliere in fallo» Gesù qui altro non può voler dire che approfittare di qualche sua dichiarazione pubblica per denunciarlo alle autorità costituite (che in Galilea erano appunto quelle erodiane), di fronte alle quali, per non essere arrestati, bastava rispondere ch'era ovvio dare il tributo a Cesare, proprio a motivo della forza militare con cui i Romani erano in grado d'imporlo: dove c'è la necessità dei fatti non si pone neppure la questione della loro legittimità. Gli erodiani la pensavano appunto così.
I farisei tuttavia sapevano bene che quella necessità era illegittima al 100%, per cui in nessun modo avrebbero potuto porre una domanda del genere al cospetto degli erodiani, a meno che non avessero rinunciato definitivamente a liberare Israele, ma con quello che avevano sofferto sotto Erode il Grande, padre dell'Antipa, è assai dubbio che in quel momento fossero già arrivati a questa conclusione. Sino al 70 d.C. essi continuarono a sperare in una liberazione nazionale e non a caso furono i principali oppositori di Saulo di Tarso.
Si noti peraltro che nella domanda dei farisei si fa distinzione tra liceità (morale) e obbligatorietà (politica) del tributo a Cesare, come se per loro la necessità potesse trovare la propria giustificazione morale nella liceità: una cosa diventa «necessaria» non quando s'impone con la forza ma quando tranquillizza la coscienza con la propria giustezza. Paradossalmente quindi se il Cristo avesse detto ch'era «giusto» pagare i tributi al nemico, i farisei avrebbero dovuto dedurre o che Cesare andava rispettato in tutto e per tutto (come facevano gli erodiani), o che Gesù non era il messia che attendevano. Ma in questo secondo caso non avrebbe avuto senso chiamare gli erodiani come testimoni del dibattito: se i farisei avessero disconosciuto la messianicità di Gesù tra i Galilei, sarebbero stati loro stessi in pericolo nei confronti degli erodiani, proprio in quanto avrebbero fatto capire d'attendere un messia diverso non solo da Gesù ma anche dall'Antipa.
Questa pericope non risulta attendibile da alcun punto di vista. Supponiamo che erodiani e farisei si attendessero da Gesù un giudizio di merito sulla liceità del tributo. Che cosa ottengono? Un giudizio di fatto sulla necessità politica di pagarlo. Cioè il giudizio, che tiene conto della realtà dei fatti e quindi della sua necessità e che, in tal senso, rassicura gli erodiani, poteva forse soddisfare le esigenze dei farisei? No, e infatti in aggiunta all'affermazione di dover pagare le tasse al nemico, il redattore è costretto a far dire a Gesù che bisogna rendere un culto pieno a dio: col che si ha l'impressione che se le esigenze politiche dei farisei non potevano essere soddisfatte, potevano però esserlo quelle di tipo religioso, sempre che loro si fossero accostati al Cristo senza «malizia».
Tuttavia anche questa interpretazione è del tutto fantasiosa. Gesù voleva cacciare i Romani dalla Palestina, non avrebbe mai sostenuto che in luogo di questo obiettivo politico sarebbe stato sufficiente affermare la separazione di Stato e chiesa, di politica e religione. Questo obiettivo non era neppure desiderato dai farisei, che pensavano invece a una sottomissione della politica alla religione. Qui Gesù appare in alternativa sia al «papocesarismo» farisaico che al «cesaropapismo» erodiano, in nome di una distinzione dei poteri istituzionali, ognuno dei quali deve conservare la propria autonomia. Questa posizione non è mai stata sua ma semmai di Paolo.
Una tesi del genere, quella della diarchia dei poteri istituzionali, in quel momento non avrebbe potuto accontentare i farisei, perché troppo «religiosa», né avrebbe potuto infastidire gli erodiani, i quali, essendo di origine ebraica, non avrebbero avuto alcuna difficoltà a negare una stretta identificazione di Jahvè e Cesare. Dunque una risposta come quella riportata nei Sinottici non poteva avere come interlocutori nessuno dei due partiti ebraici, ma solo ed esclusivamente l'autorità romana. Marco si è servito di una controversia fittizia per mandare un messaggio ai pagani che spadroneggiavano nel Mediterraneo, che miravano ad equiparare dio a Cesare e che avevano a che fare coi cristiani fuoriusciti dalla Palestina in fiamme, dopo la catastrofe del 70. La risposta di Gesù vuole essere diplomatica, si pone come offerta di una trattativa politica, in cui una delle due parti – la chiesa – rinuncia a fare politica, chiedendo però l'autorizzazione a credere in un dio diverso da quello pagano.
Mc 12,15: Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda».
La risposta non voleva solo essere conciliante nei confronti dell'autorità romana, ma anche chiaramente orientata a far capire che tra Giudei e cristiani vi era un abisso nelle posizioni di tipo politico.
Il «tributo a testa» (testatico) imposto dai Romani nel 6 a.C., dopo il censimento di Quirinio, non era particolarmente gravoso (un denario d'argento), ma poteva essere inteso come riconoscimento del dominio pagano sul popolo che si considerava «eletto». Sulla moneta peraltro era scritto che Tiberio era «figlio del divino Augusto». Dal 6 a.C al 4 d.C. erano avvenuti vari censimenti Romani in Siria, Galilea e Giudea, tutti rifiutati da quei Galilei e farisei che poi costituirono il partito zelota, di cui ben duemila furono crocifissi. Più di seimila farisei avevano rifiutato il giuramento ad Augusto al tempo di Saturnino, legato di Siria.
La richiesta ai farisei di mostrargli una moneta sembra avere come scopo quello di attestare non la giustezza dei fatti ma la loro necessità. Si noti come in questa differenza si celi la mistificazione operata dalla comunità post-pasquale ai danni del messaggio originario del Cristo. Quando una cosa è necessario farla (in questo caso pagare la tassa) e quando questa cosa non riguarda la libertà di coscienza (in quanto non viene richiesto di credere in un dio diverso dal proprio), non c'è motivo di opporvisi. Questa la mistificazione.
Un qualunque ebreo della Palestina di duemila anni fa, anche se fosse stato un collaborazionista, avrebbe sostenuto che la costrizione a pagare le tasse al dominatore straniero gli impediva d'essere libero a pieno titolo, sia come cittadino che come credente. Qui invece gli evangelisti vogliono far capire che non vanno affatto considerati come incompatibili la necessità di pagare le tasse allo straniero e la possibilità di vivere pienamente la propria fede religiosa.
Viene cioè esclusa categoricamente l'idea che il giudeo oppresso dovesse adattarsi solo transitoriamente alle negative circostanze, in attesa di trovare il momento favorevole per passare all'offensiva. L'idea che qui viene propagandata è quella di una religiosità astratta, metafisica, del tutto sganciata dalla contingenza politica di un determinato momento storico. Non si propone un modello integralistico, come quello farisaico, in cui la politica era subordinata alla religione, ma neppure un modello democratico, in cui contro un governo di oppressione si doveva far valere l'esigenza di un governo di liberazione nazionale.
Nella risposta di Cristo è evidente il compromesso tra ebraismo spiritualizzato e paganesimo individualista: il cittadino-cristiano si pone, di fronte allo Stato romano, come singolo credente, che fa della propria religione un mezzo per sfuggire alle contraddizioni sociali e politiche della vita quotidiana.
A sostegno di questa interpretazione della pericope ci viene la risposta che il Cristo dà a una domanda dal sapore analogo in Mt 17,24-27, ove egli spiega che gli «estranei», dovendo pagare (ingiustamente) le tasse ai re che li opprimono, lo fanno solo per amor di pace, fiduciosi nella divina provvidenza.
Paolo addirittura sosterrà (Rm 13,1 ss.) che il rispetto dovuto alle istituzioni è cosa che riguarda non solo il «dovere» ma anche la «coscienza», a condizione ovviamente che lo Stato non imponga al credente un'ideologia incompatibile con la propria fede. Col che in sostanza si apriva involontariamente la strada alla possibilità che un credente potesse obbedire a uno Stato confessionale, espressamente cristiano, anche nel caso in cui detto Stato tutelasse legalmente lo schiavismo o il servaggio.
Mc 12,16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare».
In questo versetto sta la chiave per comprendere la mistificazione del successivo e di tutta la pericope. Qui si vuole per così dire imporre l'esistenza di un potere oggettivo, imprescindibile. La moneta non appartiene forse a chi comanda? Ebbene chi la usa deve necessariamente obbedirgli. Sembra di assistere a un insegnamento di realismo concreto in opposizione alle concezioni utopistiche della vita.
È necessario obbedire a Cesare non perché giusto ma perché necessario, in quanto inevitabile. Il suo potere è una struttura permanente della storia: si può contestare, come cittadini, l'abuso di questo potere, ma non si può mettere in questione la realtà, l'oggettività di questo potere. Anche quando il potere viola la libertà di coscienza, imponendo la propria ideologia, la resistenza non può mai tradursi in un rovesciamento istituzionale di questo potere (cfr 1Pt 2,20). La resistenza cristiana può essere solo «passiva»; pertanto, se il tributo a Cesare è sempre necessario, esso è anche lecito, proprio perché così vuole la natura delle cose.
Quando poi il Cesare pagano si trasformerà, a partire da Costantino e Teodosio, nel «Cesare cristiano», l'obbedienza non sarà dovuta solo per motivi di forza superiore, ma anche per motivi di coscienza.
La risposta che danno gli erodiani è ovviamente la stessa di quella dei farisei e, detta da loro, non poteva non voler dire: «del più forte»; detta dai farisei invece poteva voler dire una cosa leggermente diversa: «in base a quello che affermerai noi capiremo se dobbiamo obbedire al solo Tiberio, effigiato in questa particolare moneta, oppure anche a qualunque altro imperatore che vorrà dominare in Palestina».
I redattori cristiani hanno per così dire «respinto» entrambe le posizioni poiché quella erodiana era troppo scarsa sul piano religioso, mentre quella farisaica risultava troppo equivoca su quello politico. Il partito erodiano risultava per i cristiani più coerente a livello politico, in quanto sosteneva che la proprietà del più forte andava rispettava senza indagare se era stata guadagnata lecitamente o no; di conseguenza bisognava obbedire non solo a Tiberio ma anche a qualsiasi altro futuro imperatore. Solo che questo partito considerava Erode il messia tanto atteso e di Cesare non metteva in discussione la pretesa divinizzazione.
I cristiani di origine ebraica, che sicuramente risultavano ancora in maggioranza nelle comunità espatriate dalla Palestina dopo la catastrofe del 70, non potevano identificarsi con gli erodiani, anzi avvertivano nettamente l'esigenza di differenziarsi da loro proprio per motivi religiosi.
D'altro canto i farisei, pur essendo più attenti a non riconoscere ad alcun sovrano pagano una qualsivoglia connotazione religiosa e a fare della religione una vera e propria regola di vita, erano ancora intenzionati a realizzare politicamente una Palestina in cui il giudaismo fosse la componente fondamentale dello Stato confessionale. I redattori cristiani presentano entrambi i partiti come oppositori irriducibili del cristianesimo.
Il messaggio della pericope era ovviamente diretto non a un lettore ebraico ma a uno pagano, che doveva essere rassicurato sull'affidabilità politica del cristiano nei confronti delle istituzioni romane dominanti, e a cui bisognava anche chiarire che tra pagano e cristiano esisteva una diversità relativa alla libertà di coscienza e quindi ai rapporti tra Stato e chiesa. Il cristiano era «monoteista» e non ammetteva la divinizzazione dell'imperatore: su questo non si poteva transigere.
Il cristiano avrebbe obbedito, come cittadino, alle leggi dello Stato pagano senza compromettere la propria coscienza nelle questioni politiche, a meno che queste non interferissero in quelle religiose. E finché resteranno in vigore le persecuzioni imperiali, i cristiani rinunceranno all'idea di poter costruire un regno politico-religioso nell'orizzonte storico-temporale (il nazionalismo teocratico così caro ai farisei). Solo dopo la svolta teodosiana, si avrà anche questa pretesa.
Mc 12,17 Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui.
La risposta cristiana messa in bocca a Gesù va considerata in due modi: formale e sostanziale. Sul piano formale o giuridico Dio e Cesare vengono considerati come equivalenti; sul piano sostanziale o metafisico come due realtà differenti.
Cesare non è dio e non può diventarlo, anche se, al momento della stesura dei vangeli, ne aveva sempre più la pretesa («Tiberio, Cesare, figlio del divino Augusto, pontefice», così era scritto sulle monete, e in Siria addirittura: «figlio dell'augusto dio»). Finché Cesare resta nei suoi limiti umani, l'obbedienza gli è dovuta a prescindere da ciò che politicamente compie (cfr 1Pt 2,17 e Rm 13). Infatti qualunque azione negativa egli possa compiere, esclusa quella di porsi come «signore» (kyrios), il cristiano deve accettarla con rassegnazione, come una sorta di messa alla prova della propria virtù, nella convinzione che la vera liberazione dal male sarà possibile solo nel «regno dei cieli», al punto che chi rifiuta di obbedire a Cesare si oppone a dio.
Gli ordinamenti civili ed ecclesiastici devono convivere nella medesima società, non vanno né confusi né posti in alternativa. L'uno presuppone l'altro, ed è la storia stessa che lo esige: è la legge della diarchia, che tanta fortuna avrà nell'impero bizantino sino alla caduta di Costantinopoli, e che invece nell'area occidentale dell'impero verrà costantemente messa in discussione dal cesaropapismo degli imperatori e dal papocesarismo della chiesa romana.
Quando s'imporrà la diarchia (a partire da Teodosio) non ci sarà neppure bisogno di sdoppiarsi in cittadini davanti allo Stato e credenti davanti alla propria chiesa: infatti sia l'una che l'altra posizione saranno ideologicamente cristiane, per cui lo Stato si caratterizzerà nel proprio confessionalismo. La diarchia resterà (nell'oriente ortodosso) solo nel senso che lo Stato eserciterà funzioni eminentemente politiche e non farà dipendere la propria autorità dal consenso politico della chiesa, mentre alla chiesa verranno attribuite funzioni di tipo religioso: cosa che invece l'occidente latino, già a partire dal V secolo, farà molta fatica ad accettare, avendo la chiesa romana ambizioni squisitamente politiche.
Con la diarchia espressa in questa formula evangelica (che, per quanto democratica o diplomatica sia, non può essere stata formulata da un Cristo ateo e politicamente rivoluzionario), ci si poteva opporre sia alla politicizzazione della fede che alla clericalizzazione della politica. Se nei confronti di dio si agisce come credenti e nei confronti dello Stato come cittadini, non v'è contraddizione, proprio perché la dualità degli ordinamenti va accettata come un dato di fatto storico, in cui s'è chiamati a vivere. Se poi Cesare è addirittura ideologicamente «cristiano», meglio ancora: l'identificazione tra credente e cittadino sarà ottimale.
Al momento della stesura della pericope non si poteva ovviamente immaginare che un giorno lo stesso Cesare sarebbe diventato «cristiano», e tuttavia la diarchia (o «sinfonia») che ivi si afferma non era destinata ad avere un valore soltanto per il rapporto Stato pagano/Chiesa cristiana. Essa avrebbe dovuto avere un valore anche per il rapporto Stato cristiano/Chiesa cristiana, e così infatti sarà in ambito ortodosso, dove si sapranno sempre distinguere gli aspetti ideologico-confessionali da quelli politico-istituzionali. Chiesa e Stato dovevano evitare di subordinare il civile al religioso o viceversa (l'integralismo), ma anche di farli convivere in un regime compromissorio in cui valesse come regola la reciproca strumentalizzazione (la «confusione» in luogo della «distinzione»).
Naturalmente i fatti non rispecchiarono quasi mai questi princìpi teorici, sia perché la chiesa ortodossa o cattolica si servì spesso della forza dello Stato per eliminare il dissenso religioso (le eresie), sia perché in oriente gli imperatori cercarono a più riprese, senza peraltro riuscirvi, di sottomettere alla loro volontà la realtà ecclesiastica, mentre in occidente il papato volle al più presto porsi in antagonismo a qualunque forma di gestione del potere non strettamente vincolata all'autorità politica della chiesa romana.
Ora, per riassumere, il programma politico espresso in questa pericope, si può descrivere nei seguenti termini:
1. con Cesare, che rappresenta lo Stato, il credente non deve avere che un rapporto di obbedienza, cioè gli deve rendere il rispetto dovuto non solo per timore ma anche per ragioni di coscienza, poiché così vuole l'ordinamento divino;
2. ciò che più conta per il credente è il rapporto con dio, che non è un semplice rapporto di obbedienza ma d'amore, quindi qualsiasi pretesa di Cesare d'essere venerato o addirittura adorato come una divinità, resta inaccettabile per il credente;
3. benché con Cesare, in quanto Stato pagano, sia bene per il credente non avere un rapporto di tipo «personale», onde non lasciarsi coinvolgere in questioni di potere, che potrebbero ledere la serenità della sua coscienza religiosa, ciò non impedisce al credente di fare tutto quanto sia utile allo Stato perché possa governare nel modo migliore possibile;
4. in qualità di cittadino, il credente può opporsi, appellandosi ai diritti civili, agli abusi del potere istituzionale, ma non potrà farlo con lo spirito rivendicativo di chi vuole distruggere l'ordinamento costituito, al fine di sostituirlo con un altro. Sul piano politico il credente lotterà soltanto per una progressiva democratizzazione dell'esistente, nella consapevolezza che verità e libertà esistono soltanto in una dimensione ultraterrena.
L'ambiguità sottesa al principio diarchico (detto anche «dualistico», in opposizione a «monistico»), affermato dal Cristo nella pericope in oggetto, è stata dunque resa possibile perché s'è dovuto tener conto, mistificandolo, di un messaggio cristico originario dal contenuto altamente umanistico, in stretto riferimento alla valorizzazione della libertà di coscienza; un messaggio che, essendo stato tradito negli obiettivi politici che si prefiggeva, ha subìto una chiara involuzione mistica. Tale tradimento va appunto considerato come fonte principale della trasformazione dell'idea di «coscienza umana» in «coscienza religiosa».
Nella sua variante petro-paolina, che è in fondo un compromesso tra quella parte del partito nazareno divenuta riformista e quella parte del partito farisaico divenuta spiritualista, il cristianesimo primitivo ha potuto contrapporre dio a Cesare, proprio perché aveva rinunciato definitivamente all'idea di uomo naturale, capace di lottare contro l'oppressione e lo sfruttamento, capace quindi d'impedire che il concetto di «divinità» diventasse il sostituto, sublimato, di qualcosa che in quanto ebrei si era desiderato senza però ottenerlo.
In pratica è stata proprio la valorizzazione dell'umano prodotta dal Cristo che ha permesso ai suoi seguaci di utilizzarla in maniera mistificata in chiave religiosa, senza per questo dover dipendere dalla tradizione ebraica, che mal avrebbe sopportato l'idea di separare l'istanza religiosa dall'indipendenza politico-nazionalistica.
Per poter elaborare un concetto universale di «dio», che andasse al di là di ogni tradizione e confine geografico, occorreva aver assistito, se non anche partecipato, a un forte sviluppo della coscienza umana, facendo però in modo che questa si sentisse realizzata in se stessa, senza dover ricorrere ad alcun luogo particolare che le facesse da supporto, come p.es. l'intera nazione israelitica, oppressa dall'imperialismo romano. Per affermare una coscienza umana astratta, universalmente valida, la mistificazione cristiana ebbe necessità di prendere dall'ebraismo l'attenzione per le questioni sociali e dal paganesimo l'illusione della fede religiosa.
(torna su)7) Sull'umanità del Cristo
A distanza di duemila anni di storia restano ancora da precisare due questioni fondamentali su Gesù Cristo, di cui la prima, negli ambienti laici dell'esegesi, è stata forse sufficientemente chiarita, anche se vi è ancora chi si ostina a sostenere che il Cristo dei vangeli non sia mai esistito, essendo inverosimili certi suoi comportamenti e troppo evidenti e numerose le incongruenze e contraddizioni dei vangeli canonizzati dalla chiesa.
Il che, a dir il vero, non può essere considerato un ragionamento del tutto sbagliato. L'errore sta semmai nel fatto che ci si vuole fermare a questa conclusione, senza rendersi conto che così, in ultima istanza, si fa il gioco dei clericali, i quali, di fronte a chi sostiene che tutta la religione si basa su delle falsificazioni, soprattutto su quelle di coloro che detengono il potere, non hanno difficoltà a ribattere che nessuna religione riuscirebbe a reggersi in piedi sulla base di una falsificazione totale.
Sarebbe infatti meglio che l'esegesi laica parlasse non tanto di «falsificazione» quanto piuttosto di «mistificazione», cioè di una falsificazione basata su cose realmente accadute, su cose che si sono volute tramandare, in alcuni aspetti essenziali, in maniera distorta, al fine di giustificare delle scelte di campo, delle operazioni culturali, ideologiche, politiche del tutto incoerenti col messaggio originario del Cristo.
Insomma le due questioni su cui vale ancora la pena discutere sono una di carattere politico, l'altra di natura fenomenologica.
Vediamo la prima e chiediamoci: Gesù era un avventuriero o un rivoluzionario di professione? S'è fatto catturare come un dilettante o aveva un certo senso della strategia? Il comportamento tenuto nei confronti del tradimento di Giuda, come va giudicato? È stato ineccepibile o ingenuo?
A queste domande le risposte più convincenti sono quelle che vedono il Cristo come leader politico accorto, prudente, aperto a larghe intese, ma anche risoluto, decisionista, ideologicamente laico, umanista, politicamente democratico, favorevole alla comunione dei beni.
Dopo la morte di Lazzaro egli, pur non senza dubbi interiori, si convinse che quella tragedia poteva anche essere utilizzata per compiere l'insurrezione anti-romana, sempre che ci fosse stato l'appoggio significativo di molti giudei, e infatti l'ingresso messianico glielo confermerà. In occasione della cacciata dei mercanti dal Tempio (una sorta di mezza rivoluzione contro le autorità religiose, compiuta qualche anno prima) aveva rotto i rapporti sia coi farisei che coi battisti, allacciandone di nuovi sia coi Samaritani che coi Galilei. Tuttavia, pur essendo in Galilea incredibilmente popolare, rifiutò di scendere a Gerusalemme per fare la rivolta, proprio perché voleva anche l'appoggio dei Giudei.
Insomma a volte si nascondeva e addirittura sceglieva l'esilio, altre volte si manifestava, a seconda delle circostanze. La Giudea era la sua patria d'origine, ma fu costretto a scegliere la Galilea come patria adottiva, dopo il fallimento della sua prima rivoluzione.
L'insurrezione finale era stata curata nei minimi particolari e sarebbe dovuta avvenire di notte, durante la Pasqua. Il tradimento colse tutti alla sprovvista, proprio perché si era convinti che contro la guarnigione romana non si sarebbero dovuti avere particolari problemi. Purtroppo, nonostante il tentativo di fuga presso il Getsemani, non si poté evitare la cattura di Gesù, anzi lui stesso la favorì pur di assicurare ai suoi la salvezza.
Poi, proprio sul termine «salvezza» i redattori dei vangeli elaborarono interpretazioni del tutto fantasiose, come p. es. che non si trattava di salvezza «fisica» ma «spirituale», non del «corpo» ma dell'«anima», non dalla «cattura» ma dal «peccato», proprio perché il Cristo non doveva apparire come un leader politico ma religioso. E così via.
La seconda questione da affrontare riguarda proprio l'argomento che ha fatto scatenare la falsità di queste interpretazioni religiose, ed è la presunta «resurrezione» del Cristo.
Il concetto di «risorto» è stato inventato da Pietro (che parla di «ridestato») e fatto proprio largamente da Paolo. Esso era già noto al mondo pagano e politeistico, ma veniva usato in senso simbolico-metaforico. Quando Paolo lo usa all'Areopago, in riferimento a una persona reale, gli ridono in faccia.
Gli ebrei però non risero a Pietro quando lui sosteneva, potendolo tranquillamente dimostrare, che il corpo di Gesù era scomparso dalla tomba e che, siccome nessuno l'aveva trafugato, doveva per forza essersi «risvegliato», e quindi quell'uomo non poteva essere considerato esattamente come gli altri, e che se aveva avuto il potere di ridestarsi dalla morte, allora avrebbe anche potuto evitarla, volendo, e che se invece l'aveva accettata, allora voleva dire che la sua morte andava interpretata come un evento «necessario», un evento voluto misteriosamente da dio, probabilmente per insegnare agli uomini la loro iniquità, la loro incapacità di liberarsi dalla schiavitù, dall'oppressione, per cui non restava che attendere con ansia il suo imminente ritorno glorioso, in quanto non avrebbe avuto senso una «resurrezione» senza una «parusia».
L'apostolo Giovanni si staccherà da Pietro quando si renderà conto che, in assenza di una parusia imminente del Cristo, il discorso di Pietro sulla resurrezione diventava rinunciatario rispetto all'esigenza di una insurrezione anti-romana. Paolo poi dirà, vedendo i ritardi insostenibili della parusia, che la schiavitù da cui ci si doveva liberare non era per nulla quella politica ma solo quella religiosa, quella dal peccato originale, per cui i «nemici» dei cristiani non erano i Romani (la carne e il sangue), ma i demoni (le potenze dell'aria, i principati e le potestà dei cieli).
Pietro all'inizio rimarrà interdetto per questa svolta spiritualistica, ma poi sarà costretto dagli eventi (e dal successo di Paolo) ad accettare la nuova interpretazione mistica della figura di Gesù Cristo quale figlio unigenito di dio-padre.
*
Ora cerchiamo di capire una cosa di capitale importanza: perché Paolo volle rischiare, nei suoi viaggi missionari, il sarcasmo dei greci, parlando di resurrezione di Gesù Cristo, quando in fondo ne avrebbe potuto fare a meno predicando ugualmente l'esistenza di un aldilà risolutivo per le contraddizioni terrene, in cui il mondo pagano bene o male già credeva? La differenza tra cristiani e pagani non poteva stare in altre cose? P. es. nel fatto che l'aldilà avrebbe potuto essere guadagnato da chiunque avesse compiuto il bene sulla Terra.
Se il cristianesimo petro-paolino si fosse limitato a predicare il rispetto della persona, l'assistenza dei malati, degli orfani, delle vedove e dei bisognosi in genere, l'uguaglianza di genere e altre cose analoghe, non avrebbe avuto ugualmente successo in una società basata sull'individualismo, sui traffici commerciali, sulla violenza militare, sul maschilismo, sull'oppressione dei deboli...? Perché dare così tanto peso alle questioni ultraterrene? Probabilmente il motivo sta nel fatto che quando Pietro predicava il concetto di «resurrezione», lo associava a un'imminente parusia politica del Cristo. Inizialmente anche Paolo si comportò nella stessa maniera, poi fu costretto a procrastinare il momento decisivo alla fine dei tempi e a beneficio di tutto il genere umano, non solo di Israele, il cui primato storico-politico andava considerato finito per sempre. Paolo lo diceva ancor prima della catastrofe del 70, per questo gli ebrei lo odiavano a morte.
Questo in sostanza per dire che per i primi cristiani il concetto di «resurrezione», elaborato da Pietro e sostenuto da Paolo e da altri leader del movimento nazareno, aveva un ruolo molto più centrale che nel mondo pagano (con i vari Attis, Dioniso, Osiride ecc.). E ciò è oltremodo significativo, in quanto i primi cristiani erano tutti di origine ebraica, cioè appartenenti a una cultura che non tollerava i miti astrusi dei pagani, tanto meno quelli riferiti a divinità che muoiono e risorgono.
Beninteso anche agli ebrei conoscevano il concetto di «resurrezione» (basta leggersi il racconto di Ezechiele al cap. 37) e anche l'idea di «aldilà» (ne parla p. es. il profeta Daniele, là dove associa la resurrezione del popolo ebraico a una retribuzione ultraterrena; ed erano altresì noti i diverbi tra farisei e sadducei (quest'ultimi non credevano in alcun aldilà), che Paolo utilizzerà per salvarsi dal linciaggio.
Ma queste erano teorie e posizioni molto marginali nel giudaismo ortodosso, che al massimo potevano essere accettate come ipotesi poetiche, come simbologie profetiche: credere con certezza nella resurrezione fisica di un corpo morto sarebbe apparso un'assurdità insostenibile, ai limiti della bestemmia.
Per quale motivo dunque i cristiani hanno voluto scontrarsi su una questione del genere, che sicuramente ostacolava non poco i rapporti con la cultura ebraica? Avrebbero potuto parlare lo stesso di un aldilà di giustizia e di uguaglianza e quindi di una resurrezione finale dei sofferenti e dei martiri. Cosa sarebbe cambiato? Perché insistere su una resurrezione specifica, fisica, miracolosa e soprattutto individuale e storicamente irripetibile?
Vien da pensare che qualcosa di vero ci deve essere stato nella primissima predicazione apostolica (kerygma), benché il concetto di «resurrezione» sia stato usato in maniera falsificante, per negare la politicità rivoluzionaria del Cristo.
Nel Vangelo di Marco, che ha fatto da prototipo a tutti gli altri, la figura del giovane seduto sul sepolcro vuoto rappresenta in un certo senso la posizione petrina, secondo cui il Cristo non era più nella tomba non tanto perché «scomparso» quanto perché «risorto». L'interpretazione non offre soltanto la spiegazione del fatto ma addirittura lo crea, rendendolo diverso da come in realtà appariva.
«Sepolcro vuoto» non voleva necessariamente dire «resurrezione», ma semplicemente «scomparsa misteriosa del cadavere». Per parlare di «resurrezione» vera e propria, bisognava parlare di «riapparizione di un corpo vivente», ma nel Vangelo di Marco l'ultimo racconto (16,9-20) è stato aggiunto successivamente alla prima stesura.
Il Vangelo si conclude col giovane che dice alle donne che il Cristo attende di nuovo gli apostoli in Galilea (per ricominciare da dove il tradimento e la croce avevano interrotto le cose). Cioè qui la resurrezione viene presentata come se avesse per finalità la parusia del Cristo, più o meno immediata e sicuramente trionfante.
Il fatto che le donne, temendo di essere considerate pazze, non dicano nulla di quel che avevano visto, indica un primo ingenuo tentativo di discolparsi della mancata insurrezione dopo la morte del Cristo, e permette anche di rinunciare all'autocritica da parte degli apostoli, che non avevano saputo impedire la morte del loro leader.
*
Una cosa apparentemente molto strana, nella ricostruzione marciana dei fatti, è che nei vangeli non si usa mai la Sindone, ch'era un reperto concreto, per dimostrare la fondatezza di un'interpretazione astratta come quella della resurrezione (la principale tesi petrina): perché non rendere quel lenzuolo di dominio pubblico?
Pietro, che evidentemente non era uno sprovveduto, doveva aver pensato che se avesse esibito la Sindone, qualcuno gli avrebbe potuto obiettare ch'essa non dimostrava nulla con sicurezza. Al massimo si poteva parlare di «strana scomparsa del corpo», di «strano effetto sul lenzuolo», ma certamente non si sarebbe potuto parlare di «morte necessaria», voluta da dio, di resurrezione voluta anch'essa da dio, di attesa passiva di una parusia trionfante, sicura e imminente.
Noi oggi ci opponiamo alla mistificazione operata da Pietro. Tuttavia il ragionamento che fece non era così peregrino, tant'è che la maggioranza degli apostoli lo condivise. Se il corpo di Cristo non è stato trafugato da qualcuno ma è misteriosamente scomparso e la Sindone l'attesta, allora quell'uomo – deve essersi detto e deve averlo detto agli altri – era più che un uomo comune, per quanto, quand'era in vita, nessuno s'era mai accorto di nulla. Dunque, se aveva qualcosa di più, non si capisce perché non abbia voluto dimostrarlo quand'era in vita (probabilmente lo voleva fare da morto – si sarà detto – per farci capire che da soli non possiamo far nulla, visto che è stato crocifisso come leader che avrebbe potuto liberare Israele dai Romani) e, in ogni caso, ora non si capisce perché non si possa credere all'idea ch'egli ritorni in maniera trionfale. Se non torna subito e da vincitore, tutto quello che ha fatto resta inspiegabile. Per che cosa si sarebbe fatto crocifiggere, pur potendolo tranquillamente evitare? Se gli ebrei non sono capaci di liberarsi da soli di Roma, e lui non ritorna, tutto quanto lui in vita ha fatto a cosa è servito? Una volta che lui ha dimostrato, con la sua morte, fin dove noi umani siamo in grado di arrivare, a noi cosa resta da fare se non attenderlo con ansia? Il tentativo insurrezionale non può essere stato una presa in giro; semplicemente noi dobbiamo arrivare ad ammettere che aveva tempi e modi diversi da quelli che avevamo immaginato. Noi non possiamo credere che lui si sia lasciato ammazzare perché tanto sapeva che sarebbe risorto, lasciando noi in balia di noi stessi.
Tutte queste considerazioni di Pietro (ovviamente qui ipotetiche) erano, rispetto alle posizioni originarie del Cristo, di tipo politico-religioso e quindi anti-rivoluzionarie, erano tesi revisioniste, per le quali si prevedevano, in attesa della parusia trionfale del messia, dei compromessi anche con quella parte del giudaismo che avesse ammesso il proprio errore nei confronti del Cristo e che fosse disposta a credere nella sua messianicità e quindi nelle idee di resurrezione e di parusia imminente. Dicendo queste cose, Pietro vedeva la Sindone come una cosa inutile, anzi come un'interferenza.4
*
È per questa ragione che occorre sostenere con forza che se la Sindone è vera, i vangeli mentono, e almeno tre volte.
Anzitutto perché il Cristo che descrivono è del tutto spoliticizzato, mentre quello della Sindone è un leader politico torturato, flagellato e crocifisso. Un trattamento, per uno schiavo ribelle, del tutto inconsueto, spiegabile solo in virtù del fatto che si stava compiendo un'imminente insurrezione, in cui la guarnigione romana – data la popolarità del movimento nazareno – sarebbe stata facilmente sopraffatta.
In secondo luogo se la Sindone può essere usata per sostenere una scomparsa poco chiara dal sepolcro, non può essere usata per affermare con certezza una resurrezione, proprio perché nessuno ha mai visto il Cristo redivivo e nessuno è in grado di negare con sicurezza che tutti i racconti che ne parlano possono essere stati inventati (d'altra parte chiunque si rende conto che se Cristo fosse davvero riapparso, non si sarebbe predicata la «fede» nella resurrezione, e siccome ci si rendeva conto che sarebbe stata una pretesa eccessiva chiedere di aver fede in un corpo da tutti visto morto e poi visibilmente risorto, si fu costretti a dichiarare che molti effettivamente avevano assistito alle sue apparizioni, anche se poi non si smetterà mai di dire che beati sono quelli che credono senza vedere).
In terzo luogo perché anche nel caso in cui si possa affermare con certezza l'evento di una resurrezione, ciò non può essere considerato sufficiente per sostenere l'esistenza di un dio, nel senso che nulla autorizza a pensare ch'esista un dio che l'abbia voluta, tanto meno dopo aver voluto la morte del proprio unigenito figlio.
Insomma anche se la Sindone fosse un reperto autentico che attesta una scomparsa misteriosa, in nessuna maniera ciò può implicare la necessità di credere nell'esistenza di un dio assoluto e onnipotente, che ha deciso, previo libero consenso, il destino del figlio («se puoi, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà»).
Se anche si volesse ipotizzare qualsivoglia rapporto tra Cristo e la divinità, qualunque considerazione resterebbe inopportuna, anche perché del tutto infondata, assolutamente indimostrabile, anzi pericolosamente avversa a una vera istanza umana di liberazione, come in effetti storicamente è stato prima con Pietro, con la sua idea di «morte necessaria», voluta da dio nella sua prescienza, poi con Paolo, con la sua idea di figliolanza unigenita, della medesima natura del padre.
Se anche si ammettesse, in via del tutto ipotetica, che dopo la morte del Cristo vi è stato un evento straordinario, non spiegabile razionalmente, ciò non può significare che tale evento sia stato provocato da un'entità esterna chiamata «dio», che altro non è se non la «parola» usata in una determinata cultura per indicare qualcosa di «assoluto». C'è differenza tra «constatazione» di un fatto e sua «interpretazione».
La chiesa ha usato l'interpretazione soggettiva di un apostolo (Pietro) per spiegare un evento umanamente inspiegabile, e ha chiesto di credere per fede in quella interpretazione, in virtù della quale s'è fatto credere che quell'evento fosse avvenuto in una determinata maniera: di qui la necessità di elaborare dei racconti di apparizione del risorto. Piuttosto che usare quel lenzuolo si è preferito inventarsi cose inesistenti. Ma che cos'è meglio: non credere in una cosa che si ritiene inesistente o credere in ciò che non può essere dimostrato?
All'origine di tutti i racconti di apparizione vi è necessariamente la teologia di derivazione paolina, spregiudicata quanto mai. Continuamente nelle sue lettere egli parla di un Cristo risorto che appare in modo chiaro e distinto a lui, a Pietro, agli apostoli, ai discepoli... Predicare agli ebrei, che certo ingenui come i pagani non erano, l'idea che bisognava credere per fede in un corpo morto e risorto, probabilmente era diventato troppo difficile anche per un uomo scaltro come Paolo: di qui l'idea geniale di diffondere la notizia secondo cui Gesù era apparso a più persone in luoghi e momenti diversi.
Bisognava però specificare che queste apparizioni non avevano nulla di politico (come avrebbe voluto Pietro, almeno in un primo momento), ma solo un significato di tipo religioso. Era riapparso per assicurare che tutto sarebbe proseguito al meglio nell'aldilà e che sulla Terra i discepoli avrebbero soltanto dovuto resistere con pazienza al male, amandosi vicendevolmente e, in caso di necessità, considerando il martirio una prova da superare per la gloria della fede.
Un'esegesi laica oggi invece dovrebbe sostenere che anche nel caso in cui la Sindone fosse lì a dimostrare che Gesù Cristo è in qualche modo riuscito a sfuggire alla morte, ciò non può essere considerato sufficiente ad avallare l'esistenza di alcun dio. La Sindone non è incompatibile con l'ateismo, nel senso che se anche il Cristo dovessimo considerarlo «più che umano», non dovremmo comunque pensare che la parte «in più» della sua umanità non ci appartenga.
Di sicuro l'esistenza umana del Cristo non ebbe mai nulla di sovrannaturale, finché egli restò in vita, nulla che l'uomo non potesse capire e ripetere. Quel che va «oltre» l'umano, resta comunque alla portata della nostra umanità, altrimenti ci resterebbe incomprensibile il messaggio del Cristo anche nel caso in cui l'avessimo depurato di tutte le mistificazioni che gli hanno voluto aggiungere.
Questo significa che nella vita terrena, umana, storica del Cristo si racchiude tutto il messaggio per gli uomini, utile alla loro liberazione dalla schiavitù. Qualunque tendenza a sottovalutare gli aspetti terreni, interpretandoli in senso mistico, è, ipso facto, un tradimento del suo messaggio. Qualunque tentativo d'interpretare la tomba vuota in senso religioso è un abuso ermeneutico. Di fronte ad essa l'unico atteggiamento adeguato è il silenzio.
Quando Giovanni scrisse, nel suo Vangelo, che di fronte alla Sindone «vide e credette», non specifica a cosa «credette». Infatti il suo manipolatore se ne accorse e decise di aggiungere il versetto in cui è detto che gli apostoli ancora non avevano capito che doveva risorgere. Ma Giovanni in realtà voleva semplicemente dire che il corpo non era stato trafugato (la Sindone ripiegata lo dimostrava), cioè ch'era scomparso in maniera strana, non spiegabile dal punto di vista umano.
E tutto però doveva anche finire lì, poiché l'insurrezione era stata voluta e preparata quando il Cristo era ancora vivo, e le sue motivazioni restavano identiche anche ora ch'era morto e scomparso. Iniziare a credere che lui dovesse ritornare per portarla a compimento, era una pretesa ingiustificata. Ecco perché Giovanni decise di lasciare Pietro a se stesso.
Gli uomini devono superare gli antagonismi sociali qui ed ora, devono abituarsi all'idea che tutto dipende da loro e che quello che di umano non avranno fatto su questa Terra, sarà soltanto un'occasione perduta per lo sviluppo della loro umanità.
Nota a margine
L'idea di periodizzare su tempi molto brevi il passaggio dalla tomba vuota alla predicazione petro-paolina, usata dalla chiesa per mostrare una significativa continuità tra il Cristo storico e quello della fede, in realtà si ritorce contro questa pretesa, in quanto evidenzia, al contrario, che la volontà di tradire il Cristo non solo aveva anticipato (in Giuda) la decisione di fare l'insurrezione, ma la posticipò anche subito dopo la crocifissione. Il tradimento di Pietro non va considerato meno grave di quello di Giuda, tant'è che tutta la grande mistificazione di Paolo poté innestarsi proprio su quel tradimento e non su quello di Giuda, che rimase circoscritto entro un orizzonte etico-politico.
(torna su)8) Paolo di Tarso e la spoliticizzazione del Cristo
Paolo di Tarso, elaborando la teoria secondo cui il Cristo doveva morire per essere annunciato ai gentili, in modo tale che il nazionalismo politico-religioso degli ebrei fosse sostituito dall'universalismo pagano della salvezza religiosa, contribuì fortemente a spoliticizzare la figura del Cristo, trasformandolo da «liberatore» a «redentore». L'idea della necessità della morte violenta di Cristo fa da pendant all'idea che il suo messaggio politico di liberazione non poteva essere realizzato nell'ambito della nazione israelitica.
Ora, poiché questa si poneva come semplice considerazione negativa (sul ruolo politico del messia), in virtù della quale sarebbe stato impossibile formulare un progetto alternativo a quello classico del nazionalismo ebraico, Paolo ritenne necessario portare tale considerazione a conseguenze metafisiche, che le masse popolari avrebbero dovuto passivamente accettare. E la conseguenza principale – secondo il «vangelo» di Paolo – fu questa: il Cristo morì di morte violenta perché così doveva essere.
La ragione di questa necessità metastorica viene motivata, nelle sue Lettere, da un fatto indubitabile: la conversione religiosa dei gentili al cristianesimo, che nella maniera più aprioristica possibile viene fatta dipendere dalla imperscrutabile volontà divina. Ovviamente Paolo rifiutava di chiedersi se, nel caso si fosse realizzata la liberazione politica d'Israele, sarebbe stato possibile per i gentili recepire positivamente il messaggio politico del Cristo storico. Un'eventualità del genere s'era incaricata la stessa storia a renderla irrilevante.
Paolo insomma, non accettando l'idea che il messaggio del Cristo potesse avere ancora un valore politico-nazionale per i suoi seguaci e che potesse essere universalistico proprio nella sua politicità, ha preferito ridurre le esigenze politiche a esigenze religiose e abbinare l'universalismo a una spiritualizzazione astratta del Cristo.
*
Perché Paolo non predicò mai nelle sue Lettere la liberazione degli schiavi? Semplicemente perché la riteneva inutile ai fini della salvezza personale, ch'egli intendeva in chiave etico-religiosa.
Il ragionamento di Paolo in sostanza poteva essere riassunto in questi termini: la liberazione della Palestina dai Romani non è possibile perché non ci sono le condizioni; se la civiltà ebraica vuole sussistere in maniera originale deve trasformarsi profondamente, il che significa dover cercare un'integrazione con la civiltà ellenistica, che è nettamente dominante; la principale integrazione è quella di spostare l'attenzione dalla salvezza politico-nazionale a quella etico-personale; la salvezza dunque dipende non da ciò che si fa contro il sistema oppressivo, ma dalla fede in ciò che supera il sistema in un'altra dimensione: il regno dei cieli. Ora, se la salvezza dipende dalla fede in questo regno dei cieli, frutto della volontà di dio (cosa che secondo Paolo è stato dimostrato una volta per tutte dalla resurrezione di Cristo), la salvezza può essere acquisita in qualunque condizione personale o sistema sociale, poiché la fede è un atto di coscienza, il frutto di una libertà interiore, che chiunque può avere. Si tratta semplicemente di credere che solo dio può salvare o liberare.
Se il Cristo, pur potendolo fare, ha rifiutato di realizzare il regno di giustizia sulla Terra, allora ciò significa che nessun regno di giustizia è possibile sulla Terra, ovvero che la Terra stessa non è il luogo di una liberazione possibile.
Paolo non solo rifiuta di considerare il problema della salvezza-liberazione in termini socio-politici (il che poteva far comodo ai regimi autoritari), ma relativizza anche qualunque pretesa umana di realizzare questo obiettivo sulla Terra (il che può risultare scomodo alla demagogia degli stessi regimi autoritari, oltre che ovviamente nocivo agli interessi di una vera liberazione).
Paolo aveva a disposizione alcuni modi per convincere gli schiavi e gli oppressi ad accettare il cristianesimo: 1. dimostrare che con l'aiuto reciproco interno alle comunità cristiane, i ceti marginali avrebbero potuto affrontare meglio le contraddizioni del sistema; 2. garantire che tra gli appartenenti alle suddette comunità non ci sarebbero state discriminazioni di sorta sul piano culturale; 3. invitarli a combattere il regime autoritario attraverso lo strumento della «resistenza passiva», il cui principio fondamentale era questo: «solo Cristo è dio, solo in lui c'è salvezza».
Ovviamente Paolo chiedeva anche agli schiavisti divenuti cristiani di trattare bene i loro sottoposti, specie se cristiani come loro, nella consapevolezza che «non c'è preferenza di persona presso Dio» (Ef 6,9).
Da parte dei cristiani avversi al paolinismo era difficile contestare una simile ideologia, in quanto di fatto il potere romano, che si trovava nella fase di dover gestire con la massima durezza un impero vastissimo, la perseguitava non meno delle ideologie rivoluzionarie.
L'ideologia di Paolo comincerà ad avere un vero successo popolare solo quando, sotto Costantino, il potere si vedrà costretto, pur di salvare l'impero dalla forza d'urto delle etnie barbariche, a cercare compromessi d'ogni sorta.
Paradossalmente il paolinismo apparve un'ideologia rivoluzionaria non tanto perché riuscì a coinvolgere i ceti marginali, quanto perché il sistema romano era schiavista al 100% e non tollerava interferenze di alcun tipo; quando anche gli schiavisti cominciarono ad accettare il cristianesimo, trasformandosi in signori feudali, lo schiavo, trasformato a sua volta in servo della gleba, continuerà ad avere l'impressione che il paolinismo meritava d'essere considerato un'ideologia vincente. L'illusione insomma finì col perpetuarsi per un incredibile numero di secoli.
Il cristianesimo non riuscì mai a teorizzare che la posizione dello schiavista prima e del feudatario dopo era oggettivamente votata allo sfruttamento del lavoratore, a prescindere dagli atteggiamenti di tipo personale, ovvero che quel ruolo oggettivo impediva, in ultima istanza, di assumere un atteggiamento troppo benevolo e tollerante nei confronti del lavoratore subordinato.
Un atteggiamento del genere avrebbe dovuto portare col tempo al superamento e dello schiavismo e del servaggio: superamento «vero» di entrambi e non «fittizio», come fu quello dello schiavismo per opera del servaggio. Se il padrone è davvero «buono», che bisogno c'è che qualcuno gli faccia da schiavo o da servo? Al cospetto di una classe di proprietari così «democratica», la schiavitù avrebbe ancora avuto un senso se fosse stata «facoltativa», a discrezione cioè di colui che voleva accettarla come stile di vita: il che non ha senso e non è mai avvenuto da nessuna parte.
Se vogliamo, il fallimento del cristianesimo medievale è dipeso anche dal fatto che i feudatari non si sono rivelati così democratici come il cristianesimo li voleva dipingere o come si sperava che diventassero.
La trasformazione dello schiavo in colono e servo della gleba è senza dubbio avvenuta sulla base di necessità economiche (in quanto l'attività dello schiavo non era più redditizia come al tempo in cui tale manovalanza si poteva trovare sul mercato con relativa facilità), e tuttavia molti intellettuali e lavoratori cristiani devono aver sperato che in tale trasformazione potessero democratizzarsi, anche in virtù del cristianesimo, i rapporti socioeconomici.
I fatti purtroppo diedero torto a queste speranze. Gli schiavisti e i feudatari non si lasciarono impensierire più di tanto dall'idea che nell'aldilà esiste un giudizio universale che premia i buoni e punisce i cattivi. Lo schiavo e il servo della gleba potevano anche fidarsi della magnanimità dei loro padroni, ma in ultima istanza nulla si poteva fare quando tale benevolenza veniva meno per una serie sfortunata di circostanze: cattivo raccolto, siccità, carestia, epidemie ecc., che a quei tempi erano all'ordine del giorno.
Schiavo e servo della gleba dovevano accettare la loro condizione come frutto di una decisione divina, indipendente da qualunque considerazione storica, sociale e politica. Nel momento stesso in cui si comincerà a mettere in dubbio la necessità di questa rassegnazione, nascerà l'epoca moderna. La trasformazione del servo della gleba in operaio salariato aprirà poi un nuovo capitolo nel libro delle illusioni.(torna su)
9) Ebraismo e cristianesimo: due forme di ateismo?
Il massimo dell'ateismo possibile, restando nell'ambito della religione (e del monoteismo in particolare), è quello di equiparare un uomo a (un) dio.
È noto che sia l'ebraismo che il cristianesimo sono due forme di ateismo rispetto all'ingenuo politeismo pagano: l'uno rende dio totalmente nascosto (o comunque percepibile solo in via del tutto eccezionale, in forme assai particolari, come accadeva ai patriarchi, a Mosè e ai profeti); l'altro lo rende sì visibile ma solo in Cristo, e tutti gli esseri umani devono passare attraverso di lui per avere un'esperienza della divinità. L'ateismo ebraico viene garantito, in un certo senso, dal monoteismo assoluto; nei cristiani invece viene garantito dal fatto che solo nel suo figlio unigenito dio può rivelarsi.
Esiste quindi nel cristianesimo una sorta di materializzazione umanistica di dio ovvero di autorappresentazione antropologizzata della divinità: non a caso i teologi parleranno subito di «dio incarnato» (quale prototipo dell'umanità), dando così origine a una sorta di «bi-teismo», che poi diventerà «tri-teismo», quando s'introdurrà lo Spirito Santo nell'economia salvifica, quale terza persona della trinità (la femminile «sophia», l'aspetto non istituzionalizzato della fede, in quanto «lo spirito soffia dove vuole»).
La divinità resta anche nel cristianesimo una realtà esterna all'uomo (seppure in forma meno assoluta), essendo l'uomo votato comunque al male, incapace di compiere il bene con le sole sue forze, a causa del peccato d'origine. Il fatto di voler accettare una presenza divina come forma estrinseca all'essere umano induce tutte le religioni, e quindi anche il cristianesimo, a non credere possibile una autenticità terrena. L'uomo deve semplicemente vivere di fede, confidando nella grazia divina che salva. La salvezza terrena è solo spirituale, poiché la morte, essendo inevitabile, rimanda all'aldilà la necessità di vivere secondo una piena libertà, materiale e spirituale. Nella propria mistificazione il cristianesimo considera la morte il principale effetto negativo del peccato d'origine, superiore alla stessa schiavitù sociale.
Una volta rotto con l'ebraismo, il cristianesimo petro-paolino rifiutò di abbracciare il politeismo pagano, in quanto lo riteneva una forma ingenua di superstizione, che arrivava ad attribuire caratteristiche divino-umane alla stessa persona dell'imperatore. Il cristianesimo affermò da subito che solo una persona poteva essere equiparata alla divinità, Gesù Cristo, il cui corpo, una volta sepolto, si diceva fosse «risorto». Il massimo dell'ateismo possibile, in ambito cristiano, conservando il monoteismo ebraico, era quello di dire che esisteva un dio-padre e un dio-figlio (poi divenuto tri-teismo: una medesima natura in tre persone divine).
L'islam, che non possiede il concetto triadico perché ha rifiutato quello diadico, non ha fatto che semplificare al massimo l'ebraismo, rinunciando, di questo, ad alcuni fondamentali aspetti simbolici che mediavano il rapporto uomo/dio. Ha potuto farlo proprio perché in mezzo, storicamente, c'era il cristianesimo, che aveva già svolto l'opera di semplificazione dell'ebraismo, superandone il limite del nazionalismo etnico (l'universalismo ebraico, ereditato dall'islam, non è che un etnocentrismo allargato, in cui quasi non si distingue nello Stato la funzione civile da quella religiosa).
L'umanesimo laico, in tal senso, ha fatto un passo ulteriore, affermando che l'unico dio esistente è lo stesso essere umano, artefice del proprio destino. Se vogliamo considerare Cristo un prototipo dell'uomo, dobbiamo anche affermare che il Nuovo Testamento è una mistificazione religiosa del suo messaggio laico e politico.
Oltre a ciò bisogna dire che nessuna religione è in grado di affermarsi in maniera universale, proprio in quanto è la religione in sé che implica una visione particolare dell'esistenza, soggetta a dogmi in cui bisogna credere per fede. Solo l'umanesimo laico, poggiando su valori umanamente riconosciuti, può aspirare a diventare una concezione universale dell'umanità.(torna su)
10) Il tradimento del cristianesimo primitivo
Le autorità romane del I sec. – come risulta anche dagli storici Tacito e Svetonio – guardavano con sospetto i cristiani perché sapevano che Pilato aveva fatto giustiziare Gesù come ribelle contro il loro governo in Giudea. Era la stessa crocifissione che stava ad indicare il reato di sedizione. Numerosi erano stati gli ebrei (come tanti altri ribelli di cittadinanza non-romana) sottoposti a questo tipo di esecuzione.
Tuttavia, i quattro vangeli sono unanimi nel presentare Gesù falsamente accusato di ribellione dalle autorità ebraiche, le quali forzarono il procuratore (o prefetto) Ponzio Pilato a farlo giustiziare. La crocifissione, insomma, sarebbe stata un tragico errore giudiziario.
Il primo resoconto del processo e della condanna di Gesù è quello di Marco. I vangeli di Matteo e Luca non hanno quasi alcun valore storico, avendo essi prevalentemente usato quello di Marco come modello. Decisive invece sono alcune parti del Vangelo di Giovanni per comprendere Marco.
Il primo vangelo fu scritto, probabilmente, dalla comunità cristiana di Roma verso il 60 d.C. (qui si dà per scontata la datazione della chiesa). Marco intervenne in maniera redazionale dopo la catastrofe del 70, su un testo praticamente quasi completo. Oltre a questo «protovangelo» o «Ur-Markus» (di cui non abbiamo alcun originale), dobbiamo supporre l'esistenza di una produzione letteraria della comunità cristiana di Gerusalemme, scomparsa dopo che i Romani distrussero la città nel 70. Questa produzione è andata in parte perduta, in parte censurata e manipolata dalla stessa chiesa cristiana a indirizzo paolino.
La tradizione secondo cui i membri della chiesa cristiana fuggirono in massa prima della catastrofe del 70, rifugiandosi a Pella, città della Decapoli, va considerata leggendaria, poiché risale al IV secolo, quando apparve per la prima volta nella Storia ecclesiastica di Eusebio da Cesarea. Il quale sostiene che Gerusalemme fu risparmiata da dio fino al 70 proprio in virtù della presenza degli apostoli, dopodiché venne distrutta per punire gli ebrei d'aver crocifisso il messia! E comunque, anche se i cristiani avessero effettivamente abbandonato la città, perché non condividevano l'estremismo zelota (con cui, a partire dal 66 d.C., s'inaugurò la guerra decisiva contro Roma), dopo il 70 la teologia prevalente in seno al cristianesimo fu quella paolina. Lo attesta anche il fatto che la stragrande maggioranza delle Lettere neotestamentarie conservate sono quelle di Paolo o della sua corrente.
Probabilmente la prima parte del Vangelo di Marco – fino all'ingresso messianico –, elaborata da cristiani di origine ebraica (galilaica?), non è stata modificata in modo sostanziale, a parte ovviamente tutti quegli aspetti su cui pesa di più l'influenza ellenistica della predicazione di Paolo, come ad es. il titolo che fa da prologo al vangelo (1,1), la descrizione della predicazione del Battista e del battesimo di Gesù (segno, questo, che le comunità paoline si erano avvicinate a quelle battiste, come da At 19,1 ss.), i tre annunci della passione (in virtù dei quali si voleva sostenere il carattere «ineluttabile» della morte di Gesù per opera dei capi-giudei) e soprattutto la teoria del «segreto messianico», che Marco ha usato per negare alla messianicità del Cristo qualunque valenza politica, quando invece quel «segreto» può essere stato una tattica del Cristo per togliere alla tradizione politica dell'ebraismo il carattere integralistico-teocratico. Il messaggio di Cristo è sempre stato, sin dall'inizio, di carattere «laico» e «universalistico», in coerenza con l'obiettivo ch'egli s'era posto di liberare politicamente la Palestina dall'imperialismo romano col concorso di tutti: Giudei, Galilei, Samaritani, ebrei della diaspora (di Tiro e Sidone, della Decapoli, della Transgiordania, dell'Egitto) e persino dei pagani (in Gv 12,20 s. si afferma che nell'ultima Pasqua vi erano dei «greci» che volevano conoscerlo espressamente)..
L'umanesimo laico lo si può notare, nel Vangelo di Marco, in tantissimi episodi: violazioni del sabato, del precetto del digiuno, delle abluzioni rituali prima dei pasti, della proibizione a consumare cibi «impuri»; sfiducia nell'assolutezza delle offerte sacre fatte a dio; frequentazione dei pubblici peccatori; guarigioni senza invocazione dell'aiuto divino ecc.
Viceversa, la seconda parte del Vangelo di Marco – cioè la settimana di passione – è stata per lo più riscritta per far fronte alla situazione di disagio in cui la comunità cristiana di Roma era venuta a trovarsi dopo la fine di Gerusalemme. La comunità infatti doveva escogitare qualche trucco per eliminare lo scandalo della condanna di Pilato. La croce era stata sì uno scandalo per i Giudei che attendevano un messia glorioso, ma dopo il 70 essa era diventata uno scandalo anche per i cristiani di origine pagana, che, avendo rinunciato alla lotta rivoluzionaria, avevano bisogno di propagandare l'immagine di un Cristo assolutamente pacifico.
*
Secondo Marco il primo processo che subì Gesù fu quello davanti alle autorità giudaiche. Contrariamente alla sua versione, esso fu un processo del tutto informale, condotto non nell'apposita sala del Consiglio ma dapprima nella casa privata dell'ex sommo sacerdote Anna o Anania (in carica dal 6 al 15 d.C.), poi – come dice Gv 18,24 – in quella del sommo sacerdote in carica (dal 18 al 36 d.C.), Caifa: è da presumere che le autorità convocate, di notte, fossero tra le più intenzionate a volere la morte di Gesù.5
A Marco interessava far notare che Gesù era sì il messia d'Israele, ma non quello politico-militare che Israele si attendeva. Il Cristo era anzitutto il «figlio di dio» e il suo messaggio messianico era di tipo etico-religioso (in Giovanni sarà addirittura di tipo filosofico, metafisico, ma questo dipenderà dalla particolare manipolazione che subirà il suo vangelo).
Per sostenere questa tesi, Marco ha concentrato l'attenzione su due diversi aspetti: uno politico, l'altro religioso. Il primo riguarda l'accusa, rivolta a Gesù, di aver minacciato di distruggere il Tempio: accusa che Marco vuol dimostrare essere «falsa e contraddittoria» (14,55 ss.); il secondo riguarda la pretesa di Gesù di dirsi «figlio di dio»: pretesa che Marco ritiene pienamente legittima, al pari della condanna degli ebrei, da parte di dio, per non averla riconosciuta.
Per quanto riguarda la prima accusa, Marco si era già premunito descrivendo la cacciata dei mercanti dal Tempio con un taglio di tipo «etico-religioso» (una sorta di purificazione simbolica). Marco non vede in quell'episodio alcuna finalità di tipo «politico», soprassedendo al fatto che il sommo sacerdote veniva nominato dalle autorità romane, per cui un attacco contro il Tempio, indirettamente, significava un attacco contro Roma. (Non a caso gli zeloti nel 66 d.C. sostituiranno il sommo sacerdote in carica con uno scelto secondo la legge mosaica).
Il risvolto «morale» voluto da Marco sta appunto nel gesto fine a se stesso, compiuto dal solo Gesù, il quale, ancora una volta, suscita l'odio terribile dei sommi sacerdoti e degli scribi (i cui redditi e la cui autorità dipendevano anche da quei traffici), senza però riuscire a costruire con la folla un rapporto col quale porre fine a quegli abusi. La stessa collocazione temporale datagli da Marco (e condivisa da Matteo e Luca), e cioè pochi giorni prima della crocifissione, è servita semplicemente per confermare l'abisso «teologico» che doveva separare il Cristo dall'ebraismo.
Viceversa, in Gv 2,13 ss. l'espulsione dei mercanti attesta la notevole popolarità di Gesù già agli inizi del vangelo (nessuno infatti intervenne per ostacolarlo: né la polizia giudaica né le truppe romane, insediate nella fortezza Antonia, che probabilmente vennero prese alla sprovvista. Cosa che non succederà in At 21,31 ss., quando i Romani interverranno subito per sedare l'aggressione contro Paolo nel cortile del Tempio).
L'epurazione (o, se vogliamo, il primo tentativo insurrezionale dei nazareni) segna inoltre il distacco del movimento di Gesù da quello del Battista (che, ponendosi solo obiettivi etici, preferì non lasciarsi coinvolgere in un'azione del genere), ed è servita anche per verificare il livello di sensibilità democratico-rivoluzionaria presente nella Gerusalemme oppressa non solo dai Romani ma anche da un governo giudaico corrotto o quanto meno colluso. Gesù infatti dovrà per la prima volta costatare in Giudea la debole consapevolezza politica del movimento farisaico. Nicodemo – in Gv 3,1 ss. – è l'eccezione che rappresenta una limitata disponibilità al dialogo col movimento nazareno.
*
L'avversione nei confronti del Tempio e della legge mosaica è stata ripresa, in At 6,13 ss., dall'ebreo ellenista Stefano, divenuto cristiano, che non aveva mai visto Gesù e non aveva alcun desiderio di combattere i Romani, e che voleva la fine del primato del culto nel Tempio proprio perché odiava a morte i Giudei, rei di aver crocifisso il messia-figlio di Dio.
Viceversa, gli apostoli più stretti di Gesù, che continuarono a guidare il movimento dopo la sua morte, stranamente ripresero a frequentare il Tempio (At 2,46), tanto che in occasione della persecuzione anticristiana scoppiata a Gerusalemme dopo il linciaggio di Stefano, solo loro poterono tranquillamente restare in città (At 8,1).
In effetti, il cristianesimo primitivo – stando almeno alla documentazione disponibile, ma non è escluso che l'apostolo Giovanni avesse fondato un proprio movimento – oscillò continuamente fino al 70 d.C. tra queste due posizioni contrapposte: quella filo-ellenistica di Stefano e poi di Paolo, che era avversa al culto del Tempio e al rispetto integrale della legge mosaica, e favorevole alla spoliticizzazione del messaggio evangelico, nonché alla sua apertura universalistica ai pagani in nome della fede mistica nella resurrezione di Gesù; e quella corrente filo-ebraica degli apostoli di Gesù, che, pur partendo dalla medesima fede nella resurrezione, si era posta in attesa di una imminente parusia trionfale del Cristo, sperando ancora in una liberazione politico-militare della nazione. Questa corrente, dopo la tragedia del Golgota, aveva ripreso col giudaismo un dialogo di tipo religioso che al tempo di Gesù (e i vangeli lo dimostrano) era già stato superato. Al rapporto rivoluzionario con le masse essa aveva sostituito il rapporto diplomatico con le istituzioni (si veda soprattutto il ruolo di Giacomo fratello di Gesù, che sostituisce Pietro alla guida della comunità di Gerusalemme).
Saranno la mancata apocalisse, la predicazione mistica di Paolo e la distruzione di Israele a mettere fine, irreversibilmente, a questa speranza, facendo di un episodio (la tomba vuota), del tutto irrilevante ai fini della liberazione politica d'Israele, il pilastro fondamentale della nuova fede religiosa.
Ora, nella cacciata dei mercanti dal Tempio, descritta da Gv 2,13 ss., risulta chiaro non che Gesù volesse «distruggere» il Tempio, ma che il Tempio era già «moralmente» distrutto (in quanto la religione veniva usata per traffici commerciali e a fini di potere), e che se i farisei avessero riconosciuto a Gesù l'autorità per distruggerlo anche «politicamente», cioè, togliendo il potere ai sacerdoti (i sadducei), egli, con l'aiuto del popolo, avrebbe accettato immediatamente di porsi come «nuovo referente» per l'unificazione nazionale del movimento di liberazione.
I farisei però risposero che l'avrebbero aiutato se prima lui avesse dimostrato con un «segno» d'essere veramente la persona autorevole di cui Israele aveva bisogno (Gv 2,18). In pratica chiedevano a Gesù di compiere un atto di forza (terroristico, militare...) contro i Romani, che inequivocabilmente attestasse la sua superiorità su ogni altra formazione politico-militare. E lui naturalmente rifiutò: non perché fosse un «pacifista ad oltranza», ma perché non era quello il modo di costruire la «democrazia popolare» in Israele.
*
Si è detto che Marco è particolarmente preoccupato a evidenziare le ragioni per le quali il sommo sacerdote Caifa condannò Gesù non per sedizione, ma per bestemmia, avendo egli avuto la pretesa (empia per i Giudei) di porsi come «figlio di dio» (14,61 ss.).
Ora, è arcinoto, tra gli esegeti laici, che l'idea di collegare «messianicità» a «divinità» non ha alcun senso storico, sia perché gli ebrei non si attendevano un «messia divino», sia perché la cosiddetta «divinità» del messia-Gesù fu un'acquisizione apostolica post-pasquale; anzi, il primo a proclamare «Gesù Figlio di Dio» (At 9,20), non fu nessun apostolo, ma Paolo di Tarso, il quale applicò un appellativo in uso nel mondo ellenistico al Cristo scomparso dalla tomba, sostenendo che lui e solo lui era «il figlio di dio».
Marco, che ha scritto il vangelo in una comunità dominata dall'ideologia paolina (le Lettere di Paolo furono scritte almeno 15 anni prima del suo vangelo) non solo ha voluto avallare la più grande mistificazione del cristianesimo, ma ha dato anche origine a un vergognoso antisemitismo, basato su motivazioni pretestuose.
Questo perché, se anche l'accusa di «autodivinizzarsi» può essere stata mossa a Gesù (e in Gv 10,33 ss. lo è esplicitamente, ma da parte dei farisei in uno dei tanti dibattiti pubblici), essa non aveva il significato che le attribuiamo noi oggi. Dirsi «Figlio di Dio» per un ebreo equivaleva a dirsi «senza dio», cioè «ateo», poiché nessun uomo poteva avere una pretesa così grande al cospetto di dio. Non la ebbe il giusto sofferente Giobbe, il quale affermò che «davanti a Dio l'uomo ha sempre torto», e nemmeno l'ebbero i re dell'antico Israele, che – a differenza delle monarchie pagane – non vennero mai considerati delle «divinità». Gli stessi imperatori pagani che si fregiavano di questo titolo, e per il quale rivendicavano l'altro titolo, entrambi esclusivi, di «pontefice massimo», erano considerati dagli ebrei degli individui blasfemi, assolutamente irreligiosi, per quanto nessun imperatore avesse mai professato pubblicamente l'ateismo.
In Gv 10,35 s. Gesù afferma che tutti gli uomini devono potersi considerare degli «dèi», cioè non dipendenti da alcun dio. Era questo che portava i farisei ad accusarlo non di aver la pretesa di essere il figlio «esclusivo» di Jahvè (questo concetto andava al di là di qualunque immaginazione), bensì di portare gli uomini a non credere nella loro dipendenza assoluta dall'unico vero dio. E i farisei, dal loro osservatorio «legalistico», avevano ragione. Persino molti racconti di guarigione riportati da Marco lasciano trapelare l'ateismo di Gesù (si veda ad es. il fatto ch'egli non invoca mai il nome di dio per guarire o non usa mai strumenti, riti, formule, scongiuri... di tipo religioso).
Se dunque è verosimile che i Giudei abbiano potuto vedere in quell'affermazione sulla figliolanza divina una sorta di «empietà religiosa», è assolutamente da escludere ch'essa vada interpretata – stando alla teologia petro-paolina – come se i sommi sacerdoti non abbiano voluto riconoscere nel Cristo la sua «natura divina»: questa è davvero una sciocchezza colossale. Né ha senso ritenere che in virtù di essa si deve necessariamente dedurre che Gesù non è stato anzitutto condannato per motivi politici. Il dibattito sull'atteggiamento da tenere verso le questioni religiose dev'essere stato ben poca cosa, nella vita del Gesù storico, rispetto a quello sulle questioni politiche.
In altre parole, se Gesù poteva anche essere condannato alla lapidazione per empietà, di fatto la sua popolarità era troppo grande perché potesse essere veramente condannato solo per questo. Gv 11,57 lascia chiaramente intendere che persino la semplice libertà che Gesù si era preso di guarire in giorno di sabato, era considerata una violazione delle leggi divine (o mosaiche) e quindi un motivo sufficiente di condanna a morte, ma non per questo le autorità riuscirono a catturarlo. Ciò stava a significare che vi erano sempre meno ebrei che credevano nel valore di alcune leggi tradizionali e soprattutto nel valore di alcune interpretazioni rabbiniche in merito.
In ogni caso Gv 18,19 ss., nel descrivere il processo in casa del sommo sacerdote Anna, non riporta minimamente l'accusa che Gesù avesse minacciato di distruggere il Tempio, né afferma che il sommo sacerdote avesse chiesto a Gesù se fosse il messia-divino. Di «religione» proprio non si parla e neppure, quindi, del reato di bestemmia. Giovanni è l'unico dei quattro evangelisti ad avere la netta convinzione che Gesù sia stato giustiziato per motivi politici. Forse per questa ragione il suo vangelo aveva bisogno di un'altissima filosofia spiritualistica per poter essere efficacemente manipolato.
Nel momento in cui Gesù fu condotto davanti a una parte del Sinedrio (e non a «tutto», come vuole Mc 14,55), ai capi religiosi – se vogliamo – non interessava nemmeno più verificare se egli pretendesse d'essere un messia politico-nazionale. Lo sapevano già. Gli scribi inviati in Galilea (Mc 3,22 ss.) per verificare il suo operato, avevano già capito che lui (a differenza del Battista) aspirava a un potere di tipo politico. In Gv 18,19 il sommo sacerdote Anna lo interrogò per sapere anzitutto chi erano i suoi «seguaci» più fidati e solo in secondo luogo qual era la sua «dottrina». Ecco perché al momento dell'interrogatorio – qui ha ragione Gv 18,21 ma vedi anche Mc 14,60 s. e 15,4 s. – Gesù rimase praticamente in silenzio. In effetti l'unica cosa che poteva fare era quella di aspettare che il popolo si sollevasse e lo liberasse, dai sacerdoti e dai Romani.
Se dunque nel corso del processo avessero rivolto a Gesù la domanda riportata in Mc 14,61 ss.: «Sei tu il Cristo?» (Marco aggiunge, apologeticamente, «il figlio del Benedetto»), Gesù non avrebbe potuto rispondere di «no» neanche se avesse voluto, perché fino a quel momento egli si era comportato proprio come un messia politico-nazionale. E il suo «sì» non sarebbe servito ai capi-giudei per cominciare a stabilire con lui delle trattative per liberare Israele. Essi lo detestavano perché a partire dalla cacciata dei mercanti sino alla persistente violazione del sabato avevano capito che un compromesso col movimento nazareno non era possibile.
Resta comunque storicamente inspiegabile – in Marco – il motivo per cui il Sinedrio, pur potendo condannare e giustiziare Gesù per aver bestemmiato (come in At 8,57 s. farà con Stefano), decise invece di consegnarlo a Pilato. La natura dell'accusa presentata contro Gesù dai capi ebraici al tribunale romano non è riportata da Marco. L'elemento dal quale, per deduzione, si traggono indicazioni circa la motivazione della condanna è il titolo applicato sulla croce (Mc 15,26). Come noto, Gv 18,31 sostiene che il Sinedrio non poteva far giustiziare una persona colpevole di un delitto che comportasse la pena capitale, ma proprio l'esecuzione di Stefano, nonché quella di Giacomo fratello di Gesù, voluta nel 62 con decreto sinedrita – come scrive Giuseppe Flavio – attestano il contrario. Lo stesso Paolo aveva l'autorizzazione a fare «strage» di quei cristiani che non accettassero di farsi processare davanti al Sinedrio (At 9,1).
Tuttavia, Giuseppe Flavio dice chiaramente che l'ultima parola nelle questioni di vita e di morte spettava al procuratore romano. Evidentemente i Giudei, sul piano formale, dovevano rispettare l'approvazione di Pilato, nel senso che pur potendo pronunciare sentenze di morte, avevano bisogno della convalida del procuratore.
È probabile però che nei casi concreti i capi-giudei si sentissero sufficientemente liberi, se sapevano che ciò non sarebbe dispiaciuto alle autorità romane, di ricorrere al linciaggio o ad altre forme di persecuzione nei confronti dei loro connazionali giudicati «eretici». (In At 12,1-3, non fecero alcuna obiezione, anzi se ne rallegrarono, quando il re Erode Agrippa I nel 44 d.C, condannò a morte senza processo Giacomo Zebedeo e decise di arrestare Pietro).
*
Il popolo giudaico, nel Vangelo di Marco, compare all'improvviso durante l'ultima settimana di Gesù (Mc 15,8), senza una vera spiegazione (se si eccettua l'ingresso messianico, dove però scompare altrettanto improvvisamente). Questo popolo rivolge a Pilato una petizione (Mc 15,8 e Gv 18,39 dicono che era un'abitudine propria di Pilato durante la Pasqua) con la quale chiede di amnistiare un detenuto (Marco precisa che si trattava di un prigioniero politico).
Pilato – dice Mc 15,9 – desiderava liberare Gesù, perché lo riconosceva innocente e politicamente inoffensivo (nel senso che sapeva, in qualche modo, che il regno di Gesù non si sarebbe imposto con la forza. In Gv 18,36 Gesù afferma a chiare lettere che il suo regno non è di questo «mondo»).
Tuttavia Pilato preferisce far scegliere alla folla tra Gesù e Barabba (quest'ultimo era un capo zelota, il cui nominativo, in quella occasione, venne suggerito – come vuole Mc 15,11 – dagli stessi sommi sacerdoti). Incitata dai capi religiosi, che erano «invidiosi» di Gesù (Mc 15,10), la folla chiede di liberare Barabba e di condannare Gesù. In tal modo il racconto amplifica la colpevolezza degli ebrei, scagionando quella di Pilato, che viene fatto passare per un debole e un opportunista.
Ora, lasciando da parte il mistero per cui la folla non si sia limitata a chiedere la liberazione di Barabba, ma abbia anche preteso la condanna di Gesù (le due cose in Gv 19,1 ss. sono divise nel tempo, al punto che la richiesta di condannare Gesù viene formulata solo dopo la flagellazione), almeno per una ragione questa versione dei fatti non può essere attendibile: offrendo alla folla una scelta fra il patriota Barabba (il cui vero nome resta ignoto6) che aveva rischiato la vita contro i dominatori romani, e il pacifico Gesù che aveva consigliato di pagare il tributo a Cesare (Mc 12,13 ss.), Pilato non aveva alcuna possibilità di salvare quest'ultimo.
Per gli ebrei di allora il rifiuto di questo sopruso fiscale costituiva una sorta di banco di prova del loro patriottismo, della loro lealtà alle migliori tradizioni profetiche e di resistenza popolare al nemico. In realtà Gesù, se mai la domanda di pagare o no il tributo a Roma gli sia stata rivolta e soprattutto in quei termini, non può aver dato una risposta così diplomatica: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mc 12,17), poiché essa al massimo avrebbe potuto essere data da una comunità già spoliticizzata, o comunque non intenzionata a contrastare sino in fondo il potere costituito.
Di fronte a quella questione Gesù può semplicemente aver detto che era la «forza» di Cesare a obbligare gli ebrei a pagare il tributo e che il rifiuto di pagarlo poteva essere sostenuto solo da una forza opposta e superiore a quella romana: cosa che in quel momento ancora non esisteva, se non nei termini di una mera lotta terroristica o di azioni estremistiche e isolate. Quanto poi a distinguere la «proprietà» di Dio da quella di «Cesare», questo è assolutamente irrealistico se riferito al Gesù storico. In verità, tutte le espressioni di Cristo in favore della fede in una divinità vanno considerate spurie e prodotte da un'ideologia mistica post-pasquale.
Ma c'è di più. Nel racconto di Marco, Barabba viene descritto con evidente disprezzo: uno dei «ribelli» che aveva partecipato a una rivolta anti-romana ingiustificata. Questo modo di vedere le cose – come si può facilmente notare – fa sì che la scelta del popolo ebraico di preferire un «volgare assassino» all'innocente e «divino» Gesù appaia ancora più inspiegabile (o meglio appare spiegabile solo pensando che i Giudei, «per natura», fossero un popolo «deicida»).
*
In realtà le cose devono essere andate diversamente. Anzitutto Pilato, al pari dei sacerdoti del tempio, non vedeva l'ora di catturare e giustiziare Gesù (la sommossa anti-romana di Barabba doveva aver suscitato un certo fermento in città). In secondo luogo egli si rendeva conto che, data la popolarità di Gesù, non sarebbe stato facile eliminarlo (quando Gesù entrò trionfante nella capitale in groppa a un asino, simbolo della messianicità, i Romani devono aver tremato, perché sapevano che in caso d'insurrezione generale nella capitale non avrebbero avuto alcuna vera possibilità di difesa). Non dimentichiamo che la coorte stanziata a Gerusalemme durante la Pasqua non superava i 600 uomini. Essa al completo fu radunata quando i soldati condussero Cristo dentro il pretorio, la residenza ufficiale del prefetto. Gv 18,12 addirittura afferma che fu tutta la coorte, guidata dal tribuno, insieme alle guardie dei giudei, a catturare Gesù nel Getsemani.
In terzo luogo l'idea di metterlo in alternativa a un estremista e terrorista politico come Barabba, doveva servire appunto per far condannare Gesù. Cioè a dire, Pilato, per eliminare il ribelle più pericoloso (perché più popolare), aveva bisogno di convincere la folla che il più temuto dai Romani in realtà non fosse Gesù ma Barabba, proprio a causa del suo estremismo. A tal fine egli si servì anche della complicità del clero reazionario.
Il fatto stesso che la prima domanda posta da Pilato a Gesù: «Tu sei il re dei Giudei?» (Mc 15,2), sia stata proprio questa, attesta che tra il potere romano e quello giudaico vi era una certa intesa. Probabilmente l'intesa si sarà spinta sino alla scelta del detenuto da liberare: in Gv 18,3 ss. è chiarissimo come anche l'arresto nel Getsemani, fatto dai soldati romani e dalle guardie del Tempio, sia stata un'operazione concordata tra i due poteri istituzionali.
Va inoltre detto che, siccome dell'usanza pasquale di liberare un prigioniero politico non esiste altra testimonianza oltre quella evangelica, probabilmente essa non è mai esistita, anche se può essere del tutto realistica la decisione di Pilato di offrire al popolo la possibilità di una scelta (illudendolo di avere un certo potere). Dicendo ch'era un'usanza annuale, Marco sperava di togliere il sospetto che l'avesse escogitata lì per lì lo stesso Pilato. Cercò di togliere anche il sospetto che il processo non fosse giudiziario ma politico. In realtà il processo non solo era politico, ma per poter essere concluso senza «incidenti» di sorta, aveva necessariamente bisogno di un vasto consenso popolare (persino tra coloro che avevano simpatizzato per Gesù!).
Infine, Mc 15,10 non solo non spiega perché Pilato ritenne motivata dall'«invidia» l'azione dei grandi sacerdoti, ma usando una motivazione del genere toglie alla condanna di Gesù ogni rilevanza politica. Gesù in pratica sarebbe stato ucciso, secondo Marco, non perché era in gioco il destino della nazione ebraica, che doveva liberarsi dal dominio romano (e sulle cui modalità di liberazione di scontravano varie posizioni politiche, più o meno contrapposte), ma perché i capi religiosi temevano di perdere il loro potere sul Tempio (e i farisei quello nelle sinagoghe), mentre Pilato, dal canto suo, preferiva «dare soddisfazione alla folla» (Mc 15,15), per timore che potessero scoppiare incidenti ancora più gravi.
Viceversa Gv 11,49 s. fa chiaramente intendere che la preoccupazione principale delle autorità giudaiche non riguardava tanto gli aspetti religiosi della predicazione di Gesù, quanto piuttosto quelli politici (anche se in più punti del suo vangelo appare evidente che anche la posizione ateistica del Cristo risultasse particolarmente sgradita alle autorità giudaiche). Esse temevano che l'attività del movimento nazareno avrebbe finito col provocare un intervento romano che sarebbe risultato catastrofico per le sorti del Paese, cioè non credevano nella possibilità di una sollevazione popolare di massa o comunque dubitavano ch'essa avrebbe potuto sconfiggere l'imperialismo dello Stato più forte del mondo.
Ciononostante, proprio Gv 12,42 afferma che molti capi giudaici credevano in Gesù, anche se non lo ammettevano pubblicamente per timore che i farisei li cacciassero dalle sinagoghe. La corrente farisaica che dominava al tempo di Gesù era infatti quella che faceva capo alla scuola rigorista di Shammai, che sosteneva la necessità di radicalizzare la legge. Quella della scuola di Hillel, più «liberale» e preoccupata della coerenza pratica (ad essa appartenevano lo stesso Paolo di Tarso, come da At 23,6, e Giuseppe Flavio), si affermerà solo dopo la caduta di Gerusalemme nel 70. Probabilmente anche il notabile Giuseppe d'Arimatea (Gv 19,38) e l'archisinagogo Giairo (Mc 5,22) e forse anche il traditore Giuda erano farisei. Luca dice in At 23,7 che sul tema della resurrezione dei morti i farisei parteggiavano coi cristiani contro i sadducei, ma questa intesa aveva già assunto un carattere politicamente regressivo.
*
La preoccupazione di Marco è stata dunque quella di sostenere l'innocenza di Gesù in quanto «figlio di dio» e di mostrare che gli ebrei non gli avevano creduto (nonostante tutti i suoi «miracoli») proprio perché volevano un messia politico-militare che trionfasse su tutti i nemici d'Israele, invece di un «uomo-dio» che insegnasse a tutto il mondo la legge dell'amore del prossimo.
L'attesa del suo ritorno glorioso «in Galilea» (Mc 16,7), di cui parla il «giovane» seduto sulla tomba vuota (simbolo della fede nella resurrezione), non va perciò intesa nel senso che gli apostoli avrebbero dovuto riorganizzarsi contro il sistema dominante, ma come un invito ad abbandonare la Giudea e quindi l'idea stessa di una rivoluzione politica. Gli ebrei non meritavano d'essere liberati dai Romani, proprio perché avevano ucciso l'unico leader che poteva veramente farlo. D'ora in avanti il cristianesimo avrebbe dovuto essere predicato ai gentili. Infatti il primo a riconoscere la «divinità» del Cristo è proprio il centurione romano ai piedi della croce, il quale, con la sua fede religiosa, riscatta, in un certo senso, il comportamento indegno (perché opportunistico, pusillanime) di Pilato (Mc 15,39).
Se il Vangelo di Marco fosse stato scritto prima del 70, l'affermazione del «giovane» presente nel sepolcro forse poteva essere interpretata in altra maniera, contestuale all'idea petrina secondo cui alla resurrezione sarebbe seguita un'imminente parusia trionfale del Cristo, che avrebbe fatto giustizia di tutti i suoi nemici: Gesù avrebbe aspettato gli apostoli in Galilea per ricominciare tutto da capo, e questa volta senza incertezze di sorta e soprattutto senza riconoscere ai Giudei alcun primato d'onore rispetto ai gentili.
Ma per scongiurare un'interpretazione del genere e per chiarire quella originaria di Marco, che indubbiamente restava ambigua, la comunità provvide ad aggiungere una nuova chiusura del suo vangelo: in luogo del «ritorno in Galilea» (espressione troppo ebraica) si preferì mettere la «predicazione universale del vangelo» e il «giudizio universale» da parte del «Signore Gesù asceso al cielo, alla destra di Dio» (16,15 ss.).(torna su)
11) L'opposizione di principio
fra Stato romano e Chiesa cristiana
È nota agli studiosi di storia romana la classica tesi della storiografia cattolica secondo cui solo nel III secolo l'opposizione tra Stato e chiesa cristiana divenne di principio. Prima di allora le persecuzioni – si sostiene – furono un'eccezione, caratterizzate da una grande disparità di motivazioni e di procedure. Stando a Tertulliano, furono soprattutto gli ebrei fontes persecutionum dei cristiani.
Uno Stato di diritto come quello romano – dice sempre tale storiografia – non poteva essere un persecutore ope legis. Lo dimostra il fatto che già nel II secolo fu possibile a comunità di cristiani acquistare dei fondi per costruire delle chiese; a Giustino erigere a Roma una propria scuola pubblica; a tanti scrittori produrre una vasta letteratura edificante e apologetica.
Le stesse vessazioni subite da Paolo di Tarso non furono volute direttamente dal potere romano, ma dall'odio dei giudei ortodossi, che seppero avvalersi dell'appoggio delle autorità locali. Paolo, infatti, diversamente dai Giudei, divideva nettamente la religione dalla politica (Dio da Cesare), e se sul piano religioso predicava, come gli ebrei, un monoteismo che allo Stato romano poteva non piacere, sul piano politico invece, diversamente dagli ebrei, mostrava nei confronti delle istituzioni un lealismo tale da rendere incomprensibile ogni persecuzione (cfr Rm 13,1 ss., 1 Tm 2,1 s., Tt 3,1).
Insomma le persecuzioni si possono spiegare solo pensando che a causa della predicazione paolina i Giudei, che le erano nettamente ostili per motivi ideologici, riuscivano, con le loro trame, a indurre gli stessi pagani a odiare i cristiani, come spesso risulta negli Atti degli apostoli e nelle Lettere di Paolo. A parte questo, le persecuzioni anticristiane – sostiene la storiografia confessionale – non furono che il frutto di un tragico malinteso (come da un tragico errore giudiziario dipese la crocifissione del Cristo). Se l'opposizione fosse stata di principio, lo Stato, ufficialmente, avrebbe cominciato a perseguitare i cristiani sin dal I secolo, quando ancora non li distingueva dagli ebrei. Lo Stato romano invece tollerò il cristianesimo perché non vedeva in esso un vero nemico. Esso acconsentì ai soprusi per accontentare la società pagana.
Che lo Stato fosse tollerante nei confronti del cristianesimo è dimostrato – dice ancora tale storiografia – da due cose: 1. le persecuzioni non furono mai sistematiche ma alternate a periodi di grande tolleranza; 2. con la svolta costantiniana lo Stato, in cambio della legalizzazione, non pose alcuna condizione al cristianesimo, anzi lo privilegiò su tutte le altre religioni.
Detto questo, la storiografia cattolica non può offrire altre spiegazioni del motivo per cui, posta l'inesistenza di un'opposizione di principio, le persecuzioni più gravi avvennero non all'inizio dell'impero romano ma alla fine, cioè proprio quando le masse popolari pagane vi acconsentirono senza convinzione.
*
In effetti, le persecuzioni anticristiane volute con editto imperiale vanno solo da Decio a Diocleziano. L'Institutum neronianum di cui parla Tertulliano non è mai esistito, anche se il pogrom anti-giudaico-cristiano organizzato da Nerone costituì un importante precedente che permetterà non solo alla popolazione pagana, ma anche alle autorità statali di continuare, più o meno indisturbate, sulla via dell'intolleranza.
Ma questo non significa che l'opposizione di principio maturi solo a partire dal III secolo. Lo Stato cominciò a intervenire motu proprio quando s'accorse che a livello di società civile non esistevano più le forze per un'opposizione spontanea alla diffusione del cristianesimo. Esso era convinto che la società pagana sarebbe riuscita da sola ad arginare il fenomeno (così come aveva saputo fare con l'ebraismo). Lo Stato cioè era talmente scollato dalla società che non si rendeva conto quanto questa fosse moralmente debole per vincere la forza (ideale soprattutto) del cristianesimo. I pagani si opponevano al cristianesimo sostanzialmente solo attraverso i linciaggi, le calunnie, le delazioni e altre cose spregevoli. Non esisteva un vero confronto culturale, anche se non dobbiamo dimenticare la barbara distruzione dei testi pagani anticristiani ad opera della chiesa costantiniana e soprattutto teodosiana.
Ma quando lo Stato comincerà a intervenire, le sue angherie appariranno ancora più insensate di quelle della società civile. Pur avendo gli strumenti della legge, dell'apparato poliziesco-amministrativo, con cui organizzerà nel III secolo una repressione generalizzata, ordinaria e straordinaria, contro la religione più irriducibile, meglio strutturata e più diffusa, esso non riuscirà ad ottenere assolutamente nulla.
E quando smetterà d'intervenire? Quando s'accorgerà che l'opposizione cristiana era soltanto ideologica non politica, cioè quando s'accorgerà che il cristianesimo, pur mettendo teoricamente in discussione tutto l'esistente, in pratica voleva conservarlo. Fu questo dualismo di teoria e prassi – incomprensibile a filosofi come Celso o Porfirio – che determinò l'inizio delle persecuzioni e la loro fine. In nome della teoria le persecuzioni potevano apparire anche legittime, in nome della prassi erano del tutto sbagliate, perché sotto questo aspetto il cristianesimo era più o meno come le altre religioni.
In questo senso appare limitata anche l'affermazione di A. Donini, secondo cui «non è l'impero che si è convertito al cristianesimo, all'inizio del IV secolo; ma all'inverso, il cristianesimo ha fatto proprie le nuove strutture statali, destinate a perpetuare in modo più articolato le antiche forme di dominio di classe, attraverso un controllo non meno duro e sanguinoso sugli strati subalterni» (Storia del cristianesimo, ed. Teti, Milano, p. 188).
È vero, il cristianesimo sin dai tempi di Paolo era disposto ad accettare l'impero, ed è anche vero che quando potrà ufficialmente accettarlo esso subentrerà al paganesimo di stato con molta naturalezza, ma è anche vero che l'impero si convincerà ad accettare questa generosa offerta solo con Costantino. Cioè occorrerà una decisa e reciproca convergenza d'interessi, politici ed ideologici, prima che maturi l'intesa, e questa maturò dopo tre secoli di dura ostilità, nel corso dei quali morirono centinaia di martiri che molto probabilmente non avrebbero affatto desiderato una svolta come quella «costantiniana».
Non solo, ma l'intesa, così come l'aveva voluta Costantino, poté essere continuata, proseguendo sulle tradizioni romane, solo in oriente, poiché in occidente lo Stato romano era consapevole che la chiesa cristiana non gli avrebbe permesso quella autonomia di cui esso aveva bisogno per non venir meno a quelle tradizioni.
Infine va detto che il cristianesimo, pur con tutti i suoi limiti (che sono quelli, in sostanza, di ogni religione), contribuì alla democratizzazione della politica e alla umanizzazione della cultura del tempo (specie nell'area bizantina), favorendo il passaggio dallo schiavismo al colonato e da questo alle comuni agricole del feudalesimo (con o senza servaggio).
*
La storiografia cattolica sostanzialmente non comprende questo, che lo Stato romano non poteva avere nei confronti del cristianesimo la stessa opposizione di principio che doveva avere nei confronti di un'ideologia rivoluzionaria (come ad es. quella zelota o quella del movimento nazareno di Gesù Cristo).
Lo Stato romano sapeva bene che raramente i seguaci di una religione fanno, in nome della loro stessa religione, un'opposizione politica al sistema. Anche in questo caso l'ebraismo – con la sua idea teocratica e nazionalistica – costituiva un'eccezione. Fra le religioni ellenistiche vi potevano certamente essere atteggiamenti ribellistici, ma di regola questi restavano entro una forma pre-politica (anche immorale, come nei baccanali).
Generalmente una persona legata a una religione non è mai politicamente ostile al sistema dominante, al punto da organizzarsi per cercare di rovesciarlo (cfr 1Pt 2,13 ss.). Già i primi cristiani nelle loro funzioni pregavano per l'impero e per l'imperatore (cfr la Lettera ai Corinti, 60-61, di papa Clemente Romano, che, pur essendo stata scritta nello stesso periodo dell'Apocalisse di Giovanni, contrasta notevolmente per i suoi contenuti).
Gli stessi ebrei usavano sì la loro religione per opporsi politicamente all'impero, ma non per rovesciare il potere dominante. Essi volevano solo una nazione libera dai Romani, quindi la loro religione era nazionalistica. Essi ottennero il privilegio della religio licita proprio per questa ragione, e non per questa ragione lo Stato romano rinunciò a distruggere Gerusalemme e qualsiasi opposizione politica dei Giudei.
Ecco perché inizialmente lo Stato romano non attaccò subito il cristianesimo, o meglio si limitò ad attaccarlo in quanto lo confondeva con una delle sette dell'ebraismo. Lasciò che fosse la popolazione a decidere come comportarsi. E la popolazione pagana capì che del cristianesimo non ci si poteva fidare.
*
Perché la religione pagana era così strettamente legata alla politica? Perché giustamente la società riteneva che il fine del civis fosse quello di lottare per modificare al meglio il presente. In tal senso la religione doveva essere uno strumento al servizio della politica, per realizzare degli ideali politici. Lo jus sacrum era parte integrante dello jus publicum. La libertà religiosa classica era la facoltà del cittadino non di scegliere in coscienza la propria religione e di aderirvi in base a una fede personale, ma era di partecipare al culto delle istituzioni religiose pubbliche. Il paganesimo, in questo senso, era molto più concreto di quel che non sembri. Il giovane Hegel lo comprese perfettamente.
Perché allora il cristianesimo ebbe la meglio? Perché la politica romana era classista e la religione, essendo subordinata alla politica, non faceva che avvalorare lo status quo, cioè una situazione sociale del tutto estranea agli interessi dei ceti marginali. Schiavi, meteci, liberti, stranieri... erano esclusi dalla religione ufficiale romana (o comunque dovevano crearsi delle proprie divinità pagane), mentre i plebei cittadini romani dovettero lottare moltissimo per non essere esclusi dalle cariche sacerdotali. Di qui l'importazione clandestina dei culti orientali, che offrivano la possibilità di credere in un'alternativa. Fino agli Antonini, non dimentichiamolo, la legge non riconoscerà agli schiavi alcun diritto civile e religioso.
La contraddizione tra teoria e prassi nella religione pagana era sicuramente superiore a quella del cristianesimo, ed essa si manifestò molto di più non sotto la repubblica ma sotto l'impero, dove lo Stato, per contenere lo sviluppo delle contraddizioni del sistema schiavistico, fu costretto, sul piano culturale, da un lato ad accettare tutte le religioni (anche quelle orientali), sperando di poterle usare per fini politici; dall'altro a rifiutarle tutte puntando in primis sul militarismo e sul culto imperiale per tenere unito l'impero. Esso perseguitò il cristianesimo perché pensava che il monoteismo assoluto avrebbe acutizzato i conflitti di classe. Lo perseguitava nell'illusione appunto di placare tali conflitti.
Le repressioni contro il cristianesimo servirono alle autorità romane come valvola di sfogo per le contraddizioni sociali dell'impero. A tale scopo si può dire che ad esse parteciparono anche i ceti sociali oppressi, almeno in un primo momento. Il cristianesimo era odiato da tali ceti per due ragioni: 1. perché vedevano i cristiani disinteressarsi alle sorti dell'impero; 2. perché, nonostante la crisi economica dell'impero, vedevano che i cristiani – grazie alla loro efficiente organizzazione sociale – riuscivano a sopportarla con minore fatica.
Tuttavia, fra i ceti marginali, quelli che non avevano più nulla da perdere (gli schiavi) o quelli che rischiavano di perdere tutto (piccoli proprietari) potevano anche sentirsi indotti ad abbracciare questa nuova religione (cfr l'episodio di Anania e Saffira in At 5,1 ss.). È un'illusione quella di credere che i ceti marginali, solo perché tali, dovessero necessariamente simpatizzare per i cristiani. Occorreva anche fare un salto culturale non indifferente per quell'epoca. Ecco perché all'inizio il cristianesimo poté diffondersi solo nelle città, tra quei ceti che pur non essendo particolarmente benestanti, non erano neppure così sprovveduti sul piano culturale da non capire la portata innovativa della nuova religione.
Ma se questo è vero, non è però vera la tesi che la più recente storiografia cattolica sostiene, secondo cui è bene scagionare le autorità statali dalla responsabilità di aver preso tutte le iniziative delle rappresaglie anticristiane, addebitandola invece ai pregiudizi e all'ignoranza delle masse popolari di religione pagana. Gli imperatori o i governatori locali – sostiene tale storiografia – non erano mossi da un fanatico integralismo che li portasse a perseguire i cristiani per la loro fede: piuttosto si adattavano alle esigenze del momento.
In realtà è da escludere che, nell'affermata identità di politica e religione pagana, non vi potessero essere persecuzioni direttamente volute dallo Stato. Lo Stato poteva anche non essere intenzionato a volere tali persecuzioni, ma per escludere, con relativa sicurezza, tale eventualità, esso aveva bisogno di verificare che la modalità d'esistenza di una determinata religione rientrasse nei due criteri maggiormente condivisi e largamente sperimentati: il lealismo politico e il politeismo religioso.
È assolutamente da escludere l'idea che lo Stato romano fosse favorevole alla libertà di coscienza e di culto, così come la intendiamo oggi. La religione non era un affare esclusivamente privato. Qui ha perfettamente ragione Donini, quando dice che «col passaggio dalla società gentilizia allo Stato schiavista... e poi al principato, la religione romana è sempre più diventata un fatto politico... La religiosità degli strati subalterni era intensa e differenziata, ma nei limiti di una prassi rigorosamente controllata dall'alto» (op. cit., p. 188).
La separazione di Stato e chiesa è un principio mutuato dal cristianesimo, per quanto proprio il cristianesimo, con la svolta costantiniana e soprattutto teodosiana, sia stato il primo a tradirlo. Tale separazione implicava una concezione apocalittica della storia, cioè la convinzione che il cristiano dovesse considerarsi come un pellegrino sulla Terra, in attesa della fine dei tempi (vedi La lettera a Diogneto). Senza la fede assoluta in un aldilà decisamente migliore dell'aldiquà, la separazione non sarebbe mai nata. Il motto evangelico «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mc 12,17), nonostante si presentasse come un tradimento dell'istanza di liberazione politica dall'imperialismo romano, costituiva pur sempre una novità assoluta rispetto all'integralismo romano del tempo.
L'opposizione era quindi di principio sin dall'inizio dell'impero. Sotto un regime schiavistico non solo era impensabile tollerare delle ideologie politiche che prevedessero ribellioni contro il sistema, ma non si potevano neppure tollerare delle religioni che separassero Dio da Cesare. Benché in virtù di tale separazione si dovesse escludere il carattere rivoluzionario di una religione, lo Stato romano non poteva ammettere l'esistenza di una religione indipendente dalla sua politica. Nel III secolo vi fu solo un aggravamento quantitativo delle persecuzioni, nonché una definitiva legittimazione giuridica.
Tale opposizione, contro una religione che pretendeva d'essere alternativa a quelle ufficiali, non poteva essere condotta immediatamente con strumenti giuridici e politici. Aveva bisogno di vari pretesti costruiti ad arte, in cui una buona parte della popolazione avversa al cristianesimo fosse coinvolta. Di qui l'incendio di Roma sotto Nerone. Di qui le accuse di infanticidio, di antropofagia, di incesto, di adorazione di un asino ecc., senza considerare le attribuzioni di responsabilità ai cristiani ogniqualvolta accadevano calamità naturali o sconfitte militari. I pregiudizi e le calunnie aumentavano in proporzione alla crisi della società pagana e al successo della religione cristiana, anche se ad un certo punto cominciarono a nascere fiducia e comprensione. Agostino, con la sua De Civitate Dei, era ancora alle prese con questo problema.
Quella storiografia cattolica che non accetta questo modo di vedere le cose, inevitabilmente tende:
– ad attribuire alla svolta costantiniana, nonostante i suoi limiti «cesaropapisti», un ruolo favorevole all'affermazione dell'identità cristiana;
– a escludere recisamente che il cristianesimo primitivo sia nato in antitesi alle idee di Cristo;
– a negare al cristianesimo, nonostante il suo tradimento del messaggio di Cristo, qualunque caratterizzazione eversiva (che è invece ben visibile p. es. nell'Apocalisse di Giovanni);
– ad attribuire all'ebraismo una parte dei motivi che opponevano cristiani e pagani, cioè a non riconoscere all'ebraismo neppure il diritto ad avere una nazione libera dal dominio dello straniero.
*
Perché dunque vinse il cristianesimo?
1. Perché offriva agli oppressi non solo una speranza in più, seppure nell'aldilà, di liberazione definitiva dall'ingiustizia (mentre il paganesimo classico riponeva – come dice Minucio Felice nel suo Octavius – «nel fato la ragione delle colpe o dell'innocenza degli uomini»), ma offriva anche un anticipo, una caparra «storica» di questa giustizia, rivendicando il diritto alla libertà di coscienza, contro il conformismo dominante, che caratterizzava anche il modo di vivere la fede da parte delle religioni orientali, incapaci di opporsi all'assolutismo statale.
Il cristianesimo si rivolgeva alla responsabilità personale del singolo credente, al quale chiedeva uno stile di vita il più possibile irreprensibile (ad es. il cristiano non poteva vendicarsi del suo persecutore). Sulla base di questo stile di vita si chiedeva al credente di rinunciare a tantissime cose, persino a molti mestieri remunerativi (cfr La tradizione apostolica di Ippolito) e anche ai legami di parentela; si chiedeva addirittura di resistere fino al martirio agli abusi del potere statale, se questi voleva obbligarlo all'abiura.
2. Perché sul piano sociale il cristianesimo garantiva agli oppressi, agli emarginati, alle categorie più deboli un'esistenza migliore di quella offerta dalla società pagana e dallo Stato romano. Pur non predicando mai la rivoluzione, né opponendosi, in linea di principio, alla schiavitù, la chiesa metteva in atto princìpi umanitari come p. es. l'assistenza ai malati, alle vedove, agli orfani. Essa era contraria al suicidio, all'adulterio, all'abbandono dei neonati, a ogni forma di vizio o di dissolutezza.
Viceversa, lo Stato romano passò alla trasformazione dello schiavo in colono non per motivi umanitari ma perché, con la fine dell'espansione militare dell'impero, non era più possibile procurarsi degli schiavi a buon mercato. Tutta la filosofia umanistica dello stoicismo – che caratterizzerà proprio gli imperatori più anticristiani – non portò mai a una vera democratizzazione della vita sociale.
3. Perché, pur essendo meno sofisticato sul piano culturale (filosofico), il cristianesimo garantiva una maggiore coerenza fra teoria e prassi. I documenti del Nuovo Testamento (soprattutto i vangeli), essendo frutto di un'opera collettiva pluridecennale dell'ebraismo cristianizzato della diaspora, in stretto contatto con l'ellenismo, contenevano spunti di riflessione particolarmente stimolanti per le masse popolari, anche perché più realistici di tante altre fonti di carattere mitologico-religioso: la figura di Gesù Cristo superava per concretezza e drammaticità molte divinità orientali.
In questo senso la teologia si poneva come riflessione sopra un'esperienza in atto e non come speculazione filosofica del singolo intellettuale (gnosticismo, stoicismo, neoplatonismo). L'élite filosofica, sotto l'impero, ha sempre fatto distinzione tra le opinioni teologico-filosofiche (in cui credeva) e il comportamento cultuale (in cui non credeva, perché lo riteneva del tutto formale, adatto al popolo, anche se lo praticava per puro opportunismo). Cicerone, che derideva senza pietà, nei suoi scritti, gli dèi e le loro favole, era augure in maniera scrupolosa. Il cristianesimo non ammetteva tale doppiezza. Esso dimostrò che l'astensionismo al culto pagano non comportava di per sé indifferentismo alle questioni etico-sociali.
*
Dove fallì il cristianesimo?
1. Nell'aver trasformato il messaggio laico-umanistico e politico-rivoluzionario del Cristo in uno di tipo religioso-ecclesiastico, politicamente conservatore e quindi nell'aver ridotto lo scontro tra cristianesimo e impero a uno scontro giuridico-culturale tra cristianesimo e paganesimo (come fecero gli apologisti). Minucio Felice (nell'Ottavio) e Tertulliano (nell'Apologetico) documentano che i cristiani si difendevano dall'accusa di essere adoratori della croce. Questo simbolo della punizione dello schiavo ribelle scandalizzava i cristiani non meno dei pagani e degli ebrei. Sino agli inizi del V secolo non si troverà nell'arte e neppure nella liturgia l'abbinamento della persona del Cristo allo strumento del suo martirio politico.
2. Nell'aver preteso di sostituirsi al paganesimo, diventando la nuova religione di stato e tradendo così il principio di separazione tra chiesa e Stato. Di qui le persecuzioni di tutte le religioni non-cristiane e delle cosiddette «eresie».
3. Nell'esser venuto meno (in occidente soprattutto) anche all'aspetto più trasgressivo ch'esso aveva in quanto «religione»: l'escatologia, il profetismo, l'apocalittica, il distacco dalle cose terrene ecc. Tutte le eresie sorte in ambito cristiano o le contestazioni di tipo monastico, eremitico ecc., nasceranno dalla constatazione di questa sfasatura.
Ma allora, ci si può chiedere, da dove proveniva la radicalità teorica del cristianesimo? Solo da una cosa: dalla reminiscenza del messaggio autentico del Cristo. Il cristianesimo non fu semplicemente uno svolgimento universalistico dell'ebraismo o una concretizzazione socio-umanistica delle filosofie e religioni ellenistiche. Fu anche il prodotto di un'esperienza assolutamente originale, che però venne immediatamente tradita, seppur non in maniera integrale. Qui sta la grandezza e la miseria del cristianesimo, che forse è la miseria e la grandezza dell'uomo che con Paolo dice: «c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo» (Rm 7,8).(torna su)
12) Conclusione
Per Paolo di Tarso, il fondatore, insieme all'apostolo Simon Pietro, del cristianesimo primitivo, il giudaismo era «ombra delle cose future», e queste cose altro non erano che la «sua» teologia mistica, ch'era, a sua volta, una radicalizzazione della teologia politica che il galileo Pietro aveva elaborato al cospetto della tomba vuota, parlando di «morte necessaria» (voluta da dio) e di «resurrezione» (corpo ridestato).
Oggi è diventato lo stesso «cristianesimo» un'«ombra delle cose future», e queste altro non sono che l'umanesimo laico e il socialismo democratico. Le quali hanno preso a formarsi, tra mille errori e contraddizioni, anche di una gravità eccezionale, seguendo un percorso spesso imprevedibile, ma sempre in linea con l'esigenza di recuperare qualcosa che si è perduto e di cui non si può fare a meno.
*
Il lato conservatore della teologia paolina sta proprio nella distinzione che viene posta tra Cristo e Dio, tra dio-padre e dio-figlio. Se Paolo avesse semplicemente detto che in Cristo vi è l'interezza dell'umano, l'originaria dimensione umana di cui noi abbiamo perduto memoria, non avrebbe fatto né un discorso politicamente rinunciatario, né alcun discorso di tipo teologico.
Se Cristo infatti rappresenta l'umano, qualunque concezione della divinità gli è già propria, cioè è già inclusa nell'umano.
Paolo non s'è reso conto che se Cristo fosse stato un «suo discepolo», difficilmente avrebbe portato la predicazione ricevuta alla più tragica conseguenza, quella appunto della crocifissione. Infatti se la realizzazione dell'identità umana non è possibile su questa Terra, a causa del peccato originale e delle sue conseguenze, dilatatesi e approfonditesi nel tempo a livello planetario, sarebbe stato sufficiente limitarsi a dirlo, senza bisogno di insistervi sino al punto da desiderare il martirio, o comunque questa soluzione estrema sarebbe rimasta una scelta meramente privata, un'eccezione alla regola, quella regola che era, e che ancora oggi è, della «rassegnazione metafisica».
Contro Paolo ce l'avevano i pagani politeisti e gli ebrei nazionalisti: gli uni lo accusavano, col suo monoteismo, di predicare una sorta di ateismo, in quanto il suo dio-padre restava rigorosamente invisibile, e nell'idea di resurrezione del Cristo (unica vera immagine di dio) bisognava credere come se fosse non una cosa simbolica, ma una realtà oggettiva. Gli ebrei invece lo accusavano di voler togliere a Israele la speranza di diventare una nazione libera dallo straniero.
Tuttavia, una volta distrutta Gerusalemme (nel 70 e poi di nuovo nel 135), veniva meno anche la necessità di trovare un accordo politico col giudaismo. Non restava che l'esigenza di trovare un accordo religioso col paganesimo, che sicuramente sarebbe stato molto più facile dell'altro, come poi la storia si preoccuperò di dimostrare, benché anche in questo caso i tempi dell'intesa furono piuttosto lunghi, essendo il politeismo una tradizione culturale molto radicata nelle società e civiltà basate sullo schiavismo e sul servaggio.
Il cristianesimo paolino riuscirà a convincere i pagani ad abbandonare tutti i loro dèi e ad accettare, in forma più ateistica (ch'era poi quella maturata negli ambienti ebraici), l'idea di un unico dio invisibile e irrappresentabile, nonché l'inedita idea di un figlio unigenito di dio morto e risorto, a lui consustanziale e nello stesso tempo incarnatosi come uomo (idea inedita in quanto la resurrezione andava intesa in senso letterale e non metaforico, come invece per altri culti pagani).
Se Paolo si fosse limitato a dire che non esiste alcun dio e che il Cristo aveva accettato di morire in croce non tanto per redimere gli uomini dal peccato originale, quanto per insegnare la necessità della democrazia, utile soprattutto quando si vuole compiere qualcosa contro l'oppressione, avrebbe fatto un discorso ateistico più coerente e avrebbe lasciato aperta la strada a soluzioni politiche rivoluzionarie.
La divinità è tutta racchiusa nell'umanità e, poiché la condizione naturale dell'umanità è quella terrena, almeno in quello che definiamo l'orizzonte storico, è proprio in questa dimensione che bisogna cercare di viverla, anche a costo d'essere «crocifissi». La «croce» è l'onere di cui eventualmente ci si deve far carico se, nel voler vivere la propria umanità in maniera integrale, hic et nunc, s'incontrano opposizioni risolute.
Se Paolo avesse detto questo, il problema sarebbe diventato un altro, e cioè quello di come affrontare l'illusione di credere che per dimostrare la propria umanità sia sufficiente farsi crocifiggere. Una cosa infatti è resistere all'oppressione, un'altra è provocare l'oppressore, facendo sì che ci si possa vantare della propria condizione d'oppresso, accampando pretese di verità e di giustizia, che di umano e di democratico non hanno proprio nulla.
Vittimismo infatti vuol dire fare dell'oppressione e soprattutto del martirio una sicura testimonianza di verità, a prescindere da qualunque altro comportamento.
L'unico modo razionale di tentare di uscire da questo rischio, da questo abuso della credulità, è quello di vivere la propria resistenza non in forma individuale, ma collettiva, misurando sempre l'entità delle forze in campo e chiedendosi continuamente se le esigenze dell'umano vengono rispettate in maniera adeguata. Se un perseguitato, solo perché tale, si sente migliore del proprio persecutore, è naturale che, nel caso in cui riesca ad andare al potere, assuma atteggiamenti anche più odiosi del proprio persecutore. Basta vedere cosa fece il cristianesimo dopo che, con Teodosio, divenne «religione di stato».
*
Se Paolo oggi fosse vivo sarebbe inevitabile porgli la seguente domanda: «Anche ammesso e non concesso che una liberazione effettiva su questa Terra non sia possibile, deve per forza esserci un dio-padre e un dio-figlio?».
Il cristianesimo ha voluto prendere alla lettera la questione della generazione ab aeterno, senza rendersi conto che se proprio si voleva trasferire nei cieli l'idea terrena di «famiglia», sarebbe poi stato impossibile sottrarsi all'osservazione critica di chi avesse ipotizzato che non la famiglia terrena è un riflesso di quella celeste, bensì il contrario (cfr p.es. l'opera di Feuerbach).
Peraltro una teologia davvero «democratica» avrebbe dovuto prevedere un ruolo femminile equivalente a quello di «dio-padre», sottraendo il misticismo all'egemonia del maschilismo. Se non esiste una «dea-madre», come può essere generato un «dio-figlio»? e poi perché generare un «dio-figlio unigenito» e non anche una «dea-figlia»? e perché non tanti «dèi-figli»?
Tutta la teologia cristiana, inclusa quella che s'è sforzata di vedere nello spirito santo una delle due «mani» di dio (intendendo l'altra il figlio), ovvero il lato «femminile» della trinità, resta profondamente maschilista (e politicamente monarchica). Una qualunque «teo-logia», cioè un qualunque «discorso-su-dio», non ha alcun senso razionale: l'uomo non può avvilupparsi in considerazioni che, in ultima istanza, restano del tutto indimostrabili o comunque non pertinenti alla propria esigenza di laica umanità.
Accettare, come presupposto gnoseologico, la presenza di una divinità, significa negare all'uomo la libertà di coscienza. O la divinizzazione è parte costitutiva dell'essere umano, oppure dio non esiste. Una qualunque ammissione della sua esistenza fa perdere all'uomo la sua autonomia, proprio in quanto diventa impossibile non arrivare a utilizzare le contraddizioni umane per sostenere che solo dio ne è privo e quindi può risolverle. L'esistenza di un dio assolutamente perfetto è una tentazione troppo grande per chi vuole rassegnarsi al male su questa Terra. Il che ovviamente non vuol dire che il credente sia un grande peccatore: «credere in dio» in fondo vuol dire – per tutte le religioni, non solo per quella cristiana – sforzarsi di tenere un comportamento degno, in previsione di un premio ultraterreno, a prescindere dall'intenzione che si ha di lottare in maniera più o meno convinta contro le ingiustizie sociali.
Resta tuttavia un fatto, abbastanza assodato, salvo eccezioni naturalmente. Di fronte ai peccati altrui, il credente, in genere, pecca di omissione, in quanto chiede, a chi li subisce, di pazientare sino alla fine dei giorni, sino al «giudizio universale». Anche quando s'impegna politicamente come cittadino, il credente parte sempre dal presupposto che gli antagonismi sociali non sono risolvibili sino in fondo, o comunque sono componibili solo parzialmente. La mediazione, che il credente cerca in politica, è solo uno strumento per attenuare, non per risolvere, gli opposti estremi. Anzi, nel peggiore dei casi, quello in cui si vuol fare del fondamentalismo dogmatico una regola di vita, è la stessa religione che si pone come uno degli estremi. E questo è tanto più vero quanto più essa si caratterizza in senso «monoteistico».
(torna su)1 Se ci pensiamo, in nome della divinità del Cristo, fu proprio il papato romano che, con l'idea di teocrazia, si sostituì all'ebraismo politico, usando in forme più evolute e a livello internazionale, gli stessi strumenti integralistici che quest'ultimo aveva usato a livello nazionale.
2 Archelao aveva anche permesso di ricostruire completamente l'insediamento esseno del Mar Morto, distrutto da un terremoto nel 31 a.C., e che costituirà una delle basi zelote al tempo della guerra giudaica.
3 Da notare che i sommi sacerdoti, pur essendo nominati, a partire dal regno di Agrippa I, dai dinasti erodiani e non più dai Romani, avevano perso qualunque stima da parte della popolazione ebraica, proprio perché non erano disposti a un'insurrezione armata contro Roma.
4 Non pochi esegeti confessionali hanno sostenuto che, nella fattispecie della lotta di liberazione di Israele contro Roma, una posizione «teo-politica» (quale certamente fu quella del partito zelota nel corso della guerra giudaica) avrebbe anche potuto costituire un fenomeno eversivo o addirittura rivoluzionario agli occhi dell'imperialismo romano. Questo, in effetti, può anche essere vero, ma resta il fatto – e la storia lo documenta in abbondanza – che una qualunque posizione «religiosa» si configura sempre, in ultima istanza, a prescindere dalle intenzioni di chi la professa, come un fenomeno regressivo della realtà. In tal senso non è da escludere che il fallimento della suddetta guerra giudaica sia da attribuirsi proprio alla volontà di tenere strettamente connessi «religione» e «politica».
5 Da tempo gli esegeti hanno capito che la condanna a morte non può essere stata pronunciata dall'intero Sinedrio, e questo per una serie di ragioni: 1) il processo doveva farsi in due sedute distinte in due giorni diversi; 2) doveva essere svolto di giorno e in pubblico; 3) dovevano esserci due testimoni contro l'imputato; 4) la testimonianza doveva essere oculare; 5) l'imputato doveva avere un difensore; 6) un verdetto unanime sarebbe stato considerato nullo; 7) nessun procedimento era possibile durante la pasqua; 8) l'esecuzione capitale era la lapidazione. Peraltro l'arresto doveva avvenire in pieno giorno, con un mandato legale del Sinedrio e senza alcun tradimento. Stante le cose in questi termini, il processo a carico di Gesù non può essere considerato giudiziario (se non nelle apparenze), quanto piuttosto politico, ove la responsabilità va distribuita tra i sommi sacerdoti e Pilato.
6 Barabba infatti vuol dire «figlio del padre». Su questa stranezza si è scritto molto, ma è probabile che dietro quel nome si celi un capo politico che a quel tempo doveva essere piuttosto noto. La decisione di Pilato, di mettere in libertà uno dei due prigionieri, può essere stata dettata dalla particolarità di quel momento, per attenuare una tensione che doveva essere molto alta.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube