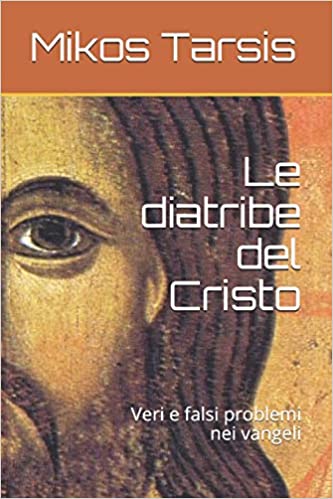
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
LE DIATRIBE DEL CRISTO
Veri e falsi problemi nei vangeli
Premessa - 1) Genealogie del Cristo - 2) La questione della nascita di Cristo - 3) Lo sposo e la discussione sul digiuno - 4) Le spighe strappate di sabato - 5) Che significa “porgere l'altra guancia”? - 6) I cibi puri e impuri - 7) La questione del divorzio - 8) La posizione di potere dello scriba - 9) Il tributo a Cesare e la diarchia dei poteri - 10) Cristo ateo o folle? - 11) La politica nella festa delle Capanne - 12) Cristo e Abramo - 13) L'ateismo nella festa della Dedicazione - 14) Gesù e l'adultera - 15) Sulla questione dei “segni” - 16) La mistificazione del Paraclito - 17) Il potere e l'umiltà - 18) I sadducei e l'idea di resurrezione dei corpi - 19) Appendici. Ebraismo e cristianesimo sono due forme di ateismo? - 20) Sull'uso delle profezie nei vangeli - 21) Sul concetto di riproduzione sessuale - Conclusione
Premessa
Davvero serve mettere in relazione i vangeli cristiani coi testi storici del giudeo Yosef ben Matityahu, meglio conosciuto col nome di Giuseppe Flavio? Per me i vangeli non sono testi storici ma manifesti di teologia politica. Che un testo di storia non possa avere più pretese di obiettività di uno di teologia-politica lo dimostra proprio Flavio, che pur raccontando con tanti particolari la storia d'Israele dello stesso periodo dei vangeli, non dice nulla di più di quanto già non si sappia dall'intero Nuovo Testamento (in riferimento ovviamente al cristianesimo e soprattutto al movimento nazareno, che son due cose ben diverse).
I testi di Flavio in cui si parla di Gesù Cristo sono stati manomessi dai cristiani, ma questo non significa affatto che gli originali fossero favorevoli al movimento nazareno; anzi, visto che Flavio scriveva per compiacersi i Romani, è molto probabile ch'egli avesse posto i nazareni sullo stesso piano degli zeloti, cui attribuisce la causa fondamentale della disfatta della Palestina. Semmai si può pensare ch'egli abbia parlato del movimento nazareno e quindi del suo fondatore come di un evento del tutto politico, cioè privo di quegli aspetti mistici e miracolistici così macroscopici nei vangeli.
Se ci pensiamo i primi imperatori romani avrebbero potuto utilizzare i testi di Flavio contro Israele in maniera molto più facile che non gli stessi vangeli, che pur sono ampiamente antisemitici.
Il punto infatti è proprio questo, che per i cristiani gli imperatori erano uomini comuni, che di messianico o di divino non avevano proprio nulla, e per loro l'unico vero Dio era padre di un figlio morto e risorto. Poteva l'impero utilizzare questa visione delle cose? Pur essendo politicamente conservatori, ideologicamente i vangeli erano eversivi, e non solo perché negavano d'esistere a tutti gli dèi pagani. Il fatto stesso che Cristo separi la funzione di Cesare da quella di Dio nell'episodio del tributo, per un romano, ligio alle istituzioni (per le quali non si faceva molta distinzione tra civile e religioso, tant'è che l'imperatore era anche pontifex maximus), doveva apparire sconcertante, e infatti ci metteranno tre secoli prima di accettarlo. E ce ne vorranno altri millecinquecento prima di capire che il Cristo si poneva sia contro Cesare che contro qualunque dio.
Invece per l'opportunista Flavio il suo imperatore era, nel contempo, “dio e cesare”, e tutti quelli che avevano cercato di opporsi a lui erano stati responsabili della distruzione di Israele e minacciavano la stabilità dell'impero. Molto meglio di Flavio fu Filone Alessandrino che, pur essendo ebreo, si limitava a fare il pagano in maniera filosofica.
Insomma noi purtroppo abbiamo a che fare con testi talmente pieni di manomissioni che è impossibile risalire a un originale. Ecco perché conviene considerare il Nuovo Testamento una falsificazione di tipo teo-politico, cui occorre contrapporre una versione dei fatti di tipo umano-politico.
I vangeli hanno usato la politica in maniera regressiva e hanno potuto farlo infarcendola di contenuti mistici. Sarebbe stato sufficiente fare un testo storico i cui protagonisti ammettessero di aver sbagliato a interpretare teologicamente la tomba vuota. Invece i protagonisti degli eventi che vi si raccontano hanno mentito e i loro seguaci hanno aspettato che morissero per mettere per iscritto le loro falsità.
A questo punto la storia non esiste più, nel senso che chi poteva raccontarla non ha voluto farlo e chi l'ha raccontata l'ha ridotta a politica teologica. Sicché, allo stato attuale delle fonti, il problema non può più essere quello di dimostrare la “verità storica”, ma solo quello di mostrare che la versione dei fatti del Nuovo Testamento può essere falsa proprio in quanto s'è trasformato il “Gesù storico” in un “Cristo teologico”.
Se ci limitassimo a fare confronti di tipo storico non si riuscirebbe a scrivere più di uno o due libri sull'argomento. Gli esegeti laici invece devono imparare a superare il cristianesimo ab intra (da politici), dando per scontato alcuni presupposti: non basta più farlo ad extra (da storici), negandoli in via preliminare.
Bisogna rileggersi i vangeli parola per parola e vedere dove un ipotetico detto umanistico-politico è stato trasformato in testo teologico-politico. Non serve a niente il metodo delle concordanze / discordanze tra Flavio e il Nuovo Testamento nella speranza di trovare qualcosa di veridico circa il cristianesimo. Flavio può essere utile per capire qualcosa della storia di Israele del I secolo, ma non bisogna dimenticare che i suoi testi è come se fossero stati scritti da Vespasiano o da Tito in persona. Possiamo forse basarci sui testi di Tacito, che stava ovviamente dalla parte di Cesare, per capire i Germani? O sui testi di Alcuino per capire Carlo Magno? Molto più credibile di Flavio è l'autore dei Maccabei, che pur non va esente da fantasticherie.
Se è opportuno usare il suddetto metodo, è sufficiente porre in relazione le versioni dei vangeli di Marco e Giovanni, che sono quelli fondamentali, tra loro in opposizione, salvo ovviamente le interpolazioni.
Gli evangelisti non solo non hanno voluto scrivere dei testi storici, ma hanno anche fatto in modo d'impedire agli storici di contestarli sotto il punto di vista dell'attendibilità dei fatti narrati, in quanto, come nel 1984 di Orwell, hanno avuto la possibilità di riscrivere la storia come pareva loro.
Se è così, allo storico non resta che smentire il Nuovo Testamento sul piano etico (quello dell'umanesimo laico) e politico (quello del socialismo democratico), cominciando a mostrare con vari ragionamenti (in cui si possono usare le stesse categorie cristiane ma con significati opposti), che il Cristo era ateo e democratico e comunista.
Cioè il limite epistemologico che occorre porsi è quello di trovare delle argomentazioni logiche che provino in che maniera nei fatti narrati dai vangeli è intervenuta una mano redazionale di tipo mistificante. Per contestare un'argomentazione mistica l'esegeta laico deve convincersi che ne basta un'altra di tipo realistico. Si lascerà poi decidere al lettore quale delle due è più convincente.
In ogni caso molto più importanti di Flavio sono i testi di Qumran, ancora non tutti pubblicati, perché da questi abbiamo capito con sicurezza che gli aspetti sacramentali del cristianesimo petro-paolino sono stati ereditati dal rapporto con gli esseni, quel rapporto che il Cristo, mentre operava in Giudea, aveva rifiutato allorquando fece la prima insurrezione a Gerusalemme, cacciando i mercanti dal Tempio e probabilmente mirando a rovesciare dal trono i sommi sacerdoti. Rifiutò l'essenismo del Battista perché troppo religioso, troppo legato ad aspetti giuridico-morali e incapace di fare vera politica.
Ancora più importante è però la rivisitazione del rapporto tra cristianesimo e fariseismo. Il cristianesimo infatti è un prodotto in cui l'elemento farisaico ha giocato un ruolo fondamentale. Al tempo di Gesù i farisei non erano un partito conservatore come i sadducei, ma ambiguo (la parte minoritaria era sicuramente democratica), anche se nei vangeli vengono presentati come ipocriti.
È dunque probabile che Gesù abbia cercato sino all'ultimo un'intesa coi farisei, che forse nell'ambito dei Dodici erano rappresentati da Giuda. L'intesa fu trovata dopo la sua morte, ma in chiave mistica, grazie a Paolo.
La descrizione che dei farisei vien fatta nei vangeli è infinitamente peggiore di quella che vien fatta dei sadducei, forse perché quest'ultimi venivano considerati dei nemici per antonomasia (da notare, peraltro, che, mentre i vangeli venivano redatti, i sadducei erano praticamente scomparsi di scena, eliminati come classe sociale nella guerra contro Roma). I farisei invece sopravvissero alla catastrofe del Tempio e presero a riorganizzare l'ebraismo a partire dalle sinagoghe e da nuovi testi di riferimento, ed è probabile che venissero visti dai cristiani come un tempo questi vedevano i sadducei, cioè nemici irriducibili.
Al tempo di Gesù i farisei erano un partito con cui il movimento nazareno si confrontava di continuo, ma non si può certo dire che si giunse a un'intesa politica con cui cacciare i sadducei dal Tempio e i Romani dalla Palestina, che pur entrambi i movimenti volevano. Purtroppo i farisei erano molto legati alle loro tradizioni giudaiche, per cui tendevano a sacrificare le esigenze politiche a quelle ideologiche. Non a caso i vangeli li bersagliano continuamente proprio su queste tradizioni, tralasciando ovviamente tutte le questioni più strettamente politiche, in quanto il Cristo che si raffigurano predica un regno per l'aldilà.
I principali comportamenti farisaici, oggetto di dura critica, sono i seguenti: scrupoloso (quasi ossessivo) rispetto del sabato (Mc 2,24; Gv 9,16); fanno abluzioni prima di mangiare (Mc 7,3.5), non mangiano mai coi pubblici peccatori (Mc 2,16) e praticano digiuni rigorosi (Mc 2,18); credono fermamente nella circoncisione e la pretendono anche quando una parte di loro diventa cristiana (At 15,5); sono favorevoli alla pena di morte (Gv 8,3) e anche al divorzio facile da parte dell'uomo (Mt 19,3); sono attaccati al denaro (Lc 16,14), però pagano la decima al Tempio (Mt 23,23) e il tributo ai Romani (Mc 12,14); comandano nelle sinagoghe e non vogliono che Gesù le frequenti (Gv 12,42), anzi minacciano di scomunica chi si dichiara apertamente suo discepolo (arrivano persino a tramare la sua morte, benché in Galilea lo mettano in guardia da Erode Antipa, che ha intenzione di arrestarlo); negano che gli uomini possano rimettere i peccati e, secondo loro, Gesù, che pretende di farlo, è un bestemmiatore (Lc 5,21); rifiutano il battesimo di Giovanni (Lc 7,30) e credono che il messia possa essere soltanto un giudeo figlio di Davide (Mt 22,42); per poter credere nella messianicità di Gesù chiedono un segno dal cielo (Mc 8,11), che però non avranno mai (in Gv 11,47 si lamentano invece che ne fa troppi); credono sia negli angeli e negli spiriti (At 23,8), al punto che attribuiscono a Belzebù il potere che Gesù ha di operare guarigioni ed esorcismi (Mt 12,24), sia nella resurrezione dei morti (At 23,6), con cui litigano coi materialisti sadducei, tant'è che uno di loro, Paolo di Tarso, una volta convertito all'idea petrina secondo cui Cristo era risorto, farà del movimento nazareno una sorta di neo-fariseismo cristianizzato.
1) Genealogie del Cristo
|
MATTEO |
LUCA |
|
Abramo |
Dio |
Mt 1,16 […] Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 17 La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.
Lc 3,23 Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli...
*
Ci si è sbizzarriti tanto, negli ultimi duemila anni, nel cercare di trovare le incongruenze o le assurdità nelle due genealogie del Cristo riportate in Matteo e Luca. E pensare che già Paolo scriveva al suo discepolo prediletto, Timoteo, di “non badare più a favole e a genealogie interminabili, che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede” (1Tm 1,4). Tanto più che già ai tempi di Erode il Grande e poi del romano Domiziano il potere fece di tutto per eliminare dalla Palestina tutte le genealogie che potessero far rivivere la dinastia davidica; anche se, nonostante questo, ancora nel 318 un certo Giosia (discendente diretto di Giuda, fratello di Gesù) riferì a papa Silvestro che la centralità della sede episcopale della Chiesa cristiana avrebbe dovuto essere trasferita da Roma a Gerusalemme (e lui si basava su una discendenza matrilineare, ritenendo evidentemente quella patrilineare del Cristo molto poco significativa).
Nel I e forse anche nel II secolo, i cristiani di origine ebraica (che alcuni definiscono col termine di Desposyni, cioè “coloro che [gli eredi] appartengono al Signore”) erano ancora stregati dal problema di come dimostrare il legame di sangue, di etnia, di “razza” che univa Gesù al proprio popolo. Non a caso la genealogia matteana (che conta 28 generazioni), presume addirittura di risalire all'origine “politica” del messia, mentre quella lucana (che conta 43 generazioni) è più impostata in chiave religiosa, risalendo direttamente a Dio: in comune hanno solo i nomi di Davide, Giuseppe e Gesù (persino sul nonno di Gesù non vi è unanimità: Giacobbe, secondo Matteo; Eli, secondo Luca). La genealogia lucana prevede in tutto 76 generazioni, di cui 56 da Abramo a Gesù, contro le 42 di Matteo.
Molti Padri della Chiesa han pensato che quella lucana sia in realtà la genealogia di Maria, che non poteva essere citata espressamente in quanto – aggiungiamo noi – Maria fu seguace di Giovanni Zebedeo, in ostilità a Pietro, o forse perché il cristianesimo petro-paolino, invece di proseguire sull'uguaglianza dei sessi, sostenuta da Gesù, preferì ereditare il maschilismo imperante nel giudaismo.
Ciò che appare strano è che dopo aver vaneggiato una fantastica “figliolanza divina” del Cristo, che doveva presumere una soteriologia universale, i cristiani si sono preoccupati, facendo un passo indietro, di ribadire la sua identità ebraica. In ogni caso, se tale operazione la si può in parte capire per il vangelo di Matteo, il cui autore, essendo stato un ebreo esattore per i Romani, odiato dagli ebrei contribuenti, poteva provare forme di risentimento, tant'è che nel suo vangelo risulta chiarissimo che il messia vuole superare il legalismo e il tradizionalismo giudaico salvando soltanto lo “spirito” dell'ebraismo; viceversa, una preoccupazione del genere pare davvero poco sensata in un vangelo “ellenistico” come quello di Luca, di cui non si riesce davvero a capire il motivo per cui egli si sia voluto cimentare in una ricostruzione, non meno fantasiosa di quella matteana, delle ascendenze del Cristo.
Probabilmente Luca ha subìto l'influsso di una tradizione ebraica legata al primato assoluto della religione sulla politica, una tradizione che ha trovato la sua espressione più prossima al cristianesimo nella corrente del Precursore. In altre parole la genealogia lucana è servita a legittimare la pretesa della corrente esseno-battista di rafforzare, in seno al cristianesimo, il nesso tra Cristo e religione ebraica. Vi è più misticismo in questa genealogia che non nell'altra. E questo senza considerare la probabilità che, data la parentela di sangue tra Elisabetta e Maria, la genealogia di quest'ultima avrebbe anche potuto vantare un maggiore lignaggio rispetto a quella di un oscuro carpentiere.
Forse questo spiega il motivo per cui nel vangelo di Luca la genealogia è posta all'interno dei racconti dedicati al Battista, subito dopo il brano dello pseudo-battesimo del Cristo. Le controversie tra le varie correnti presenti nel movimento nazareno, quando Gesù ne era leader, sembrano proseguire, su basi ideali completamente diverse, anche dopo la sua morte. Può darsi dunque che mentre quella matteana indichi una sorta di compromesso mistico-politico tra fariseismo e cristianesimo, quella lucana rappresenti un compromesso mistico-etico tra battismo e cristianesimo.
Le due genealogie, che si devono quindi intendere di origine ebraica, non sembrano aiutare granché a comprendere la specifica messianicità politica del Cristo, in quanto, in quella matteana Gesù non è che un nuovo Mosè o un novello Davide, mentre in quella lucana non si comprende affatto come il “figlio di Dio” possa redimere l'umanità mostrando i propri legami etnico-tribali.
È curioso come mentre nel vangelo di Marco, privo di qualsivoglia genealogia, si dia per scontato che Gesù fosse originario della Galilea (Nazareth), in quelli di Luca e Matteo si dà invece per scontato che la sua origine fosse giudaica, essendo nato a Betlemme, e relativa alla stirpe di Davide (cosa di cui anche il quarto vangelo sembra essere convinto, pur senza citare il riferimento leggendario del messia alla Betlemme davidica). E tuttavia, mentre in Marco non si parla affatto di “gestazione verginale”, “divina” del Cristo, viceversa Matteo e Luca riportano racconti mitologici sulla nascita del “bambino Gesù” per opera dello Spirito santo (partenogenesi della Vergine), anche se proprio nelle loro genealogie si dice espressamente che Gesù era “figlio di Giuseppe”, il che, a sua volta, ingarbuglia ancora più la situazione, poiché, se non ne fu “figlio” (Luca scrive che “si credeva” fosse suo figlio), a che pro riportare tutta la genealogia di Giuseppe? Non sarebbe stato meglio riportare solo quella di Maria, magari in polemica con quelle maschiliste della tradizione giudaica?
È indubbio che, ad un certo punto, non molto lontano dalla prima stesura dei vangeli, si formò la convinzione che un Gesù “risorto” non potesse essere figlio di Giuseppe. La versione matteana, in tal senso, sembra sia stata scritta proprio per contestare chi sosteneva il contrario. Egli infatti usa per tutti gli antenati la formula “Abramo generò… Davide generò…”, ma interrompe il ritornello alla comparsa di Giuseppe, volendo evitare di attribuire a quest'ultimo la generazione di Gesù: “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo”.
I redattori cristiani dovevano difendersi anche dall'accusa giudaica secondo cui il Cristo, non essendo sicuro il padre, andava considerato come frutto di fornicazione (vedi gli Atti di Pilato). Nella tradizione rabbinica il Cristo viene chiamato “Ben Panthera”, ossia figlio del centurione romano Tiberio Giulio Abdeo, detto Pantera (un nome che si ritrova nelle iscrizioni di alcuni soldati romani in Palestina). Questo può spiegare l'esigenza d'inventarsi degli antenati “regolamentari”. In ogni caso Matteo non voleva tanto far rilevare una filiazione di Gesù con le grandi figure del passato ebraico sulla base di legami di parentela, quanto piuttosto fondare la legittimità di lui in funzione del ministero messianico.
Ma gli esegeti non si sono fermati qui. Si è notato, p.es., che, tenuto conto che Ieconia, padre di Salatiel, è il re che venne preso prigioniero durante la deportazione in Babilonia, la somma delle generazioni da Salatiel a Gesù compreso non è pari a 14, come dice Matteo, ma a 13. Non solo, ma tra Salatiel e Gesù, essendo passati circa 600 anni, non può esservi stato un numero di generazioni di 13 o 14: Luca sembra essersi accorto della discrepanza e porta il numero a 22.
Matteo segue le genealogie riportate nel libro delle Cronache fino al nome di Zorobabele. Tuttavia, a partire da questo governatore giudaico, di cui l'Antico Testamento non riporta alcuna discendenza, egli procede in maniera arbitraria. Di fatto egli ha omesso ben cinque generazioni (Acazia, Ioas ed Amazia tra Ieoram ed Uzzia; Ioiachim tra Giosia e Ieconia, e Pedaia tra Sealtiel e Zorobabele).
Inoltre Matteo nomina Abiud come uno dei figli di Zorobabele, il quale però non compare nella genealogia presentata da Ezdra; include i nomi di quattro donne che non rendono “regale” una dinastia ebraica, in quanto tre di loro erano pagane: Tamar (si travestì da prostituta per andare a letto con il suocero, dopo essere stata rifiutata dal cognato Onan), Raab (fu tenutaria di un bordello), Rut (sedusse astutamente un ricco ebreo), mentre Betsabea (colpevole d'adulterio con Davide) era sposata con un gentile (Uria l'hittita, fatto uccidere da Davide, invaghitosi di lei).
Infine Matteo nomina Ieconia, contro cui Geremia (22,30) aveva profetizzato che dalla sua discendenza non sarebbe mai nato alcun messia d'Israele.
Stranamente la genealogia lucana rispetta meglio i parametri ebraici, non omettendo nomi né nominando le donne (anche se la menzione di donne in una genealogia giudaica patriarcale non era eccezionale); tuttavia, c'è un Cainan in più, tra Arfacsad e Sela, che non corrisponde alle Scritture.
Sia come sia a noi pare da escludere a priori che la tesi cristiana relativa alla partenogenesi possa dimostrare qualcosa come “l'esistenza di Dio” o come “l'origine divina del Cristo”: scriverci sopra delle false genealogie per contestare chi negava questa tesi è stata un'operazione di basso livello.
Addendum
Diamo per scontato che Matteo scriva prima di Luca e che quindi non possa leggerlo. Supponiamo che esista una fonte Q ad essi indipendente. Il primo che la legge è Matteo. Supponiamo che trovi scritta la genealogia, visto che Marco non la riporta. La copia uguale, in quanto, essendo quella genealogia di origine giudaica, egli non ha alcuna difficoltà ad accettarla. In essa viene riflessa l'esigenza di mostrare una discendenza davidica del Cristo, per poterlo qualificare come vero messia.
Poi viene Luca. Ch'egli legga Matteo o la fonte Q diventa, a questo punto, indifferente. Tuttavia viene inevitabile porsi una domanda: chi ha autorizzato Luca a scrivere una genealogia quasi completamente diversa? Come può pretendere d'essere accettato quando la genealogia di origine giudaica era già presente in due fonti diverse, entrambe autorevoli? Ha potuto farlo solo perché Paolo di Tarso, di cui Luca era discepolo, aveva dichiarato di non tenere in alcun conto le genealogie? Ma se è così, perché Luca non vi ha rinunciato del tutto? Perché ha avvertito il bisogno di scriverne una per proprio conto?
A tali domande, secondo noi, si può rispondere solo in una maniera: l'unica vera genealogia esistente, quella di origine giudaica, era stata scritta dal Matteo aramaico, che diventò fonte per Luca quando lo si tradusse in greco. Probabilmente Luca si pose lo stesso problema di Marco, che doveva conoscere il Matteo aramaico: o la si elimina del tutto (come appunto aveva fatto Marco), oppure la si riscrive, conformemente alle esigenze di un'utenza di origine pagana, la quale, a livello di ceti alti, non era meno interessata a questo argomento. Attenzione però che anche l'utenza di Marco era di origine pagana, eppure lui ha ritenuto, a motivo del proprio antigiudaismo, che non fosse indispensabile riportarla (probabilmente anche perché la sua utenza era di livello più basso). Dunque per quale motivo Luca si è comportato diversamente? Anch'egli era fortemente antigiudaico.
Ora però la domanda diventa un'altra: quale fonte può aver indotto Luca a riscrivere una genealogia così diversa da quella matteana? Ed ecco la risposta: come Matteo aveva elaborato una genealogia basata sul padre di Gesù, così Luca pensa di elaborarne una basata sulla madre di Gesù, facendola risalire addirittura ad Adamo, progenitore di tutta l'umanità, non solo degli ebrei.
Era vera? Era falsa? Era semplicemente diversa. Ma da dove l'aveva presa? Molto probabilmente a Efeso, dalla tradizione giovannea, cui la madre di Gesù (odiata nel protovangelo) faceva riferimento (Gv 19,25 ss.). Maria quindi aveva una propria genealogia? Sì, esattamente come Giuseppe. Tra famiglie benestanti era normale. Era un titolo di merito, che permetteva matrimoni combinati.
Ma perché Luca non ha detto esplicitamente che la propria ricostruzione genealogica era quella di Maria?1 Non l'ha fatto semplicemente perché Maria costituiva un ostacolo alla teologia petro-paolina. La figura di Maria è stata recuperata tardivamente e non è da escludere che molte parti lucane che la riguardano siano state inserite successivamente. In ogni caso si è deciso di modificare la genealogia lucana cambiando l'ultimo nome, che da Maria è diventato Giuseppe.
Certo, i teologi si son chiesti come fosse possibile che persino sul nome del nonno di Gesù vi fosse netto contrasto: in una è scritto Giacomo, nell'altra Eli. In realtà non c'è alcun contrasto, poiché si tratta di un nonno paterno e di uno materno. Se poi si vuole sostenere che la sostituzione del nome di Maria con quello di Giuseppe è stata fatta perché il giudaismo post-pasquale è tornato ad affermare l'imperante maschilismo della propria tradizione, contro l'uguaglianza di genere predicata dal Cristo, la conclusione non cambia. Per un'esegeta l'importante è affermare che la fonte Q non esiste, essendo parte del Matteo aramaico, e che Luca si è servito di una fonte che Matteo non conosceva, quella appunto mariana connessa a quella giovannea.
(torna su)2) La questione della nascita di Cristo
Parlare delle assurdità descritte nei racconti evangelici cosiddetti “natalizi” (di Matteo e di Luca), oggi sarebbe come sparare sulla Croce rossa. 2 Proviamo invece a fare un discorso opposto, cioè partiamo dalla supposizione che nei suddetti racconti – che sono indubbiamente carichi di miti e leggende – vi sia un fondo di verità, più o meno umanamente accettabile. Che cosa se ne potrebbe ricavare di ancora utile per il presente?
Anzitutto dovremmo supporre un'ipotesi in sé indimostrabile, e cioè che Maria abbia sperimentato nei confronti della maternità un fenomeno che se in natura esiste e che la scienza chiama col temine di “partenogenesi”, mai nessuno scienziato ha pensato di riferirlo anche alla specie umana (qui al massimo si parla di “gravidanza isterica”).
Con ciò naturalmente non si vuol sostenere che un fenomeno è “vero” solo dopo che l'ha verificato la scienza, ma è non meno indubbio che i fenomeni per noi sono veri solo quando la scienza (o comunque una prassi o una tradizione consolidata) li può controllare, altrimenti la loro verità si riduce a questione di mera “fede” e nessuno può vivere di sola fide, laica o religiosa che sia.
Quand'anche dicessimo che la ragione non può mai arrivare a delle “verità assolute”, dovremmo pur sempre ammettere l'esistenza di “verità relative”, momentaneamente oggettive, che ci permettono di guardare avanti con una certa sicurezza.
Ora, se diamo per buona l'ipotesi della partenogenesi nel caso di Maria, dobbiamo altresì ammettere che l'unica persona dei vangeli che sia stata capace di verificarla non può che essere stata la stessa Maria. Qui però non si può assolutamente sostenere che quanto era considerato “irrazionale” per la collettività, fosse diventato “razionale” per lei. Se Maria ha sperimentato una cosa del genere, la prima a non spiegarsene la ragione dev'essere stata proprio lei.
D'altra parte lei era anche la sola in condizioni tali da poter mostrare che il fenomeno si era verificato proprio così e non in un altro modo. Ma dimostrare una cosa del genere, dal punto di vista della ragione (e non delle fantasie mitologiche), sarebbe stato praticamente impossibile. La verità, per essere creduta, ha bisogno di una certa abitudine ai fatti: è questo che permette di calcolare le sue probabilità effettive.
Affinché l'adolescente Maria non rischiasse d'essere messa al bando nel momento in cui Giuseppe aveva scoperto ch'era rimasta incinta prima ancora che il matrimonio venisse ratificato e soprattutto prima ancora che lui si congiungesse con lei, era evidentemente necessario ch'essa fosse già sposata con Giuseppe (o almeno fidanzata).
Ma perché Maria fosse sicura al cento per cento che nel suo caso si trattava veramente di partenogenesi, era altresì necessario che il matrimonio non fosse stato ancora consumato.
Delle due quindi l'una: o tutto il racconto è una fantasia elaborata da cristiani che si sono lasciati influenzare dalle religioni pagane, oppure Maria è rimasta incinta quand'era fidanzata con Giuseppe, senza che con lui avesse avuto alcun rapporto sessuale.
Supponiamo vera la seconda ipotesi. Appare evidente che quando Maria s'è trovata incinta, ha potuto non raccontare nulla a Giuseppe, che sicuramente non l'avrebbe capita, appunto perché lo sposò subito dopo. Su questo però i vangeli dicono il contrario, e cioè che lei fu costretta ad avvisare Giuseppe, il quale, pur con molta riluttanza, decise di non esporre Maria al pubblico disprezzo.
D'altra parte Giuseppe può aver verificato personalmente che Maria, pur essendo incinta, era ancora vergine. Giuseppe può aver accettato la stranezza del suo primogenito a condizione di poter fare altri figli, sulla legittimità dei quali non avrebbe nutrito alcun dubbio.
In questo senso è difficile pensare a una moglie che, per difendere la propria illibatezza, si oppone strenuamente alla volontà del marito (che l'aveva appena salvata dall'ignominia). Stando ai vangeli i due sposi ebbero almeno altri sei figli. Il che, per una famiglia ebraica di allora, era del tutto normale.
Maria può aver raccontato la nascita verginale di Gesù solo dopo la morte di lui o solo prima della sua stessa morte. Fino a quel momento l'unico che poteva essere a conoscenza di qualcosa era stato Giuseppe, di cui però non sappiamo quasi nulla dai vangeli. Nel momento in cui Gesù inizia a predicare, egli era già scomparso.
*
Ora facciamo delle considerazioni più laiche. Sappiamo che il protovangelo (da cui dipendono gli altri due sinottici) non è solo antisemitico ma anche antigiudaico, per cui era nell'interesse del suo autore originario (Pietro-Marco) far credere che Cristo fosse galileo, tant'è che si conclude dicendo che il Cristo risorto li avrebbe “preceduti in Galilea” (Mc 16,7), come se si volesse abbandonare la Giudea al suo destino. Di questo andava data notizia ai discepoli e a Pietro in particolare, come se Pietro avesse qui bisogno di una precisazione ad hoc, che mettesse in rilievo il suo ruolo egemonico nell'ambito degli apostoli. Il che può anche portarci a credere che la teologia petrina abbia rimosso dal IV vangelo l'origine giudaica del Cristo, che però tra le righe riusciamo lo stesso a intravedere. Sin dall'inizio infatti, quando Gesù chiede ad Andrea e Giovanni di lasciar perdere il Battista, questi gli dicono: “Dove abiti?” (Gv 1,38). E lui li accompagnò a casa sua, ch'era in Giudea. Infatti Giovanni aggiunge, apparentemente senza alcun senso pregnante: “erano le quattro del pomeriggio”. Quindi il luogo in cui Gesù li ospita non doveva essere molto lontano da dove il Battista predicava. Lo stesso Battista, suo cugino, era giudeo (così come i suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta): perché mai si dovrebbe pensare che Gesù non lo fosse? Dopo l'epurazione del Tempio (compiuta all'inizio della carriera politica di Gesù, quando certamente non aveva una grande notorietà fuori della Giudea, ma che l'acquisì subito in Galilea proprio in forza di quel gesto) egli incontra Nicodemo, che gli dice: “Sappiamo (noi farisei) che sei un maestro venuto da Dio” (Gv 3,2). In quel momento, secondo Giovanni, non aveva ancora messo piede in Galilea, ma era già ben noto in Giudea, tant'è che Nicodemo aggiunge: “Nessuno può fare i tuoi segni se Dio non è con lui”. Quali “segni” non si sa, poiché qualcuno deve averli tolti dal vangelo, ma dovevano essere politici, non miracolistici, altrimenti li avrebbero lasciati. Poi va in Samaria per non essere inseguito da nessun giudeo, cioè per non far sapere dove si sarebbe rifugiato. Qui nessuno lo conosceva: la Samaria era terra di “eretici”, secondo i giudei, che non la frequentavano minimamente. Incontra la samaritana al pozzo di Giacobbe, che gli chiede subito: “Tu che sei giudeo vieni a chiedere da bere a me che sono samaritana?” (Gv 4,9). Da cosa aveva capito ch'era giudeo? Dalla parlata, che certamente non era quella, più rozza, dei galilei.
Restiamo ancora su Giovanni. Nel v. 1,46 Filippo dice a Natanaele: Abbiamo trovato il messia, è “il figlio di Giuseppe di Nazaret”. Ad un giudeo come Natanaele cosa poteva importare che Gesù fosse figlio di un galileo? Di sicuro non poteva saper nulla di questo Giuseppe, che di mestiere faceva il carpentiere. In ogni caso quella frase poteva tranquillamente riferirsi alla provenienza galilaica di Giuseppe, non necessariamente anche a quella di Gesù. Peraltro di Giuseppe noi non sappiamo nulla, mentre di Maria, sua moglie, sappiamo di sicuro ch'era giudea, essendo imparentata con Elisabetta, che col marito viveva in Giudea. Avendo entrambe un parentado illustre, che cosa mai avrebbe potuto fare Maria a Nazareth, un paesucolo del tutto insignificante della Galilea (non citato in alcuna fonte storica prima del III sec.)? Si erano trasferiti lì per la vergogna d'essere rimasta incinta prima ancora d'essersi sposata?
Inoltre quella frase: “Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?” (Gv 1,46), viene detta da uno che si chiama Natanaele, di cui non si sa proprio nulla (qualche esegeta confessionale lo identifica con Bartolomeo), e il cui dialogo con Gesù è chiaramente inventato perché completamente mistico.
Di nuovo, sempre nel IV vangelo, quando alcuni giudei si chiedono: “Il Cristo viene forse dalla Galilea?” (7,41), stanno già riferendosi a uno che aspira al ruolo di leader politico, un ruolo che ha maturato nell'esilio della Galilea. Ma poco prima, in 7,27, avevano detto con sicurezza: “Costui sappiamo di dov'è”, facendo così capire che lo conoscevano benissimo. Lo dicono a Gerusalemme, dopo che per un certo tempo non l'avevano più visto perché emigrato in Galilea.
(torna su)3) Lo sposo e la discussione sul digiuno
Mc 2,18-22
v. 18a) Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno.
Nel vangelo di Marco non appare in alcun luogo la rivalità esistente tra battisti e farisei. Viceversa, nel vangelo di Giovanni (4,1 ss.) tale rivalità, almeno fino a quando Giovanni il Precursore è stato il leader riconosciuto del movimento battista, appare come un dato acquisito. I battisti vengono presentati dall'apostolo Giovanni (1,26) come più “radicali” dei farisei: oggi diremmo come un movimento politico che non accetta la sola battaglia parlamentare.
A differenza dei farisei, i battisti, sulla scia delle migliori tradizioni profetiche post-esiliche, cercavano un rapporto con le masse, sempre nell'ambito delle leggi ebraiche vigenti, al fine di costruire una sorta di “socialismo legale”. Di qui il loro carattere utopico.
I farisei invece volevano una liberazione d'Israele dall'invasore straniero che partisse da un mutamento degli equilibri politico-istituzionali e non tanto da un confronto diretto con le istanze popolari, di cui temevano la radicalità, anche se grazie a loro s'era sviluppato il movimento sinagogale (e sarà sempre grazie a loro se l'ebraismo potrà sopravvivere dopo l'ultima guerra giudaica anti-romana). I farisei pensavano d'aver come principale problema da risolvere quello di come sostituirsi al potere conservatore dei sadducei nella guida della nazione, in vista di un'insurrezione anti-romana che salvaguardasse tutte le istituzioni e le tradizioni del giudaismo. Di qui la loro posizione politicamente moderata e socialmente regressiva.
Il fatto che in questo racconto di Marco i due gruppi rivali si trovino alleati contro i nazareni è indicativo dei limiti politici che li caratterizzano. Ovviamente dobbiamo pensare che l'avvicinamento, sul piano etico e politico, fra i due gruppi sia stato successivo alla morte del Battista.
Il digiuno in questione non era quello ufficiale e generale osservato da tutto il popolo, nel giorno dell'espiazione (Lv 16,29), ma era una scelta facoltativa, un atto supplementare, praticato ogni settimana, in segno di penitenza e contrizione per i difficili tempi d'Israele (e quindi non era meramente “privato”, altrimenti la controversia qui in oggetto non avrebbe avuto senso).
v. 18b) Si recarono allora da Gesù e gli dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?”.
Il soggetto di questa domanda è ambiguo: apparentemente sembra si tratti di un gruppo misto di farisei e battisti, ma nulla vieta di pensare che si tratti degli stessi scribi del racconto precedente. A volte peraltro Marco si serve di scribi e farisei come interlocutori negativi, per nascondere l'identità di un discepolo dello stesso Cristo.
Qui comunque l'oppositore che si cela dietro il “si” impersonale, si preoccupa di criticare il Cristo su di un fatto che, da un punto di vista etico (e indirettamente politico), viene ritenuto piuttosto grave, e cioè che in tempi così drammatici per la coscienza storica d'Israele, egli, coi suoi discepoli, non si vergogna di mangiare lautamente in grandi conviti, e per giunta in compagnia di “pubblicani e peccatori” – come Marco aveva già detto nel racconto precedente (2,15).
La differenza tra gli scribi del racconto della chiamata del pubblicano Levi, e questi rivali dei nazareni non è di sostanza ma di forma: i primi infatti si chiedevano perché Gesù mangiasse con degli individui ex-lege, se non addirittura “collaborazionisti” con Roma; i secondi si chiedono, ancora più radicalmente, perché Gesù e i suoi discepoli “mangino” e non accettino la pratica del digiuno supplementare.
Nella precedente polemica Gesù aveva dovuto dimostrare che per liberare Israele dai Romani occorreva l'aiuto di tutta la popolazione; ora deve dimostrare che la pratica del digiuno non è sufficiente per liberare la nazione.
Il senso dell'obiezione cui deve rispondere è il seguente: se i farisei e i battisti sono notoriamente apprezzati per il loro valore etico-politico, perché i nazareni non li imitano? Ovvero: se i nazareni si considerano migliori, perché non cominciano a dare il buon esempio digiunando? Per chi s'impegna in maniera pubblica, un digiuno facoltativo non va forse considerato moralmente obbligatorio?
Si noti la diversità delle contestazioni: nel banchetto in casa Levi il rilievo critico era di tipo gius-politico: non è possibile liberare Israele frequentando i trasgressori della legge ebraica e i traditori (Levi-Matteo era un esattore delle tasse al servizio di Roma); qui invece il rilievo è di tipo etico-politico: non è possibile liberare Israele se il soggetto rivoluzionario non si sottopone, preventivamente, a un'ascesi di tipo spirituale.
Queste due obiezioni appaiono come complementari: l'ascesi morale fa da pendant all'incapacità di rapportarsi alle masse, in quanto si fa del digiuno un motivo di distinzione e di discriminazione, non di dialogo e di confronto. Il legalismo come prassi politica e l'aristocraticismo come prassi etica, sono gli elementi principali con cui si cerca di contestare la posizione giudicata “eterodossa” dei nazareni.
v. 19) Gesù disse loro: “Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare”.
La risposta è ambigua, almeno apparentemente, ed è difficile sapere se il Cristo sia stato costretto a usare una metafora per motivi diplomatici, cioè per non perdere l'appoggio di movimenti importanti come quelli farisaico e battista; o se invece sia stato lo stesso Marco (o comunque l'autore di questo racconto) a confondere le acque per non palesare il contenuto esplicitamente politico della risposta del Cristo.
Chi è lo sposo? Lo sposo è il messia, cioè Gesù, che ha coscienza di esserlo. Cosa rappresentano le nozze? La possibilità della liberazione. Dunque perché digiunare quando la possibilità di questa liberazione diventa realtà?
La risposta di Gesù è una critica della tattica attendista. La liberazione non viene dall'alto, ma va preparata e, una volta preparata (con spirito di sacrificio, abnegazione ecc.), va fatta. Se si continua a digiunare, sarà impossibile riconoscere il leader che guiderà la rivoluzione. Questo il senso della sua risposta.
Il Cristo non si oppone tanto al legalismo, cioè al rispetto scrupoloso della legge, né all'ascesi morale di chi si prepara alla liberazione, ma fa semplicemente notare che questi sono aspetti propedeutici alla prassi rivoluzionaria vera e propria, che per realizzarsi esige maggiore flessibilità nel giudizio e maggiore coinvolgimento nell'azione. Chi continua a “digiunare” quando i tempi sono diventati “maturi” per il passo successivo, regredisce verso posizioni conservatrici.
v. 20) “Ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno”.
Questa frase è stata chiaramente aggiunta dalla Chiesa primitiva, la quale, con la consapevolezza post-pasquale, sa che il messia-Gesù non morirà di morte naturale, ma “verrà tolto” ai suoi discepoli con la violenza.
Ribadendo qui il valore del digiuno, come conseguenza necessaria alla morte cruenta del messia, detta Chiesa cade nello stesso errore di valutazione sui tempi rivoluzionari che già avevano fatto scribi, farisei e battisti. Invece di sostenere l'idea che, nonostante la morte violenta del messia, il progetto di liberazione andava comunque portato avanti, poiché la sua realizzazione non poteva dipendere dalla volontà di una persona singola, per quanto eccezionale essa fosse, la Chiesa preferisce qui avvalorare l'opinione di chi ha sfiducia nelle capacità umane di liberazione.
Per queste ragioni è assolutamente da escludere sia che il Cristo avesse prospettato ai suoi discepoli una propria morte violenta in tempi brevi, sia che essi, nell'eventualità che ciò fosse accaduto, dovessero rinunciare a qualsiasi istanza rivoluzionaria. È stata la Chiesa primitiva a interpretare la congiunzione temporale “finché” nel senso di una premonizione circa la breve durata della presenza storica del messia Gesù.
In realtà con l'uso della metafora delle nozze dello sposo, il Cristo voleva togliere alla liberazione d'Israele il contenuto eminentemente religioso che aveva nella mentalità ebraica più tradizionale, secondo cui lo sposo escatologico della nazione altri non poteva essere che “Dio” (cfr Is 54,5; Os 2,19).
In tal senso si può dire che Gesù, con quella metafora, si ricollega esplicitamente alla posizione del Battista, il quale si considerava non come lo sposo-messia in grado di sposare-liberare la sposa-Israele (Gv 3,29), ma semplicemente come l'amico dello sposo, che deve “diminuire” perché l'altro “aumenti” (Gv 3,30).
L'immagine dello sposo innamorato del suo popolo, che restaura la nuova Gerusalemme, la si ritrova anche nell'Apocalisse (21,2), in chiave escatologica, dopo aver preventivamente trasformato il Cristo in una divinità.
vv. 21-22) “Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi”.
Il rischio maggiore del battesimo di penitenza era quello di fermarsi al momento dell'autocritica, cioè era quello di considerare inattuale la rivoluzione col pretesto che la fase dell'autocritica non era ancora terminata. Questo nel migliore dei casi. Infatti, in quello peggiore si riteneva impossibile la rivoluzione in quanto si giudicava negativamente la coscienza rivoluzionaria del popolo.
Nello stesso rischio cadevano i farisei, per i quali il digiuno diventava – agli occhi dei nazareni – una toppa di panno grezzo su un movimento vestito male, cosciente sì della necessità di una rivoluzione, ma incapace di realizzarla. Si può forse versare il vino della speranza autentica negli otri della coscienza inadeguata del vecchio giudaismo?
Qui il Cristo evidenzia la contraddizione fra essere e dover essere, fra desiderio e realtà. E anticipa anche l'esito di questa antinomia: se essa non viene risolta, la coscienza si frantuma, si autodistrugge, poiché non può a lungo sopportare un'istanza insoddisfatta, e in tal modo perde tutto, anche quello che poteva sembrare positivo.
Durante il pasto coi pubblicani in casa Levi, il Cristo si era definito come “medico” che recupera e reintegra i reietti della società, quelli espulsi dalle sinagoghe, quelli privati dei diritti civili e religiosi; ora si definisce come “sposo”, cioè come messia che offre a tutto il popolo la possibilità di un riscatto generale. Chi meno lo comprende sono proprio le persone più impegnate sul fronte etico-politico.
(torna su)4) Le spighe strappate di sabato
Mc 2,23-28
[23] In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe.
Quest'immagine innocente, dal sapore vagamente poetico, contiene un messaggio profondamente innovativo per il giudaismo di allora. Lo si comprende dalla scelta del giorno, che non è certamente casuale. Di sabato gli ebrei erano soliti riunirsi in assemblea all'interno della sinagoga, oppure quelli di Gerusalemme si recavano al Tempio.
Qui, il fatto che il Cristo non frequenti le sinagoghe ebraiche (anche perché raramente si tollerava la sua presenza) è indicativo non solo dello scarso interesse che il movimento nazareno nutriva per le questioni di carattere religioso, ma anche di quale profondo fossato si fosse scavato tra il suo vangelo di liberazione e quello degli altri gruppi politico-religiosi più o meno ligi alle tradizioni.
Già dal primo versetto si ha insomma l'impressione che il redattore abbia voluto indicare quanto la libertà presa dal Cristo di frequentare in un giorno legato al culto un luogo generico (il campo di grano) in sostituzione del luogo specifico, preposto a quel particolare giorno (la sinagoga), fosse una diretta conseguenza del suo progressivo e motivato rifiuto delle istituzioni religiose del giudaismo, ovvero una diretta conseguenza di una posizione etica e politica sempre più prossima all'umanesimo integrale. In altre parole la pericope è stata elaborata per evidenziare che il Cristo poteva tranquillamente rinunciare a frequentare le sinagoghe e a vagabondare coi suoi discepoli nei campi di grano, che tanto nulla si sarebbe potuto togliere al valore etico-politico del suo messaggio di liberazione, proprio perché l'ideologia del sabato e il luogo di culto in cui la si giustificava avevano fatto il loro tempo.
Gli ebrei, come noto, onoravano il sabato col riposo assoluto, astenendosi dal compiere qualunque lavoro, affare quotidiano e persino faccenda domestica. Rinunciando all'idea di interesse e di contrattazione e persino di soddisfazione del bisogno, quando non fosse questione di vita o di morte, essi erano convinti di potersi in tal modo sottrarre alle “tentazioni del mondo” e quindi di poter vivere, almeno un giorno alla settimana, in una condizione molto vicina allo stato di innocenza e di beatitudine. Ovviamente non era la condizione di ozio che garantiva la purezza d'intenti, bensì le espressioni religiose e cultuali previste per questo giorno specifico.
Il Cristo invece, optando per il campo di grano in luogo della sinagoga, in apparenza sembra preferire all'impegno religioso il proprio individualismo. Ma se fosse così il contenuto della pericope sarebbe stato assai poco significativo.
Il fatto di passare tra i campi di grano in un giorno che per la mentalità dominante si dovrebbe dedicare a Dio, può far pensare ch'egli volesse ridurre il sabato a un giorno qualunque, cioè ch'egli volesse spezzare l'immagine idilliaca di questo giorno festivo, riducendolo a giorno feriale, in cui sono lecite molte più cose.
[24] I farisei gli dissero: “Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?”.
La gretta casistica farisaica aveva associato al divieto di mietere in giorno di sabato anche quello di sgranellare e di spigolare. Con queste restrizioni sempre più minuziose, scribi e farisei non miravano solo a garantire un'equivalenza di precettistica e liberazione, ovvero la proporzione tra condizione d'innocenza e aumento dei divieti, ma anche ad assicurarsi un certo controllo politico delle masse. La disobbedienza era pagata con l'espulsione dalle sinagoghe e con l'emarginazione dalla vita pubblica.
In questa assurda concezione di vita e nella stessa ideologia del sabato avevano smesso di credere da tempo molti Galilei, specie da quando al legalismo farisaico si era dovuto aggiungere il peso dell'imperialismo romano. Qui infatti sono gli stessi apostoli che si assumono in prima persona la responsabilità di violare il sabato.
I farisei, come se osservassero Gesù continuamente, non riescono a comprendere le ragioni vere della contrapposizione tra campo di grano e sinagoga, e gli pongono una domanda imbarazzante. Nei due episodi precedenti: “Pasto coi pubblicani” (Mc 2,15 ss.) e “Discussione sul digiuno” (Mc 2,18 ss.), i farisei avevano già duramente criticato i nazareni di lassismo e immoralità; ora l'accusa diventa più pesante: violazione della legge, che qui peraltro non è che l'interpretazione dominante della legge mosaica, la quale, invero, s'era limitata a un semplice enunciato di principio.
I farisei in sostanza pensano che la riduzione del sabato a giorno comune sia in realtà finalizzata a mettere in luce le contraddizioni del popolo, la sua logica di vita: negativa nei giorni feriali, dominati dalle “passioni”, dai “vizi” tipici delle società antagonistiche, e ipocrita nel giorno festivo, in cui si simula, con una maschera “buonista”, una purezza interiore che nella quotidianità non esiste.
In realtà la critica dell'ideologia del sabato, della sua mitologia o, se si vuole, del suo feticismo, non voleva essere meramente distruttiva, neppure a livello redazionale. È vero, esisteva un forte dualismo tra i giorni feriali, sottoposti alla logica dell'egoismo personale, e il giorno festivo, in cui ci si sforzava di essere o soltanto di apparire diversi dal solito. Ma questo dualismo non poteva essere risolto (e di ciò era ben consapevole anche la comunità post-pasquale, che pur ha tradito il messaggio del Cristo) dimostrando che anche di sabato, nella realtà, si deve esattamente vivere come negli altri giorni. In tale maniera si sarebbe legittimata, in maniera semplicistica, anzi di comodo, la logica negativa della vita anche per questo giorno.
Andava invece data una risposta convincente alla crisi del primato idolatrico del sabato, superando una volta per tutte il formalismo deteriore del tardo giudaismo. Occorreva indurre gli uomini a credere possibile un'esistenza in cui la motivazione sottesa al rispetto del sabato potesse essere estesa a tutti gli altri giorni. Di fronte alle seduzioni di questo mondo, la richiesta era quella di vivere una coerenza di valori che andasse al di là dell'alternanza di lavoro e riposo.
[25]
Ma egli rispose loro: “Non avete mai letto che cosa fece Davide
quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi
compagni?
[26] Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo
sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani dell'offerta, che
soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai
suoi compagni?”.
È strana la scelta di questo brano che, come vedremo, s'innesta a fatica nel contesto della pericope. Se il Cristo si fosse limitato ad affermare la superiorità dell'uomo sul sabato, il racconto non avrebbe perso di sostanza. Il riferimento veterotestamentario, non aggiungendo nulla di particolarmente significativo, può essere accettato solo nella sua valenza pedagogica di propedeutica a un'interazione tra nazareni e farisei, che si presentava da subito abbastanza difficoltosa.
Peraltro vi sono varie inesattezze che fanno pensare a un'aggiunta redazionale posticcia. Davide infatti “si trovò nel bisogno” non tanto perché aveva fame, come i discepoli nazareni nel campo di grano, quanto perché era inseguito da Saul, che voleva ucciderlo. Non “entrò nella casa di Dio”, cioè nel santuario, ma si fece consegnare i pani dal sacerdote, standosene fuori. Il sacerdote non era “Abiatàr” ma suo padre Achimelec, il quale, proprio per aver prestato aiuto a Davide, venne fatto uccidere da Saul. I “pani dell'offerta” erano quelli consacrati a Dio, che solo il sacerdote poteva mangiare; anche i compagni di Davide ne poterono mangiare, a condizione che si astenessero da contatti con donne. In seguito il fatto fu perdonato a Davide, benché egli avesse commesso una colpa molto grave riguardo alle leggi del culto. Che questo episodio sia accaduto di sabato non viene specificato in 1Sam 21,2-7.
Ora, è evidente che il redattore della pericope marciana ha voluto fare una sorta di parallelismo tra due modi, vetero e neotestamentario, di porre la coscienza al disopra della legge. Tuttavia il confronto non regge, né sul piano giuridico né su quello morale. Davide e i suoi compagni violarono sì una legge fondamentale del culto, ma perché erano pressati dalla necessità di sfuggire a una morte certa. La legge cioè non fu violata con la consapevolezza della sua inutilità ai fini di un ideale politico di liberazione nazionale. La trasgressione, agli occhi di Davide, restava un'eccezione che non intaccava minimamente il valore delle istituzioni dominanti.
Guardando le cose con gli occhi dell'avvocato, i farisei non avrebbero potuto in alcuna maniera giustificare il gesto degli apostoli, neppure avendo in mente l'eccezione costituita dall'episodio di Davide. Si poteva forse parlare di un'esigenza di vita dettata dalla fame? Gli apostoli erano forse inseguiti da qualcuno che volesse ucciderli? Ogni tentativo di spiegare determinate azioni neotestamentarie prendendo degli esempi veterotestamentari è destinato a fallire sul nascere.
Infatti il gesto di “spigolare” andava interpretato in maniera politica e non giuridica. Nella pericope marciana esiste un nemico ben più pericoloso di Saul: è l'insignificanza di una vita vissuta nel rispetto delle regole formali della legge, è l'illusione di una propria purezza interiore limitata alla coerenza prescrittiva, è la pretesa di poter dimostrare pubblicamente la propria innocenza accusando gli altri di violare le regole della civile convivenza. E tutto questo mentre l'oppressione romana rendeva inutile non solo la legge mosaica ma anche il suo minuzioso e faticoso rispetto.
Achimelec si era limitato a chiedere la purezza sessuale come condizione per trasgredire, in via del tutto eccezionale, il precetto. Agli apostoli non occorreva forse chiedere ben altro come condizione per dimostrare la superiorità dell'uomo sul sabato?
Qual è insomma l'insegnamento della pericope? È forse quello di cercare di far capire che, poste certe condizioni di vita, è necessario derogare ai principi della legge al fine di salvaguardare il valore della coscienza umana, nel senso che se le intenzioni sono positive o costruttive, si può violare la “lettera” della legge senza violarne lo “spirito”? O è forse quello di far capire che l'uomo è sempre superiore alla legge e che tale superiorità va esercitata per tutelare il bene collettivo, non per affermare un arbitrio personale?
Per quale ragione nella pericope marciana sono presenti entrambe le motivazioni? Il fatto è che, non essendo ben marcate le esigenze politiche sottese alla violazione del precetto, la pericope marciana è stata costretta a puntare su giustificazioni di tipo etico-filosofico, che poi sono risultate prevalenti in tutta l'ideologia del cristianesimo fino ad oggi.
Se guardiamo al modo come è stata affrontata la questione del sabato nel vangelo di Giovanni, noteremo subito che qui la violazione del precetto rispondeva a esigenze più politiche che etiche, o comunque più teoriche che pratiche. In occasione della festa delle Capanne (cfr la guarigione del cieco nato) l'attacco contro il precetto del sabato è pubblico, intenzionale, agganciato a un progetto di liberazione nazionale e incorniciato da affermazioni inequivoche circa la necessità di professare un integrale e autonomo umanesimo.
Viceversa in Marco l'umanesimo professato dal Cristo sembra essere fine a se stesso e il suo diverbio coi farisei assomiglia a uno scambio di battute tra filosofi, accompagnati dai rispettivi discepoli. Diversamente da Marco, dove il sabato è un precetto in cui i Galilei credono molto poco, Giovanni mostra ch'esso veniva considerato un precetto molto importante per tutti i Giudei e che l'opposizione ad esso da parte del Cristo era un motivo sufficiente per scomunicare lui e tutti i nazareni che lo seguivano, tant'è che la violazione pubblica del precetto (mediante o no le guarigioni) comportava delle conseguenze immediatamente politiche, di cui il Cristo era ben consapevole.
[27] E diceva loro: “Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato!
[28] Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato”.
L'insegnamento spirituale di questo racconto è volto a precisare la sostanziale differenza tra coscienza e legge. Quella differenza che serve appunto a capire come nei momenti critici (di Davide) o di bisogno (i Dodici) è inutile, anzi controproducente, rimanere inflessibili nelle proprie posizioni.
Nel caso di Davide la deroga non era stata concessa per debolezza o indifferenza, ma nella chiara consapevolezza della drammaticità del momento. I farisei avrebbero dovuto estendere l'eccezione ai casi in cui è in gioco il bisogno, nella consapevolezza che un'assoluta coerenza alla legge porta a situazioni di inevitabile disumanità.
Cioè l'insegnamento etico della pericope non vuole essere a favore dell'arbitrio personale, in virtù del fatto che la coscienza umana o l'uomo qua talis è un valore sempre superiore a qualunque legge, ma vuole essere un invito a riflettere sulla pretesa di dichiararsi “puri” limitandosi a una fedeltà rigorosa a norme giuridiche. Una pericope del genere avrebbe potuto essere scritta da qualunque intellettuale illuminato di stretta osservanza mosaica. Persino la massima del v. 27 poteva essere facilmente condivisa, tant'è che il Talmud la prevede.
Tuttavia, la storia del pensiero ebraico ha dimostrato che non si è mai arrivati, neppure dal punto di vista etico, a considerare l'uomo, sempre e comunque, superiore al sabato. Al massimo si è arrivati ad ammettere che se si è giusti in coscienza si può anche, in momenti particolari, trasgredire la lettera della legge senza violarne lo spirito, ma per riconfermare la superiorità della legge subito dopo. L'ebraismo è sempre rimasto la religione del “Libro”.
(torna su)5) Che significa “porgere l'altra guancia”?
Mt 5,38-39
[38] Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”;
[39] ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra.
Nel contesto della pericope matteana l'espressione viene posta in antitesi alla legge veterotestamentaria del “taglione”, la quale, a sua volta, era stata istituita (da Mosè?) per porre un freno alla prassi della vendetta personale (faida). Imponendo un castigo uguale al danno causato, la legge mosaica dell'occhio per occhio / dente per dente tendeva a limitare gli eccessi della vendetta (che rischia sempre, per sua natura, di diventare interminabile).
Nella pericope matteana non ci si riferisce ai rapporti che si devono tenere con l'oppressore (nazionale o straniero), né d'altra parte ci si può aspettare dai vangeli (meno che mai da quelli di Matteo e di Luca) un'indicazione etico-politica su come regolarsi nei confronti di chi ha interessi di classe opposti a quelli della stragrande maggioranza dei cittadini e dei lavoratori.
La morale di quella pericope non vuole avere un contenuto politico rivoluzionario; semplicemente essa afferma che di fronte a un torto non va cercata immediatamente la vendetta personale o la giustizia sommaria (la quale, com'è naturale, non può preoccuparsi di analizzare le cause del torto e le possibili attenuanti), ma va piuttosto cercata la possibilità del perdono, affinché il torto subìto non diventi più grande di quello che in effetti è stato.
Il che non esclude la necessità della giustizia: Paolo non si appellava forse ai tribunali romani per avere giustizia contro gli ebrei che lo perseguitavano per le sue opinioni politico-religiose? Il ricorso alla giustizia è giusto per almeno una ragione: chi offende non deve credere nella possibilità di poter reiterare il torto impunemente.
Se si vuol forzare l'interpretazione del testo matteano, al massimo si può arrivare a sostenere che l'espressione “porgi l'altra guancia” significa in sostanza “resistere al nemico sino alla morte”, se questo serve per salvaguardare le proprie idee o determinati princìpi condivisi da una collettività.
Quando il nemico è più forte, bisogna assecondarlo, perché sarebbe un suicidio non tener conto dei rapporti di forza, ma assecondarlo nelle “forme” non significa assecondarlo nella “sostanza”, nel senso di dover per forza condividere le sue idee, i suoi criteri di vita ecc. “Porgere l'altra guancia” non significa “porgere la mente”. Quindi l'atteggiamento apparentemente remissivo va vissuto solo in attesa di tempi migliori, quando, a forza di predicare l'alternativa, i rapporti di forza saranno radicalmente mutati.
(torna su)6) I cibi puri e impuri
Mc 7,18-23
[18] E disse loro: “Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo,
[19] perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?”. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti.
[20] Quindi soggiunse: “Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo.
[21] Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi,
[22] adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza.
[23] Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo”.
*
La purezza morale, interiore, dipendente dal divieto di consumare determinati cibi, è una sciocchezza in cui ancora oggi molte religioni credono ciecamente (si pensi a quella ebraica o a quella islamica). Già nei vangeli si contestò il fatto che un cibo lecito preso con mani non lavate potesse contagiare la coscienza di chi lo mangiava (Mc 7,18 s.).
Si tratta di un moralismo superficiale, ingenuo, primitivo, che può anche diventare aberrante quando pretende di considerare “impuri” coloro che non si comportano in maniera ortodossa. Se poi questo lo si mette in relazione all'attività politica, è facile notare quanto sia falsa l'idea di chi sostiene la salvaguardia della dignità umana, all'interno di un sistema sociale oppressivo, sulla base di norme o precetti meramente formali ed estrinseci. Per la prima volta nei vangeli si lascia intravedere la possibilità di vincere lo sfruttamento di Roma cercando anzitutto di essere meno settari nel proprio ritualismo e più aperti alla condivisione di una sofferenza comune, riguardante anche popolazioni non-ebraiche.
Che gli ebrei fossero particolarmente attaccati alle loro tradizioni (incluse quelle dietetiche) è documentato anche dalla fatica con cui l'apostolo Pietro negli Atti (11,1-18) cercò invano di convincere la comunità cristiana di Gerusalemme che tutti i cibi (non solo quelli legali) potevano essere mangiati con mani impure, ovvero che tutti i cibi era ugualmente inutili ai fini della giustificazione morale davanti a Dio. Quando Pietro venne sostituito alla guida della comunità da Giacomo il Giusto, di nuovo si ribadì la necessità di vietare il consumo alimentare del sangue e la macellazione per soffocamento (At 15,20.29).
Perché questo rigorismo fanatico? Almeno per una duplice ragione: 1. è più facile dimostrare la propria rettitudine astenendosi da cose proibite che praticando con coraggio azioni riformatrici o addirittura rivoluzionarie; 2. è più rischioso tutelare la propria identità rinunciando alle tradizioni che non conservandole.
Chi si serve dei tabù alimentari per imporre delle regole morali, non ha fiducia nella volontà delle masse, nella libera iniziativa degli individui: tratta gli adulti come se fossero dei bambini. Chi poi ha creduto di servirsi della religione per impedire che gli uomini, usando determinati alimenti, si procurassero dei danni fisiologici, non può aver continuato a impedirlo, anche in presenza del progresso scientifico, con la stessa identica buona fede, cioè senza trarre dalla religione un qualche vantaggio politico, economico o ideologico. Il progresso della scienza rende ipocrita anche il miglior credente.
Naturalmente con questo non si vuol dire che non debbano esistere determinate regole dietetiche, utili alla salute fisica degli esseri umani, né che certe regole dietetiche individuate dagli ebrei o da altri gruppi religiosi non abbiano un qualche fondamento scientifico. Non ci si pronuncia neppure sull'ipotesi, avanzata da alcuni esegeti e non senza fondamento, secondo cui in origine le regole dietetiche avevano soltanto motivazioni di tipo medico-sanitario (in relazione ai climi e agli ambienti vissuti dal popolo ebraico), e che siano invece stati i sacerdoti che, nei momenti storici di maggiore difficoltà del loro popolo, le abbiano contrassegnate in chiave normativa, nella speranza che con una disciplina autoritaria, inerente ad aspetti della vita quotidiana, si potesse salvaguardare meglio la compattezza dello stesso popolo.
(torna su)7) La questione del divorzio
Mc 10,2-12
[2] E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: “È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?”.
[3] Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”.
[4] Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”.
[5] Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma.
[6] Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina;
[7] per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola.
[8] Sicché non sono più due, ma una sola carne.
[9] L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”.
[10] Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse:
[11] “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei;
[12] se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”.
I
“È lecito a un marito ripudiare la propria moglie?” (Mc 10,2). Questa domanda rivolta a Gesù non può essere stata posta dai farisei, o comunque non può esserlo stata in questi termini. I farisei non avrebbero mai chiesto a Gesù un parere su un argomento del genere: non solo perché già avevano una loro risposta, ed era quella affermativa del giudaismo ufficiale, e su questo difficilmente si sarebbero lasciati convincere del contrario in un pubblico dibattito con Gesù, per quanto all'interno del partito farisaico – come sappiamo – vi fossero correnti progressiste disposte al dialogo e al confronto; ma anche perché materia principale del loro contendere, col movimento nazareno, erano questioni soprattutto di carattere politico.
Lo stesso Cristo, nel momento cruciale della sua rivoluzione (poiché questo racconto è posto da Marco alla fine del vangelo), non avrebbe potuto mettersi a disquisire su questioni di natura etica, anche perché, in questo specifico caso, se ne sarebbe già dovuta conoscere la risposta.
Tale domanda quindi è stata probabilmente formulata nell'ambito delle prime comunità cristiane, per differenziarsi dalle tradizioni e dalle leggi ebraiche: forse è nata in virtù di qualche spinta rivendicativa dei cristiani di sesso femminile, di origine pagana, per quanto nei vangeli molti atti di Gesù attestino che l'esigenza di uguaglianza dei sessi andava affermandosi anche in Palestina.
Un esegeta deve sempre considerare che una falsificazione, ben più pericolosa di un'invenzione vera e propria, non può mai prescindere da un riferimento alla realtà concreta. Questo significa che se il Cristo ha veramente affrontato, nel corso della sua vita, un argomento del genere, deve averlo fatto non solo in maniera diversa da come appare nel testo, ma anche in maniera così originale che l'autore del testo non ha potuto non tenerne conto. Da un lato quindi deve essere esistita una censura (i cui termini vedremo più avanti), dall'altro però bisognerà vedere se, proprio in virtù di tale censura, è possibile ipotizzare il contenuto approssimativo della fonte censurata.
II
Nella Palestina di duemila anni fa il ripudio unilaterale della moglie non era cosa inconsueta, almeno non fra i ceti più elevati, e nessuno ne metteva in dubbio la legittimità giuridica né la liceità morale. Non la prima, poiché il diritto concesso da Mosè veniva considerato come un privilegio dell'uomo; non la seconda, poiché la donna veniva tenuta alquanto sottomessa. È facile quindi pensare che la domanda possa essere stata formulata dalla comunità cristiana primitiva per giustificare una posizione ideologica e culturale fortemente critica nei riguardi del divorzio unilaterale da parte dell'uomo: una posizione che risale, almeno in fieri, allo stesso Gesù o che dalla sua predicazione poteva essere facilmente arguita.
Con la loro domanda i farisei (diamone per scontata la presenza) intendono sostenere, nel racconto di Marco, il valore di due princìpi: 1) l'unilateralità del divorzio a favore dell'uomo, ovvero la non-reciprocità da parte della donna; 2) la genericità del concetto di divorzio, che non viene visto in rapporto a casi specifici. Questo, in un certo senso, rispecchia il costume prevalente dell'epoca, ma riflette anche i classici criteri e modi di comportamento dei regimi autoritari e paternalistici. Da un lato infatti si pretende di affermare un potere assoluto del maschio sulla femmina; dall'altro si esprime un'ideologia individualistica che vede l'affermazione di sé in una scelta di vita arbitraria: il divorzio può essere chiesto “per qualsiasi motivo” – dice Matteo 19,3 – e in qualsiasi momento.
La controdomanda di Gesù: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?” (10,3), aveva semplicemente lo scopo d'introdurre alla comprensione del fatto che la pretesa del “ripudio facile”, unilaterale, non poteva considerarsi legittima, in quanto proveniva da un'interpretazione forzata della legge di Mosè, la quale infatti ammetteva il ripudio da parte dell'uomo solo se questi aveva trovato nella donna “qualcosa di vergognoso” (Dt 24,1) e, in ogni caso, la pena di morte per il reato di adulterio prescindeva dalla differenza di genere sessuale (Lv 20,10).
La risposta dei farisei: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla” (v. 4), attesta l'atteggiamento strumentale del potere maschilista, che, a sua volta, è sempre un potere basato sull'oppressione e lo sfruttamento dei più deboli. Qui i farisei considerano la legge in modo astratto, omettendo volutamente le motivazioni storico-sociali che al tempo di Mosè avevano potuto determinarla (d'altra parte la comunità cristiana primitiva non aveva alcun interesse a considerare obiettivamente la posizione farisaica).
Viceversa, nella sua replica, Gesù dà un giudizio sulla legge del divorzio di tipo storico, rievocando le considerazioni di opportunità che dovevano aver mosso il legislatore veterotestamentario, che aveva concesso la facoltà del ripudio ai soli uomini. Dunque, “per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto” (vv. 5-9).
Qui è facile notare come passi di natura religiosa si siano mescolati e confusi con una visione laica o umanistica della vita. Se infatti si toglie ogni riferimento alla divinità, si comprende ugualmente che i due valori sostenuti da Gesù sono l'uguaglianza dei sessi e la loro comunione totale.
Singolare comunque resta il fatto che per negare valore al libello del ripudio il Cristo deve appellarsi a un periodo storico addirittura precedente a quello mosaico. È difficile che gli ebrei possano aver capito un riferimento del genere. Al massimo avrebbero potuto accettare l'idea che un ripudio deve poggiare le sue fondamenta non sull'arbitrio ma su motivazioni concrete. Lo stesso evangelista, attribuendo a Dio l'origine dell'uguaglianza dei sessi, attesta che di tale uguaglianza si era persa completamente la memoria.
Mosè – come noto – diede la facoltà di divorziare solo perché il tradimento era divenuto non l'eccezione ma la regola. Egli pensò di rimediare a un “male maggiore” con un “male minore”, nella convinzione che la salvaguardia delle apparenze, in un matrimonio spiritualmente distrutto, è fonte di un'ipocrisia insostenibile.
Col passare del tempo, tuttavia, chi poteva beneficiare, in esclusiva, di quel “male minore” (e cioè l'uomo), ne approfittò per giustificare il “male maggiore”, agevolandolo il più possibile. Ai tempi di Gesù, infatti, la legge sul divorzio veniva usata con la stessa leggerezza con cui ai tempi di Mosè gli uomini tradivano le mogli.
La necessità di superare non solo la cattiva esegesi del privilegio mosaico, ma anche lo stesso privilegio, viene chiarita da Gesù ai discepoli in privato: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei” (v. 11). Il che appunto vorrebbe dire che l'uomo che divorzia con superficialità, solo perché si ritiene superiore alla donna, è come se commettesse adulterio.
Non solo, ma si potrebbe addirittura aggiungere, alla luce dei princìpi cristiani, che una qualunque forma di sessualità senza amore è di per sé una forma di ipocrisia, soprattutto se per soddisfare le proprie pulsioni erotiche si arriva a tradire una donna sposata o comunque una donna che si ama.
Tutto ciò, naturalmente, vale anche per la donna e, in questo senso, la precisazione del redattore al v. 12 è inessenziale, come lo è l'eccezione del “concubinato” presente nel testo parallelo di Mt 19,9. In effetti, se il divorzio è il fallimento dell'amore, il concubinato non può rendere il divorzio più accettabile o più legittimo. Matteo è sicuramente più moralista di Marco, anche se all'apparenza sembra il contrario (e non a caso la Chiesa cattolica si serve del testo di Marco per giustificare il suo idealismo astratto relativo all'indissolubilità del matrimonio).
Gesù qui afferma due soli princìpi – come già si è detto: quello dell'uguaglianza dei sessi sul piano giuridico e politico, e quello della comunione totale sul piano spirituale e materiale. Gli altri due che la Chiesa romana crede di poter dedurre, e cioè la monogamia e l'indissolubilità, non possono neppure essere considerati dei princìpi, poiché nessuna legge potrebbe imporli efficacemente. Monogamia e indissolubilità sono conseguenze che la coppia può avvertire nella propria libertà interiore, non possono certo essere delle norme vincolanti imposte dall'alto, cui attenersi scrupolosamente.
Il testo evangelico di Marco non insegna altro che l'esigenza di approfondire con l'amore il rapporto di coppia: solo quando, nonostante l'impegno, la buona fede e la serietà dimostrati, la comunione si spezza, al punto che si ritiene impossibile ricomporla (poiché senza reciprocità l'amore non esiste), solo allora il divorzio trova la sua ragion d'essere e, con esso, il problema di realizzare una vera comunione di vita col nuovo partner.
III
Se mai si sia discussa, all'interno del movimento nazareno, la questione del divorzio, noi non ne conosciamo i termini, anche se forse è possibile immaginarli. Un movimento rivoluzionario non avrebbe potuto accontentarsi di risolvere questo problema semplicemente puntando l'attenzione sulle questioni morali: “è bene / non è bene divorziare”. Piuttosto avrebbe cercato di valorizzare la questione dell'emancipazione della donna, ovvero della sua uguaglianza nei confronti dell'uomo.
Ma anche questo sarebbe stato un modo limitato di vedere le cose. Un movimento che vuole essere rivoluzionario non può neanche per un momento dimenticare che l'uguaglianza tra uomo e donna è strettamente correlata all'uguaglianza più generale di tutti i cittadini, che va affermata a livello sociale. Se non si crede nella possibilità di costruire una società più democratica, a livello sociale e politico, la lotta per l'emancipazione della donna rischia di rimanere circoscritta entro un orizzonte meramente morale o giuridico, nel quale sono destinate a imporsi considerazioni del tipo: “anche la donna è un essere umano”, “deve avere gli stessi diritti dell'uomo”, ecc., mentre il problema vero è proprio quello di superare il formalismo di concetti come “umanità”, “diritto”, “uguaglianza”..., che è tipico, più o meno, di tutte le moderne civiltà basate sull'antagonismo sociale.
Le cose dunque potrebbero essere andate nel modo seguente: contro il lassismo dei costumi morali, contro il divorzio facile e unilaterale che privilegiava l'uomo sulla donna, il Cristo deve aver predicato un matrimonio basato sull'amore e sull'uguaglianza dei sessi, vincolando la riuscita di tale impegno alla lotta per la liberazione sociale e politica della società e per il rinnovamento della mentalità dominante. Egli può essersi opposto al divorzio in nome dei valori umani fondamentali, tra i quali spicca quello della libertà, fonte principale dell'uguaglianza dei sessi nell'amore.
Contrario al divorzio in via di principio, il Cristo deve però averlo ammesso sul piano pratico, allorquando si è obbligati a constatare la non volontà, da parte di uno o di entrambi i coniugi, di proseguire l'intesa spirituale. Si può forse impedire con la forza a una coppia di odiarsi? Si può forse indurli all'amore, obbligandoli a un vincolo indissolubile?
Tuttavia, è difficile pensare che un uomo disposto a lottare (fino alla morte) per la liberazione della sua patria dai nemici interni ed esterni, non avrebbe cercato di spiegare, in tutti i modi possibili, che il divorzio, se il soggetto non si pone il problema di come vivere positivamente la vita, è solo l'affermazione illusoria di un arbitrio personale, quando non è ovviamente la legittima difesa da un rapporto impossibile.
Il divorzio non risolve certo i problemi di una coppia più di quanto non possano fare l'amore, la reciproca comprensione, il rispetto della diversità o l'uguaglianza dei sessi. Una persona abituata a ragionare in termini ontologici non può che guardare con sospetto alla scelta del divorzio, per quanto sia ben consapevole che non possa esistere amore là dove manca la reciprocità. L'amore unilaterale, senza l'attiva partecipazione del partner, rischia di porsi, alla lunga, in maniera non meno illusoria del divorzio.
IV
La primitiva comunità cristiana, sentendosi frustrata sul piano umano e politico, poiché vedeva che il progetto di liberazione di Cristo non riusciva a realizzarsi, ha progressivamente cominciato a credere che la liberazione non fosse di questo ma di un “altro mondo”, e che, in attesa del suo “magico” avvento, gli uomini dovessero usare la libertà il meno possibile. A loro giudizio infatti proprio l'uso arbitrario della libertà aveva portato a uccidere quel messia che più di ogni altro avrebbe potuto liberarli dall'oppressore.
Ed ecco la prima grande novità della Chiesa cristiana, rispetto alla questione rabbinica del divorzio: i coniugi debbono restare uniti perché così vuole “Dio”, che in origine aveva fatto l'uomo uguale alla donna, destinandoli a un amore reciproco ed eterno.
Con questa espressione, che si ricava in Mc 10,5-9, l'autore non aveva certamente intenzione di predicare l'indissolubilità del matrimonio: voleva semplicemente dire che gli uomini, prima di pensare ai loro egoistici interessi, dovrebbero pensare al fine religioso per cui sono stati creati. Cioè in sostanza l'uomo deve adattarsi a vivere con la donna che ha sposato, a meno che non vi sia un caso di esplicito adulterio (Mt 19,9).
La censura dove stava? Proprio in questo, che mentre il Cristo poneva il fondamento dell'unione matrimoniale nel valore umano e di tale valore faceva il perno in cui far ruotare la rivoluzione dei costumi e dei rapporti di potere, la comunità cristiana lo pone invece in un valore religioso: “Dio”, alla cui volontà gli uomini, tendenzialmente peccatori, devono adeguarsi. Gli sposi cristiani devono restare uniti perché “così vuole Dio”, non tanto perché con la loro comunione spirituale e materiale possono contribuire a modificare i rapporti sociali esistenti.
Il matrimonio resterà salvo – dice l'autore di questo racconto – non se i coniugi lotteranno per una società migliore, che li induca ad amarsi e ad amare il prossimo, ma solo se avranno “fede in Dio”, cioè se saranno credenti nella Chiesa degli apostoli. È quest'ultima, infatti, che garantisce ciò che gli uomini, con le sole loro forze, sarebbero incapaci di ottenere.
A dir il vero, nei vv. 5-9 non è ancora così esplicita un'affermazione clericale della tesi cristiana dell'indissolubilità, ma lo diventa subito dopo, nei vv. 11-12, che vogliono porsi come conseguenza logica dei precedenti. Essi infatti sostengono che “chi ripudia la propria moglie o il proprio marito e ne sposa un'altra/o, commette adulterio”. Qui l'uguaglianza dei sessi è sì riconosciuta, ma al negativo, solo sulla base di ciò che non si può fare. Il concetto di indissolubilità del matrimonio è abbastanza evidente, e la Chiesa romana lo utilizzerà, in un primo momento, contro la separazione dei coniugi; poi, quando il laicismo comincerà a imporsi, contro la richiesta del divorzio per accedere a nuove nozze, limitandosi ad accettare la separazione di fatto. E qui lasciamo perdere le assurdità inventate intorno al tema dell'annullamento del matrimonio per mezzo del Tribunale della Sacra Rota.3
Questa conclusione è “logica” solo in apparenza. In realtà la coerenza sta unicamente nell'aver accentuato la considerazione pessimistica circa la capacità umana di liberazione. Prima infatti Marco diceva che gli uomini possono essere liberi solo se si affidano a Dio; ora invece afferma che possono esserlo solo se rispettano una legge religiosa. Si tratta di una vera e propria ricaduta nel legalismo rabbinico: la differenza sta semplicemente nel fatto che il cristianesimo era un po' più favorevole all'uguaglianza dei sessi (come d'altra parte già stava avvenendo nel mondo greco-romano).
A questo eccessivo schematismo la comunità non tarderà ad opporsi, introducendo, con Mt 19,10, l'eccezione del “concubinato”, che però, guarda caso, è riferito, come “colpa”, alla sola donna, per cui la presunta maggiore democraticità di Matteo si risolve, in ultima istanza, in un ritorno alla mentalità giuridica e maschilista dei rabbini.
Matteo infatti sostiene che l'amore non ha senso quando la donna tradisce l'uomo. Anzi, sembra addirittura che i discepoli di Gesù avrebbero voluto proseguire le tradizioni rabbiniche che permettevano all'uomo di separarsi dalla donna anche per motivi molto meno gravi di quelli del “concubinato”. A questo punto Matteo, di fronte al comandamento di non separarsi, sconsiglia addirittura di sposarsi: “se non possiamo divorziare quando ci pare, è meglio non sposarsi neppure”. Meglio eunuco per il regno dei cieli che marito fedele ad oltranza.
E il Cristo, invece di offendersi al sentire un pensiero così meschino dell'amore e del matrimonio, nonché così strumentale nei confronti della donna, sembra confermarlo allorché afferma che “è meglio non sposarsi, cioè farsi eunuchi per il regno dei cieli” (Mt 19,11 ss.).
La chiusa relativa agli eunuchi deve essere stata elaborata da un redattore resosi conto che la conclusione rabbinica poteva anche essere interpretata a favore di una scelta del celibato per motivi di libertinaggio. Ciò tuttavia non toglie il limite proprio del cristianesimo, che non riuscendo a dare un valore sociale e politico all'uguaglianza dei sessi, è poi costretto a sostenere che la scelta del celibato in assoluta castità è questione solo per pochi eletti.
Matteo, in sostanza, è rimasto refrattario all'uguaglianza dei sessi e ha trasformato l'ontoteologia di Marco in una sorta di ascetismo misogino, che è poi tipico del mondo clericale. Avvalorando l'idea di una santificazione del celibato ecclesiastico, Matteo è giunto ad affermare un idealismo ancora più astratto di quello marciano.
Sulla sua scia la Chiesa romana elaborerà uno dei sillogismi più estremisti della storia: se la monogamia dev'essere assoluta e l'uguaglianza dei sessi è un fardello insopportabile, allora il matrimonio va considerato legalmente indissolubile (anche nei confronti dell'eccezione dell'adulterio, che pur Matteo aveva previsto). Per detta Chiesa esiste solo una condizione superiore al matrimonio indissolubile: il celibato forzato, tipico del sacerdote, che per definizione è migliore di qualunque uomo sposato.
(torna su)8) La posizione di potere dello scriba
Mc 12,38-40
[38] Diceva loro mentre insegnava: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze,
[39] avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
[40] Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più grave”.
Mt 23,1-12
[1] Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
[2] “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
[3] Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
[4] Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito.
[5] Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange;
[6] amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe
[7] e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare 'rabbì' dalla gente.
[8] Ma voi non fatevi chiamare 'rabbì', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
[9] E non chiamate nessuno 'padre' sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo.
[10] E non fatevi chiamare 'maestri', perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
[11] Il più grande tra voi sia vostro servo;
[12] chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”.
*
In Mc 12,38 ss. la riprovazione morale e politica, da parte di Gesù, del comportamento dello scriba è molto più severa che nei passi paralleli di Mt 23,1 ss. Laddove infatti il Gesù di Marco invita a “guardarsi dagli scribi” (v. 38) che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze (la vanità), avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti (l'ambizione), e che nel contempo divorano le case delle vedove (la cupidigia) e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra (l'ipocrisia); il Gesù di Matteo invece invita a “osservare tutte le cose ch'essi dicono”, pur senza agire secondo le loro opere (23,3).
Matteo dunque è un moralista e, come tutti i moralisti, da un lato crede di poter salvaguardare la propria coscienza rinunciando ad un'opposizione politica contro la corruzione del potere, dall'altro spera che tale potere, sentendosi moralmente giudicato, cambi atteggiamento. Di qui il suo lunghissimo elenco delle falsità scribo-farisaiche.
Marco invece è un realista che bilancia il giudizio negativo (morale e politico) con uno positivo (altrettanto morale e politico). Egli infatti afferma che taluni scribi erano molto vicini a comprendere il messaggio di liberazione di Gesù (12,28-34).
[28] Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”.
[29] Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore;
[30] amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza.
[31] E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi”.
[32] Allora lo scriba gli disse: “Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui;
[33] amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici”.
[34] Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
La disponibilità politica degli scribi verso il movimento nazareno, Matteo non l'avrebbe mai ammessa: sia perché è tipico del moralista condannare il potere in quanto tale, cioè il non saper distinguere nell'ambito del governo le forze reazionarie da quelle con cui è possibile realizzare dei compromessi; sia perché il moralista tende a ritenersi migliore in modo aprioristico rispetto al potere dominante, specie se questo potere non tiene conto di alcuna critica morale. Il moralista si ritiene impeccabile appunto perché non dispone di alcuna leva di comando. Il suo è un idealismo soggettivistico.
Viceversa, Marco, se fa capire che con gli scribi ipocriti è bene stare in guardia (ovviamente non solo limitandosi a fingere di ascoltarli, come propone Matteo), fa anche capire che nel loro ceto bisogna saper distinguere gli onesti dagli ipocriti, quelli cioè che desiderano una transizione da quelli che invece preferiscono collaborare con Roma.
Molto interessante, in questo senso, è Mc 12,34, dove appare evidente che per il Cristo “amare” Dio e il prossimo con tutto il cuore, la mente e la forza costituisce solo il primo passo verso la realizzazione del regno di Dio. In che senso? Marco, come al solito, resta in questi casi un po' ambiguo: nello specifico sembra essere abbastanza chiaro, ma siccome l'impianto generale del suo vangelo (come gli altri, del resto) è finalizzato a una legittimazione del movimento cristiano agli occhi del potere romano, alla fine risulta falsata anche l'interpretazione della situazione particolare. Per cui, da un lato Marco non lascia chiaramente capire cosa intenda Gesù con la frase “tu non sei lontano dal regno di Dio” (12,34), dall'altro però è assai evidente che l'amore per Dio e per il prossimo (in cui anche lo scriba si poteva distinguere) non era condizione sufficiente alla realizzazione del regno.
Cos'è che manca allo scriba, che ha risposto – secondo Gesù – con “intelligenza”? Manca l'impegno personale sul piano politico in un progetto di liberazione. Questo Marco non poteva dirlo, poiché il suo vangelo è nato proprio per aver rinunciato a tale progetto, cioè per giustificare questa rinuncia agli occhi del neonato movimento cristiano, rassicurando nel contempo, in maniera convincente, il potere romano. Ma non poteva neppure tacerlo del tutto, poiché il suo vangelo, essendo nato allo scopo di falsificare l'interpretazione politica della morte di Gesù, doveva in qualche modo tener conto di tale interpretazione.
Non essendo stati specificati i veri motivi che hanno indotto Gesù a formulare quella espressione, cosa può dedurre il lettore dal testo? Che l'esegesi più corretta sia quella di tipo religioso, e cioè che lo scriba non ha ancora la fede per... e qui i vari teologi possono inventarsi le motivazioni più varie. Un'interpretazione, molto grossolana, afferma che lo scriba non aveva fede nella “divinità” di Gesù, in quanto – a giudizio dello scriba – “vi è un solo Dio e fuori di lui non ve n'è alcun altro” (12,32); un'altra, un po' più sofisticata, vuole che Gesù abbia detto allo scriba ch'era soltanto “vicino” al regno di Dio, perché per un ebreo di allora “amare il prossimo” voleva semplicemente dire amare una persona della stessa religione o della stessa razza, nazione, tribù, clan, famiglia... Tale esegesi si spiega col fatto che la Chiesa s'è servita della nozione paolina e pseudo-giovannea di “amore universale” per superare il particolarismo politico-culturale del nazionalismo ebraico (naturalmente tale esegesi evita di aggiungere che in tale superamento si è anche rinunciato all'idea di dover realizzare politicamente l'istanza di liberazione degli schiavi e delle popolazioni sottomesse all'imperialismo romano).
Un'altra interpretazione religiosa che forse può essere utilizzata in chiave laica è quella che vede nell'affermazione di Gesù relativa alla semplice “vicinanza” dello scriba al regno (nonostante il riconoscimento della sua risposta “intelligente”), il tentativo di dimostrare che la “vicinanza” o la “lontananza” dal regno di Dio non dipende dal rispetto o meno della legge, ma da un'esperienza concreta di liberazione (qui ovviamente, in luogo di “liberazione”, l'esegesi religiosa preferisce parlare di “redenzione”). Gesù cioè sembra aver posto un'ipoteca sulla possibilità di poter realizzare la giustizia attraverso il puro e semplice rispetto della legge.
In effetti, ognuno può facilmente rendersi conto che, se anche tutti gli uomini rispettassero le leggi, la giustizia non sarebbe comunque realizzata. Perché? Perché se tutti gli uomini fossero così onesti da rispettare le leggi, essi non avrebbero bisogno di alcuna legge, la cui ragion d'essere sta appunto nella volontà delle classi sociali più forti di nascondere la propria “disonestà” e di controllare la coscienza e il comportamento delle classi più deboli, reprimendo soprattutto coloro che, in nome della loro “onestà”, rivendicano una società diversa. Non a caso il Cristo predicava la “fine della legge”, ovvero la fine della pretesa della legge di giustificare il giusto (che sarà poi il discorso che Paolo utilizzerà in più occasioni, anche se non in chiave politica ma religiosa, facendo della fede nella grazia di Dio e non della fede nell'impegno politico la fonte della giustificazione del credente).
La legge può al massimo “controllare” la disonestà, non “impedirla” (qui solo la coscienza è sovrana), e può controllarla se al suo fianco si sviluppa una società democratica, cioè se chi emana la legge è la stessa persona che costruisce una società in cui la legge, col tempo, non avrà più ragione d'esistere, essendo stata sostituita con la consuetudine e la morale collettiva. Il problema infatti è proprio quello di sapere quali mezzi darsi non tanto o non solo per tenere sotto controllo la disonestà, quanto soprattutto per cercare di superarla. Per un relativo controllo è sufficiente la legge, se la formulazione della legge è nelle mani dello stesso popolo che la deve rispettare. La disonestà però può essere vinta solo in un modo: partecipando attivamente alla costruzione di una società in cui la giustizia venga percepita come una possibilità reale. Se gli uomini si convincono interiormente di questo, sulla base di esperienze concrete, che possano anche verificare personalmente, allora la forza coercitiva e persuasiva della legge sarà un “nulla” a confronto della forza morale delle masse.
Nel racconto di Marco, Gesù riconosce allo scriba la necessaria disposizione morale, soggettiva, per il superamento del valore della legge ai fini dell'edificazione del regno, però non gli riconosce la capacità operativa necessaria a tale edificazione. Ovvero lo scriba ha perfettamente inteso che la capacità di sopportare i sacrifici, richiesti dalla legge (o compiuti addirittura spontaneamente, per il bene di un ideale), non rende di per sé l'uomo migliore, né modifica la società in cui egli vive, ma non ha capito in che modo si deve vivere quell'esperienza che non fa dipendere tout-court dalla disponibilità al sacrificio (come invece è in Matteo) il significato della liberazione sociale.
Gesù, in sostanza, non voleva soltanto abolire la pretesa di giustificazione insita nella legge: altrimenti si sarebbe limitato a predicare l'amore universale (come il Battista e lo stesso Paolo). Egli voleva anche risolvere il problema di come appagare sulla terra il desiderio di liberazione delle masse oppresse, partendo da una situazione particolare, paradigmatica: la Palestina. In questo senso, se si voleva accettare l'idea di un necessario “amore universale” (come il miglior profetismo ebraico ha sempre predicato), allora si doveva smettere di considerarla alla stregua di un puro e semplice “sacrificio fatto con gioia”. L'amore universale o corrisponde alla necessità di lottare per la giustizia sociale, l'uguaglianza degli uomini, la piena libertà personale e la verità delle cose, oppure è vuota retorica, mera finzione, che qualcuno peraltro può anche utilizzare proprio per non realizzare detti obiettivi.
Se il movimento nazareno avesse realizzato la democrazia sociale, gli scribi e i farisei non avrebbero potuto, impunemente, dire cose diverse da quelle che facevano: il popolo se ne sarebbe accorto. In realtà la loro doppiezza già allora era nota, solo che, essendo essi al potere, i danni che procurava erano assai maggiori. In fondo la “riprovazione” degli scribi, espressa da Gesù, non aveva altro scopo che quello di mettere in luce il tradimento subìto dal popolo, invitando le persone politicamente “oneste” del regime a uscire allo scoperto, a prendere posizione a fianco delle masse sfruttate e ingannate.
Solo dal comportamento pratico di una persona si può dedurre se le sue parole sono vere o false. Gli uomini possono anche arrivare a dire cose opposte a quelle dette un minuto prima, ma questa incoerenza teorica, ideale, non è di per sé indice di ipocrisia. Anzi, l'incoerenza teorica può anche essere un forma di realismo, di elasticità mentale, di duttilità e flessibilità. L'oggettività delle cose a volte è così potente che l'incoerenza non solo è inevitabile, ma addirittura necessaria, per salvaguardare la purezza degli ideali. Persino gli ipocriti, senza volerlo, possono arrivare a dire cose giuste.
Marco fa capire chiaramente – a differenza di Matteo – che la vera falsità dello scriba generalmente inteso, quella che lo squalifica completamente come persona, oltre che come professionista della legge e della politica, sta nel fatto ch'egli “divora le case delle vedove”, cioè manda in rovina le categorie sociali più deboli, più esposte all'inganno dei potenti. Approfittando della propria superiorità intellettuale, del proprio prestigio sociale e politico e, soprattutto, della buona fede di chi è in uno stato di bisogno, lo scriba si arricchisce ogni giorno di più, ampliando i suoi poteri. Ecco perché – dice il vangelo di Marco – egli dovrà essere maggiormente “condannato”.
Viceversa, Matteo lascia il giudizio nelle mani di “Dio”, in attesa del regno dei “cieli”. Con il suo moralismo ad oltranza egli ottiene l'effetto contrario a quello sperato. L'unico riferimento al denaro Matteo lo fa in termini generici, non specifici: non dice che “derubavano le vedove”, ma che avevano imposto il giuramento per “l'oro del Tempio” (e anche per “l'offerta sull'altare”), affinché il credente si sentisse veramente obbligato. Se qualcuno, durante una lite o una contesa o in un processo indiziario, giurava sul Tempio e poi si scopriva che aveva mentito, non veniva considerato colpevole, ma se aveva giurato sull'oro o sul denaro che nel Tempio veniva offerto ai sacerdoti, subito doveva essere obbligato a pagare ciò su cui aveva giurato. Lo stesso per quanto riguardava l'altare. Gli scribi cioè credevano, così facendo, di rendere più impegnativo il giuramento. Pensavano di porre un freno all'indifferenza e all'opportunismo di quei fedeli che non credevano più nell'autorità morale del Tempio di Gerusalemme e dell'altare, ma che continuavano, per quieto vivere, a servirsi di tali istituzioni.
In pratica, con la loro ipocrisia, gli scribi, pur pretendendo di realizzare un rapporto più stretto fra istituzioni e popolo, non facevano che accentuare l'ostilità che li divideva. Invece di mettere in discussione il “tutto”, cercavano di salvaguardarlo esasperandone alcuni aspetti particolari. Matteo è senza dubbio consapevole di questa contraddizione, ma non sa scorgere i criteri politici per superarla in modo realistico. Egli non mette in discussione il valore in sé del Tempio e dell'altare, ai fini della liberazione sociale, ma solo il loro uso mercificato.
(torna su)9) Il tributo a Cesare e la diarchia dei poteri
Mc 12,13-17
[13] Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso.
[14] E venuti, quelli gli dissero: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?”.
[15] Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: “Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda”.
[16] Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: “Di chi è questa immagine e l'iscrizione?”. Gli risposero: “Di Cesare”.
[17] Gesù disse loro: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. E rimasero ammirati di lui.
*
Se l'episodio narrato da Mc 12,13 ss. fosse effettivamente nato dalle preoccupazioni politico-religiose che le autorità giudaico-romane avevano di costringere Gesù a chiarire esplicitamente la propria posizione nei confronti del potere costituito, è assai dubbio che la sua collocazione spazio-temporale offerta dall'evangelista possa rispecchiare la verità dei fatti.
Durante la seconda (o terza) pasqua di Gesù a Gerusalemme (stando ai vangeli), le autorità giudaico-romane sapevano già bene che del movimento nazareno non potevano fidarsi. Considerando anzi l'importante tema in questione, è più probabile che l'episodio sia accaduto agli inizi della sua attività pubblica, subito dopo che la popolarità acquisita attraverso la predicazione aveva costretto il potere a intervenire (cf Mc 6,14).
Resta tuttavia impossibile credere che da parte dei movimenti ebraici anti-romani ci potessero essere dei dubbi sulla illegittimità del tributo a Cesare. Una domanda di questo genere non poteva che apparire oziosa e la risposta scontata: se qui non lo sono, la ragione va cercata nell'interesse apologetico dell'autore della pericope (Matteo e Luca, come noto, copiano da Marco).
In effetti, quando Marco scrisse il vangelo, la comunità cristiana aveva già rinunciato, da tempo, a realizzare l'obiettivo politico della liberazione nazionale dal dominio romano, e aveva anzi cominciato a maturare l'esigenza di farsi accettare da Roma. A tale scopo era indispensabile che la comunità dichiarasse la propria lealtà nei confronti dell'imperatore, senza però venir meno alla propria identità religiosa, che si era costruita opponendosi in maniera più o meno radicale al giudaismo.
In questo senso il brano in oggetto può essere sorto sotto l'influenza del movimento legato al più grande riformatore giudaico: Paolo di Tarso, il quale, per la prima volta, riuscì a unificare il rispetto (gius-politico) delle istituzioni di governo pagane con la difesa ad oltranza del nuovo concetto cristiano di “Dio-padre”, che voleva porsi in alternativa sia alle concezioni religiose elleniche che a quelle ebraiche tradizionali. Paolo infatti trasformerà il Cristo nell'unico vero “figlio di Dio”, venendo così a scontrarsi col monoteismo assoluto dei Giudei, col politeismo pagano e col processo di autodeificazione in atto da parte degli imperatori romani.
Il fatto che, per queste ragioni, il cristianesimo primitivo venisse duramente osteggiato da pagani ed ebrei, non poteva non suscitare l'impressione (oggi come allora) ch'esso rappresentasse un movimento rivoluzionario. In realtà la diarchia dei due poteri, civile e religioso, sostenuta da Paolo, aveva lo scopo non di abbattere l'imperialismo di Roma, bensì di confermarlo, seppure con la rivendicata autonomia della realtà ecclesiale (il che, per quei tempi, era politicamente inaccettabile da parte dei Romani, abituati a servirsi della religione come instrumentum regni).
Con la svolta costantiniana, infatti, si capirà che la novità culturale del cristianesimo poteva essere tranquillamente accettata, in quanto essa non si sarebbe mai trasformata in una transizione politica verso l'uguaglianza sociale o la democrazia. Sotto questo aspetto ci si potrebbe chiedere se questa pericope possa costituire il fondamento gius-politico della concezione bizantina della diarchia dei poteri.
Ora, prima ancora che qualcuno dica che stiamo forzando i testi, ci teniamo a precisare, in via preliminare, che l'episodio in oggetto va considerato assolutamente privo di attendibilità storica, per tutta una serie di ragioni che vedremo al momento della sua analisi (qui basti dire che solo in chiave del tutto strumentale alla posizione cristiana post-pasquale i redattori han potuto mettere insieme farisei ed erodiani). Tuttavia, se anche il Cristo avesse formulato, in nuce, una teoria di tipo “diarchico”, è assai improbabile ch'egli, con essa, volesse rivendicare la mera autonomia della sfera religiosa dalle ingerenze della sfera politica. Questo semmai può essere considerato un obiettivo democratico e anche culturalmente rivoluzionario del cristianesimo primitivo, essendo in netta controtendenza alla deificazione, allora emergente, della figura imperiale; ma è altresì facile rendersi conto che se il Cristo politico si fosse limitato a questo, egli non sarebbe certo stato più “rivoluzionario” dell'apostolo Paolo, il quale affermava la diarchia non per abbattere il potere istituzionale di Cesare ma, al contrario, per confermarlo.
Neppure ha senso sostenere che il Cristo abbia voluto affermare la diarchia solo in maniera tattica o provvisoria, in attesa di realizzare una rivoluzione politico-nazionale vera e propria: farisei, zeloti, esseni o battisti non avrebbero accettato neppure formalmente alcun confronto paritetico fra Dio e Cesare. Nessun partito di Israele avrebbe voluto pagare il tributo ai Romani, neppure quello più conservatore e collaborazionista dei sadducei.
In realtà la preoccupazione principale del Cristo, quella per cui si trovarono d'accordo nell'eliminarlo sia i Romani che i capi-giudei (timorosi, quest'ultimi, di una devastante ritorsione da parte dell'imperatore), era quella di rovesciare il governo di Pilato, ridimensionando di molto, nel contempo, le pretese integralistiche dei Giudei.
Mc 12,13: Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso.
Qui interviene un duplice potere: quello ufficiale (galilaico) di Erode Antipa, e quello popolare dei farisei, inviati dalle autorità di Gerusalemme. Luca, che era un seguace dell'ex-fariseo Saulo di Tarso, preferisce limitarsi a citare “scribi e sommi sacerdoti”; Matteo invece, che odia mortalmente l'ipocrisia dei farisei, fa di quest'ultimi i responsabili principali dell'interpellanza (anche perché, a ben guardare, non avrebbe avuto senso accusare di “ipocrisia” o “malizia” gli erodiani).
Come noto, infatti, gli erodiani erano dei collaborazionisti (Erode era un vassallo di Roma) ed è ben strano che qui siano “inviati” dagli scribi, che pur essendo ostili a Gesù sin dall'inizio dei vangeli, non avrebbero accettato di compromettersi ufficialmente con gli erodiani: in via di principio essi rifiutavano il dominio di Roma come potenza occupante, anche se, di fatto, vi si adattavano, in attesa della venuta di un messia liberatore. Così erano anche i farisei, che però riscuotevano un certo consenso negli ambienti popolari delle sinagoghe, essendo stati duramente perseguitati sotto il regno di Erode il Grande.
La presenza degli erodiani può far pensare che in origine l'episodio sia avvenuto in Galilea, ove prevalentemente essi risiedevano, ma sarebbe stata davvero improbabile un'interrogazione pubblica di questo genere direttamente rivolta a Gesù: era sufficiente interpellare i suoi discepoli, i quali avrebbero risposto che il tributo i nazareni lo pagavano, seppure obtorto collo. Chi si rifiutava di farlo non veniva interpellato, ma ricercato dai funzionari del fisco.
Se d'altra parte il potere giudaico avesse voluto sincerarsi di persona dell'effettivo pagamento del tributo da parte di Gesù, avrebbe inviato solo gli scribi (come risulta da Mc 3,22 per un'altra questione): e in ogni caso al Sinedrio interessava che Gesù pagasse anzitutto la tassa al Tempio (cf Mt 17,24 ss.) non quella a Roma. Solo Lc 23,2 dirà che davanti a Pilato, al momento del processo, accuseranno falsamente Gesù di “impedire di dare i tributi a Cesare”. Cosa che se fosse stata vera, avrebbe offerto a Pilato un motivo in più per procedere all'arresto motu proprio, senza aspettare che glielo consegnassero grazie a un tradimento.
Nella versione di Mt 22,16 sono stati i farisei a prendere autonomamente l'iniziativa dell'interpellanza e a invitare gli erodiani ad assistere al dibattito. Non è la prima volta che questi due gruppi politico-religiosi, notoriamente nemici per questioni di ordine politico, si trovano d'accordo nei vangeli (sempre sul piano politico, ma per motivi diversi) nel complottare contro Gesù (cf Mc 3,6).
Tuttavia, gli stessi farisei (si veda ad es. una figura democratica come quella di Nicodemo) potevano anche non essere convinti della necessità di pagare il tributo a Cesare, ed è quindi assai dubbio che, rivolgendosi a Gesù in maniera così ufficiale, avrebbero cercato di “coglierlo in fallo nel discorso”. La domanda se pagare o no le tasse a Cesare, un fariseo avrebbe potuto tranquillamente porla a Gesù in privato, per capire s'egli si riteneva il messia tanto atteso oppure no.
Qui invece appare evidente che dietro la domanda da parte delle due rappresentanze politiche, si nasconde una decisione negativa presa già in precedenza nei confronti del leader nazareno, e se questa cosa può apparire normale pensando agli erodiani, non lo è affatto pensando ai farisei, le cui intenzioni qui appaiono esageratamente prevenute. Mettendo farisei ed erodiani sullo stesso piano, gli evangelisti dimostrano di ragionare col senno del poi, per giunta ideologicamente viziato.
Nel racconto, in un certo senso, Gesù appare già come un “vincente”, in quanto, nei confronti degli erodiani, afferma un primato del religioso ch'essi negano, mentre nei confronti dei farisei afferma un valore autonomo, di principio, della politica di Roma, che i farisei erano disposti ad accettare solo de facto, in quel momento, e che soltanto dopo la distruzione di Gerusalemme saranno costretti ad accettare anche de jure.
È singolare il fatto che nella pericope Gesù assuma una posizione contraria più alle aspirazioni indipendentistiche dei farisei che non al collaborazionismo smaccato degli erodiani (contro il quale avrebbe potuto trovare l'appoggio degli stessi farisei). E questo nonostante che l'intenzione redazionale sia quella di mostrarlo al di sopra delle parti.
Mc 12,14: E venuti, quelli gli dissero: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi gli uomini in faccia, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?”.
Qui i farisei e gli erodiani sembrano voler strappare a Gesù una dichiarazione che dia motivo d'accusarlo presso le autorità romane (o filo-romane) o di screditarlo davanti al popolo ebraico (che qui si suppone nemico di Cesare). La forma usata nei due falsi elogi di questo versetto, sembra essere attribuibile, la prima, agli erodiani, la seconda ai farisei. L'ipocrisia dei farisei non può essere identica a quella degli erodiani, nei cui confronti la popolazione ebraica non poteva avere che parole di condanna.
I farisei, che avrebbero potuto trovare in Gesù un loro alleato, appaiono inevitabilmente più ipocriti degli erodiani, per i quali il messia era già venuto nella persona di Erode. Considerando che il movimento facente capo a Gesù era divenuto sempre più consistente e sempre più capace di opporre una valida resistenza alla politica filo-romana di Erode, i farisei avrebbero dovuto preferire una risposta negativa al pagamento del tributo. Standosene invece alleati coi loro rivali, dimostrano di preferire una risposta negativa soltanto per consegnare Gesù al potere del tetrarca. Sinceramente parlando, un atteggiamento del genere appare molto improbabile in un gruppo politico che non aveva affatto scelto di stare dalla parte di Erode, né, tanto meno, da quella di Cesare.
La posizione sfavorevole dei farisei nei riguardi di Gesù è peraltro contraddetta da Lc 13,31, ove si afferma che alcuni di loro avvisarono Gesù di fuggire dalla Galilea perché Erode voleva eliminarlo. Tra l'altro, stando ai racconti di tutti gli evangelisti, essi non compariranno mai nei racconti della Passione, anche se certamente la maggioranza degli scribi presenti nel Sinedrio aderiva al partito farisaico. Va detto però che in Giovanni appaiono al momento della cattura di Gesù.
L'ipocrisia degli erodiani si pone qui a un livello alquanto superficiale, tanto che la loro domanda non potrebbe neppure essere definita come una forma di capziosità: infatti se volevano porla per mettere alla prova una persona scomoda come Gesù, non l'avrebbero fatto in Giudea ma in Galilea, e non alla fine della sua predicazione ma all'inizio.
Più profonda invece è l'ipocrisia redazionale. In effetti, il fatto che qui i farisei vogliano verificare se Gesù ha il coraggio di dire no al tributo in presenza degli erodiani, è emblematico dell'odio che i primi cristiani dovevano provare, dopo la morte di Gesù, nei confronti degli stessi farisei, dimostratisi poco affidabili al momento della tentata insurrezione e del processo, allorché appunto essi assunsero una posizione piuttosto attendista e assai poco responsabile.
In realtà per un fariseo di sane tradizioni ebraiche, il tributo a Cesare non andava assolutamente pagato. Ciò su cui bisognava discutere, per loro, era semmai l'effettiva consistenza del potere giudaico, in virtù del quale gli ebrei avrebbero dovuto opporsi a tale ingiusto fiscalismo. Tuttavia, proprio su questo punto la loro posizione era poco convincente, cioè troppo pessimista per costituire un valido polo di aggregazione.
I farisei erano stati coraggiosi nel passato, ai tempi di Erode il Grande, quando avevano pagato con la vita il loro rifiuto di ellenizzare la cultura ebraica. Ma al tempo di Erode Antipa e di Pilato, la loro forza eversiva era scemata, o comunque era basata, in maniera illusoria, su una “rendita politica” pregressa. È evidente, in questo senso, che già da molto tempo essi dovevano sapere che Gesù non aveva alcuna intenzione di pagare il tributo a Cesare e che, alla prima occasione, egli sarebbe stato intenzionato ad offrire al popolo ebraico l'opportunità di una coerenza pratica rispetto alle generali aspettative di liberazione nazionale. Lo scetticismo dei farisei si evidenziava soprattutto nel fatto ch'essi non ritenevano ancora maturi i tempi per una rivoluzione antiromana.
Al tempo di Gesù esisteva un solo partito per il quale era più che doveroso il rifiuto di pagare il tributo a Cesare: quello degli zeloti, i quali, dopo essersi rifugiati nel deserto, conducevano una guerriglia armata a scopi eversivi. Barabba era uno di loro e così gli altri due estremisti crocifissi con Gesù, giustiziati per aver partecipato a una rivolta pasquale nella Città Santa. E sicuramente tra gli apostoli militavano alcuni ex-zeloti, p.es. Pietro.
I farisei invece avevano abbandonato il terreno eversivo dell'insurrezione, e si erano adattati a una resistenza di tipo soprattutto morale, che non dispiaceva ai ceti sociali medi: di qui la loro relativa popolarità, che però aveva iniziato a entrare in crisi quando si erano acuiti i termini dello scontro giudaico-romano. Già il movimento del Battista li aveva in qualche modo surclassati.
Nei confronti di Gesù i farisei hanno sempre tenuto un comportamento ambiguo, perché da un lato si rendevano conto, memori della loro precedente esperienza, che senza un'opposizione all'imperialismo romano, la Giudea non sarebbe mai stata libera; dall'altro però temevano che il protagonista di questa liberazione dovesse essere un movimento, quello nazareno, estraneo all'ufficialità istituzionale della cultura ebraica (non solo perché esso violava il sabato, ma anche perché contestava talune interpretazioni e applicazioni della legge mosaica, non praticava più certe tradizioni ecc.).
I farisei erano conservatori a livello ideologico, ma – a differenza dei sadducei – sul piano politico cercavano di essere o di apparire progressisti. Essi sapevano bene che né gli erodiani né gli zeloti erano i loro veri antagonisti, ma unicamente il movimento nazareno, che non era né vergognosamente collaborazionista come gli erodiani né irriducibilmente estremista come gli zeloti; il che rendeva anche probabile la ricerca di un'intesa politica.
La domanda relativa al tributo, riportata in questo versetto, appare assurda anche per un'altra ragione. Se Gesù avesse risposto negativamente, le alternative, per lui, sarebbero state due: 1) essere immediatamente arrestato, 2) diventare esplicitamente messia. Ora, un messia che si fa arrestare così ingenuamente, è poco credibile. Ma è forse credibile che un individuo decida di diventare messia solo dopo aver risposto a quella domanda? Peraltro che senso avrebbe avuto porre una domanda del genere (in quelle modalità) a un individuo che non avesse già chiaramente manifestato una caratterizzazione messianica? Ma se il Cristo impressionava per la sua carica messianica (non a caso gli riconoscono l'onestà e la schiettezza nella sua predicazione), possibile che su una questione di così capitale importanza, gli avversari non sapessero già come la pensava? possibile ch'egli non avesse già manifestato la sua opinione? ed è forse possibile (come vedremo) ch'egli, in tale contesto, assumesse una posizione così ambigua?
In realtà gli erodiani da tempo sapevano che il Cristo era un personaggio molto scomodo (certamente non meno di quel Battista che Erode aveva fatto giustiziare): in Mc 3,6 essi si trovano pienamente d'accordo coi farisei sulla decisione di farlo morire. O meglio, gli erodiani lo vogliono morto per motivi politici, in quanto Gesù gode di troppa popolarità; i farisei invece lo vogliono morto per motivi ideologici, in quanto, con la sua predicazione mina le fondamenta dell'establishment e delle tradizioni giudaiche. È altresì da escludere che gli erodiani volessero morto Gesù semplicemente perché chiedeva di non pagare le tasse: la decisione di costituire un movimento politico, quello nazareno, non era nata col proposito precipuo di non pagare le tasse ai Romani, anche se certamente questo era un obiettivo della liberazione nazionale, un modo per opporsi allo straniero invasore.
Gli inquirenti pongono la questione del tributo in due modi diversi: 1) in rapporto alla liceità del fatto, 2) in rapporto alla sua necessità. Si può in un certo senso dire che, mentre per i farisei è in dubbio la liceità del fatto, per gli erodiani si tratta soltanto di costatarne la necessità.
La visione politica degli erodiani è più schematica e semplicistica, in quanto si avvale dei soli rapporti di forza: che Gesù pagasse o no le tasse, restava comunque una persona politicamente indesiderabile. Qui l'autore del racconto ha voluto far risaltare una forma d'ipocrisia che nella fattispecie era impossibile. Non ha infatti senso che essi, pur sapendo benissimo quanto Cesare fosse forte, ne chiedessero a Gesù la conferma, onde assicurarsi una dichiarazione di sottomissione. Un messia che pretende d'essere “veritiero” e “imparziale”, non avrebbe mai dato loro alcuna soddisfazione e un partito collaborazionista come il loro non avrebbe avuto bisogno di appurare se il Cristo fosse o no un “vero” messia.
In pratica è come se gli avessero detto: “La tua verità e la tua imparzialità hanno valore solo nella misura in cui paghi le tasse a Cesare”. Uno zelota, a questo punto, avrebbe potuto sostenere esattamente il contrario: “Chi è costretto a pagare le tasse a un governo straniero non potrà mai pretendere d'essere pienamente veritiero e imparziale”.
Nel contesto tuttavia l'autore cristiano vuole dimostrare un'altra cosa, e cioè che Gesù è veritiero e imparziale anche se paga tranquillamente le tasse a Cesare, e non perché egli ha in mente di non pagarle quando verrà il momento opportuno (quello dello scoppio rivoluzionario), quanto perché il versamento del tributo allo straniero non va più considerato in contraddizione con la liberazione meramente spirituale dell'individuo (quella propagandata dal movimento petro-paolino).
Di conseguenza, se agli occhi degli erodiani Gesù avesse accettato di esporsi, pagando il tributo a Cesare e smettendo così di rappresentare un pericolo pubblico, nel racconto evangelico non avrebbe dovuto aver paura di compromettersi, in quanto la sua teoria diarchica obbligava a versare il tributo senza problemi di coscienza. Dunque gli erodiani sarebbero stati “maliziosi” senza ragione; la loro domanda nasceva da un puro e semplice malinteso...
Ovviamente una considerazione del genere non ha alcun senso, altrimenti non staremmo qui a parlare di un Cristo politicamente eversivo. Se vogliamo, le due suddette forme della domanda sarebbero state più appropriate se fossero state attribuite a un unico gruppo politico, quello appunto farisaico, ancora indeciso su quale coerenza tenere nei confronti dei propri ideali di liberazione. Ma, di nuovo, una domanda del genere i farisei avrebbero dovuto porla all'inizio della predicazione di Gesù, quando ancora non sapevano la sua risposta, che non poteva che essere la seguente: “il tributo va pagato fin quando è possibile farne a meno”.
I farisei amavano discutere sui princìpi: per loro una cosa diventava necessaria, reale, solo quando ne veniva dimostrata sul piano concettuale la giustezza. E ovviamente obbedivano a Cesare per necessità, non per virtù, pagandogli le tasse controvoglia, nella convinzione di non avere alternative praticabili.
Per questa ragione assai difficilmente avrebbero potuto considerare Gesù come loro messia, s'egli li avesse convinti della giustezza di pagare le tasse a Cesare; e se si aspettavano che cercasse di convincerli della non liceità di quel pagamento, non si capisce perché loro abbiano chiesto agli erodiani di assistere al dibattito. “Cogliere in fallo” Gesù qui altro non può voler dire che approfittare di qualche sua dichiarazione pubblica per denunciarlo alle autorità costituite (che in Galilea erano appunto quelle erodiane), di fronte alle quali, per non essere arrestati, bastava rispondere ch'era ovvio dare il tributo a Cesare, proprio a motivo della forza militare con cui i Romani erano in grado d'imporlo: dove c'è la necessità dei fatti non si pone neppure la questione della loro legittimità. Gli erodiani la pensavano appunto così.
I farisei tuttavia sapevano bene che quella necessità era illegittima al 100%, per cui in nessun modo avrebbero potuto porre una domanda del genere al cospetto degli erodiani, a meno che non avessero rinunciato definitivamente a liberare Israele, ma con quello che avevano sofferto sotto Erode il Grande, padre dell'Antipa, è assai dubbio che in quel momento fossero già arrivati a questa conclusione. Sino al 70 d.C. essi continuarono a sperare in una liberazione nazionale e non a caso furono i principali oppositori di Saulo di Tarso.
Si noti peraltro che nella domanda dei farisei si fa distinzione tra liceità (morale) e obbligatorietà (politica) del tributo a Cesare, come se per loro la necessità potesse trovare la propria giustificazione morale nella liceità: una cosa diventa “necessaria” non quando s'impone con la forza ma quando tranquillizza la coscienza con la propria giustezza. Paradossalmente quindi se il Cristo avesse detto ch'era “giusto” pagare i tributi al nemico, i farisei avrebbero dovuto dedurre o che Cesare andava rispettato in tutto e per tutto (come facevano gli erodiani), o che Gesù non era il messia che attendevano. Ma in questo secondo caso non avrebbe avuto senso chiamare gli erodiani come testimoni del dibattito: se i farisei avessero disconosciuto la messianicità di Gesù tra i Galilei, sarebbero stati loro stessi in pericolo nei confronti degli erodiani, proprio in quanto avrebbero fatto capire d'attendere un messia diverso non solo da Gesù ma anche dall'Antipa.
Questa pericope non risulta attendibile da alcun punto di vista. Supponiamo che erodiani e farisei si attendessero da Gesù un giudizio di merito sulla liceità del tributo. Che cosa ottengono? Un giudizio di fatto sulla necessità politica di pagarlo. Cioè il giudizio, che tiene conto della realtà dei fatti e quindi della sua necessità e che, in tal senso, rassicura gli erodiani, poteva forse soddisfare le esigenze dei farisei? No, e infatti in aggiunta all'affermazione di dover pagare le tasse al nemico, il redattore è costretto a far dire a Gesù che bisogna rendere un culto pieno a Dio: col che si ha l'impressione che se le esigenze politiche dei farisei non potevano essere soddisfatte, potevano però esserlo quelle di tipo religioso, sempre che loro si fossero accostati al Cristo senza “malizia”.
Tuttavia anche questa interpretazione è del tutto fantasiosa. Gesù voleva cacciare i Romani dalla Palestina, non avrebbe mai sostenuto che in luogo di questo obiettivo politico sarebbe stato sufficiente affermare la separazione di Stato e Chiesa, di politica e religione. Questo obiettivo non era neppure desiderato dai farisei, che pensavano invece a una sottomissione della politica alla religione. Qui Gesù appare in alternativa sia al “papocesarismo” farisaico che al “cesaropapismo” erodiano, in nome di una distinzione dei poteri istituzionali, tale per cui ognuno deve conservare la propria autonomia. Questa posizione non è mai stata sua ma semmai di Paolo.
Una tesi del genere, quella della diarchia dei poteri istituzionali, in quel momento non avrebbe potuto accontentare i farisei, perché assai poco politica nella sua “religiosità”, né avrebbe potuto infastidire gli erodiani, i quali, essendo di origine ebraica, non avrebbero avuto alcuna difficoltà a negare una stretta identificazione di Jahvè e Cesare. Dunque una risposta come quella riportata nei Sinottici non poteva avere come interlocutori nessuno dei due partiti ebraici, ma solo ed esclusivamente l'autorità romana. Marco si è servito di una controversia fittizia per mandare un messaggio ai pagani che spadroneggiavano nel Mediterraneo, che miravano ad equiparare Dio a Cesare e che avevano a che fare coi cristiani fuoriusciti dalla Palestina in fiamme, dopo la catastrofe del 70. La risposta di Gesù vuole essere diplomatica, si pone come offerta di una trattativa politica, in cui una delle due parti – la Chiesa – rinuncia a fare politica, chiedendo però l'autorizzazione a credere in un Dio diverso da quello pagano.
Mc 12,15: Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: “Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda”.
La risposta non voleva solo essere conciliante nei confronti dell'autorità romana, ma anche chiaramente orientata a far capire che tra Giudei e cristiani vi era un abisso nelle posizioni di tipo politico.
Il “tributo a testa” (testatico) imposto dai Romani nel 6 a.C., dopo il censimento di Quirinio, non era particolarmente gravoso (un denario d'argento), ma poteva essere inteso come riconoscimento del dominio pagano sul popolo che si considerava “eletto”. Sulla moneta peraltro era scritto che Tiberio era “figlio del divino Augusto”. Dal 6 a.C al 4 d.C. erano avvenuti vari censimenti romani in Siria, Galilea e Giudea, tutti rifiutati da quei Galilei e farisei che poi costituirono il partito zelota, di cui ben duemila furono crocifissi al tempo di Quintilio Varo (lo stesso governatore della successiva catastrofe romana nella foresta di Teutoburgo). Più di seimila farisei avevano rifiutato il giuramento ad Augusto al tempo di Saturnino, legato di Siria.
La richiesta ai farisei di mostrargli una moneta sembra avere come scopo quello di attestare non la giustezza dei fatti ma la loro necessità. Si noti come in questa differenza si celi la mistificazione operata dalla comunità post-pasquale ai danni del messaggio originario del Cristo. Quando una cosa è necessario farla (in questo caso pagare la tassa) e quando questa cosa non riguarda la libertà di coscienza (in quanto non viene richiesto di credere in un Dio diverso dal proprio), non c'è motivo di opporvisi. Questa la mistificazione.
Un qualunque ebreo della Palestina di duemila anni fa, anche se fosse stato un collaborazionista, avrebbe sostenuto che la costrizione a pagare le tasse al dominatore straniero gli impediva d'essere libero a pieno titolo, sia come cittadino che come credente. Qui invece gli evangelisti vogliono far capire che non vanno affatto considerati come incompatibili la necessità di pagare le tasse allo straniero e la possibilità di vivere pienamente la propria fede religiosa.
Viene cioè esclusa categoricamente l'idea che il giudeo oppresso dovesse adattarsi solo transitoriamente alle negative circostanze, in attesa di trovare il momento favorevole per passare all'offensiva. L'idea che qui viene propagandata è quella di una religiosità astratta, metafisica, del tutto sganciata dalla contingenza politica di un determinato momento storico. Non si propone un modello integralistico, come quello farisaico, in cui la politica era subordinata alla religione, ma neppure un modello democratico, in cui contro un governo di oppressione bisognava far valere l'esigenza di un governo di liberazione nazionale.
Nella risposta di Cristo è evidente il compromesso tra ebraismo spiritualizzato e paganesimo individualista: il cittadino-cristiano si pone, di fronte allo Stato romano, come singolo credente, che fa della propria religione un mezzo per sfuggire alle contraddizioni sociali e politiche della vita quotidiana.
A sostegno di questa interpretazione della pericope ci viene la risposta che il Cristo dà a una domanda dal sapore analogo in Mt 17,24-27, ove egli spiega che gli “estranei”, dovendo pagare (ingiustamente) le tasse ai re che li opprimono, lo fanno solo per amor di pace, fiduciosi nella divina provvidenza.
Paolo addirittura sosterrà (Rm 13,1 ss.) che il rispetto dovuto alle istituzioni è cosa che riguarda non solo il “dovere” ma anche la “coscienza”, a condizione ovviamente che lo Stato non imponga al credente un'ideologia incompatibile con la propria fede. Col che in sostanza si apriva involontariamente la strada alla possibilità che un credente potesse obbedire a uno Stato confessionale, espressamente cristiano, anche nel caso in cui detto Stato tutelasse legalmente lo schiavismo o il servaggio.
Mc 12,16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: “Di chi è questa immagine e l'iscrizione?”. Gli risposero: “Di Cesare”.
In questo versetto sta la chiave per comprendere la mistificazione del successivo e di tutta la pericope. Qui si vuole per così dire imporre l'esistenza di un potere oggettivo, imprescindibile. La moneta non appartiene forse a chi comanda? Ebbene chi la usa deve necessariamente obbedirgli. Sembra di assistere a un insegnamento di realismo politico in opposizione alle concezioni utopistiche della vita.
È necessario obbedire a Cesare non perché giusto ma perché necessario, in quanto inevitabile. Il suo potere è una struttura permanente della storia: si può contestare, come cittadini, l'abuso di questo potere, ma non si può mettere in questione la realtà, l'oggettività di questo potere. Anche quando il potere viola la libertà di coscienza, imponendo la propria ideologia, la resistenza non può mai tradursi in un rovesciamento istituzionale di questo potere (cfr 1Pt 2,20). La resistenza cristiana può essere solo “passiva”; pertanto, se il tributo a Cesare è sempre necessario, esso è anche lecito, proprio perché così vuole la natura delle cose.
Quando poi il Cesare pagano si trasformerà, a partire da Costantino e Teodosio, nel “Cesare cristiano”, l'obbedienza non sarà dovuta solo per motivi di forza superiore, ma anche per motivi di coscienza. Anzi, visto che questi motivi Paolo li prevede anche nei confronti di un sovrano pagano, bisognerebbe aggiungere quelli basati sul convincimento ideologico.
Dunque alla domanda su chi appartenga l'immagine e l'iscrizione stampigliata sulla moneta, la risposta che danno gli erodiani è ovviamente la stessa di quella dei farisei, e si può tradurre nella maniera seguente: “del più forte”. Tuttavia, una certa sfumatura avrebbe anche potuto esserci. Infatti, a detta dai farisei, la risposta poteva anche voler dire una cosa leggermente diversa: “in base a quello che affermerai noi capiremo se dobbiamo obbedire al solo Tiberio, effigiato in questa particolare moneta, oppure anche a qualunque altro imperatore che vorrà dominare in Palestina”.
I redattori cristiani hanno per così dire “respinto” entrambe le posizioni, poiché quella erodiana era troppo scarsa sul piano religioso, mentre quella farisaica risultava troppo equivoca su quello politico. Il partito erodiano risultava per i cristiani più coerente a livello politico, in quanto sosteneva che la proprietà del più forte andava rispettava senza indagare se era stata guadagnata lecitamente o no; di conseguenza bisognava obbedire non solo a Tiberio ma anche a qualsiasi altro futuro imperatore. Solo che questo partito considerava Erode il messia tanto atteso e di Cesare non metteva in discussione la pretesa divinizzazione.
I cristiani di origine ebraica, che sicuramente risultavano ancora in maggioranza nelle comunità espatriate dalla Palestina dopo la catastrofe del 70, non potevano identificarsi con gli erodiani, anzi avvertivano nettamente l'esigenza di differenziarsi da loro proprio per motivi religiosi.
D'altro canto i farisei, pur essendo più attenti a non riconoscere ad alcun sovrano pagano una qualsivoglia connotazione religiosa e a fare della religione una vera e propria regola di vita, erano ancora intenzionati a realizzare politicamente una Palestina in cui il giudaismo fosse la componente fondamentale dello Stato confessionale. E lo saranno sino all'ultima guerra, quella del 132-135 d.C. I redattori cristiani presentano entrambi i partiti come oppositori irriducibili del cristianesimo.
Il messaggio della pericope era ovviamente diretto non a un lettore ebraico ma a uno pagano, che doveva essere rassicurato sull'affidabilità politica del cristiano nei confronti delle istituzioni romane dominanti, e al quale bisognava anche chiarire che tra pagano e cristiano esisteva una diversità relativa alla libertà di coscienza e quindi ai rapporti tra Stato e Chiesa. Il cristiano era “monoteista” e non ammetteva la divinizzazione dell'imperatore: su questo non si poteva transigere.
Il cristiano avrebbe obbedito, come cittadino, alle leggi dello Stato pagano senza compromettere la propria coscienza nelle questioni politiche, a meno che queste non interferissero in quelle religiose. E finché resteranno in vigore le persecuzioni imperiali, i cristiani rinunceranno all'idea di poter costruire un regno politico-religioso nell'orizzonte storico-temporale (il nazionalismo teocratico così caro ai farisei). Solo dopo la svolta teodosiana, si avrà anche questa pretesa di derivazione “ebraica”.
Mc 12,17 Gesù disse loro: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. E rimasero ammirati di lui.
La risposta cristiana messa in bocca a Gesù va considerata in due modi: formale e sostanziale. Sul piano formale o giuridico Dio e Cesare vengono considerati come equivalenti; sul piano sostanziale o metafisico come due realtà differenti.
Cesare non è Dio e non può diventarlo, anche se, al momento della stesura dei vangeli, ne aveva sempre più la pretesa (“Tiberio, Cesare, figlio del divino Augusto, pontefice”, così era scritto sulle monete, e in Siria addirittura: “figlio dell'augusto Dio”). Finché Cesare resta nei suoi limiti umani, l'obbedienza gli è dovuta a prescindere da ciò che politicamente compie (cfr 1Pt 2,17 e Rm 13). Infatti qualunque azione negativa egli possa compiere, esclusa quella di porsi come “signore” (kyrios), il cristiano deve accettarla con rassegnazione, come una sorta di messa alla prova della propria virtù, nella convinzione che la vera liberazione dal male sarà possibile solo nel “regno dei cieli”, al punto che chi rifiuta di obbedire a Cesare si oppone a Dio. La teologia petro-paolina, su questo, è tassativa.
Gli ordinamenti civili ed ecclesiastici devono convivere nella medesima società, non vanno né confusi né posti in alternativa. L'uno presuppone l'altro, ed è la storia stessa che lo esige: è la legge della diarchia, che tanta fortuna avrà nell'impero bizantino sino alla caduta di Costantinopoli, e che invece nell'area occidentale dell'impero verrà costantemente messa in discussione dal cesaropapismo degli imperatori e dal papocesarismo della Chiesa romana.
Quando s'imporrà, a partire da Teodosio, lo Stato confessionale e la Chiesa di stato, non ci sarà neppure bisogno di sdoppiarsi in cittadini davanti allo Stato e credenti davanti alla propria Chiesa: si sarà ideologicamente cristiani in maniera del tutto naturale, anche se non tarderanno a svilupparsi le eresie e le contestazioni monastiche. La diarchia resterà (nell'oriente ortodosso) solo nel senso che lo Stato eserciterà funzioni eminentemente politiche e non farà dipendere la propria autorità dal consenso della Chiesa, mentre a questa verranno attribuite funzioni di tipo esclusivamente religioso: cosa che invece l'occidente latino, già a partire dal V secolo, farà molta fatica ad accettare, avendo la Chiesa romana ambizioni squisitamente politiche, tese a realizzare un proprio Stato.
Con la diarchia espressa in questa formula evangelica (che, per quanto democratica o diplomatica sia, non può essere stata formulata da un Cristo ateo e politicamente rivoluzionario), ci si poteva opporre sia alla politicizzazione della fede che alla clericalizzazione della politica. Se nei confronti di Dio si agisce come credenti e nei confronti dello Stato come cittadini, non v'è contraddizione, proprio perché la dualità degli ordinamenti va accettata come un dato di fatto storico, come una realtà indiscutibile in cui s'è chiamati a vivere. Se poi Cesare è addirittura ideologicamente “cristiano”, meglio ancora: l'identificazione tra credente e cittadino sarà ottimale.
Al momento della stesura della pericope non si poteva ovviamente immaginare che un giorno lo stesso Cesare sarebbe diventato “cristiano”, e tuttavia la diarchia (o “sinfonia”) che ivi si afferma non era destinata ad avere un valore soltanto per il rapporto Stato pagano / Chiesa cristiana. Essa, di fatto, avrà un valore anche per il rapporto Stato cristiano / Chiesa cristiana. In ambito ortodosso, infatti, quello della Chiesa greco-bizantina e slava, si sapranno distinguere in maniera sufficiente gli aspetti ideologico-confessionali da quelli politico-istituzionali, nel senso che, almeno sul piano teorico, si eviterà di subordinare il civile al religioso o questo a quello.
Naturalmente i fatti storici non rispecchieranno quasi mai questi princìpi teorici, sia perché la Chiesa (ortodossa e cattolica) si servirà spesso della forza dello Stato per eliminare il dissenso religioso (le eresie), sia perché in oriente gli imperatori cercheranno a più riprese, senza peraltro riuscirvi, di sottomettere alla loro volontà la realtà ecclesiastica, sia perché in occidente il papato vorrà al più presto porsi in antagonismo a qualunque forma di gestione del potere non strettamente vincolata all'autorità politica della Chiesa romana. Di fatto ciò che s'imporrà, sia a est che a ovest dell'ecumene cristiano, sarà un regime compromissorio in cui varrà, come regola, la reciproca strumentalizzazione.
Ora, per riassumere, il programma politico espresso in questa pericope, si può descrivere nei seguenti termini:
1. con Cesare, che rappresenta lo Stato, il credente non deve avere che un rapporto di obbedienza, cioè gli deve rendere il rispetto dovuto non solo per timore ma anche per ragioni di coscienza, poiché così vuole l'ordinamento divino;
2. ciò che più conta per il cristiano è il rapporto con Dio, che non è un semplice rapporto di obbedienza ma d'amore, quindi qualsiasi pretesa di Cesare d'essere venerato o addirittura adorato come una divinità, resta inaccettabile;
3. benché con Cesare, in quanto Stato pagano, sia bene per il credente non avere un rapporto di tipo “personale”, onde non lasciarsi coinvolgere in questioni di potere, che potrebbero ledere la serenità della sua coscienza religiosa, ciò non impedisce al credente di fare tutto quanto sia utile allo Stato perché possa governare nel miglior modo possibile;
4. in qualità di cittadino, il cristiano può opporsi, appellandosi ai diritti civili, agli abusi del potere istituzionale, ma non potrà farlo con lo spirito rivendicativo di chi vuole distruggere l'ordinamento costituito, al fine di sostituirlo con un altro. Sul piano politico il cristiano lotterà soltanto per una progressiva democratizzazione dell'esistente, nella consapevolezza che verità e libertà esistono, nella loro pienezza, soltanto in una dimensione ultraterrena.
L'ambiguità sottesa al principio diarchico (detto anche “dualistico”, in opposizione a “monistico”), affermato dal Cristo nella pericope in oggetto, è stata dunque resa possibile perché s'è dovuto tener conto, mistificandolo, di un messaggio gesuano originario dal contenuto altamente umanistico, in stretto riferimento alla valorizzazione della libertà di coscienza; un messaggio che, essendo stato tradito negli obiettivi politici che si prefiggeva, ha subìto una chiara involuzione mistica. Tale tradimento va appunto considerato come fonte principale della trasformazione dell'idea di “coscienza umana” in “coscienza religiosa”.
Nella sua variante petro-paolina, che è in fondo un compromesso tra quella parte del partito nazareno divenuta riformista e quella parte del partito farisaico divenuta spiritualista, il cristianesimo primitivo ha preteso la distinzione tra Dio e Cesare, proprio perché aveva rinunciato definitivamente all'idea di uomo naturale, capace di lottare contro l'oppressione e lo sfruttamento, capace quindi d'impedire che il concetto di “divinità” diventasse il sostituto, sublimato, di qualcosa che, in quanto ebrei, si era desiderato senza però ottenerlo.
In pratica è stata proprio la valorizzazione dell'umano prodotta dal Cristo che ha permesso ai suoi seguaci di utilizzarla in maniera mistificata in chiave religiosa, senza per questo dover dipendere dalla tradizione ebraica, che mal avrebbe sopportato l'idea di separare l'istanza religiosa dall'indipendenza politico-nazionalistica.
Per poter elaborare un concetto universale di “Dio”, che andasse al di là di ogni tradizione e confine geografico, occorreva aver assistito, se non anche partecipato, a un forte sviluppo della coscienza umana, facendo però in modo che tale coscienza si sentisse realizzata in se stessa, senza dover ricorrere ad alcun luogo particolare che le facesse da supporto, come p.es. l'intera nazione israelitica, oppressa dall'imperialismo romano. Per affermare una coscienza umana astratta, universalmente valida, la mistificazione cristiana ebbe necessità di prendere dall'ebraismo l'attenzione per le questioni sociali e dal paganesimo l'illusione della fede religiosa. L'idealismo cristiano, che si esprimerà prima in chiave teologica, poi filosofica, è tutto qui, ed esso va superato in due direzioni: umanesimo laico e socialismo democratico.
(torna su)10) Cristo ateo o folle?
Gv 5
[1] Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
[2] V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici,
[3] sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.
[4] Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto.
[5] Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato.
[6] Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: “Vuoi guarire?”.
[7] Gli rispose il malato: “Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me”.
[8] Gesù gli disse: “Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina”.
[9] E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato.
[10] Dissero dunque i Giudei all'uomo guarito: “È sabato e non ti è lecito prender su il tuo lettuccio”.
[11] Ma egli rispose loro: “Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina”.
[12] Gli chiesero allora: “Chi è stato a dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?”.
[13] Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo.
[14] Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: “Ecco che sei guarito; non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio”.
[15] Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo.
[16] Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato.
[17] Ma Gesù rispose loro: “Il Padre mio opera sempre e anch'io opero”.
[18] Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
[19] Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa.
[20] Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati.
[21] Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole;
[22] il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio,
[23] perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
[24] In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
[25] In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno.
[26] Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso;
[27] e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo.
[28] Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno:
[29] quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.
[30] Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
[31] Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera;
[32] ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace.
[33] Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità.
[34] Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi.
[35] Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce.
[36] Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
[37] E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto,
[38] e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato.
[39] Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza.
[40] Ma voi non volete venire a me per avere la vita.
[41] Io non ricevo gloria dagli uomini.
[42] Ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio.
[43] Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste.
[44] E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo?
[45] Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza.
[46] Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto.
[47] Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?”.
I
La domanda che sorge spontanea, alla lettura di Gv 5, è: “davvero il Cristo può aver usato un linguaggio del genere?”. Alla luce della moderna esegesi critica oggi possiamo tranquillamente rispondere di no: in nessun modo può aver parlato in termini così mistici. Tuttavia se un approccio laico al testo dovesse limitarsi a questa banale constatazione, traendo la conclusione ch'esso, a prescindere dal suo contenuto semantico, è retto da un impianto linguistico che lo rende del tutto inutile a una comprensione adeguata dell'evento-Cristo, noi avremmo fatto un regalo all'esegesi confessionale, anche nei confronti di quella che nega un realismo storico all'episodio ivi narrato.
Se esaminassimo il testo da un'angolazione strettamente religiosa e volessimo evitare di considerare l'uomo-Gesù un esaltato che si equipara a Dio, dovremmo far nostro il punto di vista dei redattori cristiani, per i quali la natura divino-umana rendeva titolato il Cristo, in senso unico nell'orizzonte storico, a far valere quella identificazione. Ma questo punto di vista – come noto – è tautologico, in quanto dà per scontato ciò che non può dimostrare. L'evento della tomba vuota inteso come “resurrezione” fu semplicemente un'interpretazione, non un fatto incontrovertibile.
Se invece esaminiamo il testo sul piano laico-umanistico, avvalorando la tesi della improponibilità storica di un linguaggio così marcatamente teologico, quello che dobbiamo cercare di capire è se l'identificazione con Dio serviva all'uomo-Gesù per sostenere delle opinioni religiose non convenzionali, rispetto alle certezze di fede dominanti, nel senso cioè che aveva intenzione di affermare una diversa concezione della realtà duale (uomo-dio), in cui l'identità di Dio andava considerata “prossima” a quella umana e non “totalmente altra”, alla maniera ebraica, oppure se quello era l'unico modo, in quel contesto socioculturale, caratterizzato da una forte religiosità, per negare alla divinità qualunque esistenza in vita, mostrando che l'unico Dio esistente è lo stesso essere umano.
In altre parole ci si può chiedere se l'identificazione con Dio sia un trucco della mistificazione redazionale, che l'ha usata per stravolgere un discorso originario, esplicitamente favorevole all'ateismo, oppure se quella identificazione va considerata come un escamotage intelligente dello stesso Gesù, attraverso cui, riducendo Dio a un uomo si faceva dell'uomo un Dio di se stesso.
Vien detto nei vangeli e nel quarto in particolare che gli ebrei han sempre ritenuto che Gesù bestemmiasse proprio perché si “faceva uguale a Dio”, cioè uguale a un Dio del tutto inaccessibile: una stretta identificazione del genere, anche facendo salva la diversità parentale di Padre e Figlio, inevitabilmente portava a formulare l'accusa di ateismo, anzi di folle e indegno ateismo, di vergognosa blasfemia.
Sotto questo aspetto bisognerebbe chiedersi quante possibilità avrebbe potuto avere Gesù d'essere capito, usando la suddetta identificazione: per un ebreo poteva aver senso la nozione di “figli di Dio” solo in maniera traslata, esattamente come quella di “figli di Abramo”. Tutto il popolo si sentiva compartecipe della divinità. Ma farsi strettamente “uguali” a Dio voleva dire un'altra cosa: difficilmente un ebreo avrebbe potuto interpretarla in un senso favorevole all'esistenza di Dio.
Nei termini in cui il discorso appare nel testo, Gesù non avrebbe avuto alcuna possibilità d'essere capito, e non solo da un avversario politico ma neppure da un proprio seguace. Cioè fino a quando il farsi uguale a Dio veniva detto nel senso generico che ogni credente è “figlio di Dio”, il dialogo poteva anche continuare (benché raramente l'ebreo andasse oltre l'espressione di “figli di Abramo”); ma sarebbe stato impossibile non far sorgere gravi dubbi quando con quella uguaglianza si voleva sostenere che non esiste alcun Dio indipendente dall'essere umano; e si sarebbe letteralmente finiti nello scandalo se si fosse voluto far credere, alla maniera cristiana, che quella uguaglianza andava intesa nel senso esclusivo che solo il Cristo, tra tutti gli uomini, era “come Dio”.
Se si accettava un “Cristo politico”, forse si poteva anche accettare un “Cristo ateo”, ma se lo si rifiutava, fino a che punto si poteva condividere l'idea che fosse un soggetto “divino-umano”? Affermare l'idea di una stretta “consustanzialità”, sarebbe parsa un'insopportabile assurdità anche a chi s'attendeva, peraltro in maniera inspiegabile, un messia “figlio di Dio”. Infatti un'attesa del genere non sarebbe potuta andare oltre un certo livello umano di immaginazione, a meno che il Cristo non avesse cercato di dimostrare pubblicamente la propria origine divina con segni e prodigi assolutamente impensabili per qualunque mente umana.
In verità i redattori cristiani di questo vangelo più volte hanno cercato di servirsi del genere letterario delle guarigioni miracolose o dei prodigi spettacolari per dimostrare agli ebrei che il Cristo era davvero il figlio di Dio, ma più che altro lo hanno fatto con intenti antisemitici, cioè per addossare ai Giudei tutta la responsabilità del fraintendimento delle parole del Cristo, del misconoscimento della sua natura divino-umana, mostrando ch'essi non avrebbero creduto neppure s'egli avesse resuscitato dei morti sotto i loro occhi.
Quindi in questo racconto c'è qualcosa di più complesso. La matassa è stata volutamente ingarbugliata e ora dobbiamo trovarne il bandolo.
Al cospetto di un giudeo il Cristo sarebbe apparso ateo sia se avesse negato l'esistenza di Dio (come p.es. facevano il naturalismo milesio, Empedocle, Anassagora, l'atomismo, Leucippo, Democrito, i cirenaici, Epicuro, Lucrezio e tanti altri filosofi e scienziati dell'antichità), sia se avesse affermato d'essergli uguale. Con la differenza che nel primo caso tutti l'avrebbero accusato semplicemente d'ateismo (il che, comunque, per la mentalità dell'epoca restava grave); nel secondo invece si sarebbe aggiunto ch'era folle e bestemmiatore e quindi meritevole di morte. Un ebreo, anche se fosse stato discepolo di Gesù, non avrebbe mai potuto accettare un'uguaglianza “esclusiva” con Dio, perché l'avrebbe comunque considerata un ingiustificato abuso.
Ma se questa dichiarazione d'uguaglianza è stata scritta per essere letta da un cristiano, cioè da uno che già crede nella “resurrezione”, che valore persuasivo potrebbe mai avere? Un qualunque cristiano sarebbe stato indotto a interpretarla, in maniera molto naturale, come una professione esplicita di teismo, espressa da un soggetto che, essendo il figlio unigenito del Dio-padre, sapeva quello che diceva. L'inevitabilità di questa interpretazione sta appunto nel fatto che il cristiano non ha bisogno che qualcuno gli dimostri la verità di una cosa trascendente in cui lui già crede. Non dimentichiamo che la stesura definitiva di questo vangelo viene fatta risalire dagli esegeti a ben oltre mezzo secolo dalla crocifissione, quando la predicazione petro-paolina s'era già abbondantemente imposta su tutte le altre.
Dunque, come si può notare, qui siamo in presenza della possibilità di dare una lettura esegetica del tutto opposta a quella confessionale: sia perché quella identificazione non può essere stata formulata per convincere un ebreo a credere in una diversa interpretazione della divinità, sia perché essa non può essere stata formulata neppure per convincere un cristiano, poiché, per essere ritenuta vera, essa presume una fede che il cristiano ha già.
Ma allora che senso ha quella identificazione di uomo-dio? A chi era rivolta? Può davvero essere stata espressa nei termini evangelici che conosciamo? E in ogni caso è ancora possibile risalire alla sua versione originaria?
Qui si ha l'impressione che i redattori abbiano usato un'originaria professione di ateismo in cui Gesù poneva un'identificazione con Dio non per essere interpretata come una sua appartenenza esclusiva alla divinità, ma come un invito rivolto a tutti gli uomini a concepirsi come divinità di loro stessi. Si è usata una egualitaria professione di ateismo, aperta a tutti gli uomini, per rovesciarla in una privilegiata professione di teismo, riservata a uno solo.
Tale mistificazione non può essere stata elaborata in ambienti esclusivamente cristiano-pagani, benché sicuramente abbia risentito di influssi di tipo ellenistico. I redattori avevano probabilmente sotto mano un testo semitico (l'originale giovanneo), che hanno manipolato offrendo del Cristo un'immagine mitologica, assolutamente antitetica a qualunque influenza giudaica sul cristianesimo. Per poter compiere una operazione falsificante così raffinata i redattori non potevano certo essere degli sprovveduti in materia di “mentalità ebraica”. Non è da escludere che tale falsificazione sia stata operata dagli stessi discepoli dell'evangelista.
II
Nel vangelo di Giovanni, in maniera esplicita, Gesù dichiara la sua uguaglianza con Dio quando decide pubblicamente che non avrebbe rispettato il precetto del sabato se avesse incontrato una situazione di bisogno. E l'esempio di bisogno che propone di considerare è sempre uno di quelli molto gravi, in quanto il malato risulta ufficialmente inguaribile.
Col che i redattori credono di potergli evitare di cadere nella trappola che avrebbe potuto porgli un fariseo, secondo cui non poteva certo essere un privato cittadino a decidere quando la soddisfazione di un bisogno, per quanto grave fosse, andasse considerata prioritaria nei confronti del rispetto della legge.
Il punctum dolens della controversia sta proprio in questo, che i redattori cristiani, affrontando la questione sociale e politica in termini meramente religiosi, dopo aver attribuito al Cristo dei superpoteri terapici, correlati alla sua natura divina, erano convinti che questo fosse sufficiente per assicurargli il diritto di violare il sabato, in quanto egli era assolutamente titolato a dare l'interpretazione più corretta della natura del bisogno, della sua gravità e dell'urgenza a soddisfarlo.
Tuttavia se era sbagliata la posizione farisaica che anteponeva sempre alla soddisfazione del bisogno, in giorno di sabato, il rispetto rigoroso del precetto festivo, era non meno sbagliata quella cristiana, che non sapeva associare bisogno individuale a bisogno sociale e collettivo. Cioè anche nel caso in cui il Cristo fosse stato quell'incredibile guaritore che i vangeli descrivono, i redattori cristiani, pur arrivando a capire che la guarigione di un singolo caso non aveva come scopo la mera guarigione della singola malattia (altrimenti il Cristo avrebbe dovuto fare solo questo, come generalmente fanno i guaritori), credono di poter mostrare come in quelle terapie straordinarie vi fosse la prova inconfutabile dell'origine divina del Cristo e quindi il privilegio esclusivo alla trasgressione di qualunque divieto giudaico. Ciò facendo, non si rendono conto che le guarigioni (ammesso e sicuramente non concesso che siano state fatte nel modo in cui vengono descritte) al massimo potevano essere considerate come simbolo evocativo di una liberazione ben più grande, di tipo politico-nazionale, ovvero come un modo psicopedagogico di attirare l'attenzione delle masse sull'idea di realizzare un progetto di tutt'altra natura.
Togliendo alle guarigioni il nesso simbolico con la politica, i redattori le hanno deliberatamente trasformate in una prova della divinità di un messia impolitico. Una prova però che non solo sul piano razionale ha un valore prossimo allo zero, ma che anche su quello giuridico non rende meno arbitraria la violazione del sabato, che non può certo essere giustificata solo perché un guaritore è dotato di superpoteri. E questo non solo da un punto di vista ebraico, ma anche da un qualunque punto di vista laico, che consideri la legge come una forma di regolamentazione della vita pubblica.
L'origine dell'autorità con cui egli decide di non rispettare la legge viene fatta risalire a una pretesa uguaglianza con Dio e non al fatto che il rispetto farisaico della legge mosaica e di tutte le altre leggi ch'essi si erano dati non portava in definitiva alcun vero vantaggio sociale e politico alla popolazione ebraica oppressa da Roma. I redattori cristiani evitano accuratamente d'impostare il problema in questi termini, poiché in tal caso sarebbero stati costretti a ripensare il loro rifiuto dell'attività eversiva antiromana.
Se la controversia sul sabato fosse avvenuta sul terreno della laicità (cosa possibile in quanto il sabato rappresenta in realtà il primato della legge sul bisogno sociale), noi saremmo dovuti arrivare alla conclusione che chiunque ha il diritto di sentirsi libero di non rispettare la legge o di interpretarla come meglio crede, se è in grado di dimostrare che non lo sta facendo per un interesse personale ma per il bene di una collettività, le cui necessità vengono legittimate da valori e princìpi che la legge e le istituzioni non tutelano a sufficienza.
Ma se i redattori avessero presentato un Cristo capace di comportarsi così, l'impianto dei vangeli sarebbe stato completamente diverso. Avremmo avuto a che fare con un leader politico che decide di violare la legge ogniqualvolta il rispetto di essa non favorisce l'emancipazione delle masse e la liberazione del paese dall'oppressione dello straniero. E questo a prescindere dai casi di gravi malattie.
III
Se il testo in oggetto fosse esaminato sul piano psico-linguistico, dovremmo dire che qui si è in presenza di un esaltato che chiama Dio “suo padre” e si fa uguale a lui. Cioè si dovrebbe arrivare a questa conclusione prescindendo dall'atteggiamento che si ha nei confronti della religione. Qui infatti anche un credente convinto dell'esistenza di un Dio onnipotente, indipendente dall'uomo (e l'ebreo di duemila anni fa, di regola, la pensava così), se avesse ascoltato un messaggio del genere, la conseguenza che avrebbe potuto trarre sarebbe stata delle più negative, nel senso che non avrebbe quasi fatto differenza tra “eresia” e “follia”.
Gli sarebbe stato relativamente facile arrivare alla conclusione che nel discorso tenuto dal Cristo la pretesa religiosa o teologica era umanamente così elevata che veniva direttamente a sconfinare con l'irrazionalismo, proprio perché si doveva dare per scontato, in via preliminare, che nessun uomo può paragonarsi a Dio.4
Dunque perché i redattori lo fanno parlare in termini così poco credibili? Per quale motivo vogliono indurre il lettore ad accettare l'idea che il Cristo di questa pericope non stava parlando come un uomo ma come una divinità? Una cosa infatti è violare il sabato di fronte ai casi di bisogno, un'altra è sostenere che si ha il diritto di farlo in quanto si pretende d'avere con Dio un rapporto personale esclusivo.
Il motivo di queste esagerazioni ampiamente volute sta nel fatto che il Cristo del quarto vangelo, almeno là nelle parti visibilmente manipolate da redattori senza scrupoli, non si rivolge affatto ai Giudei ortodossi, bensì ai cristiani, siano essi di origine pagana o ebraica. I Giudei sono soltanto un interlocutore fittizio, del tutto incapace d'intendere e di volere rettamente, e qui rappresentano, in fieri, varie tipologie di “eresia cristiana” rispetto all'ideologia dominante del petro-paolinismo. Si tratta pertanto di un regolamento di conti tutto interno al cristianesimo primitivo.
Infatti i termini della discussione vertono esclusivamente sul modo d'intendere l'identità del Cristo dandone per scontata la “resurrezione”, cioè la teoria interpretativa elaborata da Pietro e fatta propria, con sviluppi ulteriori, da Paolo.
In tal senso il quarto vangelo si situa, chiudendola, su quella linea mistificatoria dell'operato del Nazareno partita dal vangelo di Marco, il quale, non a caso, non era ancora arrivato a trarre delle conclusioni così categoriche circa la divinità del messia. In Marco p.es. si attende ancora la venuta trionfale del Cristo contro i suoi nemici terreni, per quanto con Paolo sia stata procrastinata alla fine dei tempi; in Giovanni invece si dà per scontato ch'egli ha già vinto contro “il Principe di questo mondo” (Gv 12,31; 14,30; 16,11).
Quando, nel vangelo di Marco, vi sono attestazioni esplicite circa la divinità del Cristo, esse non avvengono in concomitanza di guarigioni miracolose: è Dio che afferma la figliolanza di Gesù (durante il battesimo o nella trasfigurazione), non è Gesù che la sostiene e anzi quando qualcuno l'afferma (un demone esorcizzato o lo stesso Pietro), lui intima di non rivelarlo a nessuno. Questo a testimonianza che al tempo della stesura del vangelo di Marco (almeno nella sua prima versione) non si era ancora sicuri di dover far coincidere esplicitamente “resurrezione” con “divinità”: sarà Paolo a compiere questo passo decisivo, ma potrà farlo solo a prezzo di allontanarsi definitivamente dall'ebraismo.
Ebraismo e cristianesimo sono, in un certo senso, due forme di “ateismo religioso”, in cui il primo tutela l'immagine di Dio impedendo all'uomo di rappresentarla, mentre il secondo permette di rappresentarla solo a un uomo fatto passare per suo “figlio unigenito”. La divinità viene trasformata dal cristianesimo in una realtà che si può personalizzare: Dio scende al livello dell'uomo per permettere all'uomo di salire al suo livello, benché il genere umano partecipi solo indirettamente a questo privilegio, in quanto la vera consustanzialità è pertinente in maniera esclusiva al Cristo.
Viene così colmata una distanza che pareva eccessiva, insormontabile, non rigorosamente interpretabile: Dio diventa una realtà interiorizzabile, addirittura familiarizzabile, in quanto elemento del rapporto primordiale che lega un genitore al proprio figlio. Il cristianesimo ha rinunciato al rapporto politico tra Dio e popolo, che nell'ebraismo implicava il possesso di un territorio, per trasformarlo in un rapporto personale di tipo mistico, tra credente e divinità, valido in ogni contesto di spazio-tempo. In tal senso il cristianesimo assomiglia di più a una religione pagana, con la differenza fondamentale però ch'esso obbliga a credere in certi dogmi, in quanto il rapporto personale col sacro viene mediato da una presenza istituzionale, la Chiesa, che impone un'interpretazione oggettiva della fede, ritenendosi unica erede del movimento nazareno.
La Chiesa cristiana nasce da un evento politico tradito, non nasce dalla riflessione teologica o di filosofia religiosa di qualche illuminato pensatore. Vuole restare un'esperienza di popolo ma senza confini territoriali, senza riferimenti specifici a tradizioni locali. Una volta rotti i ponti con l'ebraismo, il cristianesimo ha posto in essere la pretesa all'universalità, superando, in questo, anche i particolarismi locali del paganesimo. Ogniqualvolta la Chiesa ostenta una veste politica (come p.es. nel caso della Chiesa romana), lì vi è un ulteriore tradimento dello spirito cristiano originario, tradizionalmente impostato su termini più mistici ed escatologici (come generalmente è nella Chiesa ortodossa o in certe esperienze monastiche).
Un ebreo fondamentalista non avrebbe mai potuto sopportare questa visione teologica delle cose, sia perché essa negava il lato politico della fede (anche se questo aspetto la Chiesa cristiana lo assumerà con la svolta teodosiana), sia perché, non credendo egli nella possibilità di elevare l'uomo a Dio, riteneva sommamente eretica l'idea di abbassare Dio all'uomo.
La battaglia era tra due forme di “ateismo religioso”. L'operazione mistificante dei redattori cristiani s'è risolta appunto in questo, nel voler far passare l'ateismo umanistico del Cristo in un'alternativa all'ateismo religioso ebraico, in cui la realtà divina non viene negata ma soltanto reinterpretata. Nel vangelo manipolato di Giovanni non siamo in presenza di un uomo che nega a Dio una qualunque sussistenza, facendo dell'uomo il Dio di se stesso, ma siamo in presenza di un uomo che, in via esclusiva, pretende d'essere Dio, in quanto figlio unigenito di una divinità onnipotente.
Cioè quello che per gli ebrei sarebbe parso come una forma di ateismo conclamato, per i cristiani invece diventa il fondamento su cui erigere un edificio del tutto religioso. In questa maniera i redattori cristiani ottengono un duplice risultato: dopo aver trasformato il Cristo da politico rivoluzionario nazionale a redentore morale universale, hanno anche trasformato il suo ateismo umanistico in una professione di fede religiosa.
D'altra parte non potevano revisionare una cosa senza toccare anche l'altra. Finché era esistita una tensione rivoluzionaria che portava a credere in un rivolgimento politico-istituzionale del proprio paese, i nazareni potevano anche accettare la pretesa della totale umanizzazione del rapporto uomo / universo, che metteva Dio nel dimenticatoio. Ma dopo la crocifissione, dopo la catastrofe del 70 e dopo la tragedia del 135, se si voleva continuare a parlare di “Cristo” non lo si poteva certo fare negli stessi termini del 30-35, tanto meno con gli stessi argomenti che lui aveva usato. Tutto doveva ruotare attorno al tema della politica dualistica, in virtù della quale si ammetteva la legittimità dell'operato di Cesare e l'esistenza di una realtà separata dalla Chiesa, lo Stato, che obbligava i credenti a sperare in una loro liberazione umana e materiale solo nell'aldilà.
IV
Non ci sono motivazioni particolari per negare a questo racconto la collocazione spazio-temporale decisa dai suoi redattori, per quanto esso sia stato pesantemente interpolato.
Dopo aver tentato, invano, di epurare il Tempio, invitando la popolazione, rappresentata dal partito farisaico, a cacciarne il clero corrotto, Gesù e i suoi primi discepoli, staccatisi dal movimento battista, s'erano rifugiati in Galilea. Già in Samaria avevano fatto capire che per loro le questioni religiose dovevano assumere un valore alquanto secondario, essendo il compito della liberazione nazionale quello principale.
L'ateismo del Cristo era già una realtà assodata durante la sua permanenza in Galilea. Non lo si vede neanche una volta compiere un qualsivoglia rito di tipo religioso: sin dall'inizio del terzo capitolo del vangelo di Marco, i farisei e gli erodiani han già intenzione di eliminarlo, proprio perché non rispettava il sabato e si arrogava il diritto di decidere autonomamente come interpretare le leggi. Il quinto capitolo del vangelo di Giovanni mette in evidenza il fatto ch'egli, senza grandi successi, cercava di estendere questa sua nuova visione laica della vita anche alla Giudea.
Le diatribe sul sabato e sull'identità del messia-taumaturgo sono state introdotte, in questa lunga pericope, da un miracolo stupefacente, proprio perché i redattori non volevano mettere in chiaro i termini esatti della controversia. Ogni miracolo evangelico, anche il più banale (cioè alla portata dell'uomo), è sempre una forma di criptazione di qualcosa di sconveniente per l'interesse della fede religiosa. Nella fattispecie in oggetto la strategia redazionale adottata è stata molto semplice: s'è voluto far credere che il Cristo poteva sentirsi autorizzato a violare il precetto del riposo assoluto del sabato, in quanto era in grado di compiere, essendo “divino-umana” la sua persona, prodigi assolutamente impossibili per chiunque.
S'è quindi usato un evento miracoloso proprio per negare all'uomo la possibilità d'identificarsi col Cristo. Ciò è paradossale, ma neanche più di tanto, se si pensa che un'operazione del genere, squisitamente religiosa, serviva appunto per indurre il credente a sentirsi una nullità al cospetto di Dio. Se Cristo, stando ai vangeli, non ha mai sostenuto d'essere un semplice essere umano, è giocoforza che nessun uomo possa mai rivendicare piena autonomia nei confronti di Dio. È il concetto di “Dio” o di “divinità” che tiene l'uomo dipendente, sottomesso, strumentalizzabile da parte dei poteri costituiti.
Invece di far dire al Cristo che la violazione del sabato era lecita proprio in quanto, al cospetto di un'istanza di bene oggettivo, espressa nella forma di un bisogno radicale e urgente, prima di tutto vengono questi interessi e non quelli di un astratto rispetto della lettera della legge; invece di far dire al Cristo che si può discutere sulle modalità di soddisfazione del bisogno, evitando però di negarne l'evidenza o di considerare l'importanza dei bisogni come secondaria rispetto al valore della legge; invece di fargli dire che il rispetto formale della legge non solo impediva la soddisfazione di un grave bisogno individuale, ma non era neppure di alcun aiuto per l'interesse collettivo di una liberazione nazionale, in quanto si finiva col discriminare quei ceti o quelle persone le cui sofferenze esigevano interventi di assistenza e condivisione di ben altro livello rispetto a quelli legalmente permessi; invece di presentare il Cristo come un semplice essere umano dotato di buon senso, apertamente contrario a queste forme di ipocrisia giuridica, s'è preferito far vedere che un Dio può interpretare la legge come gli pare, tanto più se il fine di questa facoltà è quello di far del bene a qualcuno.
Non solo, ma così facendo s'è voluta finalizzare la violazione del sabato alla soddisfazione di un'esigenza particolare di guarigione (in Giovanni anche a un'esplicita attestazione di divino-umanità), togliendo a tale violazione quella carica eversiva, anti-istituzionale, che doveva avere sul piano politico. Violando il sabato, il Cristo non aveva tanto di mira la semplice guarigione dei malati gravi né la dimostrazione di una potenza superiore, quanto lo scopo di dimostrare che il rispetto formale della legge, ai fini della liberazione nazionale, era semplicemente inutile. Non ci si sarebbe mai liberati dei Romani, limitandosi a stare tenacemente attaccati alle proprie tradizioni: quello che mancava ai farisei era la capacità di organizzare un movimento di massa insurrezionale, del tutto indipendente dalle interpretazioni ufficiali della legge.
Nonostante i redattori si sforzino di far vedere la buona volontà di Gesù di dialogare coi Giudei, in realtà, quando c'è di mezzo il sabato, non si discute mai sull'opportunità di guarire proprio quel malato e non altri, proprio quel tipo di malattia e non altre; non si discute neppure sulle priorità degli interventi risanatori. Un uomo in grado di fare cose del genere, per giunta nella più assoluta gratuità, avrebbe facilmente trovato ampi consensi, anche da parte di alcune autorità, attraverso i quali si sarebbe potuta stabilire un'adeguata strategia riabilitativa per la collettività, partendo democraticamente dai casi più gravi.
Niente di tutto questo. Anzi qui abbiamo a che fare con un terapeuta che si serve dei propri poteri paranormali per asserire che gli provengono direttamente dalla sua natura divina, e che chiede di credere in questa natura proprio in virtù delle sue straordinarie guarigioni; ovvero, se proprio non si vuol credere nella sua divino-umanità, chiede di fidarsi comunque di lui, della sua nuova “religione”, in considerazione del fatto che ogni guarigione è compiuta per un fine di bene e che egli non ha intenzione di servirsene per rivendicare un potere autoritario.
Insomma tutto il capitolo è una mistificazione dell'ateismo umanistico del Cristo, volta a negare che il principale scopo ch'egli s'era prefisso era eminentemente politico: liberare Israele dall'occupazione del nemico esterno, ch'era appoggiato dai collaborazionisti interni. Di fronte a questo obiettivo, che certamente Gesù non avrebbe potuto realizzare da solo, qualunque guarigione, anche la più straordinaria possibile, avrebbe assunto un significato molto secondario.
V
Dopo la cacciata dei mercanti dal Tempio, la guarigione del paralitico di Betesda viene considerata nel vangelo di Giovanni la seconda manifestazione pubblica di Gesù a Gerusalemme. Entrambe erano state di tipo laico, con la differenza che mentre quella poneva in questione gli assetti politico-istituzionali del giudaismo, questa invece ne mina i fondamenti ideologico-normativi (qui rappresentati dal precetto festivo).
È stato come se il Cristo avesse voluto precisare che un rovesciamento del potere clericale avrebbe dovuto comportare, necessariamente, una revisione dei princìpi teorici che il sacerdozio e gli altri partiti fondamentalisti avevano col tempo consolidato. I vv. 16 e 18 lo dicono chiaramente: “i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma anche perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio”.
Violare il sabato di fronte a una semplice questione di bisogno e non perché qualcuno era in pericolo di vita, né perché si doveva adempiere a un dovere superiore, o farsi uguali a Dio, erano in sostanza la stessa cosa, poiché il precetto del sabato era stato dato, secondo gli ebrei, dallo stesso Jahvè, era un precetto sacro per definizione, quello che appunto indicava la dipendenza dell'ebreo dal Creatore.
Il sabato non era e ancora non è un semplice giorno di riposo, ma una sorta di imitazione del ritmo della creazione divina, in quanto Dio “riposò nel settimo giorno” (Es 20,11). È ancora oggi proibito all'ebreo non solo lavorare, ma anche far lavorare gli altri, sia pure il servo o lo straniero o il bestiame: tutti hanno diritto al riposo. Persino accendere la luce o farsi da mangiare o mettere una firma su un contratto costituiscono lavori che il giudaismo proibisce di eseguire in questo giorno, dato che hanno per fine una “creazione”.
Osservare il sabato significa anche “santificarlo”, cioè “tenerlo separato”, lontano dai rapporti sociali che implicano interesse o rivalità..., nella convinzione che, non facendo nulla, vi siano più probabilità di comportarsi meglio che non facendo qualcosa, come negli altri giorni profani.
Il sabato dunque non era affatto una questione banale. Se la circoncisione indicava l'appartenenza simbolica a un popolo eletto, da Jahvè scelto, che aveva stabilito un patto d'alleanza, sancito dalla legge, il rispetto del sabato indicava invece il contenuto religioso di questa alleanza, espresso sempre in chiave simbolica ma con un simbolo assolutamente più ancestrale di tutti quelli che si usavano per ricordare l'epopea di Mosè. Non riconoscere la fatica della creazione dell'universo e quindi la necessità del riposo divino, la sacralità di questo riposo assoluto, non dedicare l'astensione da qualunque attività al culto della volontà divina, mai soggetta a imperfezioni e cadute, equivaleva in sostanza (e ancora oggi è così) a fare esplicita professione di ateismo. Ecco perché diciamo che mentre con l'epurazione del Tempio si poteva pensare a un intervento contro la corruzione del clero, al fine di ripristinare una purezza originaria nei rapporti umani, qui invece vengono messi in discussione i pilastri su cui si regge la stessa fede ebraica.
È la prima volta in questo vangelo che viene detto qualcosa contro i princìpi teorici dell'ebraismo all'interno del territorio giudaico. Analoga critica radicale era stata espressa infatti in Samaria, contro il primato del Tempio. Il che lascia supporre che non fosse la prima volta che Gesù negava la dipendenza dell'uomo dal precetto del sabato. Nel vangelo di Marco, ambientato in Galilea, la violazione del riposo assoluto – se vogliamo – era data per acquisita non solo da parte del Cristo ma anche da parte degli stessi apostoli, che p.es. lo trasgrediscono per soddisfare il bisogno di mangiare (Mc 2,23 ss.).
Il precetto era già stato ribaltato: “il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato”, che in sostanza implicava la necessità di tenere costantemente soggetta alla volontà umana qualunque disposizione legale, da reinterpretarsi ogniqualvolta lo richiedessero le esigenze vitali della collettività. Fissare una volta per tutte una qualsivoglia interpretazione significava, in ultima istanza, negare valore e persino esistenza ai bisogni umani, ovvero fare dei propri princìpi teorici degli idoli da adorare.
Tuttavia i vangeli di Marco e di Giovanni hanno affrontato la questione del sabato in modo abbastanza diverso: per il primo sarebbe stato sufficiente applicare sino in fondo il principio talmudico secondo cui “il sabato è stato messo nelle vostre mani e non voi nelle mani del sabato” (5 Yoma 85 b), per il secondo invece l'abolizione del sabato era una diretta conseguenza della divinità del Cristo. Marco (o meglio Pietro) si sarebbe accontentato di un po' di buon senso da parte dei farisei, che facevano del rispetto del sabato il criterio della perfezione morale. Giovanni invece (o meglio i suoi manipolatori) ritiene che l'attaccamento morboso che gli ebrei avevano nei confronti del sabato fosse sufficiente per rompere con loro qualunque rapporto.
VI
La cosa che appare strana, in questo racconto del vangelo di Giovanni, è che si associa esplicitamente la negazione del sabato con l'affermazione della divinità del Cristo. Marco non avrebbe avuto il coraggio di farlo, benché fosse anche nelle sue intenzioni dimostrare che Gesù era più che un uomo. Il motivo di questa riluttanza probabilmente sta nel fatto che la mistificazione del vangelo di Giovanni è di livello più elevato, ponendosi come fase conclusiva di un processo revisionistico iniziato molti decenni prima.
Di fronte all'ateismo esplicito di Gesù i due vangeli si sono comportati in maniera differente: Marco ha fatto finta di nulla, considerandolo un aspetto del tutto irrilevante della sua predicazione, e ha preferito concentrarsi su quale falsificazione operare circa gli aspetti politici della crocifissione; non a caso in Marco il Cristo appare nei panni di un essere umano “particolare” ma non “eccezionale”, in quanto la sua morte viene interpretata come “necessaria”, come “voluta da Dio”, non in quanto il Cristo stesso era “Dio”. La divinità del Cristo non è ancora ben definita: per dimostrarla non vengono neppure usati i racconti di resurrezione, che invece negli altri vangeli sono fondamentali.
E anche gli episodi in cui viene palesata espressamente la divinità del Cristo (battesimo e trasfigurazione) rientrano in un genere di tipo mitologico, ad uso popolare, cronologicamente successivo all'idea mistificante di fondo relativa alla morte necessaria. Sicuramente furono inseriti nel vangelo marciano in un secondo momento.
Nel vangelo di Giovanni invece si compie un'operazione più sofisticata, più teologica, mediante cui i redattori si pongono un duplice obiettivo: trovare ulteriori e definitive giustificazioni alla tesi petrina originaria, sviluppata da Paolo; rovesciare ideologicamente il contenuto di quegli aspetti della predicazione del Cristo che il vangelo di Marco aveva trascurato o sottovalutato.
Di qui l'idea, che da un punto di vista cristiano può essere considerata geniale, di trasformare l'ateismo esplicito del Cristo in una sua personale dichiarazione di figliolanza divina: cosa che nel vangelo di Marco, dominato dalla tesi del “segreto messianico”, sarebbe stata impensabile.
Nel quarto vangelo non siamo in presenza di una semplice “censura” di aspetti ritenuti scomodi per la teologia, ma di un loro radicale rovesciamento interpretativo. Se Marco ha alterato il significato della morte del Cristo, facendo dipendere da questa tutto il resto, persino la tesi della resurrezione; Giovanni invece (o meglio, i suoi manipolatori) mistifica tutta la vita del Cristo e considera la sua morte come un inevitabile “glorioso” compimento. La follia di questo revisionismo teologico è pari alla sua lucidità.
Il motivo per cui nel quarto vangelo si sia avvertita la necessità di falsificare tutta la vita del Cristo (quando un apostolo come Paolo aveva semplicemente preferito partire dalla mistificazione di Pietro, portandola alle sue più radicali conseguenze operative, senza aver alcun bisogno di riscrivere una biografia del Cristo), sta nel fatto che la tradizione giovannea era in origine del tutto opposta a quella petrina, sicché i successivi redattori, dovendo tener conto di una narrazione che contraddiceva i Sinottici nel loro insieme e negli aspetti più fondamentali, si sono accinti, al fine di ricondurre questa tradizione entro i limiti di quella petro-paolina, a una manipolazione generale molto più evoluta, in grado peraltro di tener conto anche di quelle prime eresie formatesi all'interno del cristianesimo primitivo, le quali, pur non mettendo in discussione le tesi fondamentali della morte necessaria e della resurrezione, cominciavano a formulare delle interpretazioni sulla natura del Cristo non esattamente conformi a quella dominante. Tracce di queste eresie s'intravvedono già nell'Apocalisse.
Ecco perché l'ateismo del Cristo, che in Marco viene vanificato dalla tesi della “morte necessaria” (voluta dalla “prescienza divina”), fatta sostenere dal Cristo stesso coi tre annunci della passione, relativi a quello che gli sarebbe accaduto entrando in Giudea (8,31; 9,31; 10,33); in Giovanni invece quell'ateismo viene mistificato sin dall'inizio, facendo credere che in realtà Cristo voleva soprattutto affermare la propria uguaglianza con Dio, definito come “Padre”, e dunque la propria esclusiva appartenenza filiale. Questo per dire che se nel vangelo di Giovanni c'è del “marcio” in quantità superiore che nei Sinottici, il motivo è dipeso dal fatto che, una volta avviato il processo di mistificazione della realtà, se lo si vuole conservare di fronte alle inevitabili contestazioni, occorre aumentarne il grado di inattendibilità, almeno fino a quando non si avrà la forza sufficiente per mettere a tacere quelle contestazioni.
VII
Se il IV vangelo venisse esaminato anche solo da un punto di vista cristiano, sarebbe impossibile non sostenere ch'esso è stato scritto col senno del poi, e non tanto perché al Cristo si attribuiscono delle qualità sovrumane (già riscontrabili nei Sinottici), quanto perché egli le usa con una consapevolezza della propria origine divina assolutamente straordinaria (inedita rispetto ai Sinottici). Se Gesù fosse davvero stato quel “Dio” che i cristiani ritengono, ci si sarebbe come minimo dovuti chiedere come mai nei quattro vangeli canonici la consapevolezza ch'egli ha della propria origine divina si presenta in lui in una forma evolutiva, come un'acquisizione che matura progressivamente nel tempo. Il IV vangelo, in tal senso, è molto diverso dal protovangelo.
In Giovanni è così apodittica la maniera in cui si fanno derivare le qualità terapeutiche dalla consapevolezza d'essere il figlio unigenito di un Dio-padre onnipotente, che non sarebbe stato sufficiente interpretare la tomba vuota come “resurrezione”: infatti anche Marco la interpreta così, ma non per questo arriva alle conclusioni mistiche degli autori del IV vangelo.
Dunque in questo lungo racconto del cap. 5 deve per forza essere intervenuta la mano di una tradizione paolina (ebreo-ellenistica), che fu la prima ad avere l'ardire di rompere definitivamente col giudaismo affermando la figliolanza esclusiva del Cristo.
Il Gesù giovanneo è completamente smaterializzato, è una sorta di ologramma teologico che parla di sé, con se stesso, nella più totale indifferenza della storia e della società. Egli non si preoccupa affatto delle macroscopiche incongruenze dei suoi discorsi coi fatti reali. È un Cristo, se vogliamo, solipsistico, e ciò fa pensare che la sua rappresentazione surreale sia maturata in un contesto monastico isolato.
L'identificazione di Dio-padre e Dio-figlio è così stretta che praticamente viene data per scontata, come se la verità di questa tesi potesse essere colta solo in maniera tautologica. Tale presupposto metodologico deriva dal fatto che nella comunità cristiana avevano finito per prevalere in maniera decisiva le tesi petrine della “morte necessaria” e della “resurrezione”, nonché la tesi paolina della “figliolanza divina” del Cristo. Qui in sostanza siamo in presenza di un'autoreferenzialità linguistica che si basa su delle tesi teologiche (quelle petro-paoline) del tutto indimostrabili. Uno psichiatra direbbe che siamo in presenza di una qualche forma di psicosi delirante.
Supponiamo infatti che sia attendibile una guarigione eccezionale, e quindi “miracolosa” per la mentalità dell'epoca e forse anche per la nostra; supponiamo anche che questa guarigione non dipenda dall'autosuggestione o dalla forza di volontà del malato ma da un effettivo potere del terapeuta. Ebbene, potremmo considerarla sufficiente per attribuire al terapeuta delle qualità sovrumane? Certamente no. Allora per quale motivo i redattori di questo vangelo pretendono che i Giudei accettino l'idea che il Cristo terapeuta vada considerato come “unigenito figlio di Dio”? La prova che per loro andava considerata inconfutabile, non avrebbe potuto essere convincente per nessuno, sia perché avrebbero potuto avvalersene anche altri guaritori-imbonitori (negli Atti si assiste al forte diverbio tra Pietro e Simon Mago), sia perché la fede in generale (e, a detta di Paolo, quella cristiana in particolare) non ha bisogno di miracoli per credere, salvo ovviamente l'unico che importa e che oscura tutti gli altri, quella della “resurrezione”.
Quindi in questo vangelo non è confluita solo una tradizione paolina ma anche un'altra tradizione, ancora più ellenistica, che ha visto nell'accettazione delle “opere miracolose” una sorta di discrimen tra l'ortodosso e l'eretico. Che questa sia una caratteristica pagana, ereditata dal cristianesimo, lo lascia capire lo stesso Cristo che nel racconto precedente, rivolgendosi a Cuza, il funzionario reale, dice: “Se non vedete segni e prodigi, voi non credete” (4,48).
Questo per dire che nel capitolo quinto i due racconti, quello della guarigione e quello dell'autoproclamazione divina, possono anche essere stati scritti da mani diverse, di cui solo le ultime hanno ritenuto opportuno servirsi del primo come segno inconfutabile dell'attendibilità del discorso pronunciato da Gesù.
C'è un punto infatti che potrebbe anche mettere in crisi il rapporto organico tra i due elementi del capitolo: il versetto 18, in cui il redattore afferma che il Cristo veniva perseguitato perché violava il sabato e perché si faceva come Dio. Il fatto che venisse perseguitato per entrambe le cose non sta di per sé a significare ch'egli si servisse delle guarigioni per dimostrare la propria divinità. Questa cosa non appare mai nel vangelo di Marco; anzi, l'unica volta che un ossesso afferma che il Cristo è figlio di Dio, viene messo a tacere. Marco riflette una specifica posizione galilaica contro quella giudaica, ma Giovanni, o meglio, il suo manipolatore riflette una posizione ellenistica contro una ebraica in generale. Questo vangelo artefatto ha tradito lo stesso ebraismo di Giovanni.
Il redattore del lungo discorso di Gesù deve avere unito le due parti, utilizzando sì la guarigione come premessa per credere nella divinità del Cristo, ma lasciando al lettore, almeno in apparenza, la facoltà di non credervi come prova inconfutabile della sua divinità. Quello che a lui premeva di dire era che al Cristo non gli si poteva in alcun modo rimproverare di violare il sabato, proprio in quanto, essendo figlio di Dio, lo poteva fare in tutta tranquillità. Solo che una tesi del genere è un'arma a doppio taglio. Infatti se è vero che uno può anche non credere nella divinità di Gesù e limitarsi a osservare i suoi prodigi spettacolari in una maniera distaccata, nella convinzione che la sua grandezza stia solo nelle parole, è anche vero però che se si accetta l'idea ch'egli veniva perseguitato perché violava il sabato (simbolo della legislazione ebraica), è difficile poi non credere anche nella sua divinità. Una volta entrati nella comunità cristiana non si possono avere atteggiamenti dubbiosi; e non è detto che tale problematica non rifletta delle tensioni ereticali, poiché il discorso non avrebbe avuto alcun senso in un contesto giudaico. Si parla a suocera (il giudaismo) perché nuora intenda e qui la “nuora eretica” può anche essere stata la setta dei nazorei, il cui vangelo, andato perduto, accettava l'idea di un Gesù profeta e taumaturgo ma non di natura divina, tant'è che veniva rifiutata completamente la predicazione paolina.
Qui non si è in alcun modo in presenza di un racconto con cui si vuol dimostrare la fondatezza di un ragionamento logico. La procedura redazionale è stata esattamente inversa: utilizzare un racconto di guarigione per far credere nella necessità di un dogma, cioè di una tesi che non può essere oggetto di discussione. Il Cristo che qui parla ha già le sembianze di una Chiesa autoritaria, che affronta in maniera paternalistica l'eresia in ambito cristiano e che però minaccia i più severi castighi se si persiste nell'errore. “Io non condanno nessuno (a morte) – sembra dire Gesù –, ma questo non m'impedirà dal giudicarvi molto severamente”.
I Giudei in senso stretto difficilmente possono essere considerati come i destinatari di questo ultimatum, anche perché i redattori non vanno a cercare dei pretesti per giustificare il loro antisemitismo: questo anzi è già così ben radicato che dobbiamo darlo per scontato. Gli ebrei fondamentalisti vengono ritenuti dal cristianesimo una causa persa. Essi, in questo racconto, rappresentano soltanto una controfigura, la maschera che copre il volto di quegli intellettuali già cristianizzati che, pur partendo da basi ideologiche condivise (morte necessaria, resurrezione ecc.), cominciano a fare riflessioni troppo personali, che non collimano con quelle istituzionali. Il quarto vangelo ha reso improrogabile la necessità di stabilire un canone definitivo del Nuovo Testamento.
VIII
Sarebbe alquanto facile dimostrare, tecnicamente, che la guarigione del paralitico è un racconto completamente inventato. Basterebbe infatti sostenere che in teoria può anche esserci stata un'acqua salutare, ma non fino al punto in cui potesse guarire ciechi, storpi o paralitici, a meno che qui non si vogliano chiamare in causa quei fenomeni di autosuggestione che associano una guarigione di tipo psichico a mezzi e strumenti usati in maniera magica, fantascientifica.
In tal caso però un giudeo avrebbe dovuto escludere ancora di più la pretesa cristiana di associare la natura divina del Cristo con le terapie miracolose. Infatti se per guarire basta un po' d'acqua miracolosa, a che pro credere nel terapeuta che si autoproclama figlio di Dio? Qui si ha l'impressione che i redattori abbiano voluto porre in essere una gara di “potenza” tra eresia e ortodossia.
Non meno assurdo è il fatto che quell'acqua guarisse da qualunque tipo di malattia soltanto il primo che riuscisse a bagnarvisi. Anche questo aspetto è stato usato dai redattori in chiaro senso provocatorio, per far vedere che i tentativi di opposizione alla “forza cristiana”, da parte dell'interlocutore (giudaico o cristiano-eretico), erano inesorabilmente destinati a fallire.
Decisamente incomprensibile è la domanda che Gesù (tutto solo, senza neanche un discepolo con sé) rivolge al paralitico che da ben 38 anni era in quella penosa condizione: “Vuoi guarire?” (v. 6). Sembra quasi una presa in giro. Uno psicanalista avrebbe detto che quella domanda voleva in realtà mettere in dubbio il vero desiderio di guarigione dell'infermo, come se questi cioè avesse fatto della propria malattia un alibi per restare ai margini della società, per non assumersi alcuna responsabilità. Era forse un vittimista? Se dicessimo “rassegnato” non riusciremmo a spiegarci il motivo della sua presenza in quel luogo.
Si ha insomma la sensazione che questo malato rappresenti quel cristiano di origine ebraica ancora troppo legato alle tradizioni ebraiche. Infatti il metodo della guarigione operata dal Cristo vuole apparire assolutamente antitetico a quello ebraico.
Il redattore non mette in dubbio l'efficacia terapeutica dell'acqua, ma vuole mostrare due cose: che pur in presenza di quel dono eccezionale, i più deboli, tra i malati, ne restavano esclusi; che un uomo come Gesù, essendo un Dio, non solo non ha bisogno di nulla per guarire, ma si preoccupa anche di non fare differenze tra malato e malato. La democrazia delle guarigioni viene realizzata mediante l'onnipotenza della volontà taumaturgica.
Tuttavia, anche solo per questa fondamentale ragione, il racconto andrebbe considerato del tutto inventato. Qui il miracolo mistifica un'interpretazione del sabato che in origine doveva essere strettamente collegata a una nuova visione della vita, più laica, il cui obiettivo principale, in quel momento, era la liberazione non dalle malattie ma dalla presenza romana.
I redattori hanno trasformato Gesù in un supereroe della medicina, dopo avergli negato qualunque legittimità come leader rivoluzionario. Chi lo ascolta sono soltanto i malati bisognosi di guarigione: tutti gli altri lo perseguitano e cercano continuamente di linciarlo. Nel racconto, anzi, è lo stesso paralitico risanato che, appena viene a saperlo, rivela alle autorità il nome di Gesù.
Il finale è del tutto sorprendente. Gesù lo va a trovare nel Tempio (e già questo stava ad indicare che l'ex-paralitico non aveva saputo approfittare dell'episodio fortunato per ripensare il suo tradizionale rapporto col giudaismo, quel giudaismo che nel corso del dibattito con Gesù, qualificarlo come fanatico e integrista sarebbe stato poco). Non gli chiede di seguirlo, pur avendo saputo che al cospetto dei farisei l'aveva difeso, ma di non peccare più, associando così alla maniera ebraica colpa e malattia, e lasciando peraltro stupefatto il lettore, che non può certo immaginare quale incredibile peccato possa aver compiuto uno che da 38 anni giaceva paralizzato su un lettino (non dimentichiamo però che nei vangeli i numeri possono anche essere usati in maniera figurata, per indicare un tempo storico o una simbologia di tipo religioso).
Qui Gesù non ha e non vuole avere alcun rapporto col giudaismo. Si ha anzi l'impressione che il redattore abbia voluto sottolineare la condizione peccaminosa dell'infermo solo allo scopo di giustificare meglio il fatto che alla fine sarà proprio lui a rivelare alle autorità il nome del guaritore. Questo redattore non ha scrupoli nel considerare negativamente i Giudei in quanto tali, siano essi sani o malati, siano essi credenti o increduli.
L'ultimo aspetto incongruente del racconto è che Gesù guarisce il paralitico in mezzo alla gente (sana e malata) e nessuno sembra essersi accorto di nulla. Qualcuno ha sentore di un'anomalia soltanto quando vede il paralitico camminare, portandosi sottobraccio il lettuccio. E il redattore antisemita sembra addirittura compiacersi nel mostrare che, di fronte a quella spettacolare guarigione, ai Giudei non viene in mente di congratularsi col neorisanato, ma di accusarlo di fare qualcosa di proibito in giorno festivo.
E che strana personalità doveva avere questo malato, che dopo essere stato emarginato per ben 38 anni, senza poter accedere per primo all'acqua della fontana di Siloe, dopo essere stato guarito da uno che per lui era soltanto un illustre sconosciuto, dopo aver rischiato, una volta ottenuta la guarigione, d'essere denunciato per aver violato la legge sul sabato, dopo aver sostenuto con vigore le sue tesi davanti ai farisei ed essere stato espulso, per questo, dalla sinagoga, se ne va come se nulla fosse al Tempio a ringraziare Jahvè e i suoi portavoce!
IX
Il v. 17 fa da collante tra la guarigione e l'autoproclamazione divino-umana. Nei Sinottici sarebbe stata impensabile una cosa del genere, e non perché non si propagandi in essi un medesimo messia teologico, quanto perché le guarigioni miracolose erano state messe semplicemente per mistificare eventi di tipo politico.
Nel vangelo di Giovanni non solo si fa questo, ma, all'interno di tale mistificazione, si ha addirittura l'ardire di sostenere che il Cristo guariva per dimostrare la propria divinità. È un passaggio ulteriore, che implica anche una modifica nella scelta del destinatario da parte dei redattori cristiani: non più o non solo i giudeo-ortodossi ma anche e soprattutto i cristiani di origine ebraica o pagana. Possiamo anzi sostenere che le prime eresie cristiane (quelle che davano vita a correnti di pensiero eterodosse rispetto a quella petro-paolina) siano state tutte di origine ebraica, per ovvi motivi cronologici.
L'esigenza di canonizzare gli scritti post-pasquali, per dar vita a un “Nuovo Testamento” ufficiale, una sorta di “opere complete” della mistificazione più credibile ai danni del Cristo5, maturò proprio quando iniziarono ad emergere eccessive varianti alle tesi ufficiali e, dopo la stesura del vangelo di Giovanni (la cui ultima revisione avvenne intorno al 100, dopo almeno 60 anni di manipolazioni), ci vollero ancora decine di anni prima di arrivare a una comune e definitiva approvazione.6
Nel vangelo di Marco il messia si nasconde e rivela la sua natura divina, in rarissimi casi, solo ai suoi più stretti discepoli, intimando tassativamente di non divulgare quello che avevano visto e/o sentito. È una posizione opposta a quella dei manipolatori di Giovanni, che presentano sempre un Cristo intenzionato a rivelare apertamente, in pubblico, la propria divinità dopo aver compiuto un miracolo o una straordinaria guarigione.
Il v. 17 è decisivo per comprendere la volontà redazionale di tenere unite teoria religiosa e prassi ecclesiale. Gesù ha guarito il paralitico perché l'ha fatto in nome di Dio, che opera sempre per il bene degli uomini: fin qui la teoria. La giustificazione di questo incredibile potere taumaturgico egli la fa derivare dal particolare rapporto filiale che, in maniera diretta ed esclusiva, ha con lo stesso Dio-padre. E qui interviene la prassi ecclesiale, che è mediatrice tra il credente e Cristo.
Non è solo “in nome di Dio” ch'egli compie guarigioni miracolose, ma anche in virtù del fatto che sul piano divino non c'è differenza sostanziale tra lui e il Dio onnipotente, tant'è che la Chiesa indivisa arriverà a dire, al primo concilio di Nicea (325), dopo oltre un secolo di furibonde controversie, che sul piano della “natura divina” vi è “consustanzialità” tra il Padre e il Figlio, essendo diverse solo le persone.
I redattori del quarto vangelo hanno praticamente posto le basi alla teoria della “consustanzialità”, in quanto hanno voluto far vedere che il Cristo era molto di più che un guaritore devoto a Dio. Infatti, precisano subito al v. 18 che Gesù veniva perseguitato sia perché operava guarigioni di sabato (e in ciò bisogna vedere la volontà di scardinare le fondamenta del potere politico-religioso giudaico), sia per la stretta uguaglianza che si vantava d'avere con Jahvè, il che per un ebreo suonava non semplicemente come un'eresia, quanto come una bestemmia vera e propria, una sorta di imperdonabile blasfemia. Il Cristo era meritevole di morte due volte.
Tutto quanto segue a questo impianto mistificatorio, che ha la funzione di fare da supporto metodologico preliminare ai discorsi del guaritore, è incentrato sul presupposto che miracoli del genere non possono essere fatti che da un uomo avente natura divina.
Col suo discorso Gesù si preoccuperà di far capire che, nonostante questi straordinari poteri taumaturgici, non era nelle sue intenzioni servirsene per dominare gli uomini: è un Cristo sì eversivo, rispetto al giudaismo ortodosso, ma impolitico, poiché il suo regno “non è di questo mondo”. Le sue terapie, i suoi miracoli erano soltanto l'attestazione di una potenza virtuale, non destinata a esprimersi adeguatamente sulla Terra, il cui fine era ovviamente quello di compiere il bene, soddisfacendo bisogni reali, di tipo fisico, per far capire l'importanza di quelli morali e spirituali.
X
Ora vediamo, in sintesi, quali sono stati i modi scelti dai redattori per dimostrare le buone intenzioni di Gesù:
1. egli dice di voler applicare al mondo un modello di relazione sociale la cui origine risale al suo rapporto col Dio-padre, cioè dice di non fare nulla che non abbia già visto fare;
2. il suddetto modello gli appartiene così tanto che, a tempo debito, egli sarà in grado di compiere un miracolo molto più grande di questa guarigione, quello di far risorgere i morti;
3. che tale modello gli appartenga pienamente è dimostrato – a suo dire – dal fatto che Dio-padre gli ha affidato il compito di guarire gli uomini non solo “fisicamente”, ma anche “spiritualmente”, e per essere guariti in questo secondo modo è sufficiente credere ch'egli è figlio di Dio;
4. tutto ciò vale non solo per la generazione a lui coeva, ma anche per tutte quelle che lo hanno preceduto e per quelle che lo seguiranno, sicché tutti gli uomini e le donne della storia dovranno porsi il compito se credere o non credere in questa rivelazione divino-umana circa il rapporto filiale che lega lui all'Onnipotente;
5. il figlio di Dio giudicherà rettamente chi non gli riconoscerà il rapporto diretto col Padre dei cieli, proprio perché ha ricevuto il mandato per farlo.
In questi cinque punti non è ovviamente il Cristo che parla, ma la comunità post-pasquale, la quale sta proponendo, in chiave mistica, l'ultima chance di salvezza al popolo ebraico, o sta minacciando di scomunica gli ebrei divenuti cristiani, intenzionati ad opporsi ad alcuni aspetti della teologia petro-paolina.
Cioè è come se venisse detto che la Chiesa cristiana è disposta ad accettare l'autocritica dei Giudei (che hanno crocifisso il messia), a condizione però che ne riconoscano la natura divina e la stretta ed esclusiva parentela col Dio onnipotente. Il Cristo che parla è come una sorta di morto redivivo che offre ai suoi carnefici l'ultima possibilità di salvezza: una salvezza che vuole essere unicamente spirituale (di cui la guarigione fisica è solo un simbolo metaforico), del tutto estranea a obiettivi politici o di riscatto sociale. Una salvezza assai poco realistica, che lascia presumere che l'intero discorso si rivolga a credenti ebrei divenuti già cristiani, costretti dagli eventi a rinunciare alla liberazione politica.
Il v. 30 chiude la prima parte del discorso, quella principale, che non avrebbe avuto bisogno della seconda per essere compresa nella sua essenzialità. Non si tratta di un discorso di “teologia politica” ma di “teologia spirituale”, di “metafisica religiosa”, in quanto il contesto spazio-temporale in cui i princìpi teorici di questa teologia andranno a realizzarsi sono decisamente ultraterreni.
XI
A partire dal v. 31 si cercherà di rispondere a un'altra obiezione, quella di chi, non ritenendo sufficienti i grandi prodigi miracolosi per credere nella divinità del Cristo, chiede che gli venga offerta una prova più convincente.
Prima di affrontare la seconda parte del discorso di Gesù, si può aprire una parentesi relativa alla possibilità che un discorso così mistico, pur sapientemente costruito a livello redazionale, abbia un qualche riscontro a livello storico. Ci si può cioè chiedere, in via del tutto ipotetica, quante probabilità vi siano ch'esso abbia un substrato attendibile.
Abbiamo già detto che discorsi del genere sarebbero apparsi un'assoluta follia a un qualunque ebreo: ancora oggi, uno che si paragonasse a Dio in tutto e per tutto, dovrebbe essere rinchiuso in una casa di cura, anche nel caso in cui volesse attenuare la pretesta con l'idea di “figliolanza”. Persino un credente “cristiano” non l'avrebbe capito, se quel discorso avesse potuto ascoltarlo dalla viva voce di Gesù, che qui di “umano” ha solo la parvenza.
Detto questo, si tratta ora di capire se esso sia stato completamente inventato, o se invece non sia il prodotto di una mistificazione operata ai danni dell'ateismo del Cristo. Questo perché non è sufficiente dire che con esso si è voluta avvalorare la tesi della “morte necessaria” e della “resurrezione”: che cos'altro si è voluto fare?
Proviamo qui a esporre una serie di ragioni per negare al suo discorso una qualsivoglia attendibilità di tipo storico, rimotivandolo però sul piano dell'interpretazione mistica, in maniera tale che venga comunque salvaguardata l'istanza dell'umanesimo laico:
1. qualunque discorso interno a una concezione favorevole all'esistenza della divinità porta inevitabilmente gli uomini a non cercare nel mondo adeguate forme di giustizia sociale, e ciò risulta contraddittorio col ruolo di leader politico che una parte significativa del popolo ebraico aveva attribuito al Cristo (per la liberazione nazionale del paese);
2. tutto il suo discorso ruota attorno a quanto avverrà alla fine dei tempi, cioè è un discorso di escatologia metastorica, indifferente alle sorti del popolo ebraico nel presente;
3. l'associazione tra “guarigione miracolosa” e “autoproclamazione divina” non è mai esplicitata nei Sinottici ed è persino ignorata se non addirittura negata nelle lettere paoline: essa peraltro non ha alcun senso per le aspettative messianiche di Israele, e per la sorte di un qualunque messia politico sarebbe stata addirittura controproducente, poiché inevitabilmente e giustamente gli ebrei l'avrebbero accusato d'essere un impostore. Un ebreo avrebbe visto con sospetto, e non senza ragioni, anche un messia che avesse voluto far valere le proprie capacità terapeutiche non per rivendicare un'identità divina ma semplicemente per legittimare la pretesa a una leadership politica (un nesso che i Sinottici han sì voluto avvalorare ma senza enfasi). Qui bisogna convincersi che tutte le guarigioni descritte nei vangeli o si riferivano a malattie di tipo psico-somatico, e quindi erano alla portata di una qualunque persona competente, oppure sono state elaborate a livello redazionale per stravolgere azioni o parole dal contenuto marcatamente politico, al punto che là dove esse appaiono più sensazionali, lì si deve vedere una mistificazione maggiore;
4. se, in via del tutto ipotetica (partendo p.es. dal reperto della Sindone, che è l'unica fonte attendibile di tutto il Nuovo Testamento), vogliamo considerare plausibile l'idea che il Cristo possa essere stato a capo, in qualche maniera, della creazione dell'universo, ovvero che lo si possa considerare una sorta di prototipo del genere umano, resta comunque altamente improbabile ch'egli abbia potuto affrontare un argomento del genere con chi non avrebbe neppure avuto gli elementi per capirlo;
5. se anche volessimo dare per acquisito che il Cristo abbia potuto fare un discorso metafisico di natura così elevata ai suoi più stretti discepoli, il suo ruolo nella creazione dell'universo non avrebbe certo potuto essere interpretato come pretesto per rinunciare alla rivoluzione politico-nazionale, ch'era l'obiettivo fondamentale di tutto il movimento nazareno;
6. e, in ogni caso, un qualunque discorso che il Cristo avesse potuto fare intorno alla propria diretta partecipazione alle fasi della creazione dell'universo, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un Dio onnipotente quale realtà esterna a quella umana. Cioè anche nel caso in cui il Cristo avesse affermato d'essere all'origine dell'universo, noi dovremmo ugualmente ammettere l'idea che questo può non essere incompatibile con una professione di ateismo.
XII
Ora però vediamo il contenuto del secondo discorso (vv. 25-47), che è un invito a credere nelle sue parole e nelle sue azioni partendo dal presupposto che l'intenzione che la muove è benevola.
Qui il Cristo è come se sia disposto a non tener conto del nesso “redazionale” tra “guarigioni miracolose” e “identità divina”, e che voglia quindi accettare l'obiezione ch'esso, di per sé, non dimostra nulla e che forse, se può essere tranquillamente accettato dal popolino, può risultare persino fastidioso ai ceti intellettuali. Di qui il livello di maggiore astrazione presente nel secondo discorso. Egli deve rispondere a chi gli ha obiettato che le guarigioni sono compiute in virtù della sua propria volontà, non per adempiere a un mandato ufficiale, pubblicamente riconosciuto: esse pertanto non possono rendergli testimonianza. Occorre un'attestazione di fiducia a lui esterna, che garantisca oggettivamente la verità delle sue parole, la sincerità delle sue azioni.
Una critica del genere la si incontra spesso nel vangelo di Giovanni e anche, formulata diversamente, nei Sinottici, ove gli chiedono di fare un segno strabiliante perché tutti possano credere e lui sistematicamente oppone un deciso rifiuto.
Qui – come si può notare – l'impostazione stessa dei termini del problema è del tutto fuorviante. Da un lato infatti siamo in presenza di una richiesta assurda, relativa all'attestazione di un segno inequivocabile, oggettivamente favorevole alla volontà del Cristo: il che, anche nel caso non fosse in questione l'Onnipotente come garante, fa comunque pensare a una sorta di richiesta magica, poiché sappiamo che solo una volontà popolare può dare valore all'operato di uno che pretende di porsi come “leader” di qualcosa di eversivo. Va detto, peraltro, che se anche i Giudei in quel momento avessero preteso che Gesù ricevesse il dovuto consenso da parte delle loro autorità costituite, noi avremmo avuto a che fare con un dibattito ancora più inverosimile di quello che i redattori ci hanno fatto pervenire.
Dall'altro lato vediamo che il Cristo si rifiuta di esaudire la richiesta di un'attestazione indipendente, ma solo per ribadire un'ulteriore verità mistica, quella secondo cui la testimonianza più convincente circa la verità del proprio operato gliela offre lo stesso Dio-padre, della cui identità e volontà lui stesso si fa garante e portavoce, in quanto figlio unigenito. Col che il “discorso di fede”, sapientemente tautologico, si chiude.
Ma vediamo meglio il suo svolgimento, cercando soprattutto di capire perché questa seconda parte presenta tracce altamente anti-democratiche sul piano politico.
Anzitutto appare evidente che il Cristo offre meno chances di “soluzione spirituale” ai propri compatrioti: è come se dicesse loro che se non si fidano dell'equazione “guarigione miracolosa” = “identità divina” è perché in realtà vogliono credere solo a loro stessi, cioè vogliono restare così come sono.
L'obiezione relativa alla testimonianza oggettiva (che pur non può essere offerta dalle guarigioni in sé, per quanto straordinarie siano) qui viene fatta apparire dai redattori come un pretesto per continuare a non credere nella figliolanza divina del Cristo. E si presume di dimostrarlo facendo leva su tre prove ritenute da lui inconfutabili:
1. la testimonianza a lui favorevole di Giovanni il Battezzatore. Qui i redattori cristiani prendono per buona la versione che nello stesso quarto vangelo viene data sui rapporti tra i due leader storici. In realtà il loro rapporto subì una rottura traumatica proprio a motivo del fatto che il Battista non volle partecipare all'epurazione del Tempio. Il Battista aveva trovato un'intesa col Cristo sul piano “etico”, non su quello “politico”;
2. la testimonianza a lui favorevole delle Sacre Scritture e, in particolare, di Mosè, che avrebbe addirittura “scritto di lui” (v. 46)! Qui i redattori compiono quell'abuso ermeneutico – ben visibile in tutto il Nuovo Testamento – secondo cui è possibile reinterpretare taluni passi veterotestamentari in una direzione favorevole alle tesi petrine della “morte necessaria” e della “resurrezione” come lettura della tomba vuota;
3. la testimonianza a lui favorevole di Dio-padre, in cui i Giudei non credono perché non credono nel Dio-figlio. Qui il circolo raggiunge l'apice della viziosità.
Chiunque è in grado di rendersi conto che con queste presunte testimonianze la comunità cristiana, sin dall'inizio dello stravolgimento petro-paolino, non ha fatto che arrampicarsi sugli specchi, arrivando a dare per scontato, come una setta che si rinchiude in se stessa, che i Giudei non sarebbero arrivati a credere neppure se avessero visto Dio in persona. Questa è la ragione per cui definiamo il testo fortemente antisemitico e non destinato ai lettori giudei, ma ai cristiani di origine ebraica o pagana.
Come può essere interpretata una comunità che se la prende contro chi chiede un segno incontrovertibile e che, per tutta risposta, mette sul piatto tre “prove” che, alla resa dei conti, non valgono nulla? Dove sta la superiorità del cristianesimo rispetto all'ebraismo? Perché non dire semplicemente, come hanno fatto i Sinottici, che non sarebbe stata offerta alcuna prova, né umana né divina?
Il motivo di tutto ciò è molto semplice: questa seconda parte del discorso è stata scritta in un momento in cui i rapporti tra cristiani ed ebrei s'erano irrimediabilmente guastati. Le evidenti tracce di antisemitismo possono addirittura far pensare a una sorta di dura controversia (un regolamento di conti) tra gli elementi ebraici e quelli pagani interni a una medesima comunità cristiana: l'ellenismo (o gnosticismo cristiano) pare negare qualunque valore all'ebraismo, persino a quello che dice d'essere “cristiano”.
Ma l'antidemocraticità del discorso non sta tanto o non sta solo in questo. Qui non siamo in presenza soltanto di una contrapposizione irriducibile tra ebraismo e cristianesimo. In questo discorso il soggetto totalmente assente, quello che in definitiva avrebbe potuto offrire la prova più convincente della giustezza dell'operato del Cristo, è il popolo.
Qui sembra di assistere a un confronto antistorico tra un singolo che si ritiene figlio esclusivo di Dio, presumendo di dimostrarlo nei modi più strampalati, e un pubblico che, al solo sentirlo parlare, lo ritiene un bestemmiatore. Da questo confronto è totalmente assente un qualunque riferimento alle condizioni storico-politiche della Palestina di allora, ch'erano poi quelle stesse che avevano indotto migliaia di persone ad aderire, in varie forme e modi, al movimento nazareno.
Il cristianesimo di questo vangelo vuol porre le basi di uno scontro di civiltà basato su questioni esclusivamente religiose, che nulla hanno a che vedere con le reali esigenze dei protagonisti dell'epoca. Vengono poste le basi di una storiografia del tutto mitologica, in cui ancora oggi credono milioni di persone.
(torna su)11) La politica nella festa delle Capanne
Gv 7
[1] Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
[2] Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne;
[3] i suoi fratelli gli dissero: “Parti di qui e va' nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai.
[4] Nessuno infatti agisce di nascosto, se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo!”.
[5] Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui.
[6] Gesù allora disse loro: “Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto.
[7] Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che le sue opere sono cattive.
[8] Andate voi a questa festa; io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto”.
[9] Dette loro queste cose, restò nella Galilea.
[10] Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di nascosto.
[11] I Giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: “Dov'è quel tale?”.
[12] E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla; gli uni infatti dicevano: “È buono!”. Altri invece: “No, inganna la gente!”.
[13] Nessuno però ne parlava in pubblico, per paura dei Giudei.
[14] Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e vi insegnava.
[15] I Giudei ne erano stupiti e dicevano: “Come mai costui conosce le Scritture, senza avere studiato?”.
[16] Gesù rispose: “La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato.
[17] Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso.
[18] Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia.
[19] Non è stato forse Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva la Legge! Perché cercate di uccidermi?”.
[20] Rispose la folla: “Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?”.
[21] Rispose Gesù: “Un'opera sola ho compiuto, e tutti ne siete stupiti.
[22] Mosè vi ha dato la circoncisione non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi e voi circoncidete un uomo anche di sabato.
[23] Ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la Legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato?
[24] Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio!”.
[25] Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: “Non è costui quello che cercano di uccidere?
[26] Ecco, egli parla liberamente, e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo?
[27] Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia”.
[28] Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: “Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete.
[29] Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato”.
[30] Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora.
[31] Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: “Il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di quelli che ha fatto costui?”.
[32] I farisei intanto udirono che la gente sussurrava queste cose di lui e perciò i sommi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.
[33] Gesù disse: “Per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato.
[34] Voi mi cercherete, e non mi troverete; e dove sono io, voi non potrete venire”.
[35] Dissero dunque tra loro i Giudei: “Dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e ammaestrerà i Greci?
[36] Che discorso è questo che ha fatto: Mi cercherete e non mi troverete e dove sono io voi non potrete venire?”.
[37] Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva
[38] chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”.
[39] Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato.
[40] All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: “Questi è davvero il profeta!”.
[41] Altri dicevano: “Questi è il Cristo!”. Altri invece dicevano: “Il Cristo viene forse dalla Galilea?
[42] Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?”.
[43] E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui.
[44] Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso.
[45] Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: “Perché non lo avete condotto?”.
[46] Risposero le guardie: “Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!”.
[47] Ma i farisei replicarono loro: “Forse vi siete lasciati ingannare anche voi?
[48] Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei?
[49] Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!”.
[50] Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù:
[51] “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”.
[52] Gli risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea”.
[53] E tornarono ciascuno a casa sua.
*
Quando Giovanni parla di “Giudei” sensu lato, senza specificare il particolare gruppo politico, non sempre intende riferirsi alle autorità di Gerusalemme. A volte si riferisce alla popolazione giudaica nella sua interezza. Bisogna dunque indovinare dal contesto in quale accezione viene usata questa parola. Qui, al v. 1, non si può non pensare alle autorità del Tempio e in modo particolare ai sommi sacerdoti e ai sadducei: costoro infatti avevano deciso la condanna a morte di Gesù subito dopo ch'egli aveva cominciato a violare il sabato (i vangeli dicono con le “guarigioni”) e a negare l'esistenza di un Dio superiore all'uomo (Gv 5,18). Ecco perché – afferma Giovanni – “dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea e non voleva più girare per la Giudea” (v. 1).
In realtà i fatti in questione sono quelli che legano questo racconto a quello detto dei “pani moltiplicati”. È dopo la massiva defezione dei discepoli galilei sul monte Tabor che il Cristo continua a muoversi in Galilea, senza riuscire a trovare una valida alternativa a quell'inaspettato smacco e, nello stesso tempo, senza poter rientrare in Giudea, in quanto teme che lo arrestino immediatamente. Dalla primavera all'autunno di quell'anno deve aver vissuto come un pesce fuor d'acqua.
Di fronte a questa situazione improduttiva, i “fratelli” (cioè gli altri figli di Maria o comunque i parenti più stretti interessati al suo messaggio), che qui paiono gli unici a essergli rimasti vicini, oltre naturalmente ai discepoli più fidati, ben sapendo che per lui il problema era quello di riuscire a trovare un'intesa strategica, in funzione antiromana, tra Giudei e Galilei, gli chiedono insistentemente, pensando all'approssimarsi della festa delle Capanne (quella del raccolto autunnale), di partire per la Giudea, al fine di esporre pubblicamente il suo progetto.
Il v. 3, sotto questo aspetto è illuminante, ma sotto un altro aspetto confonde molto le acque. Affermano infatti i suoi fratelli: “Parti di qui e va' nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai”. Col che essi sembrano fare riferimento a un'attività di successo in Galilea, un'attività che, secondo loro, meriterebbe d'essere proseguita in Giudea; anzi, per loro, è addirittura un suo dovere politico farsi conoscere in Giudea negli stessi termini in cui s'era fatto conoscere in Galilea.
In realtà non può essere andata così. Essi dovevano essere ben consapevoli della gravità dello sbandamento del movimento nazareno in Galilea; se adesso gli chiedono di recarsi in Giudea, esponendosi in prima persona, lo fanno proprio per tenere alta l'istanza rivoluzionaria che fino a quel momento il movimento aveva avuto e non perché “non credevano in lui” (v. 5). L'atteggiamento che hanno è opposto a quello dei parenti che nel vangelo di Marco volevano distoglierlo dal continuare l'attività politica (3,31).
Dove sta dunque il contrasto tra Gesù e i suoi fratelli? Apparentemente infatti si ha l'impressione ch'essi lo stiano provocando e non consolando, e che arrivino persino ad accusarlo di opportunismo. Il loro modo di vedere pare astratto, avventuristico e, in tal senso, fa bene Giovanni a scrivere che “neppure loro credevano in lui” (v. 5).
Le cose purtroppo non sono così semplici e il v. 5, preso così com'è, sembra non avere alcun senso. In realtà i suoi fratelli gli chiedono di entrare in Giudea proprio perché hanno fiducia in lui, proprio perché hanno capito che la defezione galilaica non può essere un motivo sufficiente per rinunciare all'idea dell'insurrezione nazionale, proprio perché hanno capito che la sua idea di cercare un'alleanza coi Giudei per realizzare una rivoluzione vittoriosa è giusta. Dunque perché Gesù rifiuta di partecipare pubblicamente alla festa delle Capanne, che sicuramente sarebbe stata un'ottima occasione per riprendere i rapporti coi Giudei?
Il motivo è di opportunità. Gesù non crede affatto di avere sufficiente popolarità per evitare l'arresto, né che i Giudei siano disposti ad ascoltarlo per permettergli di aumentarla. Non è dunque sulla strategia ch'egli non è d'accordo coi suoi fratelli, ma sulla tattica. Gli stanno chiedendo qualcosa di eccessivamente rischioso.
Ora, per quale motivo i redattori cristiani hanno reso le cose così poco chiare, manipolando persino quelle poche righe di circostanza, che aiutavano a capire il nesso contestuale tra questo racconto e quello dei cosiddetti “pani moltiplicati”? Il motivo è rinvenibile proprio nella risposta, dal sapore metafisico, che Gesù ha dato ai suoi fratelli: “il mio tempo non è ancora venuto”, mentre per quanti, velleitariamente, non tengono conto della realtà “il tempo è sempre pronto” (v. 6).
Detta così, la risposta può soltanto voler dire una cosa, che mentre per i suoi fratelli le istanze che supportano le loro richieste di esposizione pubblica sono squisitamente politiche, lui invece deve tener conto di istanze ben più elevate, di tipo eminentemente religioso, che non dipendono strettamente da lui, ma da chi l'ha “mandato”. Cioè in sostanza – secondo l'intenzione redazionale dei manipolatori di Giovanni – egli avrebbe fatto capire che i Giudei lo volevano eliminare perché non accettavano la sua pretesa uguaglianza con la divinità, come già eloquentemente risulta, nel vangelo di Giovanni, in tutto il quinto capitolo.
Ecco, ora s'è capito il motivo per cui i redattori hanno inserito il v. 5, proprio per indurre il lettore a credere che persino i suoi fratelli di sangue erano lontanissimi dal comprendere la sua natura divino-umana. Ma questo versetto resta illogico sotto ogni punto di vista, anche sul piano teologico, poiché esso avrebbe avuto un qualche senso mistico soltanto se la situazione fosse stata rovesciata, cioè solo nel caso in cui i fratelli si fossero opposti alla decisione di Gesù di salire a Gerusalemme per adempiere alla volontà del Dio-padre.
Tuttavia, per non apparire ai loro occhi come un pusillanime, egli decise ugualmente, a proprio rischio e pericolo, di recarsi alla festa, seppure in maniera clandestina, “di nascosto” – dice Giovanni (v. 10).
Intanto la folla dei Giudei lo cercava per poter discutere con lui: “gli uni dicevano: – È buono! Altri invece: – No, inganna la gente! Nessuno però ne parlava in pubblico, per paura dei Giudei” (vv. 11-13). Anche qui due modi diversi di usare la parola “Giudei”: nel primo caso si tratta della gente comune, tra cui vi sono persone favorevoli al vangelo ed altre contrarie; nel secondo caso si tratta delle autorità sinedrite, generalmente avverse alla sua predicazione.
Questo modo di rappresentare le cose è del tutto normale: situazioni del genere rientrano nel cliché di qualsivoglia rapporto storico tra reazione e progresso. Sarebbe anzi apparso alquanto strano che con la parola “Giudei” Giovanni volesse indicare un solo atteggiamento nei confronti di Gesù e del suo movimento. Anzi si può dire che proprio nel suo vangelo, a differenza dei Sinottici, la cui impostazione redazionale è di tipo massimalista, vi sono descrizioni più sfumate relativamente alle posizioni dei vari gruppi politici. Giovanni è in grado non solo di individuare chi tra le autorità sinedrite era possibilista nei confronti del Cristo (p.es. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo), ma anche di precisare le diverse sfaccettature delle ideologie popolari.
Non si capisce tuttavia perché non sottolineare, nella pericope, questa importante differenza politica. Qui si ha l'impressione che l'uso del termine plurale “Giudei” abbia quasi una valenza antisemitica: è come se l'ideologia cristiana sia intervenuta per marcare la propria netta contrapposizione al giudaismo, al punto da far risultare inincidenti le debite precisazioni storiche. Neppure Giuseppe Flavio, che pur passò esplicitamente dalla parte dei Romani, tradendo il suo popolo, si permise mai di compiere delle generalizzazioni così unilaterali.
Ora, nonostante la scelta dell'anonimato, nel corso della festa, Gesù – dice Giovanni o un altro redattore di questo racconto interpolato – decise lo stesso di esporsi pubblicamente, insegnando addirittura presso il Tempio (v. 14). Pare, nel contesto della pericope, che solo in occasione di questa festa i Giudei si siano accorti della originalità del suo pensiero (di qui le osservazioni esegetiche relative a una redazione plurima di questo racconto).
In particolare si meravigliano della sua approfondita conoscenza delle Scritture – lui che non aveva studiato presso alcuna scuola rabbinica (v. 15) – nonché delle capacità dimostrate di denunciare l'incoerenza tra il significato della legge di Mosè e il modo in cui veniva applicata e interpretata. “Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi la osserva!” (v. 19). Eccone la prova: “Mosè vi ha dato la circoncisione – non che essa venga da Mosè ma dai patriarchi – e voi circoncidete un uomo anche di sabato” (v. 22).
Gesù ha scelto un esempio utile a giustificare il suo operato taumaturgico, giudicato illegale dai sinedriti: “Ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato?” (v. 23). Cioè in pratica egli voleva dimostrare, motivando la guarigione dell'infermo presso la piscina di Betzaetà (Gv 5,1 ss.), che se si considera la circoncisione (istituita dai patriarchi) superiore al sabato (istituito da Mosè), al punto che si pensa di rispettare la legge circoncidendo anche di sabato, allora, visto che la circoncisione altro non rappresenta che il simbolo di una purificazione interiore, non c'era ragione di vietare una guarigione che si poneva come simbolo di una liberazione dall'oppressione da tutti invocata.
Un'esegesi del genere è certo forzata rispetto al testo giovanneo. Essendo la pericope di natura più giuridica che politica (di qui l'ipotesi di una seconda mano redazionale), forse l'interpretazione più corretta è la seguente: guarendo di sabato, Gesù non chiedeva di abolire il precetto ma solo di “umanizzarlo”, facendo leva appunto sul fatto ch'esisteva un'eccezione unanimemente condivisa ogniqualvolta gli otto giorni prescritti per la circoncisione cadevano di sabato.
Se però ci si limitasse a un'interpretazione del genere, rinunciando a vedere nelle sue parole ogni riferimento di natura politica, si dovrebbe concludere che l'insegnamento del Cristo metteva semplicemente in discussione che l'idea di giustizia potesse dipendere dal mero rispetto della legge, non foss'altro perché tale equazione – come appunto nel caso della circoncisione – veniva regolarmente smentita.
Ora, forzando di nuovo la mano, cioè portando di nuovo il senso della diatriba entro i binari della politica, si potrebbe invece concludere che il messaggio del Cristo mirava a far capire che la scelta di quanti credono d'essere nel giusto, limitandosi a una pura e semplice osservanza di nome giuridiche, è destinata ad essere messa in crisi tutte le volte che si manifestano delle esigenze umane superiori alla stessa legge (a maggior ragione se di “liberazione nazionale”), al punto che chi non accetta questa realtà naturale delle cose rischia di compiere azioni che alla fine risultano contrarie a ogni forma di legalità.
Da notare che se si accetta un'interpretazione meramente giuridica del testo si deve necessariamente concludere che la motivazione per cui i capi giudei volevano morto Gesù dipendeva soltanto da una diversa interpretazione del precetto del sabato; se invece si accetta un'interpretazione politica, si deve concludere che i capi lo volevano morto perché avevano capito che la violazione del sabato poteva rappresentare il segno di una minaccia incombente nei confronti del loro potere costituito.
Questa distinzione è importante per capire la differenza tra le due mani redazionali. Se si accetta la versione giuridica deve per forza apparire naturale che la folla si scandalizzi quando Gesù afferma che, a causa della violazione del sabato, lo volevano uccidere: nessuno infatti tra la folla lo avrebbe ucciso per una motivazione del genere, ed è quindi naturale che lo si accusi d'essere un indemoniato (v. 20). Qui, tra Gesù e la folla, non c'è vero dialogo: mentre lui infatti dà per scontato di non essere capito, l'altra invece non vede nella violazione del sabato un significato eversivo.
Se invece si opta per l'interpretazione politica ci si accorgerà subito che, da un lato, il Cristo cercava un consenso che andasse al di là della pura e semplice violazione del sabato e, dall'altro, che la folla avrebbe sì potuto seguirlo, ma anche ucciderlo.
La tendenza, presente in tutti i vangeli, a spoliticizzare la figura del Cristo impedisce di vedere nella folla un soggetto che per motivi politici avrebbe anche potuto, consapevolmente, condannarlo a morte.
Sull'operato di Gesù le opinioni erano molte, spesso discordanti. È d'altra parte normale che di un evento molto popolare si parli in forme e modi molto diversi. Al v. 27 Giovanni indica l'opinione di chi credeva in un messia “superuomo”, capace di liberare in maniera prodigiosa la Giudea dai Romani. Era l'opinione di chi, fino a quando non sarebbe apparso un messia del genere, non avrebbe mosso un dito per predisporne la venuta. Altri invece dubitavano che l'arrivo in gloria del vero messia avrebbe oscurato la grandezza di quest'uomo venuto dalla Galilea.
Vanno notate tuttavia altre cose. Anzitutto l'obiezione che gli muovono, ai vv. 25-26, non entra nel merito della discussione sul valore del sabato, in quanto chiama in causa il fatto ch'egli predica liberamente in pubblico, senza che le autorità giudaiche intervengano. Per quale ragione sia stata messa questa tergiversazione appare poco chiaro. È probabile che i redattori cristiani volessero evitare di far notare che in realtà non c'era stata alcuna guarigione miracolosa e che il vero problema, oggetto di discussione, era soltanto il diverso modo di concepire il significato del riposo assoluto. Un'argomentazione del genere avrebbe comunque avuto il suo senso anche nel caso in cui Gesù non avesse compiuto alcuna guarigione miracolosa, ma si fosse semplicemente limitato ad aiutare quel paralitico ad entrare, di sabato, nelle acque terapiche della piscina, da cui poi ne uscì guarito, ricevendo da lui l'invito a tornarsene a casa portandosi il suo lettuccio (il che peraltro potrebbe confermare la tesi che le guarigioni altro non erano che operazioni di tipo “psicologico”).
Ai redattori cristiani di questa pericope non deve essere affatto piaciuto che nella versione originaria di Giovanni Zebedeo si discutesse di un argomento del genere, prescindendo da quegli straordinari poteri taumaturgici, così ben presenti nei Sinottici, che avrebbero potuto essere interpretati in direzione di una stretta uguaglianza tra Cristo e Dio. Anche qui dunque le manipolazioni devono essere state pesanti, e fa un po' sorridere veder biasimare i farisei che giudicano “maledetto” (v. 49) il popolino ignorante, quando, per accettare queste interpretazioni evangeliche, il lettore cristiano doveva avere una dose di credulità ancora maggiore.
Si prenda p.es. il v. 15, ove viene detto che i Giudei si meravigliano alquanto che Gesù conosca molto bene le Scritture senza aver fatto studi accademici. Una constatazione del genere, fatta passare come storica, è una vera manna dal cielo per un falsificatore, il quale non avrà scrupoli nel motivarla dicendo che Gesù era più esperto di un rabbino proprio perché era “figlio di Dio”. E non a caso anche in questo episodio, come in quello del capitolo quinto, i Giudei cercano di arrestarlo proprio quando egli si equipara a Dio.
Intere righe di testo sono state indebitamente inserite in una stesura originaria ch'era o molto più breve o molto diversa, in quanto non è da escludere che vari passi siano stati del tutto censurati. Basta p.es. guardare la decisione di arrestarlo: al v. 30 sembrano volerlo fare gli stessi Giudei che discutono con lui; al v. 32 sono invece i capi dei sacerdoti e i farisei che mandano apposite guardie.
Questo fa pensare che i redattori cristiani volessero accuratamente evitare di far credere che tra i Giudei vi potessero essere frange significative disposte ad ascoltarlo e persino a seguirlo. Il loro intento era quello di dimostrare che il giudaismo in quanto tale aveva giustiziato il proprio messia, il quale, per somma sventura dello stesso giudaismo era addirittura l'unigenito figlio di Dio, cioè una sorta di tragico eroe greco.
Da qui all'accusa, terribile, di “popolo deicida” il passo non poteva che essere molto breve. Ai vv. 33-36 l'antisemitismo di questo racconto raggiunge vette alquanto elevate, poiché qui i redattori cristiani si permettono il lusso di ipotecare il destino dell'intero popolo giudaico, imponendogli un fardello dal peso insopportabile: l'impossibilità di ottenere per sempre una qualunque forma di liberazione.
Qui i redattori ebreo-cristiani tradiscono le loro influenze ellenistiche, considerandosi il nuovo “popolo eletto”, sparso nel mondo, senza alcun confine geografico, senza alcuna “nazione” da difendere. Si contrappongono nettamente al giudaismo, dimenticandosi che in quel frangente storico il nemico comune da combattere era l'imperialismo romano.
Si può invece ipotizzare che buona parte delle masse giudaiche non era affatto ostile al messaggio di Gesù, tant'è che le guardie mandate dai farisei e sommi sacerdoti per arrestarlo, non riuscirono a far nulla (vv. 44-45). Esse infatti – secondo i redattori manipolatori – dicono ai farisei di essere rimaste affascinate dalle parole divino-umane di quel “galileo”. In realtà il motivo dipendeva dal loro esiguo numero: non si aspettavano un consenso così forte. Al che i farisei, indignati, replicarono: “Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta!” (vv. 47-49).
Nel vangelo di Giovanni l'ipocrisia dei farisei, formalmente progressisti (perché frequentavano le masse) e sostanzialmente reazionari (perché appoggiavano il clero conservatore), è descritta con grande maestria. Senonché – dice Giovanni – tra i capi farisei c'era anche chi, come Nicodemo, si sforzava di guardare le cose obiettivamente, senza pregiudizi di sorta, come al tempo dell'epurazione del Tempio: “La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?” (v. 51). Nicodemo in sostanza chiedeva di stabilire col movimento di Gesù un vero e proprio confronto politico. Ma i suoi colleghi, con durezza e acrimonia, gli ribatterono: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea” (v. 52).
In altre parole i farisei più integralisti (la netta maggioranza) collegavano strettamente l'autenticità del messaggio messianico con la sua origine etnica: da una terra imbastardita come la Galilea (soggetta a molte influenze pagane) non poteva sorgere – secondo loro – la vera liberazione nazionale. Per i farisei era più facile credere che la resistenza antiromana potesse sorgere dal convincimento di appartenere a un popolo “eletto”, che non da un'istanza di liberazione comune a tutti gli oppressi. In tal senso essi rifiutavano un'alleanza strategica coi Galilei per motivi speculari a quelli che questi avevano nei confronti dei Giudei.
Dopo questo disquisire di alta politica, l'epilogo giovanneo: “E tornarono ciascuno a casa sua” (v. 53), sembra lasci trapelare qualcosa che sconfina tra il comico e il tragico. Tutto sommato, comunque, Gesù era riuscito a ottenere più consensi di quelli sperati.
(torna su)12) Cristo e Abramo
Gv 8,12-59
[12] Di nuovo Gesù parlò loro: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.
[13] Gli dissero allora i farisei: “Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera”.
[14] Gesù rispose: “Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado.
[15] Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno.
[16] E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato.
[17] Nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera:
[18] orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà testimonianza”.
[19] Gli dissero allora: “Dov'è tuo padre?”. Rispose Gesù: “Voi non conoscete né me né il Padre; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio”.
[20] Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro mentre insegnava nel Tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora.
[21] Di nuovo Gesù disse loro: “Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire”.
[22] Dicevano allora i Giudei: “Forse si ucciderà, dal momento che dice: Dove vado io, voi non potete venire?”.
[23] E diceva loro: “Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo.
[24] Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati”.
[25] Gli dissero allora: “Tu chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che vi dico.
[26] Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui”.
[27] Non capirono che egli parlava loro del Padre.
[28] Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo.
[29] Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite”.
[30] A queste sue parole, molti credettero in lui.
[31] Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;
[32] conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”.
[33] Gli risposero: “Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi?”.
[34] Gesù rispose: “In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato.
[35] Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre;
[36] se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.
[37] So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi.
[38] Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro!”.
[39] Gli risposero: “Il nostro padre è Abramo”. Rispose Gesù: “Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo!
[40] Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto.
[41] Voi fate le opere del padre vostro”. Gli risposero: “Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio!”.
[42] Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato.
[43] Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole,
[44] voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna.
[45] A me, invece, voi non credete, perché dico la verità.
[46] Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
[47] Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio”.
[48] Gli risposero i Giudei: “Non diciamo con ragione noi che sei un Samaritano e hai un demonio?”.
[49] Rispose Gesù: “Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate.
[50] Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica.
[51] In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”.
[52] Gli dissero i Giudei: “Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte”.
[53] Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”.
[54] Rispose Gesù: “Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”,
[55] e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola.
[56] Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò”.
[57] Gli dissero allora i Giudei: “Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?”.
[58] Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono”.
[59] Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
I
Tutto il cap. 8 del quarto vangelo, se si esclude il racconto spurio dell'adultera, è incentrato su un unico tema, che per la vastità della trattazione non ha precedenti in alcun altro vangelo e che troverà pari interesse solo nella Lettera ai Romani di Paolo di Tarso: come dimostrare la superiorità di Cristo su Abramo, il vero padre spirituale dell'ebraismo.
Questo è uno dei capitoli più antisemitici del vangelo giovanneo ed è stato elaborato allo scopo di dimostrare, in maniera artificiosa, che la superiorità di Cristo su Abramo non era tanto di natura politica, bensì teologica, non di natura umana bensì divina. Quindi, sotto questo aspetto, vi domina l'impossibilità assoluta di una qualunque intesa tra Gesù e i Giudei.
Risulta pertanto molto difficile individuare quali passi possono ritenersi sufficientemente credibili, anzi si può addirittura pensare che tutto il capitolo sia stato completamente inventato. Non è neppure possibile trovare un'adeguata collocazione spazio-temporale alla controversia, se non quelle generiche del Tempio di Gerusalemme (sala del tesoro). Gesù non fa allusione ad alcuna situazione pregressa. L'unico legame col capitolo precedente sta nel fatto che i redattori cristiani, dopo aver fatto vedere come Gesù si ritenesse superiore a Mosè (giudaismo legale), ora invece vogliono far credere ch'egli si ritenesse superiore allo stesso Abramo, cioè ai fondamenti ancestrali dell'ebraismo, quelli in un certo senso ontologici, poiché Abramo fu il primo a rifiutare nettamente, nell'interpretazione storica che il giudaismo dà di se stesso, lo schiavismo come sistema di vita.
I redattori avevano di fronte a loro un compito molto difficile da risolvere: come dimostrare la superiorità di un uomo con una storia molto breve rispetto al capostipite della nazione ebraica. La soluzione trovata è, in un certo senso, sconcertante: la superiorità del Cristo su Abramo è assoluta, in quanto teologica, al punto che qualunque discepolo abbia fede nel vangelo di Cristo è superiore allo stesso Abramo. Neppure Paolo (nelle lettere ai Romani, ai Galati e agli Ebrei) e neppure Pietro (negli Atti degli apostoli) si erano mai spinti a tanto: Abramo, per loro, restava comunque il campione della fede, di quella fede in virtù della quale gli ebrei potevano aspirare a veder realizzato un popolo universale, che comprendesse anche i pagani.
Nel vangelo di Giovanni la situazione assume toni molto più radicali: la vera fede è solo quella che si può avere nel Cristo e Abramo è grande solo nella misura in cui gli viene dato il diritto di concepirsi come suo discepolo! Non stupisce che una posizione così estrema (se mai sia stata sostenuta) potesse essere giudicata dagli interlocutori giudei di quel momento al pari di una bestemmia o di una follia meritevole di morte.
È probabile che i redattori cristiani si siano sentiti costretti a questi eccessi perché ancora forte doveva essere, al loro tempo, l'esigenza di una liberazione della Palestina dal giogo romano, per la cui riuscita gli ambienti giudaici pensavano fosse sufficiente ribadire un puro e semplice senso di appartenenza alla stirpe ancestrale degli antichi patriarchi, il primo dei quali era appunto Abramo; cosa che, peraltro, era già stata contestata dal movimento battista, che predicava l'urgenza di un impegno concreto sul piano sociale e civile (Lc 3,8).7
I redattori cristiani hanno preferito imbastire un discorso di tipo metafisico, in cui la grandezza di Cristo viene fatta dipendere non tanto dal suo carisma personale o dal programma politico del suo movimento, quanto piuttosto da una pretesa “figliolanza divina”. Essi così hanno potuto facilmente dimostrare che l'aristocraticismo della nazione santa e del popolo eletto erano un nulla rispetto alla grandezza divina del Cristo. È facile pensare, in tal senso, che una pericope del genere dovesse avere come target quei cristiani che ancora non avevano rinunciato, senza rimpianti, alla loro origine ebraica.
Nel dibattito riportato in questo capitolo siamo in presenza di una sorta di “teologia della storia”, esposta in una forma dialogica molto simile a quella usata nelle grandi opere platoniche, nelle quali però alla fine ognuno tornava a casa, felice d'aver compiuto un'ottima conversazione filosofica sui massimi sistemi. Qui invece un ottimismo di maniera viene escluso a priori.
Siamo indubbiamente in presenza di un'operazione redazionale di tipo intellettualistico, con forzature interpretative di livello elevato, ancorché assolutamente inaccettabili, ma alla fine della conversazione è il dramma che domina, poiché l'intenzione degli interlocutori giudei è sempre la stessa, nell'ottica espositiva dei redattori cristiani del quarto vangelo: o cercano di arrestare Gesù o addirittura di linciarlo sul posto.
II
La diatriba ha il suo esordio con una precisa obiezione da parte dei farisei: “Tu sei testimone di te stesso, dunque la tua testimonianza non è valida” (v. 13). Si riprende qui un tema già trattato nel capitolo 5: l'accusa farisaica di non poter credere nella divinità del Cristo, in quanto questi non è in grado di provarla, limitandosi a dare una sorta di autotestimonianza.
Sembra uno strano doppione, per cui si può anche pensare che qui siano intervenute nuove mani redazionali. L'esigenza di scriverla può anche essere dipesa dal fatto che se per dimostrare la superiorità divina del Cristo rispetto a Mosè, si era già dovuti ricorrere nel cap. 5 a una sorta di irrazionalismo teologico, ora, parlando di Abramo, non resta che approfondire la strada già segnata.
In realtà, se anche volessimo dare per scontato che il Cristo non era interessato a cercare una testimonianza a suo favore nell'ambito dei poteri costituiti, la motivazione di ciò non può certo essere stata quella delineata nei vangeli, ovvero l'individualismo mistico, irriducibile a qualunque consenso umano.
In altre parole, i farisei possono anche aver avuto la consapevolezza di avere di fronte a loro un'alternativa, anche piuttosto radicale, all'ideologia dominante, ma è da escludere a priori che i limiti epistemologici entro cui doveva essere definita tale alternativa fossero quelli “cristiani”.
È impossibile che i farisei non si siano resi conto che nei discorsi del Cristo non erano solo presenti elementi politici a favore della liberazione nazionale, sui quali, volendo, ci si poteva confrontare senza problemi, ma anche elementi culturali che urtavano contro tradizioni storicamente acquisite, una delle quali era appunto quella relativa al modo di considerare Abramo capostipite della loro stirpe. È comunque da escludere tassativamente l'attendibilità di tutto l'impianto che in questo capitolo s'è voluto dare alla controversia in oggetto.
Se il tentativo del Cristo può essere stato quello di dimostrare che il senso di appartenenza a una specificità etnica di per sé può anche risultare del tutto ininfluente ai fini della liberazione nazionale (cosa che già il Battista aveva detto), nel contesto della nostra pericope la dimostrazione è stata condotta su binari che non potevano certo essere i suoi, poiché nessuno sarebbe stato in grado di capirla, neppure una coscienza “cristiana” che non fosse già stata indotta ad accettare la tesi petro-paolina della “resurrezione” e della “natura divina” del messia.
III
Qui bisogna aprire una parentesi, altrimenti si rischia di fraintendere il senso di ciò che abbiamo appena detto. I vangeli sono documenti nati allo scopo di dimostrare che la sconfitta politica del Cristo in realtà è stata una vittoria contro la morte e il peccato. Se i vangeli fossero stati scritti da redattori onesti, ci si sarebbe dovuti limitare a raccontare i fatti, mostrando che, sino all'ultimo, Cristo era rimasto coerente coi propri ideali e quindi, in un certo senso, aveva trionfato sulla tentazione di tradirli.
Tuttavia, una versione del genere sarebbe risultata contraddittoria con gli ideali stessi del Cristo, per i quali egli era morto nella convinzione che i discepoli li avrebbero ripresi in maniera non meno coerente. I discepoli invece non furono capaci di questa coerenza, non ebbero la necessaria determinazione e, poiché non vollero neppure dimenticare ciò che avevano vissuto, decisero che l'unico modo di proseguire il messaggio del Cristo era quello di modificarlo sensibilmente in direzione della religione, cioè in direzione della rinuncia alle istanze di tipo politico-rivoluzionario. Di qui la necessità di falsificare tutto ciò che poteva contraddire questa scelta di campo.
I vangeli quindi sono il frutto di un compromesso tra ciò che non si poteva dimenticare e ciò che non si voleva dire, tra ciò che si sarebbe dovuto fare e ciò che effettivamente fu fatto. Posto questo, è facile rendersi conto che ogniqualvolta i redattori chiamano in causa motivazioni o spiegazioni di natura mistica, lì occorre sospettare che sia avvenuta una qualche falsificazione dei fatti.
Il tema di questa pericope, in tal senso, è molto chiaro: che valore ha la testimonianza di un uomo uscito politicamente sconfitto dal suo scontro coi poteri costituiti? La risposta che si è data a questa domanda non è ovviamente quella che si sarebbe dovuta dare, altrimenti i vangeli non sarebbero testi ideologici ma storici, per quanto sia sempre lecito il dubbio sull'equivalenza tra storia e scienza o tra storia e verità. Sarebbe sciocco pensare come possibile una scienza senza ideologia.
Un testo storico avrebbe dovuto limitarsi a dire che al Cristo nessuno seppe dare vera testimonianza, poiché nessuno riuscì a proseguire fedelmente la strada ch'egli aveva indicato, in quanto i tradimenti furono all'ordine del giorno non solo in occasione del processo, ma anche subito dopo la crocifissione, allorché si cominciò a sostenere – dopo aver constatato la tomba vuota – che il Cristo sarebbe tornato e avrebbe trionfato sui suoi nemici. Un testo storico scritto dagli apostoli avrebbe anzitutto dovuto essere autocritico.
Qual è stata invece la scelta che si è presa redigendo i vangeli e in particolare questa pericope? Quella di sostenere che il Cristo non aveva bisogno della testimonianza di nessuno, poiché egli l'aveva direttamente da Dio.
Con delle premesse del genere le conclusioni non potevano che essere inequivoche: ciò che il Cristo fece fu voluto da Dio; gli uomini che l'hanno seguito non sono responsabili di alcun tradimento; gli unici veri responsabili sono quelli che l'hanno crocifisso, ma anche questi non sono “veri traditori”, in quanto la morte cruenta del Cristo era comunque necessaria o, se vogliamo, prevista dall'insondabile piano di Dio: infatti solo in questa maniera si poteva togliere all'umanità il complesso della colpa originaria e unificare tutto il genere umano in un unico popolo, sotto un'unica Chiesa.
Un Dio fattosi uomo si era sacrificato per redimere l'umanità che dai tempi più remoti si era resa colpevole del proprio distacco dalla divinità. Quest'essere divino-umano aveva accettato liberamente di pagare il prezzo delle colpe dell'intero genere umano. Dio infatti aveva bisogno del sacrificio di qualcuno per potersi riconciliare con l'umanità e questo qualcuno non poteva essere che il Figlio, perché solo il Figlio avrebbe potuto accettare la morte liberamente, dimostrando la sua assoluta innocenza.
Tale versione teologica degli eventi post-pasquali, elaborata in ambienti ebraici filo-ellenistici, se fosse assolutamente falsa, sarebbe stata da tempo facilmente smascherata. Essa in realtà utilizza alcuni elementi di verità stravolgendoli però nel loro significato originario.
Il Cristo effettivamente si sacrificò per il bene di un ideale, che fu appunto quello di far recuperare a Israele e quindi a tutti gli uomini un rapporto basato sulla comunione dei beni, ma in tutto questo aspetti come la religione, Dio, il peccato originale, la resurrezione... vanno considerati come dei corpi estranei, che sono stati aggiunti successivamente, in maniera del tutto arbitraria.
Se vogliamo, proprio quel fariseismo che nel corso della vita di Gesù si oppose strenuamente alla sua predicazione, sarà lo stesso che, per bocca di Paolo, porterà i cristiani al tradimento definitivo del messaggio originario. Paolo di Tarso infatti rappresenta quella corrente farisaica che fu disposta a rinunciare alla liberazione nazionale, convincendo i cristiani che l'intesa tra vecchio e nuovo ebraismo si poteva trovare trasformando il Cristo da liberatore nazionale a redentore universale. Per poter realizzare questa intesa i cristiani dovevano rinunciare all'idea di una parusia imminente del Cristo in veste gloriosa. Il Cristo di Paolo non è più un uomo che deve trionfare come un militare, ma il Figlio di Dio che alla fine dei tempi trionferà come un giudice.
IV
E ora torniamo alla pericope. Anzitutto bisogna premettere che coi concetti di “stirpe eletta”, “nazione santa”, “popolo di Dio”... gli ebrei seppero coltivare per molti secoli il sentimento dell'orgoglio nazionale, con cui hanno potuto opporsi o resistere alle invasioni dei popoli stranieri, ai tentativi di colonizzazione culturale, alle deportazioni in massa e ai genocidi. Proprio in quanto “popolo”, gli ebrei si sentivano diversi dagli altri popoli. Se non fossero oggi concetti decisamente superati, si potrebbe dire che la specificità degli ebrei era sostanzialmente basata sulla “razza” e sul “sangue”. “Siamo figli di Abramo” – questo, nei momenti di crisi nazionale, era il loro grido patriottico.
Qualunque riferimento ad Abramo andava inteso nel senso della pretesa superiorità etnica che il popolo ebraico nutriva nei confronti di tutti gli altri popoli. In virtù di questa storia passata e in parte gloriosa, consolidatasi in precisi usi e costumi, gli ebrei, come “popolo”, erano convinti di poter essere immortali, tant'è che la loro teologia non conosceva neppure concetti come “anima”, “separazione dell'anima dal corpo”, “immortalità personale”, “oltre tomba”, “aldilà”, “resurrezione”...
I fatti, e per fatti si devono qui intendere l'occupazione romana, che di tutte le invasioni straniere fu la più terribile, hanno dimostrato che il concetto di “forza” può anche essere superiore a quello di “etnia”, se quest'ultimo concetto viene vissuto in maniera fatalistica.
I primi cristiani – negli Atti (3,13.25; 7,2-8.16-17.32; 13,27) e nelle Lettere di Paolo (Rm 4,1 ss.; 9,7; 11,1; Gal 3,6 ss.; 3,14-18.29; 4,22; Eb 2,16; 6,13-15; 7,1 ss.; 11,8.17) – si guardarono bene dal mettere in alternativa Cristo ad Abramo. Al contrario, si cercò da subito di dimostrare una certa linea di continuità, sul piano religioso, tra il Dio dei Padri e quello dei cristiani. La fede in Cristo viene presentata come un'alternativa non alla religione ebraica ma al potere dei sommi sacerdoti e dei partiti religiosi che vollero la morte di lui.
Abramo resta per tutti il campione della fede, sia perché se ne uscì con la sua tribù dalla Mesopotamia in cerca della libertà, sia perché fu disposto a sacrificare Isacco. Paolo accetterà questa versione aggiungendovi che ad Abramo era stata promessa una discendenza che non avrebbe fatto differenza tra ebrei e gentili. Forzando un po' i testi, egli sostiene che grazie alle sue opere Abramo ottenne una terra per il suo popolo, ma per la sua fede – che è poi quella che, secondo Paolo, ogni uomo dovrebbe avere – gli fu promessa una discendenza e quindi un'eredità universale, che ha appunto trovato il suo compimento in Cristo, unico vero redentore del genere umano.
Quindi sino a quando gli eventi non li costrinsero ad agire diversamente, sia Pietro che Paolo cercarono subito un compromesso di tipo religioso tra ebraismo e cristianesimo. Ecco perché la pericope del vangelo di Giovanni non può che riflettere la posizione di chi dava per scontata l'impossibilità di tale compromesso: se si rivolge a dei lettori di origine ebraica, essa deve per forza presumere che tali lettori siano già diventati cristiani e che, almeno teoricamente, abbiano rimosso ogni riferimento culturale e religioso al giudaismo.
Lo si comprende soprattutto dal modo come viene usato il termine “testimonianza”, che è un'autentica perspective nel vangelo di Giovanni, una sorta di chiodo fisso che attraversa tutto il vangelo, dall'inizio alla fine. Già nel Prologo il termine viene usato in chiave teologica per dire che il Precursore riconobbe il Cristo come “Figlio di Dio”, quando i fatti, in realtà, dimostrarono proprio il contrario, e cioè che il Battista, al momento di decidere la cacciata dei mercanti dal Tempio, non ebbe il coraggio di seguirlo.
Al termine del racconto dell'epurazione – sempre a proposito del concetto di “testimonianza” – i redattori scrissero due versetti che sicuramente non rispecchiavano la realtà: “Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro; egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo” (Gv 2,24-25). In tal modo Gesù vien fatto passare per un Dio e con un carattere anche piuttosto altezzoso, come se non avesse avuto alcun bisogno di consenso popolare per compiere quell'iniziativa.
Come noto, l'espulsione termina col dialogo ufficioso con Nicodemo, nel quale il Cristo rimprovera al partito farisaico di non aver accolto la sua testimonianza, che è però nel testo quella, assurda, di un uomo che pretende d'essere “disceso dal cielo” (Gv 3,13) e che, per questa ragione, può vedere le cose meglio di altri.
In Gv 5,31-19 il Cristo contrappone addirittura la testimonianza del Dio-Padre a quella del Battista, e rifiuta la testimonianza di qualunque uomo. A quanti cercano nelle Scritture una testimonianza a favore della vita eterna e non si accorgono di averla di fronte a loro, egli risponde che sono ciechi.
In uno degli ultimi discorsi, inventato dai redattori, il Cristo introduce un nuovo elemento divino in grado di rendergli testimonianza: lo Spirito Santo, cioè il Paraclito, il Consolatore. Anche gli apostoli saranno in grado di testimoniare per lui, ma non senza prima aver ricevuto lo Spirito, che procede dal Padre e passa attraverso il Figlio.
Di fronte a Pilato Cristo afferma di essere venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Questo è forse il massimo di concessione laica che il vangelo manipolato di Giovanni è disposto ad ammettere intorno al concetto di testimonianza. Il Cristo cioè non sarebbe stato un politico rivoluzionario ma semplicemente un filosofo idealista.
Fa sorridere, in tal senso, l'attestazione che i discepoli di Giovanni fanno, alla fine del vangelo, in riferimento alla testimonianza oculare dell'apostolo Giovanni, allorché dicono: “Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera” (Gv 21,24). Tale attestazione di fiducia è assai poco convincente, semplicemente perché Giovanni non ha scritto tutto quanto oggi possiamo leggere nel suo vangelo.
Forse l'unica vera testimonianza, quella più tragica, quella più umana che Giovanni poté dare o che gli permisero di dare, fu quella relativa al colpo di lancia che servì per attestare l'avvenuto decesso del Cristo: “uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate” (Gv 19,34 s.). Questo a prescindere dal fatto che ai piedi della croce forse non vi era Giovanni, bensì, tra le altre donne, sua madre Salome.
Quanto alla nostra pericope bisogna dire che il dibattito pare essere suddiviso in sequenze tra loro separate, facilmente individuabili, che potrebbero addirittura essere state scritte in momenti diversi, in quanto non sembrano avere un legame logico-consequenziale tra loro.
La prima include i versetti 12-20, la seconda i versetti 21-29, la terza i versetti 30-47, la quarta i versetti 48-59. Riproducono tutte una sorta di dialogo tra sordi, in cui nessun interlocutore si sforza di andare incontro alle ragioni dell'altro. La diversità di significato che si attribuisce alle parole è totale. Anzi, si ha l'impressione che l'incomprensione aumenti man mano che i Giudei si sforzano di capire le parole di Gesù. Ognuno insomma è convinto di avere la verità in tasca, con la sola differenza che i redattori, stando dalla parte di Gesù, fanno dire a quest'ultimo delle cose così urtanti per la sensibilità giudaica che alla fine deve subire una reazione abbastanza scomposta.
1 – La prima sequenza è la più banale, poiché non aggiunge nulla a quanto già detto nel cap. 5. I farisei criticano Gesù di non poter indicare nessuno che confermi la sua pretesa natura divino-umana, e Gesù obietta di avere Dio-padre come testimone d'eccezione; dopodiché, alla domanda di mostrarlo concretamente, egli risponde che se credessero in lui, crederebbero anche in suo Padre. E così la sequenza viene chiusa, nella maniera tautologica più sublime, tipica di tutte le religioni e anche, se vogliamo, di tutte le persone esaltate: si sostiene che “b” dipende da “a” e a chi non crede si sostiene il contrario: se si accettasse “b” si accetterebbe anche “a”.
In essa risulta assolutamente impossibile trovare una soluzione al problema dell'identità del Cristo, proprio in quanto sono fuori luogo gli stessi termini con cui il problema è stato impostato. Invece di discutere di strategia politica per la liberazione d'Israele, si stanno facendo disquisizioni così astruse, quali se ne potrebbero sentire solo in un ospedale psichiatrico, tra degenti affetti da megalomanie e deliri di onnipotenza.
Il difetto di questo ragionamento è tutto nella premessa, cioè nell'aver bisogno di chiamare in causa una motivazione religiosa per giustificare il proprio operato umano, proprio perché sul piano umano non si riesce a trovare una motivazione convincente.
Da notare che dai redattori cristiani i farisei vengono fatti passare per atei irriducibili e irresponsabili, che non crederebbero neppure se vedessero Gesù resuscitare i morti. Ma anche gli stessi farisei, al sentire Gesù equipararsi a Dio, non possono fare a meno di accusarlo di ateismo. Gli astanti si accusano reciprocamente di indegno ateismo, quando tutti in realtà si professano “credenti”, con la sola differenza che una fede è “mono-teista”, mentre l'altra è “bi-teista”.
2 – Anche la seconda sequenza riprende un tema già affrontato nel capitolo precedente, quello tristissimo e fortemente antisemitico relativo all'impossibilità che i Giudei avranno di ottenere una loro liberazione come popolo: cosa che in questa pericope Gesù prevede con sicurezza e quasi con malcelata soddisfazione.
Evidentemente i redattori, leggendo il capitolo precedente, non si erano accontentati delle perplessità manifestate dai Giudei, i quali si chiedevano, sentendo Gesù parlare in quel modo, se sarebbe andato a predicare al di fuori di Israele, tra gli ebrei-ellenisti o tra gli stessi pagani. Qui la lontananza empatica e teologica che separa l'emittente dal ricevente la si vuole accentuare al massimo, inducendo i Giudei a chiedersi se con le sue parole Gesù non volesse dire che stava per suicidarsi.
I Giudei vengono qui dipinti in maniera caricaturale, come ottusi che non capiscono una sola parola di quello che lui dice. La cosa più curiosa è che i redattori fanno continuamente dire a Gesù che non intende “giudicare” il proprio popolo, e poi però egli non resiste alla tentazione di farlo e nel modo più categorico che può. Qui infatti si delinea una situazione ai limiti del terrorismo psicologico: il Cristo prospetta una pena severissima (“morirete nel vostro peccato”) a tutti coloro che non hanno voluto credere alla sua testimonianza. Ed è soltanto di fronte a queste minacce che finalmente “molti” cominciano a credergli.
Rebus sic stantibus, i cristiani seguaci di Pietro e di Paolo non possono che essersi compiaciuti dei due disastri nazionali avvenuti nel 70 e nel 135 d.C. È difficile infatti dubitare che i ragionamenti fatti da questi redattori fossero già politicamente in linea con le posizioni imperiali romane.
Ambiguo, in questa pericope, resta il v. 28, che pare avere un riferimento al serpente di rame usato da Mosè (Num 21,4 ss.): chiunque lo guardava, dopo essere stato morso da un serpente velenoso (il peccato), restava in vita. Questa cosa era già stata scritta da altri redattori in Gv 3,14, allorché Cristo, parlando a Nicodemo, dopo l'epurazione del Tempio, si paragona esplicitamente al serpente di Mosè.
Tuttavia nella nostra pericope le sequenze più importanti non sono quelle in cui si ribadisce la superiorità di Gesù rispetto a Mosè, ma quelle in cui si propone di considerarlo superiore, in maniera metafisica, allo stesso Abramo.
3 – La cosa stupefacente della terza sequenza è che finalmente Gesù incontra tra i Giudei qualcuno disposto a credere nella sua divinità. Si tratta tuttavia di un semplice fuoco di paglia. Infatti, alla dichiarazione filosofica, dal sapore apodittico, in quanto basata sulla fede religiosa, secondo cui chi avrà fede nella divinità del Cristo conoscerà la verità e questa lo renderà libero, i Giudei, che hanno appena iniziato, nella pericope, a simpatizzare per lui, si sentono in dovere di rispondere che, essendo discendenti di Abramo, che uscì dalla regione di Ur, rifiutando la schiavitù, da sempre loro conoscono la libertà.
Detto questo, il dialogo tra i due interlocutori ripiomba nel buio più assoluto. Gli uni, infatti, quando si parla di “libertà”, pensano a quella politica; l'altro invece intende riferirsi a quella metafisica, per la quale i Giudei, non riconoscendo Gesù come “figlio di Dio”, restano nel “peccato”. Al Cristo manipolato del quarto vangelo non interessano minimamente le condizioni di oppressione sociale e politica del popolo d'Israele: non c'è nessuna missione politica da compiere, ma solo un atto di devozione fideistica. Gli stessi Giudei vengono presentati come se avessero una concezione della libertà del tutto astratta, estranea a qualunque riferimento storico. La figura di Abramo viene usata in chiave mitologica.
A dir il vero la rivendicazione della paternità politica di Abramo la si era già vista nel vangelo di Matteo (3,9), poi ripresa in quello di Luca (3,8), ed era stata usata negli stessi termini di questa pericope, cioè per sostenere la tesi che con un patriarca del genere sarebbe stato impossibile per gli ebrei cadere definitivamente in uno stato di soggezione o di sudditanza nei confronti dello straniero.
Nel quarto vangelo però i redattori vogliono presentare le cose in maniera più radicale: Gesù per loro è superiore a tutti, non solo a Mosè ma anche ad Abramo. Egli si pone non solo come nuovo legislatore, ma anche come nuovo e ultimo patriarca, l'unico in grado di liberare definitivamente dalla schiavitù, quella del peccato.
Di fronte a una pretesa del genere, diventa quasi comico che a un certo punto egli chieda agli astanti che lo ascoltano: “Perché non comprendete il mio parlare?” (v. 43). La risposta, serafica e senza giri di parole, la dà lui stesso: “voi siete figli del diavolo, che è vostro padre... omicida fin dal principio... bugiardo e padre della menzogna” (v. 44). Ed è una risposta data a quelli che avevano iniziato a credergli (vv. 30-31)!
4 – L'ultima sequenza raggiunge il culmine della drammaticità. Il climax è andato in crescendo. La rottura è inevitabile. Non c'è mai stato un vero dialogo, ma solo, da parte di Gesù, la richiesta di accettare una posizione teologica apodittica, senza che l'interlocutore potesse porgli condizioni di sorta.
Insulti per insulti, ormai anche i Giudei non ne possono più e rispondono per le rime. “Non diciamo con ragione che sei un Samaritano e che hai un demonio?” (v. 48). Era come dire “pazzo e bastardo”.
Al che Gesù alza il tiro e si appresta a fare una dichiarazione choc. Cioè invece di trovare una mediazione che ammorbidisca i toni, spara una cannonata, sperando di lasciarli senza parole, come nelle guerre di conquista, quando i militari vogliono far capire una volta per tutte che ogni resistenza è vana.
Con la solita formula solenne usata in casi analoghi, egli dunque afferma: “In verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte” (v. 51). Difficile non prenderla come una dichiarazione da mentecatto.
Ma i redattori cristiani non sono stupidi: sanno bene che se giocano sull'ambiguità semantica della parola “morire” riusciranno ad averla vinta. Per loro infatti è evidente che con essa non si deve intendere la morte “fisica”, quella visibile, terrena, quanto quella “spirituale”, quella dell'anima. E siccome fino adesso hanno dipinto i Giudei come dei volgari materialisti, non avranno difficoltà a metterli di nuovo in imbarazzo.
Sono già stati abilissimi a imporre una discussione basata su presupposti fantastici: ora sarà loro facile sferrare il colpo di grazia. Infatti agli occhi dei Giudei il Cristo vuole apparire come una persona immortale e i redattori cristiani quasi si divertono nel far vedere che i Giudei si scandalizzano proprio della cosa che per i cristiani è in assoluto la più vera. È come la trama di un fumetto, in cui il supereroe sa già in partenza che vincerà, sapendo di aver ottenuto dei poteri infinitamente superiori a quelli di qualunque rivale (e se alla fine deciderà di soccombere, lo farà soltanto non per debolezza ma per ubbidire alla volontà di chi glieli aveva dati).
Il Gesù di questa pericope arriva a dire una cosa, alla fine della controversia, che sarebbe stato molto difficile, se davvero fosse stata detta, non prenderla come una barzelletta o come la spacconata di un malato di mente: “Abramo ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno; e l'ha visto e se ne è rallegrato... in verità vi dico: prima che Abramo fosse nato, io sono” (vv. 56-58).
Difficile aggiungere ulteriori commenti a queste assurdità. Se Gesù avesse davvero parlato in questi termini, quali seguaci avrebbe mai potuto avere? Qui si può semplicemente osservare come la tendenziosità di questa pericope sia tutta dovuta all'errore di voler dimostrare la superiorità del cristianesimo sull'ebraismo dal punto di vista della religione. La nozione di “Dio-Padre” è stata elaborata allo scopo di cercare un'oggettività teologica superiore a quella che l'ebraismo, religione del Libro per eccellenza, poteva offrire con una storia antichissima e con delle figure storiche di grande valore. Indubbiamente su questo piano mistico il tentativo è riuscito, ma sicuramente a un prezzo molto oneroso: l'impossibilità di superare l'ebraismo anche dal punto di vista politico.
(torna su)13) L'ateismo nella festa della Dedicazione
Gv 10,22-42
[22] Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era d'inverno.
[23] Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone.
[24] Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: “Fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”.
[25] Gesù rispose loro: “Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza;
[26] ma voi non credete, perché non siete mie pecore.
[27] Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
[28] Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.
[29] Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio.
[30] Io e il Padre siamo una cosa sola”.
[31] I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo.
[32] Gesù rispose loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?”.
[33] Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”.
[34] Rispose loro Gesù: “Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi?
[35] Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata),
[36] a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio?
[37] Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi;
[38] ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre”.
[39] Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
[40] Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò.
[41] Molti andarono da lui e dicevano: “Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero”.
[42] E in quel luogo molti credettero in lui.
I
Le più grandi mistificazioni compiute dalla Chiesa cristiana nei confronti del Cristo sono state sostanzialmente due: una di natura politica, l'altra di natura culturale. La prima è ben nota: il messia – sostengono i vangeli, senza dirlo esplicitamente, per ovvi motivi – “doveva morire” per unificare ebrei e gentili in un progetto etico-religioso universale, in cui il concetto politico di “liberazione” fosse sostituito da quello teologico di “redenzione”, per il quale la liberazione dalle contraddizioni antagonistiche diventava un obiettivo realizzabile solo in chiave mistica ed escatologica.
Così venne spiegato il fallimento del tentativo insurrezionale dei nazareni per liberare la Palestina dai Romani. La Chiesa ha progressivamente sostituito un progetto politico originario con un progetto teologico artificioso, all'interno del quale il concetto di “resurrezione” – a partire soprattutto dall'ideologia petro-paolina –, con cui s'interpretò l'evento della tomba vuota, è venuto ad assumere un ruolo centrale.
Obiettivo del Cristo – secondo Paolo di Tarso – non era tanto quello di liberare la Palestina dall'oppressione della schiavitù sociale e nazionale, quanto quello di vincere la schiavitù fisica e metafisica della morte, dimostrando all'intero genere umano che la condanna causata dal peccato d'origine non aveva più ragione d'esistere. Il suo ragionamento, in sostanza, si riduceva ai seguenti termini: il peccato originale ha introdotto la schiavitù, di cui l'effetto principale è stata la morte. Dalla schiavitù è impossibile emanciparsi, poiché non ci si può liberare della morte. Il Cristo, risorgendo, ci ha fatto capire che dalla schiavitù (fisica, materiale) su questa Terra ci si può liberare solo dopo morti.
La seconda mistificazione – abbiamo detto – è di tipo culturale. Essa in un certo senso è collaterale se non conseguente a quella di tipo politico. Infatti, l'idea di resurrezione ad un certo punto ha portato la Chiesa cristiana ad elaborare l'idea che il Cristo fosse un Dio fattosi uomo, anzi l'unico vero “Figlio di Dio”. Di qui la trasformazione del Gesù storico nel Cristo della fede, del liberatore nel redentore, del messia nel sacerdote, del “figlio dell'uomo” nel “figlio di Dio” e così via.
Mentre la prima mistificazione ebbe soprattutto lo scopo di convincere gli ebrei a rinunciare all'idea di una liberazione nazionale, la seconda invece ebbe lo scopo di persuadere i pagani a credere in una nuova religione, dalle caratteristiche sociali (vedi l'idea di “comunione”), spirituali (l'idea appunto della “divino-umanità” del Cristo) e universali (superando concetti quali “popolo eletto”, “nazione santa”, “legge mosaica”, “circoncisione”, “sabato”, “divieti alimentari” ecc., tipici della cultura ebraica).
Ora, s'è c'è una pericope che nel vangelo di Giovanni più di altre si presta a confermare la tesi della spiritualizzazione post-pasquale del messaggio di Cristo, è proprio quella della festa della Dedicazione, che non a caso viene intitolata dalla Chiesa con le parole “Gesù afferma la propria divinità”, o anche “Gesù si dichiara il Figlio di Dio”.
Tutta la pericope si pone come un'evidente forzatura, anzi, come un vero e proprio stravolgimento del significato originario del discorso che in quell'occasione il Cristo può aver pronunciato. Per poterla adeguatamente comprendere è doveroso premettere che una qualunque lettura letterale dei vangeli non può minimamente essere accettata sul piano storiografico, in quanto la tendenziosità delle fonti neotestamentarie è troppo manifesta perché possa essere sottovalutata. I vangeli non sono che un'interpretazione del vangelo non scritto del Cristo. Pretendere, sotto il pretesto che non vi sono valide alternative documentaristiche, che quella interpretazione venga considerata come l'unica possibile e soprattutto come l'unica vera, è quanto meno sciocco, non foss'altro che per una ragione: gli stessi vangeli canonici sono, in molti punti di cruciale importanza, in contraddizione tra loro, a testimonianza che un'interpretazione univoca del messaggio non scritto di Gesù non esisteva neppure duemila anni fa.
Certo qui l'esegeta confessionale potrebbe obiettare che, allo stato attuale delle fonti, una qualunque lettura non ufficiale dei vangeli è puro flatus vocis. Tuttavia, questo non può impedirci dall'ipotizzare determinate interpretazioni o dal porre almeno dei dubbi esegetici su questa o quella pericope evangelica. Anche perché, falso per falso, è preferibile cimentarsi in un'esegesi arrischiata, non documentata, volta a trovare ipotetiche tracce di “umanesimo laico” nella predicazione di un messia politico trasformato in redentore mistico, piuttosto che avvalersi ciecamente di interpretazioni palesemente apologetiche di testi chiaramente tendenziosi. Semmai il confronto sarà sulla forza argomentativa delle tesi da dimostrare.
Al giorno d'oggi la Chiesa cristiana, se vuole conservare ai vangeli canonici una qualche utilità, ha di fronte a sé soltanto due alternative praticabili: o fa del vangelo non-scritto del Cristo un argomento in virtù del quale chiunque può sentirsi autorizzato a proporre delle letture non convenzionali, chiedendo un libero confronto su di esse; oppure, ostacolando un dibattito del genere, essa finirà col rendere del tutto obsoleti gli stessi vangeli canonici e, con essi, anche se stessa.
II
È singolare vedere come, pur avendo partecipato a molte festività ebraiche, il Cristo non vi abbia mai compiuto alcun gesto di tipo religioso. Spontanea a questo punto sorge la domanda: i redattori cristiani han voluto omettere le pratiche religiose di un credente ebreo, oppure il Cristo, effettivamente, era una persona indifferente alla religione? Tale domanda è tanto più lecita in quanto nella pericope in oggetto (priva di equivalenti nei Sinottici) il Cristo dà una risposta di tipo religioso a una precisa interrogazione di tipo politico; cioè alla domanda s'egli fosse davvero il messia da tutti atteso, la risposta, categorica, è stata: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (v. 30). Il che fa pensare a un'ennesima manipolazione del discorso originario.
Anzi, guardando le cose da vicino si ha la netta impressione che nelle argomentazione usate qui da Gesù non vi sia neppure un versetto che non abbia subìto almeno un qualche ritocco apologetico. Il motivo di questo particolare accanimento strumentale è relativamente semplice: per il cristianesimo post-pasquale il Cristo era messia solo in quanto “Figlio di Dio” redentore dell'umanità peccatrice, non era certo un messia in quanto “liberatore nazionale”. Un messia politico può anche assumere un atteggiamento indifferente nei confronti della religione o addirittura nutrire sentimenti o esprimere opinioni del tutto ostili verso ogni forma di clericalismo. Viceversa, un redentore dell'umanità deve anzitutto porre un'alternativa religiosa alla religione dominante.
Forse l'unica cosa vera di questa pericope è la sua collocazione spazio-temporale. La festa della Dedicazione o della riconsacrazione del Tempio era una festa eminentemente politico-religiosa, in quanto vi si commemorava la purificazione del Tempio avvenuta dopo la vittoria di Giuda Maccabeo sul re di Siria Antioco IV nel 164 a.C. (1 Mac 4,36-59; 2 Mac 1,9.18; 10,1-8). Tutta la discussione sembra avvenire sul lato orientale del Tempio di Gerusalemme.
Giovanni parla di “Giudei”, cioè di una folla generica, anonima, postasi attorno a Gesù: in realtà dalla domanda ch'essa pone si tratta di uomini politici interessati alla liberazione nazionale e forse in quel momento delusi che Gesù non avesse fatto ancora nulla di veramente significativo per dimostrare una volta per tutte ch'egli era il messia politico tanto atteso. Non sono sicuri di lui, perché vedono che il tempo stringe e non succede nulla di eclatante contro Roma.
Fra le parole con cui l'avevano apostrofato i Giudei, al termine del suo discorso politico nella precedente pericope del “buon pastore”, e cioè: “Ha un demonio ed è fuori di sé” (Gv 10,20), e la domanda che ora sotto il portico di Salomone gli rivolgono: “Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente” (v. 24), esiste una certa discontinuità, poiché, sebbene sia relativamente breve il tempo trascorso tra l'uno e l'altro dibattito, nella pericope del “buon pastore” la folla di Gerusalemme si pone la domanda su chi sia Gesù, su cosa effettivamente voglia fare per i destini di Israele, nella seconda invece (racchiusa in un medesimo capitolo) la stessa folla mostra di conoscere molto bene le pretese politiche del Cristo, al punto che ne chiede esplicita conferma.
Poiché è da ritenersi del tutto inverosimile il discorso di Gesù relativo alla sua stretta relazione di parentela col “Dio-Padre”, pronunciato nella parabola del “buon pastore”, e, di conseguenza, è da ritenersi non meno irreale l'atteggiamento scandalizzato delle folle, nella parte finale della stessa pericope, si può forse ipotizzare come del tutto verosimile la domanda sulla identità messianica del Cristo che i leader politici gli pongono in occasione di questa festa.
Qui appare evidente che l'operato di Gesù era ormai diventato troppo noto perché lo si potesse facilmente ignorare. La domanda sulla messianicità sembra partire dall'esigenza, viste le crescenti tensioni nel paese, di trovare una sorta d'intesa o di compromesso tra le aspettative delle masse, l'ideologia politica dei gruppi politici più in vista nella capitale e le forti capacità aggregative di un leader carismatico come Gesù e di un movimento socialmente diffuso e politicamente determinato come quello nazareno.
Se questa interpretazione non fosse vera, si dovrebbe considerare del tutto legittimo l'atteggiamento tenuto dalle folle giudaiche, che giudicavano “pazzo” (Gv 10,20) un uomo che affermava di “poter offrire la propria vita e di riprendersela” (in riferimento alla propria morte e resurrezione), e di poter fare questo “secondo la volontà del Padre”, cioè di ritenersi, stricto sensu, “Figlio di Dio”, anzi Dio stesso, in quanto la differenza di persona tra le entità non sembra pregiudicare ma anzi presupporre l'identità della sostanza: “Io e il Padre siamo un unicum” (v. 30).
In questa pericope “post-giovannea” il Cristo dà sempre risposte teologiche a domande di tipo politico non tanto perché l'anonima mano redazionale aveva interesse a palesare l'ostinato rifiuto, da parte delle autorità ebraiche, di credere in ciò che Gesù diceva (questo è un leit-motiv scontato in tutti i vangeli canonici), quanto perché si doveva in qualche modo dimostrare – e a tal fine si è dovuti intervenire pesantemente su tutta la pericope – che se nelle risposte di Gesù non vi era assolutamente nulla di politico, allora non poteva esserci nulla di eversivo nell'ideologia cristiana post-pasquale che vedeva nel solo Cristo, e non anche nella figura dell'imperatore, la personificazione della divino-umanità.
Questa tuttavia è una tesi da precisare. Per poter dimostrare che il Cristo era un soggetto innocuo al cospetto delle autorità romane, la Chiesa cristiana è stata costretta, avendo comunque a che fare con un lascito eversivo, a porre il Cristo in una posizione di assoluta incompatibilità col mondo ebraico, complessivamente considerato. Tale forma di revisionismo politico doveva essere supportata da una precisa elaborazione culturale, che, nella fattispecie, assunse necessariamente le fattezze della cultura allora dominante: quella religiosa.
Nella pericope della Dedicazione il Cristo passa per “ateo” agli occhi degli ebrei proprio per evitare che passi per “rivoluzionario” agli occhi dei Romani. Quando l'ideologia romana, per sua natura totalitaria, arriverà ad accettare l'idea che i seguaci del Cristo non erano politicamente eversivi, sarà poi facile alla Chiesa far valere il principio secondo cui l'unico vero Dio sulla Terra è Gesù Cristo.
Ma prima di procedere analizziamo la domanda dei Giudei: attendono un messia politico ma sono incerti che Gesù possa esserlo. Perché questa insicurezza? Per quale motivo dicono “dillo a noi apertamente” (10,24)? Erano loro che non si fidavano di lui e che, a tale scopo, avevano bisogno di una testimonianza inequivocabile, o era lui che, proprio sulla base di questa richiesta, non si fidava di loro?
Qui si ha l'impressione che con quella loro domanda, i Giudei gli stessero chiedendo di esporsi, di uscire allo scoperto, di fare qualcosa di palesemente eversivo, prima ancora che lui fosse sicuro di avere l'appoggio popolare sufficiente per affrontare le conseguenze di una decisione del genere. Il fatto che lui non potesse ancora contare con relativa sicurezza sulla collaborazione dei Giudei è testimoniato proprio dalla conclusione del racconto in oggetto: è costretto a fuggire e a nascondersi da loro perché volevano linciarlo. Se ne andrà coi suoi discepoli “nel luogo dove prima Giovanni battezzava” (10,40), al di là del Giordano, dove resterà fino a quando non entrerà in maniera trionfale a Gerusalemme, alcuni mesi dopo, durante la festa delle palme che precede la pasqua. Tra il rischio di questo linciaggio e l'ingresso messianico Giovanni colloca un episodio tragico: la morte di Lazzaro, un alleato del Cristo.
Cerchiamo anzitutto di capire il motivo per cui gli interlocutori politici avevano ad un certo punto deciso di lapidarlo. O diamo per scontato che anche questa descrizione dei fatti sia inventata, oppure dobbiamo cercare di capirne la motivazione, poiché è difficile immaginare una scelta del genere nel bel mezzo di un dibattito meramente politico, senza implicazioni di tipo ideologico, che sono quelle che fanno suscitare nei Giudei reazioni spesso esagerate.
In altre parole, se vogliamo azzardare l'ipotesi che nella risposta del Cristo vi siano stati elementi culturali che in qualche modo rovesciavano o mettevano in discussione i tradizionali criteri interpretativi in materia di religione o di cultura dominante, allora si deve per forza arguire che già nella domanda iniziale, relativa alla messianicità, vi fossero anche dei riferimenti più o meno espliciti circa l'atteggiamento che i nazareni tenevano nei confronti della religione in generale e del potere religioso in particolare.
Cioè l'interrogazione doveva in qualche modo contenere degli elementi nei confronti dei quali il Cristo non poteva dare una risposta evasiva o generica. E, considerando che la reazione dei Giudei è stata durissima, in quanto lo si voleva giustiziare in modo sommario (il che viene ribadito anche in Gv 11,8), è da presumere che la risposta del Cristo abbia toccato degli aspetti strettamente legati a questioni di natura religiosa, questioni che non riguardavano soltanto il clericalismo o l'amministrazione corrotta del Tempio o il collaborazionismo dei sommi sacerdoti e dei sadducei, su cui difficilmente si poteva non essere d'accordo, ma doveva riguardare anche la funzione stessa della religione, la sua utilità sociale, il contributo ch'essa poteva dare alla causa nazionale.
È difficile pensare, in tal senso, che se le parole di Gesù avessero offerto un qualche appiglio a favore del compromesso tra forze rivoluzionarie e istanza religiosa, i Giudei avrebbero comunque deciso di lapidarlo. Forse non sarebbe azzardato sostenere che se sulla trasgressione patente del sabato i leader giudei avrebbero anche potuto soprassedere, in considerazione del fatto che le violazioni avvenivano per soddisfare un bisogno altrui, per di più di una certa gravità, e non per un arbitrio soggettivo 8, su un'altra questione però assai difficilmente si sarebbe potuti giungere a un'intesa: lo stretto legame tra politica e religione, vero asse portante della cultura ebraica. Il monoteismo giudaico era inscindibilmente unito con la concezione della democrazia sociale e politica. Oltre che nazionalista, il giudaismo era anche una cultura, se vogliamo una civiltà, sostanzialmente integralista, disposta a prospettare aperture universalistiche più che altro in chiave escatologica.
Ora, supponendo che il Cristo alla domanda politica abbia anche dato una risposta contenente elementi di tipo culturale, cosa può aver detto di così sconvolgente da indurre gli astanti a prendere le pietre per lapidarlo? In luogo della dichiarazione iperbolica, in senso mistico: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (10,30), che cosa può aver detto da doverlo indurre a rientrare nella clandestinità?
L'accusa che gli muovono infatti è esplicita: “Non vogliamo ucciderti per un'opera buona, ma perché tu bestemmi. Infatti sei soltanto un uomo e pretendi di essere Dio” (v. 33). Il reato insomma è quello della bestemmia e la sanzione prevista è l'esecuzione capitale, anche senza processo. Per questa ragione egli deve aver detto qualcosa che, pur non essendo così “teistica” in senso “cristiano”, doveva ugualmente risultare meritevole di morte immediata.
Noi sappiamo che per un ebreo nessun uomo poteva paragonarsi a Dio, meno che mai rivendicare un'esclusiva figliolanza divina. Questa appariva come una sorta di pretesa folle, ateistica, meritevole di condanna senza neppure un formale processo. L'unico momento che nei Sinottici vagamente assomiglia allo sitz im leben di questa pericope è quello del racconto della guarigione del paralitico, in cui Gesù fa un'affermazione che agli occhi degli astanti scandalizzati apparve come una sorta di bestemmia: il diritto di stabilire il bene e il male indipendentemente da qualunque autorità superiore, umana o divina che fosse.
Tuttavia noi qui non possiamo ipotizzare che ai suoi interlocutori, del cui sostegno politico egli aveva bisogno per realizzare l'insurrezione nazionale, Gesù abbia detto una cosa che avrebbe suscitato una naturale riprovazione, un inevitabile diniego. Al contrario, il fatto che nel testo giovanneo si sia comportato proprio così va considerato esclusivamente redazionale: la comunità cristiana (qui profondamente antisemitica) ha tutto l'interesse a far risultare un dialogo unidirezionale tra un “supermaestro”, che apparentemente sembra dire cose molto facili da capire, e degli interlocutori ottusi, totalmente incapaci di comprenderle.
In realtà Gesù deve aver detto una cosa che, volendo, avrebbe anche potuto essere accettata. Infatti – scrive Giovanni – quando lui andò a rifugiarsi in Transgiordania “in quel luogo molti credettero in lui” (10,42). Quindi lo seguirono, dissociandosi dagli altri che invece volevano lapidarlo. E se “molti” andarono a trovarlo, pensando che fosse più grande del Battista, significa che stavano pensando a qualcosa di importante. Cioè in sostanza avevano capito che, pur essendo espatriato, Gesù non voleva mollare la partita: stava soltanto aspettando il momento favorevole per rientrare in gioco. E quel momento avverrà qualche mese dopo, con la morte di Lazzaro (Eleazar), caduto probabilmente in uno scontro armato coi Romani, appoggiati da elementi ebraici collusi.
Le autorità del Tempio odiavano a morte Lazzaro non meno di Gesù, al punto che anche sulla sua testa pesava una taglia (Gv 12,10). Lazzaro doveva aver avuto un certo ascendente sulle folle giudaiche e, dopo la sua morte, Gesù aveva deciso di uscire allo scoperto, col rischio d'essere catturato, per impedire che i seguaci del suo compagno, vedendo la morte del loro leader, si demoralizzassero e rinunciassero a combattere. Come già aveva fatto ai tempi del Battista, raccogliendo molti suoi seguaci prima e dopo la morte di quest'ultimo, così ora faceva con Lazzaro: proseguire il messaggio in maniera più risoluta, ampliando, nel contempo, il consenso popolare. Doveva portare gli eventi a un punto tale di rottura da far risultare l'insurrezione come una cosa assolutamente necessaria. Lazzaro infatti “risorse” nei suoi discepoli appunto in questo senso, ch'essi seppero trovare nel Cristo il suo migliore erede politico.
Ma che cosa può aver detto il Cristo durante la festa della Dedicazione da indurre i Giudei a prendere le pietre per lapidarlo? Cioè in che senso può aver preteso di abolire la vecchia immagine di Jahvè e, di conseguenza, il privilegio sacerdotale d'interpretarne la volontà? Stando ai vangeli dovremmo dire nella maniera più inverosimile, in quanto che egli arriva a paragonarsi, sic et simpliciter, a Dio, legittimando così, inevitabilmente, l'accusa di follia o di somma eresia. Infatti, se un uomo si fa Dio e quindi esclude Dio come altro da sé, non può che dichiararsi “ateo” e quindi porsi al di fuori di qualunque normativa sociale. Un ebreo non avrebbe mai accettato una pretesa del genere; anzi, considerando che l'equiparazione con Dio era cosa che nel mondo pagano potevano permettersi solo gli imperatori, una pretesa del genere non sarebbe stata accettata neppure da un romano.
Qui i redattori cristiani si sono comportati in una maniera davvero curiosa: rinfacciano ai Giudei d'essere increduli, quando di fatto l'idea della divino-umanità del Cristo venne elaborata dal cristianesimo solo dopo l'evento della tomba vuota. È per questo che nella pericope c'è qualcosa che non quadra. Il fatto che Gesù appaia “ateo” agli occhi dei Giudei non può stare a significare ch'egli volesse professare l'ateismo equiparandosi a Dio. Diciamo che solo in senso traslato egli può aver posto il ragionamento su queste basi, nel senso che egli può anche aver affermato che ogni uomo dotato della facoltà di discernimento del bene e del male può, a buon diritto, ritenersi al pari di un Dio. Di qui il senso dei vv. 34-35. La “divinità”, in altre parole, andrebbe intesa nel senso della “piena umanità”. Ogni uomo, al pari dei giudici veterotestamentari contro le iniquità pagane (Sal 82,6), avrebbe dovuto sentirsi “Dio”, ovvero “figlio dell'Altissimo”.
Naturalmente un'interpretazione del genere non potrà essere condivisa dalla Chiesa cristiana. Gli esegeti e gli storici confessionali hanno più volte sottolineato il fatto che i cristiani venivano considerati al pari di “atei” dai pagani, in quanto rifiutavano i sacrifici alle classiche divinità e soprattutto all'imperatore. Questo è il massimo che si è disposti a concedere sull'accusa di ateismo. Se per “ateismo cristiano” s'intende il fatto che i cristiani professavano una religione rigorosamente monoteista, in cui l'unico essere umano, pienamente uomo e pienamente Dio, era Gesù Cristo, allora gli storici ed esegeti confessionali sarebbero anche disposti ad accettare l'idea che il cristianesimo sia una forma di “ateismo”.
Ma spieghiamoci meglio. Possiamo facilmente intuire che in quel momento Gesù deve aver detto che per poter liberare Israele dai Romani bisognava prima epurare il Tempio dagli elementi corrotti che lo gestivano, e bisognava altresì escludere dal Sinedrio tutti quanti pensavano di poter essere lì presenti per una qualche forma di privilegio.
Perché una richiesta del genere può aver spaventato quegli interlocutori giudei? Non era forse di pubblico dominio che i sadducei, gli anziani, i sommi sacerdoti erano persone corrotte e collaborazioniste col nemico in patria? Non la pensavano così anche i farisei, gli esseni, i battisti, gli zeloti, i Galilei, i Samaritani, gli Idumei...? Cos'è che li ha davvero spaventati? Non può certo essere stato il giudizio eticamente e politicamente categorico, in senso negativo, sulla casta sacerdotale.
Qualcuno dovrà per forza avergli chiesto chi avrebbe continuato a gestire il Tempio subito dopo l'epurazione. Questo problema non era stato neppure affrontato durante la cacciata dei mercanti avvenuta qualche anno prima, poiché durante quella mezza rivoluzione Gesù non incontrò sufficienti appoggi, da parte dei farisei, per proseguirla in maniera coerente. Anzi, anche quella volta fu costretto a espatriare rifugiandosi in Galilea.
Altri possono avergli prospettato, una volta abolito il primato politico-religioso del Tempio, una possibile, rischiosa, defezione di massa dalla causa rivoluzionaria, in quanto i semplici credenti non avrebbero potuto fare a meno di quella istituzione; e sostituire d'emblée un'intera categoria di professionisti del culto con una visione laica della vita sarebbe stato impensabile.
A questo punto Gesù deve aver detto qualcosa che li ha particolarmente infastiditi, qualcosa che deve aver scioccato persino i redattori cristiani, che infatti si sono subito premurati dal mistificarla a dovere. Deve per forza aver detto che nessuna gestione del Tempio avrebbe potuto servire per compiere l'insurrezione nazionale, proprio perché non era con la “fede religiosa” che ci si sarebbe potuti liberare dei Romani, anzi, con essa di sicuro non ce l'avrebbero mai fatta. Gesù insomma non aveva alcuna intenzione di creare una “repubblica teocratica” o un “regno di Dio”.
Frasi di questo genere venivano interpretate dai Giudei (ma anche dai cristiani) come una forma di ateismo, anche se in realtà non voleva essere, questo, un ateismo imposto politicamente, ma semplicemente una scelta politica contro il clericalismo, il quale inevitabilmente si poneva contro gli interessi nazionali del paese.
Gesù stava loro proponendo di fare una rivoluzione non in nome degli ideali giudaici tradizionali, ma in nome di ideali umanistici, che con la religione non avevano niente a che fare, almeno non con quella che gestivano i sacerdoti del Tempio, che con le loro interpretazioni tendenziose l'avevano ridotta a loro uso e consumo. I credenti potevano restare credenti, ma la gestione del potere politico, civile e religioso andava tolta alla classe aristocratica e sacerdotale del Tempio.
Da notare che nella pericope Gesù, quando vuole affermare il proprio ateismo, ovvero l'irrilevanza di un'istanza di tipo religioso ai fini di una rivoluzione politica, non lo fa con la pretesa del rabbino convinto di avere la verità in tasca. Infatti, prendendola un po' alla larga, egli giustifica il proprio ateismo citando un passo del Salmo 82: “Io ho detto: voi siete dèi” (10,34). In altre parole, egli afferma il proprio ateismo sulla base delle Scritture giudaiche, e vorrebbe che anche i propri interlocutori le interpretassero nella stessa maniera, traendone le debite conseguenze pratico-politiche. Se lui, che è uomo, si sente autorizzato dalla Legge a sentirsi “Dio”, cioè autonomo nel giudizio, indipendente dal clero, anche loro devono comportarsi nella stessa maniera, se davvero vogliono fare la rivoluzione. Non è lui che deve esplicitamente dichiarare d'essere il “messia”, sono loro che devono dire esplicitamente di non credere più nelle istituzioni che li governano.
Sarebbe stato impossibile fare un'insurrezione armata e nazionale contro Roma confidando nell'appoggio di una casta di privilegiati, disposta a predicare cose che invece d'indurre le masse alla ribellione, le portavano alla rassegnazione, una casta che alla prima occasione sfavorevole ai propri interessi sarebbe passata esplicitamente dalla parte del nemico, tradendo, senza ritegno, il proprio popolo. Chi, in quel momento, iniziò a credere nel Cristo, si convinse finalmente che contro i sacerdoti del Tempio non bastava fare, come il Battista, delle semplici critiche morali, ma occorreva piuttosto una risoluta iniziativa politica, con cui estrometterli definitivamente dal potere, e senza aver la pretesa di ripristinare il glorioso “regno davidico”, che peraltro non era certo stato un esempio di vera democrazia.
Quindi, per concludere, nella pericope in oggetto non solo va categoricamente esclusa la versione secondo cui il Cristo ha voluto dare una risposta teologica a una domanda politica, ma va esclusa anche la tesi secondo cui il Cristo ha voluto fare professione di ateismo scegliendo di paragonarsi, in via esclusiva, a Dio-Padre. Al massimo, come già detto, l'equiparazione avrebbe potuto avere un senso in chiave metaforica o figurata o traslata, mostrando che ogni uomo, in fieri, è una divinità, cioè un soggetto dotato di autonomia di giudizio o di libero discernimento, e quindi autorizzato a non credere in alcuna entità posta al di fuori o al di sopra di sé.
Se il Cristo ha parlato di ateismo in una forma così involuta o criptica, è probabile che l'abbia fatto perché la cultura del tempo, dominante in Giudea, non gli avrebbe permesso di usare un linguaggio più esplicito, col quale poter affermare il dovere di superare qualunque forma di divinità, cioè qualunque tentazione idolatrica nei confronti di chicchessia. L'uomo non deve soltanto rimuovere da sé tutte le paure immotivate, i pregiudizi, la superstizione e quindi ogni religione, poiché ogni religione è, au fond, una forma di superstizione, ma deve rimuovere anche i timori reverenziali verso le autorità o, in altre parole, i cosiddetti “culti della personalità”.
Purtroppo il fallimento dell'insurrezione nazionale ha indotto la Chiesa a reinterpretare la professione di ateismo del Cristo in chiave teologica. L'identificazione di uomo e Dio, che pur la Chiesa volle mantenere, venne letta non nel senso umanistico secondo cui ogni uomo può diventare Dio, “conoscitore del bene e del male” – come già prospettava il Genesi –, ma piuttosto nel senso che, in Cristo, Dio-padre si era abbassato a diventare “uomo” (kenosis), per cui la “divino-umanità” del “figlio di Dio” andava vista in maniera esclusiva e personalissima, cioè a partire da “Dio” e non a partire dall'uomo. Gesù – si sanzionò definitivamente nel Credo – è “vero Dio e vero uomo”, appunto perché anzitutto era “Dio” o “Verbo di Dio”, non tanto perché era figlio di Maria e Giuseppe.
Da ultimo si può far notare che nella pericope si è cercato di attenuare l'esclusivismo unilaterale della figliolanza divina del Cristo, introducendo la distinzione tra “fede nella sua divinità” e “fede nelle sue opere”. Forse si è scelta questa variante sul tema nella consapevolezza che sarebbe potuta apparire forzata una versione dei fatti che mettesse in assoluta opposizione ideologica il Cristo coi Giudei. La distinzione tra “persona” ed “opere” appare come una sorta di compromesso tattico a favore dell'idea che l'incompatibilità sul piano ideologico non avrebbe dovuto di per sé precludere la possibilità di un'intesa sul piano pratico. Tuttavia, se il Cristo ha voluto presentare le cose in maniera così flessibile, va comunque escluso che l'incompatibilità ideologica fosse di natura teologica, cioè va esclusa a priori la tesi che il Cristo volesse opporre un'idea religiosa a un'altra idea religiosa.
È noto, negli ambienti esegetici laici, che la Chiesa cristiana è intervenuta sull'ateismo del Cristo in almeno tre maniere: 1. ha trasformato ogni negazione di Dio in un'affermazione, riconfermando il precedente monoteismo ebraico; 2. ha attribuito al solo Cristo il privilegio d'essere unigenito figlio di Dio, modificando il monoteismo ebraico in un biteismo, che poi diventerà, con l'attribuzione della divinità anche allo Spirito o Paraclito, un triteismo; 3. ha usato politicamente il titolo di “figlio di Dio” in opposizione a quello rivendicato dagli imperatori.
Il finale della pericope è indicativo della tendenziosità tipica dei vangeli. Infatti, dopo aver detto che era espatriato in Transgiordania e che “molti andavano da lui” (v. 41) e “molti credettero in lui” (v. 42), i redattori, che si erano soffermati così tanto nel mostrare le differenze teologiche tra Cristo e i Giudei della capitale, ovvero tra cristianesimo ed ebraismo, non hanno voluto spendere neppure una parola nel descrivere le intese politiche tra il movimento nazareno e gli altri gruppi politici giudaici che cominciavano a credere seriamente nella possibilità di un'insurrezione nazionale.
(torna su)14) Gesù e l'adultera
Gv 8,3-11
[3] Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo,
[4] gli dicono: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio.
[5] Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”.
[6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.
[7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”.
[8] E chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
[9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
I
Nell'episodio giovanneo della “donna adultera” si vuol dare di Cristo un'immagine profondamente morale. Infatti, a differenza degli scribi e dei farisei, egli dimostra di saper distinguere fra “peccato” e “peccatore” e di perdonare la donna senza per questo giustificare l'adulterio.
Non solo, ma, chiedendo il perdono per una colpa che, secondo la legge mosaica, meritava la sentenza capitale, il Cristo appare come un fautore ante litteram del moderno abolizionismo. Duemila anni fa la pena di morte, in taluni casi, veniva considerata scontata non solo nel mondo ebraico, ma anche in tutto il mondo allora conosciuto.
Tuttavia il Cristo “umanista”, che qui oppone una propria etica all'etica dominante, non è più il Cristo che lotta contro le condizioni sociali che possono portare all'adulterio e quindi all'uso della sentenza capitale. In questo senso, ma solo in questo senso, egli, paradossalmente, assomiglia proprio agli avversari che lo interpellano.
La morale di questo episodio è di tipo stoico, ma senza essere legalistica, altrimenti non vi sarebbe differenza tra Gesù e i suoi accusatori; ed è una morale più sofisticata dello stoicismo, altrimenti non si capirebbe la differenza tra cristianesimo e filosofia greco-romana. Non è comunque una morale rivoluzionaria, cioè tesa a rovesciare i rapporti sociali dominanti, che, nella fattispecie, hanno portato la donna all'adulterio e gli accusatori a chiedere il massimo della pena.
Il Cristo del vangelo (manipolato) di Giovanni chiede semplicemente alle autorità di usare una maggiore flessibilità nel giudizio. Si noti però che, invece di mettersi a discutere sulle possibili attenuanti del caso, egli – come dice il v. 6 – “scrive col dito sulla sabbia”, cioè assume una posizione che se giuridicamente può apparire “sospensiva” (tant'è che gli accusati sono costretti a “insistere”), sul piano metafisico invece è indicativa di una concezione pessimistica dell'essere umano, ritenuto incapace di vero bene, per cui il racconto non solo fa capire, giustamente, che nessun reato può essere oggetto di sentenza capitale, in quanto non si deve mai escludere una possibilità di recupero, ma induce anche a credere, ingiustamente, che la causa di un qualunque reato sia irrilevante, in quanto la “colpevolezza” viene ritenuta un dato imprescindibile dell'essere umano.
In altre parole, la lezione del Cristo qui delineato non vuole tanto prendere di mira la schematica giurisprudenza rabbinica, che, di fronte a un reato grave, spesso non si preoccupava di capire le motivazioni ad esso sottese: i vangeli già documentano ampiamente di quale attaccamento ossessivo per la legge fossero capaci scribi e farisei.
La novità piuttosto sta nel fatto che il cristianesimo sostiene, da un lato, un principio impensabile per quei tempi (e ancora oggi difficile per molti da condividere), quello per cui bisogna anzitutto accettare l'idea che nessuno può mai ritenersi del tutto innocente (meno che mai di fronte a Dio, aggiungerebbe un credente), sicché nessuno può mai sentirsi autorizzato a richiedere una sentenza di morte; dall'altro però afferma un principio opposto, che porta alla rassegnazione nei confronti dell'arbitrio, quello per cui, non potendo nessuno aspirare a uscire dal suo “naturale stato di colpa”, diventa del tutto inutile qualunque rivendicazione di libertà o di giustizia, in quanto l'unica persona veramente innocente, Gesù Cristo, ha scelto di morire sulla croce.
In tutto questo c'è qualcosa di paradossale, poiché se davvero si volesse un Cristo spoliticizzato, meramente intento a scrivere col dito per terra, onde sottrarsi alla discussione sulle attenuanti, la morale di questo racconto finirebbe col mettere sullo stesso piano l'adultera e le autorità: il che è moralmente inaccettabile. Infatti, la prima poteva avere, nel compiere quell'infrazione alla legge, molte più attenuanti di quante ne avrebbe potute avere un esponente delle istituzioni che avesse fatto la medesima violazione. Questo poi senza considerare che l'adultera potrebbe anche rappresentare, se vogliamo, un'alternativa, seppur negativa, al legalismo ipocrita dei rappresentanti delle istituzioni, in questo molto più colpevoli di lei. Basti p.es. pensare che solo al maschio si concedeva il libello del ripudio o al fatto che la testimonianza di una donna valeva la metà di quella di un uomo.
Il Cristo insomma non coglie qui la violazione della legge come occasione per ripensare i criteri di giustizia e di moralità che dominavano nella società del suo tempo. Non solo, ma l'autore di questa pericope, evitando di far discutere il Cristo in merito all'ambigua posizione politica che scribi e farisei avevano assunto nei confronti di ideali come la giustizia sociale e la liberazione nazionale, non aiuta certo il lettore a comprendere come il reato della donna in questione fosse ben poca cosa rispetto ai continui “tradimenti” del potere politico ebraico (nella veste sia “popolare”, come appunto quello farisaico, che “istituzionale”, come p.es. quello sadduceo, il quale, quanto a “tradimenti”, non era inferiore a nessuno).
Se tutti sono “potenzialmente peccatori”, nessuno lo è più di un altro, per cui il principio della “responsabilità personale” non ha più ragione di sussistere. Col che si finisce in una situazione senza via d'uscita: apparentemente il racconto sembra avvalorare il principio, facilmente comprensibile, almeno virtualmente, da qualunque onesto cittadino (ebreo o cristiano che fosse), secondo cui la legge è fatta per l'uomo e non viceversa; di fatto invece il racconto porta a credere che, non essendo l'uomo in grado di rispettare neppure lo “spirito” della legge, l'unica soluzione possibile diventa quella di avere pietà del trasgressore.
La conseguenza politica inevitabile è la conservazione dello status quo, sia perché la giustizia sociale diventa impossibile, sia perché la liberazione nazionale (dai Romani, come nel caso della Palestina di allora) diventa inutile.
II
L'immagine di Cristo qui tratteggiata non è molto diversa da quella del Giobbe veterotestamentario, il quale guardava la vita con rassegnazione. Certo, non era la rassegnazione di chi lo accusava di meritarsi il castigo della lebbra (e di tutte le altre disgrazie) per aver commesso un grande peccato, di cui poteva anche non avere consapevolezza, ma era comunque la rassegnazione di chi considerava ogni sventura come una prova mandata da “Dio” per misurare il livello della fede.
Non c'è, nel racconto di Giobbe, la volontà “politica” di affrontare e risolvere le contraddizioni sociali per migliorare la realtà. Quando la realtà è troppo contraddittoria – questa la filosofia di Giobbe –, occorre che il soggetto vi si adegui conservando la purezza della sua fede (nella divina provvidenza).
Nel racconto (certamente non originario) di Giovanni la situazione non è molto diversa: il lettore infatti è invitato, di fronte alla durezza della vita, ad assumere un atteggiamento benevolo, compassionevole, tollerante, proprio per rendere più sopportabile quella durezza.
La frase detta da Gesù: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” (v. 7), ha un sapore decisamente fatalistico. Peraltro essa suppone che Gesù conoscesse tutti gli astanti, poiché, nel caso in cui qualcuno avesse davvero lanciato la prima pietra, il Cristo avrebbe dovuto dimostrargli con esempi concreti le proprie ragioni.
Qui il Cristo vince i suoi avversari semplicemente perché l'autore del racconto, in maniera idealistica, presenta gli scribi e i farisei come uomini dalla coscienza relativamente “onesta”. Essi infatti vanno da lui a chiedere come devono comportarsi sul piano “morale”: sanno che la legge condanna l'adultera, ma hanno degli scrupoli nell'applicarla. Scribi e farisei qui appaiono come discepoli “schematici” del Cristo, che ancora non hanno imparato il principio della superiorità dell'uomo sulla legge: alla fine del racconto però gli daranno ragione, seppur malvolentieri (prima gli anziani, più “riflessivi”, poi i giovani, più “impulsivi”). Anche gli avversari politici devono in qualche modo ammettere che l'unica persona giusta, in quel frangente, era Gesù Cristo.
L'autore della pericope non vuole certo presentare Gesù come un novello Giobbe: questi, infatti, pur ritenendosi giusto, non ne aveva la certezza, poiché non riusciva a spiegarsi il motivo delle sue tante disgrazie; di qui le lunghe e tortuose discussioni con i “saggi” di turno; di qui l'amara conclusione: il giusto può soffrire l'ingiustizia in qualunque momento, se questo deve servire per metterlo alla prova.
La filosofia del libro di Giobbe è la rassegnazione, proprio in quanto si ritiene che il bene possa trasformarsi in qualunque momento nel suo contrario, al solo scopo di mettere alla prova la fede di un individuo che, essendo un essere umano, è ritenuto di per sé tendenzialmente incline al male.
Il Cristo invece non ha dubbi, né deve averli il cristiano che ha fede nella sua “natura divina”: gli unici beni alla portata dell'uomo sono la coscienza del peccato e la fede nel Cristo redentore. Giobbe si chiedeva come migliorare se stesso; il cristiano sa che solo Cristo rappresenta la perfezione, per cui non può occupare il suo tempo a chiedersi in che cosa ha sbagliato.
III
Se considerassimo storicamente attendibile il racconto, finiremmo col cadere in una situazione insostenibile, poiché avremmo che le autorità politiche (popolari), da un lato, danno per scontato che si debba applicare la legge e, dall'altro, chiedono a un loro avversario se debbono effettivamente applicarla. Colloqui del genere, fra Gesù e le autorità, al massimo potevano esserci privatamente, come nel caso di Nicodemo.
I farisei non avevano bisogno dell'avallo del movimento nazareno per legittimare il loro potere; semmai per loro doveva essere il contrario. Se gli scribi e i farisei fossero andati da Gesù a chiedergli un parere in merito a un reato del genere, avrebbero avvalorato, agli occhi della pubblica opinione, l'importanza del movimento nazareno e quindi la giustezza delle critiche politiche che tale movimento faceva al governo giudaico. Il loro compito invece era sempre stato quello di screditarlo il più possibile, proprio per avere il monopolio di una eventuale critica al sistema dominante. Sono poche le eccezioni in senso contrario.
Scribi e farisei si aspettavano, in genere, una reazione da parte di Gesù che servisse loro non solo a dimostrare che la legge andava applicata così com'era, ma anche a dimostrare che Gesù, in quanto trasgressore della legge (come nel caso del precetto del “sabato”), meritava d'essere punito. Il suo rifiuto di considerare la legge mosaica come un dogma lo si era già visto nella questione del rispetto del sabato, allorché gli era stato impedito di assistere gli ammalati in quel giorno festivo (e la questione del sabato non era certo meno importante di quella dell'adulterio, almeno per un ebreo).
I farisei inoltre sapevano che l'adulterio – in quell'epoca di crisi politica, sociale e normativa – non poteva essere considerato un peccato molto più grave di altri (si pensi p.es. ai mestieri proibiti), da meritare addirittura un'esecuzione capitale. Il potere religioso non aveva più l'autorità morale sufficiente per legittimare sentenze del genere, anche se quello istituzionale, con motivazioni demagogiche, avrebbe potuto autorizzarne l'esecuzione, ma in questo caso non vi sarebbe stato dibattito pubblico sull'opportunità della sentenza. Da tempo il potere aveva perso credibilità agli occhi del popolo, proprio a causa del suo atteggiamento indulgente verso il dominio romano.
Il racconto sembra dare per assodata una popolarità enorme di Gesù, ma se così fosse, non si potrebbe poi spiegare l'ignoranza delle autorità sulla inevitabile risposta ch'egli avrebbe dato alla loro domanda. In tal senso, il v. 6 esprime solo un luogo comune: “Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare”. Esso probabilmente è servito per dirimere una controversia scoppiata all'interno della stessa comunità cristiana. Quello degli scribi e dei farisei non era certamente un ceto che di per sé andava considerato totalmente privo di scrupoli morali.
La frase riportata al v. 6 avrebbe avuto senso se fosse stata detta all'inizio del vangelo, come fa Marco nel suo racconto della mano inaridita (3,1 ss.), là dove si dimostra la superiorità dell'uomo sulla legge. Messa quasi alla fine, quando le autorità da tempo avevano avuto conferma del carattere “eterodosso” del movimento nazareno, quella frase non ha senso. La morte violenta del Cristo non sta forse ad indicare quanto sia facile agli uomini di potere, cioè ai suoi carnefici, censurare gli aspetti morali della loro coscienza?
IV
Il Cristo di Giovanni (o dell'autore di questo racconto interpolato) è senza dubbio più un filosofo ingenuo che un politico avveduto. Egli s'illude di poter incidere sugli assetti politici conservatori promuovendo delle azioni esclusivamente morali. In tal senso ci si può anche chiedere fino a che punto un individuo moralmente degno, ma spoliticizzato, sarebbe disposto a sacrificarsi per il bene comune.
Naturalmente non si vuol togliere a questo racconto il suo valore umanistico. Si vuol semplicemente evidenziarne il limite politico e quindi la vana pretesa di superare un'esigenza politica di liberazione da un punto di vista esclusivamente morale. Una morale che pretende d'essere autonoma da qualunque impegno politico, rischia facilmente di produrre effetti (non solo politici ma anche morali) contrari a quelli voluti.
Il problema qui non era semplicemente quello di avere o non avere pietà di un'adultera, ovvero di perdonarle un'azione allora considerata, almeno de jure, molto grave (in riferimento alla sola donna, benché Lv 20,10 preveda la morte anche per l'adultero), ma era piuttosto quello di capire le motivazioni ad essa sottese (frustrazione personale della donna? oggettive esigenze economiche? o altro?) al fine di porre le condizioni per indurre a una non reiterazione del gesto. Perdonare o condannare non ha alcun senso se non si esaminano le cause che spingono gli individui a compiere determinate azioni. Finché le motivazioni restano, le condanne non sortiranno mai gli effetti desiderati, e se c'è volontà di risolvere le motivazioni non ci sarà bisogno di condanne.
Oltre a ciò, un Cristo politicizzato avrebbe dovuto estendere il concetto di “tradimento” a un atteggiamento più vasto e complesso, riguardante tutti coloro che, pur non essendo “adulteri” stricto sensu, tradiscono i propri ideali o la propria coscienza per ragioni quali il denaro, il potere, l'interesse... Il concetto di “adulterio” spesso nella Bibbia viene usato come sinonimo di “tradimento” delle “istanze popolari” (cfr. Ger 3,6; 5,7; 7,9; Os 4,2; 5,4; Sap 14,12.26; Ez 16,20).
Il fatto che il Cristo, chinatosi, si metta a scrivere col dito per terra, sta proprio a indicare – nella mente dell'ignoto autore – la sua volontà di non affrontare argomenti di carattere sociale o riferibili alla pratica specifica dell'adulterio o, tanto meno, allusivi alla questione più generale (metaforica) del “tradimento”. Il Cristo di questo racconto non cerca un confronto con gli accusatori, ma solo un gesto di pietà, cioè la commiserazione per una donna “debole”, ovviamente nella consapevolezza che nessuno è “perfetto” (o che tale si debba sentire). L'indulgenza richiesta nei confronti della donna è in realtà un invito sia a ridimensionare le proprie pretese di perfezione morale, sia, in ultima istanza, le proprie aspirazioni a modificare qualitativamente la realtà sociale oppressiva.
Paradossalmente, proprio mentre si afferma, dal punto di vista morale, che in una società decadente bisogna essere più transigenti nei confronti dei “peccatori”, poiché chi giudica spesso non è meno “peccatore”; viceversa, dal punto di vista politico, la transigenza finisce col peggiorare la crisi della società, obbligando gli uomini a tollerare reati sempre più gravi, e questo proprio perché si è usata la transigenza solo in chiave morale, per dei casi singoli, senza considerare la società nel suo insieme.
In sintesi, se sul piano morale il racconto, con qualche sforzo, può essere visto in una luce positiva, sul piano politico i suoi limiti sono evidenti, in quanto il Cristo chiede la pietà per un caso concreto e non la giustizia per la situazione generale. Chiede anzi di rassegnarsi all'ingiustizia generale e di perdonare i più deboli, coloro che subiscono di più le contraddizioni del sistema o che non hanno le forze morali per opporvisi individualmente o stoicamente.
V
Poste le cose nei termini visti, il finale del racconto sembra dimostrare che Gesù, in via di principio, sia sostanzialmente d'accordo con gli accusatori della donna, i quali avevano giudicato negativamente l'adulterio qua talis, prescindendo dalle motivazioni che potevano averlo generato. Da nessuno le circostanze della colpa vengono considerate oggetto di discussione. Anzi, il racconto sembra essere stato scritto proprio per contestare il legalismo rabbinico, che, pur essendo pedante e cavilloso, a volte arrivava a conclusioni freddamente ciniche, spietate.
La differenza tra la posizione di Gesù e quella degli scribi verte unicamente sui mezzi da usare per punire la donna: gli scribi vogliono la lapidazione (e in questo senso appaiono degli estremisti); Gesù invece, dopo aver preso atto della flagranza della colpa e, se vogliamo del pentimento della donna (che non si è mai difesa), si dichiara disponibile al perdono. Cioè dal lato umano egli appare flessibile, tollerante; dal lato politico, invece, appare come un rassegnato all'ingiustizia dominante, poiché non ne mette in discussione le dinamiche sociali.
Il Cristo è favorevole al recupero dell'accusata per motivi di principio, senza che questa abbia neppure promesso di non reiterare l'azione. È solo alla fine del racconto che Gesù chiede alla donna di “non peccare più”. Il vantaggio ch'egli offre è tutto qui, oltre naturalmente allo scampato pericolo di morte.
Egli non solo dà per scontato, giustamente, che nessun ideale di giustizia (neppure quello scriba e farisaico) sia così perfetto da necessitare punizioni esemplari nel caso in cui venga violato, ma dà anche per scontato che ogni ideale è impossibilitato a realizzarsi, per cui il perdono unilaterale, in luogo della rimessa in discussione dei valori dominanti, finisce col diventare una garanzia di maggiore coerenza o di minore illusione.
Alla donna, inevitabilmente, non può essere offerta una vera alternativa di vita (neppure nel senso di una chiamata alla sequela messianica). Le viene soltanto chiesto di rassegnarsi al fatto d'essere colpevole, anche se in tale rassegnazione non deve temere una condanna affrettata, irrevocabile, in quanto appunto di fronte a “Dio” l'uomo ha sempre torto. Non c'è dialogo sulla motivazione dell'atto. L'ipocrisia del Cristo alla fine appare maggiore, perché più sofisticata, di quella degli scribi, che è indubbiamente rozza e schematica.
In forza di tale ipocrisia, che è sconosciuta al mondo ebraico, essendo stata introdotta dal cristianesimo, si potrebbe anche ipotizzare un'amara prosecuzione di questo racconto, cioè una sorta di “doppio finale”.
Proviamo infatti a immaginare cosa sarebbe potuto accadere alla donna che avesse ripetuto la colpa. L'adultera, certo, non poteva sentirsi giudicata da “scribi e farisei” che, quanto a “tradimenti” (in senso lato), erano senz'altro peggiori di lei. Ma come avrebbe potuto sentirsi di fronte a un Cristo che, vedendola peccare una seconda volta, avesse deciso di non perdonarla?
Evitando di analizzare o contestualizzare la colpa, il Cristo non aveva neppure messo in discussione il senso della pena. Ora, cosa potrebbe impedirgli di portare la donna, caduta di nuovo nella colpa, alla convinzione che il gesto ripetuto non meriti più alcuna comprensione, non essendoci più valide attenuanti che possano giustificarlo?
Dopo un primo perdono, concesso gratuitamente, per libero consenso di chi avrebbe potuto anche condannarla, la donna non avrebbe più dovuto peccare. Siccome il Cristo non aveva chiesto esplicitamente che si abolisse la lapidazione per “reati” di questo tipo ripetuti nel tempo, la donna, recidiva, non solo rischia di nuovo, col cristianesimo, l'esecuzione capitale, ma rischia pure di doversi sentire indotta a credere che se la sia meritata.
Nel testo insomma la lapidazione sembra non aver senso solo in via transitoria, in quanto il colpevole ha diritto sì al recupero, ma, in caso di reiterazione, non solo la pena di morte rischia di diventare inevitabile, ma diventa anche necessaria l'ammissione di colpa da parte del condannato, cioè la convinzione, in coscienza, d'essere irrimediabilmente colpevole e di meritarsi senz'altro la condanna a morte. In questo caso giustiziare una persona o portarla al suicidio diventerebbero le facce di una stessa medaglia.
Molto ingenua, in tal senso, è la posizione di Ambrogio e di Agostino, secondo i quali la mancanza di questo racconto nei codici antichi fosse dovuta a una deliberata soppressione, in quanto si sarebbe potuto pensare che il Cristo avesse usato un'esagerata misericordia.
(torna su)15) Sulla questione dei “segni”
Mc 8,11-13
[11] Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova.
[12] Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: “Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun segno a questa generazione”.
[13] E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda.
*
La questione del “segno dal cielo” viene collocata dai Sinottici in una più ampia requisitoria contro il partito farisaico, uno degli interlocutori privilegiati del movimento nazareno del Cristo.
Nei capitoli 7 e 8 del vangelo di Marco vengono poste sotto accusa varie consuetudini e interpretazioni farisaiche della legge mosaica, quali p.es. l'idea che la “purezza interiore” possa coincidere con quella “esteriore” che si pratica osservando scrupolose regole dietetiche, nonché l'idea che un giuramento di tipo “religioso” possa esimere i figli dall'assumersi delle responsabilità “civili” nei confronti dei propri genitori in stato di bisogno.
L'idea di politica che avevano i farisei, secondo cui solo pochi erano veramente in grado di esercitarla, si esprime appunto nella richiesta di esibire un “segno” convincente (“dal cielo”) con cui Gesù doveva dimostrare la propria pretesa alla messianicità.
Anche durante la cacciata dei mercanti dal Tempio avevano chiesto a Gesù a che titolo, con quale permesso facesse quelle cose (Mc 11,27 ss.). E lui aveva risposto che per compierle non c'era bisogno di alcuna particolare autorizzazione: era l'evidenza (della corruzione) che lo esigeva. Lo stesso aveva pensato, prima di lui, seppur in forme più etiche che politiche, il Battista, un uomo non del “potere” ma del “popolo”, che il “potere” non aveva voluto né riconoscere né proteggere.
Analoghe domande i farisei ponevano a Gesù quando trasgrediva il sabato in nome di una grave esigenza da soddisfare: assistere i malati. Chiedevano un “segno” proprio mentre negavano l'“evidenza”. Era solo il popolo che capiva che Gesù “insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi” (Mc 1,22).
A motivo di queste continue richieste di attestare la propria credibilità, Gesù qui paragona i farisei ai loro avversari: gli erodiani, palesemente collaborazionisti con Roma (Mc 8,15). I discepoli stentano addirittura a comprenderlo, poiché l'appoggio dei farisei pareva decisivo, vista la loro influenza nell'ambito delle sinagoghe, per compiere una rivoluzione anti-romana.
Ecco perché egli rifiuta sempre di dimostrare con un “segno” straordinario di essere autorizzato ad aspirare alla leadership di Israele contro Roma. Non vuole far valere alcun carisma particolare, non vuole imporsi in modo autoritario, non vuol dimostrare militarmente d'essere più forte di qualsivoglia legione romana. Chi chiede un “segno” di tipo “miracoloso”, eccezionale, inevitabilmente finisce col promuovere il culto della personalità.
Nicodemo, uno dei leader farisei di minoranza, riferendosi all'epurazione del Tempio, compiuta da Gesù, si risparmiò di cadere in questa assurda pretesa, affermando con sicurezza che “nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui” (Gv 3,2). Eppure anche questa ammissione al Cristo non bastò, proprio perché non voleva che si pensasse che aveva lottato per la democrazia solo perché un'entità religiosa (in questo caso “Dio”) l'aveva autorizzato.
Tuttavia i redattori cristiani (inclusi i manipolatori del quarto vangelo) han sempre sostenuto che il Cristo si rifiutava di concedere un “segno” specifico, cioè una prova inconfutabile della propria messianicità (anzi “della propria divinità”), poiché, per averla, sarebbe stato sufficiente dedurla dalle straordinarie guarigioni che operava.
Se guarire un lebbroso con un dito o un paralitico con una solenne dichiarazione o un cieconato con della semplice saliva non poteva costituire per i Giudei una “prova” che Gesù fosse il messia, allora anche se avesse resuscitato un morto non avrebbero creduto (Lc 16,31).9
È stato il forte antisemitismo a indurre i redattori cristiani ad affermare simili sciocchezze. In realtà nemmeno per il Cristo le guarigioni (se mai siano state compiute così come vengono descritte) avevano la pretesa di porsi come “segni” inconfutabili della propria messianicità. Egli si rifiutava di concedere “segni inequivocabili” di alcun genere (che in pratica non possono essere offerti da nessuno), semplicemente perché ciò avrebbe leso la libertà di scelta dell'uomo.
Nella presunta attività terapica del Cristo sembra esserci stata, almeno per come appare nel primo vangelo (che resta comunque fortemente tendenzioso), la volontà di unire “desiderio di sanità psico-somatica” a “istanza sociopolitica di liberazione”. Cioè in sostanza il Cristo può anche aver chiesto ai “risanati” di diventare – se possibile, nel rispetto della loro libertà – suoi fattivi seguaci o in qualche modo collaboratori (cosa che non tutti, in realtà, facevano e che, non per questo, venivano puniti). Ma non è da escludere che proprio nelle guarigioni occorra vedere, a motivo del forte realismo che esprimono, il primo tentativo redazionale di mistificare la prassi politica del Cristo.
Nel migliore dei casi le guarigioni (come altre cose da lui compiute) dovevano soltanto suscitare una speranza nella possibilità del cambiamento; la decisione di aderire al manifesto programmatico e di impegnarsi responsabilmente dovevano restare il frutto di una scelta personale, decisa autonomamente, del tutto indipendente dai favori ottenuti.
Se la concessione di un favore avesse dovuto vincolarsi alla richiesta di una sequela politica, il rapporto tra Cristo e i malati sarebbe stato strumentale, oggi diremmo di tipo “mafioso”, sia che le guarigioni fossero state alla portata dell'uomo, sia che fossero andate oltre le capacità umane.
In ogni caso, sostenere che, al cospetto di quelle guarigioni “miracolose”, i Giudei insistevano nel chiedere un particolare “segno” da parte del Cristo, affinché dimostrasse, sul piano politico, le sue buone intenzioni, la sua legittimità a governare, il suo diritto alla messianicità, significa soltanto avvalorare idee antisemitiche, facendo passare i capi politici del giudaismo come soggetti profondamente in malafede.
I redattori cristiani non si resero conto che se il Cristo avesse imposto il proprio carisma, usando la forza delle sue prodigiose guarigioni, gli ebrei, come qualunque altro popolo, l'avrebbero accolto in maniera trionfale, ma in tal modo sarebbe sorta una monarchia, non una democrazia. E se, nonostante questi segni mirabolanti, avessero continuato a dubitare ch'egli potesse essere un valido leader politico, avrebbero soltanto dimostrato d'essere migliori di qualunque altro popolo.
(torna su)16) La mistificazione del Paraclito
Gv 16
[1] “Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi.
[2] Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio.
[3] E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me.
[4] Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi.
[5] Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai?
[6] Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
[7] Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò.
[8] E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.
[9] Quanto al peccato, perché non credono in me;
[10] quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più;
[11] quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.
[12] Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
[13] Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future.
[14] Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.
[15] Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.
[16] Ancora un poco e non mi vedrete; un po' ancora e mi vedrete”.
[17] Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: “Che cos'è questo che ci dice: Ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado al Padre?”.
[18] Dicevano perciò: “Che cos'è mai questo 'un poco' di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire”.
[19] Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: “Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un pò ancora e mi vedrete?
[20] In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.
[21] La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo.
[22] Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
[23] nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
[24] Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
[25] Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre.
[26] In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi:
[27] il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio.
[28] Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre”.
[29] Gli dicono i suoi discepoli: “Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini.
[30] Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio”.
[31] Rispose loro Gesù: “Adesso credete?
[32] Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
[33] Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!”.
*
Di questo capitolo del vangelo di Giovanni il versetto più mistificante è il 12: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”.
I motivi del carattere subdolo di questo versetto sono due:
– fa sembrare Gesù un Dio, assolutamente superiore agli apostoli che lo ascoltano;
– mette un'ipoteca sulla possibilità di realizzare una società a misura d'uomo.
Infatti, se gli uomini non possono conoscere la “verità”, sono destinati a vivere nella menzogna o quanto meno nelle mezze verità, in ogni caso non sono nelle condizioni di poter conoscere quanto basta per essere umani.
Ora, siccome una tesi del genere avrebbe potuto indurre alla disperazione, il redattore è stato costretto ad aggiungere che gli uomini conosceranno la verità progressivamente, non attraverso Cristo, ma attraverso un suo mediatore, lo Spirito, il Paraclito, il Consolatore (che in ebraico è di genere femminile). Questo non solo per dire che la ricomparsa del Cristo sulla Terra non dipende in alcun modo dalla volontà umana, ma anche per dire che di Cristo ce n'è stato solo uno e nessuno potrà mai prendere il suo posto, neppure se lo facesse in suo nome.
Il suddetto Consolatore non è che uno “Spirito di verità” a favore del Figlio. Sarà questa entità a convincere il mondo d'aver compiuto un orrendo crimine crocifiggendo il figlio di Dio, d'aver reso impossibile, con questo delitto, la giustizia sulla Terra e d'aver obbligato gli uomini ad attendere la sua venuta trionfale solo alla fine dei tempi. Il tutto sulla base della teologia paolina.
Quindi l'acquisizione della verità è un fatto progressivo, in crescendo e, finché non si sarà arrivati alla verità assoluta, quella diretta, senza similitudini (v. 25), sarà impossibile essere se stessi, trovare la pace, vivere secondo natura. Quindi la giustizia, la libertà, l'uguaglianza saranno possibili solo in presenza della verità assoluta, che agli uomini verrà rivelata integralmente alla fine dei tempi. Per il momento esiste solo la consapevolezza di una verità oggettiva, che è quella di dover credere nella divinità del Cristo e nell'impossibilità per gli uomini di realizzare da soli la liberazione sulla Terra. È una verità oggettiva al negativo, in relazione alla dimensione mondana.
Cristo dunque doveva morire per far capire agli uomini che sulla Terra non possono essere liberi. Se questa possibilità per loro ci fosse stata, egli avrebbe trionfato sui suoi nemici. Invece il peccato originale è stato così grande (e lo dimostra appunto la crocifissione del Dio-figlio), che gli uomini hanno perduto definitivamente la possibilità di salvarsi con le loro stesse forze. Da soli non riescono a fare più nulla di costruttivo, possono soltanto distruggere e autodistruggersi, a meno che non assumano un atteggiamento di serena passività, di motivata rassegnazione, lottando affinché questo atteggiamento s'imponga in maniera universale, diventi cultura dominante, fino al giorno della parusia del Cristo, il giorno escatologico dell'apocalisse.
La croce ha tolto la possibilità di una liberazione terrena non solo agli uomini della generazione del Cristo, ma anche agli uomini di tutti i tempi, almeno finché non tornerà di nuovo lui a liberarli, secondo la promessa fatta. Anzi la sua morte violenta ha dimostrato che, in realtà, la possibilità di un'effettiva liberazione terrena non c'è mai stata, non avrebbe potuto esserci, e il Cristo, con la sua morte, doveva soltanto indurci a prendere consapevolezza di un dato di fatto, mentre con la sua volontaria accettazione della croce ha voluto farci capire che, pur macchiandoci noi di un delitto mostruoso, non ci avrebbe condannati a morte, non ci avrebbe fatti scomparire nel nulla, pentendosi amaramente di averci creati.
Dai tempi del peccato d'origine gli uomini sono destinati a vivere nella sofferenza, poiché è per loro impossibile, non avendo saputo riconoscere nel Cristo la divinità, sapere riconoscere in loro stessi l'umanità.
La libertà del Cristo è stata quella di morire per poter tornare al Padre, dopo aver compiuto una missione che gli era stata assegnata: far capire che una riconciliazione col bene perduto è sempre possibile e che se anche non la si vuole, chi la offre continuerà ad offrirla; e la libertà degli uomini è soltanto quella di ottenere un Consolatore che preceda, preparandolo, il ritorno trionfale del Cristo.
Quindi, sino a questa parusia, gli uomini sono soltanto destinati a provare gli effetti negativi delle varie forme del loro arbitrio. Quando avranno sperimentato tutte le forme negative di questo arbitrio, scopriranno la “verità tutta intera” (v. 13). A forza di comprendere la negatività delle loro azioni, arriveranno a comprendere quale sia la vera positività: “in quel giorno non mi domanderete più nulla”, dice il Cristo agli apostoli (v. 23).
Il divario tra Gesù e i discepoli è immenso, assolutamente incolmabile. Qui è come se gli apostoli avessero divinizzato al massimo il Cristo per nascondere la vergogna della loro sconfitta politica. Invece di fare autocritica, hanno preferito falsificare e mistificare le cose. Proprio mentre fanno dell'altissima teologia mistica, negano profondamente la loro umanità, il loro diritto a essere se stessi.
(torna su)17) Il potere e l'umiltà
I
Mc 9,33-37
[33] Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la via?”.
[34] Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande.
[35] Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti”.
[36] E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:
[37] “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato”.
*
In Mc 9,34 gli apostoli avevano discusso chi tra loro fosse il più grande e si vergognavano di spiegare a Gesù l'argomento della loro discussione. Il redattore vuol far notare, con l'ambiguità tipica di una qualunque lettura “religiosa”, che il concetto di potere politico che aveva Gesù era assai diverso da quello tradizionale. Ecco perché essi non risposero alla sua domanda su cosa avevano discusso.
Ma egli, intuito il problema, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti” (v. 35).
Questo può apparire un consiglio moralistico. Come se l'umiltà fosse una virtù politica! Politici spregiudicati alla Machiavelli la considerano al massimo una tattica per acquisire proprio il potere politico, da amministrare poi con criteri tutt'altro che democratici. Nel migliore dei casi la ritengono un ostacolo insormontabile a una qualunque gestione della “cosa pubblica”.
In realtà, l'umiltà richiesta nel brano di Marco è più di un semplice sforzo di abnegazione personale, è piuttosto una sorta di verifica della stretta coincidenza di valori umani e valori politici. Essere “servo di tutti” implica un rapporto sociale caratterizzato dalla democraticità. Nel senso cioè che quanto più un individuo aspira al potere politico, tanto più deve dimostrare di possedere una grandissima umanità. E l'unica possibilità di dimostrarlo è quella di mettersi al servizio della collettività, ascoltandone le esigenze.
“E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me” (vv. 36-37).
Che significa? Semplicemente che nessuno può mettersi al servizio degli altri se non ha la semplicità, la disponibilità di un bambino. La persona orgogliosa, prepotente, intollerante... potrà anche essere un ottimo politico secondo i canoni tradizionali delle società antagonistiche, ma essendo una nullità sul piano umano, lo sarà anche come “moderno” uomo politico.
Oggi le qualità democratiche di uno statista non è possibile misurarle né sulla base delle sue capacità di “mediare” i contrasti, i conflitti di classe o d'interesse (poiché ciò può degenerare nell'opportunismo o nel trasformismo più bieco, stante l'attuale sistema politico), né sulla base della sua familiarità al sacrificio, all'abnegazione personale (poiché ciò rischia di avere un valore solo temporaneo, transitorio, in attesa appunto di conseguire il potere agognato). Oggi un politico può essere considerato veramente democratico solo nella misura in cui si sa confrontare con gli interessi reali della popolazione (soprattutto di quella locale, che è l'unica a potergli impedire di dire una cosa e farne un'altra).
Naturalmente il fatto che un politico debba concepirsi al servizio della cittadinanza, non significa che deve restarne in balìa, soggetto alle varie pressioni corporative: non è il numero che di per sé fa la democrazia. Piuttosto il politico deve dialettizzare con la gente, confrontandosi di continuo, discutendo sulle questioni più rilevanti... La verità delle cose non sta né dalla parte del politico, né dalla parte della gente: essa è un processo in itinere, in cui ognuno può rivendicare una partecipazione paritetica.
“Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri” (v. 38).
Incredibile che Giovanni abbia detto una frase di questo genere, poiché era troppo intelligente per poter credere nel valore degli esorcismi; però essa è indicativa di un atteggiamento sbagliato: quello di voler egemonizzare il diritto alla verità, trasformandolo in privilegio. Il monopolio della verità si trasforma sempre, sul piano politico, in una dittatura. Per evitarlo, i cittadini che eleggono i loro rappresentanti dovrebbero prima verificare il loro atteggiamento nei riguardi delle opinioni altrui.
Giovanni impediva a quell'uomo di fare del bene solo perché non li seguiva. La logica politica degli schieramenti, la coscienza di classe senza coscienza dei valori umani universali possono appunto portare a considerare “cattiva” un'azione “buona”. È anche il pericolo di tutti coloro che, militando nei partiti politici, tendono ad allontanarsi dalle masse, rapportandosi solo o alle istituzioni del sistema o ad altri partiti. Che il rischio sia reale, è dimostrato anche dal fatto che quando i movimenti popolari (di base) cercano di confrontarsi coi partiti, questi spesso tendono (proprio come fanno le istituzioni) a strumentalizzarli o a fagocitarli o ad ignorarli completamente.
“Ma Gesù disse: Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi, è per noi” (vv. 39-40).
In questo senso, mali come il fanatismo e il settarismo colpiscono, nell'ambito dei partiti, anche i più grandi “mediatori” e diplomatici della politica. Nessun politico ha la sicurezza di non essere condizionato da questa logica perversa dello schieramento, almeno sino a quando non è costretto a misurarsi con una realtà che non rientra nei tradizionali schemi di impegno sociale o di presenza politica. Ma deve esservi “costretto” da una realtà davvero significativa, altrimenti l'umiltà costa troppa fatica.
Gesù fa capire ai Dodici che il “bene” può provenire da diverse parti, che la verità ha sempre mille sfaccettature, che si può essere anche solo “simpatizzanti” di un movimento. Ma come individuare queste persone? Come distinguere un'azione “positiva” da una “negativa”? Tutti sanno che non esiste nella realtà un criterio discriminante valido a priori. Spesso cose in sé positive o che almeno sembrano tali, si rivelano negative alla prova dei fatti, oppure restano positive solo per un certo periodo di tempo. Se un'azione è “buona” o “cattiva” lo si vede soltanto dagli “effetti” che produce. Le migliori qualità umane sono quelle che si verificano al momento di correggere gli errori, le deviazioni, le storture che continuamente caratterizzano la nostra attività. Non si può impedire a una persona di esprimere le proprie idee o di agire in un determinato modo solo per timore che le conseguenze delle sue parole o delle sue azioni siano negative. Si può discutere, si può ragionare, dimostrando, sulla base dei cosiddetti “precedenti”, che l'applicazione di determinate idee può portare a esiti sfavorevoli, ma l'individuo, alla fine, deve essere lasciato libero di verificare le proprie idee, anche se dovrà rispettare la volontà opposta della controparte (specie se questa è maggioritaria). Naturalmente, se l'individuo in questione è uno statista avente a disposizione un notevole potere politico e militare, il problema del controllo delle sue azioni diventa molto più complesso.
In questo caso, effettivamente, le strade percorribili sembrano essere solo due: o la popolazione è sufficientemente matura e responsabile per impedire allo statista di commettere pazzie (ma allora dovremmo chiederci com'essa ha fatto a permettergli di arrivare al potere: se è stata ingannata, allora dovrebbe reagire immediatamente; se invece non ha la prontezza di farlo, perché normalmente, al momento delle elezioni o dell'attività politica in generale, non mostra un particolare impegno o interesse, allora si può sperare ch'essa maturi la forza di reagire nel corso della gestione negativa del potere politico); oppure la popolazione è così immatura che reagirà solo dopo aver subìto su di sé tutte le conseguenze negative della gestione di tale potere (l'esempio del nazifascismo può essere illuminante).
È bene infatti rendersi conto che se il potere politico oggi è alienato dalla società civile, nel senso che il “politico”, nell'ambito del capitalismo, non riesce ad essere efficacemente controllato dal “sociale”, ciò dipende anche dal fatto che la società civile fa poco o nulla per superare questa alienazione. Sotto tale aspetto, persino il peggior governo rispecchia sempre, seppur non completamente, l'immagine della società civile, almeno fino a quando i cittadini non comprenderanno che il loro potere politico non possono soltanto delegarlo, ma devono anche gestirlo in proprio, direttamente, soprattutto negli ambiti locali. Peraltro, quando la grande maggioranza della popolazione è coinvolta in tale “autogestione della politica”, si evita più facilmente il rischio che quei gruppi o movimenti socialmente più impegnati facciano da supporto agli interessi del sistema.
Se la maggioranza della popolazione dimostrasse forte l'esigenza di autogovernarsi, apparirebbe subito evidente la pochezza morale e intellettuale di molti politici tradizionali, la loro fragilità interiore, la loro profonda povertà umana. “Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono – dice il Cristo – meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare” (v. 42). Questo perché un politico smascherato dall'umanità e dal senso di democrazia della gente, rischia di diventare un soggetto molto pericoloso, se continua a disporre di molto potere politico e militare. Ma può anche voler dire che un politico smascherato è un uomo perduto, poiché, non essendo abituato all'autocritica, non riuscirà a sopportare questa umiliazione.
Il potere politico oggi non conosce alcuna forma di umiltà non tanto perché è separato dalla morale, quanto perché è totalmente separato dalla società. Lo dimostra questo semplice esempio: un qualunque movimento molto impegnato sul terreno dei diritti umani, della pace o della tutela ambientale, quando si trasforma in un partito politico, entrando negli ingranaggi istituzionali e parlamentari, se non continua a svolgere, assiduamente, un'attività legata all'esperienza quotidiana delle masse popolari, inevitabilmente regredisce fino a perdere ogni caratteristica innovativa. È la stessa logica del sistema che gli impone questa involuzione. Non dipende dalla “malafede” o dalla “scarsa volontà”, ma da regole oggettive che il sistema si dà per assorbire le varie forme di contestazione. Ecco perché bisogna sostenere il principio che la lotta rivoluzionaria contro il sistema va condotta anche e soprattutto a livello extraparlamentare, cioè sulle piazze, fra la gente, insieme a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini.
II
Mc 10,32-45
[32] Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto:
[33] “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani,
[34] lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà”.
[35] E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: “Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo”.
[36] Egli disse loro: “Cosa volete che io faccia per voi?”. Gli risposero:
[37] “Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”.
[38] Gesù disse loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?”. Gli risposero: “Lo possiamo”.
[39] E Gesù disse: “Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete.
[40] Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”.
[41] All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni.
[42] Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere.
[43] Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore,
[44] e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.
[45] Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”.
*
Il racconto di Mc 10,32-45 chiude, in un certo senso, la trilogia di questo vangelo relativa a “sesso, soldi e potere” (c. 10), che rappresentano i tre principali aspetti che un movimento rivoluzionario deve affrontare per porre un'alternativa credibile alla società.
La trilogia era iniziata con la questione delle pulsioni libidiche che portano al divorzio (vv. 1-12) e proseguita con quella dell'avarizia del giovane ricco (vv. 17-31). Il senso di questa trilogia è analogo a quello dell'episodio simbolico delle tentazioni di Gesù nel deserto (Mt e Lc 4,1 ss.), dove l'unica differenza stava nell'oggetto specifico del materialismo volgare: il “pane” (in luogo del “sesso”), ma si tratta di una formalità, in quanto il vero contenuto etico sta nella critica del “primitivismo” di certe opzioni esistenziali.
Qui la terza tentazione è di tipo politico e si pone ovviamente a un livello più sofisticato, rispetto alle due precedenti (che erano di natura fisica ed economica): non a caso colpisce alcuni degli apostoli più in vista. La richiesta che Giacomo e Giovanni pongono a Gesù è la seguente: “Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra” (v. 37), subito dopo l'ingresso trionfale a Gerusalemme.
Come si può notare, l'esigenza è quella di poter disporre di un certo potere politico, o meglio, è quella di ottenere il riconoscimento di un merito politico: l'essere i migliori militanti del movimento nazareno. In fondo, i due apostoli non hanno fatto altro che manifestare una loro interiore convinzione, quella secondo cui il trionfo della strategia politica di Gesù era imminente. E, in tal senso, non si vergognano di avanzare la loro candidatura alle cariche più prestigiose del futuro governo. Matteo, dal canto suo, e come al solito, ha voluto ridimensionare questa pretesa facendo in modo che fosse la “madre” dei due ad avanzare la richiesta; ma così – senza volerlo – ha finito con lo sminuire il valore effettivo degli apostoli, ovvero la loro consapevolezza e maturità politica.
Di fronte a tanta sicurezza, che non partiva soltanto da una mera ambizione personale, ma anche e soprattutto dall'esigenza di veder affermata la giustizia in tutta la Palestina, Gesù non può fare altro che mettere alla prova i due fidati collaboratori. “Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?” (v. 38). Gesù, in sostanza, chiede conferma della disponibilità ad accettare con lui la sofferenza inevitabilmente correlata alla rivoluzione; non nega valore alla richiesta degli apostoli né dà per scontata la sconfitta della rivoluzione.
Gli risposero: “Lo possiamo”. Anche qui non si tratta tanto di presunzione, di arroganza o di sopravvalutazione di sé, quanto piuttosto di consapevolezza del proprio ruolo, cioè del coraggio e dell'intelligenza che occorre per poter assumere e conservare determinate funzioni e prerogative (quel coraggio e quell'intelligenza che fin lì avevano indubbiamente saputo dimostrare). Essi sanno che la liberazione comporta dei sacrifici e non si sentono impreparati ad affrontarli. Anzi, il loro idealismo politico è così grande che accetterebbero anche l'idea di morire per il bene della nazione. Questo, in fondo, è il significato del “calice” e del “battesimo”.
Il che però non vuol dire che il vangelo marciano sia tenero coi fratelli Zebedeo. Anzi, si può dire che quanto più Gesù s'avvicina a Gerusalemme, tanto più il redattore li pone sotto accusa: in particolare Giovanni, cioè colui che sarà il principale avversario di Pietro a motivo dell'interpretazione forzata della tomba vuota come “resurrezione”. Giovanni viene citato negativamente sia in 9,38 che in 10,35, facendolo passare per un settario e, insieme al fratello, per un ambizioso, al punto che gli altri apostoli cominciarono a indignarsi con loro (10,41).
In ogni caso Gesù, non potendo rifiutare questa disponibilità al sacrificio, non potendo dubitare della loro buona fede (poiché da tempo li conosce), è costretto ad articolare la propria risposta in maniera più approfondita. “Il calice che io bevo voi lo berrete e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato” (vv. 39-40).
Pur riconoscendo le loro straordinarie qualità politiche ed umane, e immaginando che anch'essi non sarebbero stati risparmiati dalle persecuzioni, Gesù dichiara ugualmente la propria incapacità a prevedere il futuro, in quanto la soluzione del problema del potere da conquistare è – a suo giudizio – un compito che spetta unicamente alla storia e non tanto alla volontà o alle aspirazioni di singoli uomini o movimenti politici (Matteo qui ha stravolto il testo introducendo le parole “Padre mio”, per interpretare in chiave religiosa il concetto implicito di “storia”).
In pratica l'insegnamento di Gesù riguarda il principio secondo cui la lotta rivoluzionaria non deve essere condotta solo a condizione di ottenere il “massimo”, costi quel che costi. Il senso di questa lotta le è intrinseco e non dipende dal risultato finale, il quale va sempre lasciato al giudizio e alle scelte della storia. Nessun uomo, nessuna rivoluzione e nessuna singola epoca potrà mai aver la pretesa di costruire per intero il grande edificio della democrazia.
In tal senso, l'idealismo e il volontarismo dei figli di Zebedeo non sono sufficienti per garantire che la rivoluzione sarà condotta secondo criteri e metodi democratici, poiché se la capacità di sopportare le sofferenze e le privazioni può rendere apprezzabile l'attività del militante durante la rivoluzione, questa stessa capacità, una volta giunti al potere, può diventare fonte di abusi, se l'orgoglio maturato non sa riconoscere i fallimenti cui ogni rivoluzione rischia sempre di andare incontro.
Ecco perché Gesù chiede di nutrire dei sentimenti di umiltà non solo nel momento in cui si lotta e si soffre per la giustizia, ma anche per il giorno in cui si conquisterà il potere, poiché senza quella umiltà, la violenza e l'inganno saranno inevitabili. Gli uomini devono sapere prima che con l'impegno rivoluzionario non sono destinati a creare una società “perfetta” ma solo “migliore”, col rischio di renderla “peggiore” qualora dimenticassero l'uso dell'autocritica. A tale scopo vale la massima evangelica: “Chi vuol essere il primo tra voi sia il servo di tutti” (vv. 43-44).
Quando viene meno l'umiltà, anche i rivoluzionari diventano come i “capi delle nazioni”, che esercitano il “dominio”, il puro “potere” (v. 42): gli ideali rivoluzionari non possono da soli impedire questa degenerazione. Non è sufficiente essere disposti al sacrificio per dimostrare che si può esserlo anche nel caso in cui la rivoluzione trionferà o, peggio, nel caso in cui essa fallirà. L'esito rivoluzionario non dipende dal singolo individuo, ma dalla storia, ovvero dalle masse che fanno la storia senza subirla. È al cospetto di queste masse che il rivoluzionario deve rendere conto del proprio operato: solo così egli potrà impedire che i suoi sacrifici si trasformino, una volta ottenuto il potere, in un motivo d'orgoglio, di ambizione e di sfrenato autoritarismo.
(torna su)18) I sadducei e l'idea di resurrezione dei corpi
I
(Mc 12,18-27)
v. 18) Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo:
“I sadducei – scrive Luca negli Atti degli apostoli – affermano che non c'è resurrezione, né angeli, né spiriti; i farisei invece professano tutte queste cose” (23,8).
Questo gruppo politico-religioso, ricco e potente, benché poco numeroso, ebbe il monopolio per via ereditaria del sacerdozio di Gerusalemme (la somma dignità) da Salomone fino al 76 a.C. Questa data segna l'ingresso nel Sinedrio dei farisei, rappresentati dai loro scribi, che iniziano a ostacolarli politicamente, benché la presidenza del Gran Consiglio restasse riservata al sommo sacerdote sadduceo, il cui potere, da tempo, dipendeva da quello civile, non strettamente giudaico (asmoneo, erodiano, romano).
Nel I sec. a.C. Roma, con Pompeo, li aveva privati di ogni potere politico e di una parte di quello religioso (p.es. il sommo sacerdote non era più scelto da “Dio”, secondo l'eredità, ma dall'imperatore, attraverso il proprio legato). Da parte loro i farisei avevano contribuito a spogliarli, sul piano sociale, della loro restante autorità (persino nel culto si dovevano eseguire alcune regole farisaiche).
Ai tempi di Gesù questo partito aristocratico e conservatore (divenuto sempre più politico e sempre meno religioso) era, esattamente come gli erodiani, collaborazionista con Roma, nella speranza di conservare le posizioni di preminenza all'interno del Tempio e, per questa ragione, era avversato, in linea di principio, dall'ideologia farisaica e ovviamente da quella cristiana: gli Atti degli apostoli lo documentano a più riprese (4,1; 5,17s.; 5,33ss.; 23,6ss.). Sono sempre i sadducei i primi a frenare ogni rivendicazione popolare che potesse dare adito a rappresaglie da parte romana; e saranno ancora loro i principali responsabili della morte di Gesù (Gv 11,49s.).
Ciononostante fu proprio uno di loro a dare il via alla strage del 70, interrompendo nel 66 il sacrificio per l'imperatore presso il Tempio. Quando questo venne distrutto da Tito, scomparve anche l'influenza sadducea sul giudaismo, definitivamente soppiantata dal fariseismo, non legato né al Tempio né al sacerdozio.
La loro posizione dottrinale era caratterizzata dal rifiuto di riconoscere l'esistenza di una legge scritta o orale che non fosse quella contenuta nel Pentateuco, quindi dal rifiuto di riconoscere i profeti (ritenuti troppo eversivi) e ogni tipo di tradizione, anche quella degli “antichi” (Mc 7,3). In questo assomigliavano ai samaritani, salvo che, diversamente da loro, non avevano provveduto a modificare lo stesso Pentateuco; inoltre i samaritani contrapponevano nettamente il monte Garizim al Tempio di Gerusalemme.
Interpretavano alla lettera la legge mosaica (Torah) e rifiutavano di estendere ai laici le disposizioni valide per i sacerdoti; al di fuori del servizio del Tempio era permesso – secondo loro – avere contatti coi pagani (i farisei invece la pensavano diversamente, cfr Mc 7,3s.); la purità e quindi la santità erano riservate ai capi dei sacerdoti, non al popolo. Una sorta di “dualismo” dominava la gestione del loro potere religioso: conservatori sul piano del diritto, in quanto tenacemente legati a un ruolo aristocratico del tutto obsoleto; permissivi nei confronti della prassi religiosa del popolo, in quanto consapevoli di scarsissima rappresentatività sociale; quindi autoritari e lassisti allo stesso tempo.
Più in particolare, e per quanto riguarda l'argomento in questione, essi non credevano nell'idea della resurrezione, né ammettevano la fede in una retribuzione nell'altra vita, ma si attenevano a un determinismo materialistico dell'umana esistenza, ove era esclusa, propriamente parlando, l'idea di una “trascendenza” che non fosse quella del rigido monoteismo. Negli Atti appare evidente che la questione della resurrezione costituisce la principale divergenza dottrinale tra loro e i farisei (23,8). Ma si tratta di un'operazione redazionale chiaramente interessata ad esaltare quella divergenza, che ai tempi del Cristo non aveva in realtà alcuna significativa importanza e che invece diverrà cruciale ai tempi di Pietro e Paolo.
In effetti, solo in passi tardivi, non riconosciuti da tutti come biblici, si ammetteva la possibilità di una vita ultraterrena; ma era anche vero che queste riflessioni, maturate in senso alla corrente apocalittica giudaica, non erano affatto patrimonio di pochi individui. I farisei, politicamente frustrati, si sentivano ricettivi a tali riflessioni mistiche e pensavano a una sorta di resurrezione generale alla fine dei tempi (At 24,15; 26,6ss; 4,2), e l'affermazione di Marta, alla vista di Gesù venuto per “risorgere” Lazzaro: “So che resusciterà nell'ultimo giorno” (Gv 11,24), conferma in qualche modo che l'opinione farisaica era abbastanza popolare (questo senza mettere minimamente in discussione che quell'espressione di Marta fu soltanto un prodotto redazionale utilizzato per mistificare un intervento politico del messia a favore delle “idee” di Lazzaro non del suo “corpo”).
La dottrina della resurrezione (2Mac 7,9) e quella degli angeli (Tb 5,4) si erano dunque affermate nel giudaismo solo in epoca relativamente recente. Fino a quel momento si pensava unicamente all'immortalità del popolo d'Israele o, al massimo, si poteva credere nella resurrezione finale dei soli giusti. Si escludeva sia la resurrezione di tutti gli uomini, sia che l'aldilà fosse qualcosa di molto diverso dalla vita terrena. E comunque per i sadducei era da escludere che nel Pentateuco vi fossero delle prove o delle evidenti testimonianze a favore della resurrezione finale o eterna dei morti, né, a parer loro, potevano bastare le documentazioni tratte dalla letteratura profetica (Dan 12,2s.; Is 26,19; 38,18; Ps 88,6; 115,17; 73,23s.; Gb 19,25).
Certo è che una domanda come quella che ora i sadducei stanno per fare al Cristo, presuppone, necessariamente, o che Gesù non abbia compiuto neppure uno dei tre straordinari miracoli di resurrezione attribuitigli dai vangeli, oppure che, pur avendoli compiuti, non vi sia stata prestata da parte dei sadducei alcuna attenzione. Ci riferiamo alla resurrezione della figlia di Giairo (Mc 5,35ss.), che è l'unica presente nel vangelo di Marco, a quella del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11ss.) e soprattutto a quella di Lazzaro (Gv 11), che, come ben sappiamo, sono state tutte inventate dai redattori dei vangeli. Nessuna delle tre viene qui citata e, in ogni caso, anche se lo fosse stata, non avrebbe reso storicamente più credibile la controversia in oggetto, che è tipicamente post-pasquale, conseguente probabilmente al fatto che una parte dei farisei era confluita nelle file del movimento cristiano.
v. 19) “Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello.
I sadducei si riferiscono al cosiddetto “matrimonio del levirato” (Dt 25,5s.). Il cognato, fratello ancora celibe d'un uomo morto senza lasciare discendenza maschile, aveva l'obbligo di sposare la propria cognata; i figli che nascevano venivano considerati del primo marito. Lo scopo era quello di tutelare la successione nel possesso della terra (Gen 38,9), ma già in epoca veterotestamentaria non si insisteva ormai più sulla sua stretta osservanza, soprattutto in considerazione di Lev 18,16 e 20,21, che vietava rapporti disonorevoli con una cognata.
Peraltro, con l'entrata in vigore della legge sulle “figlie ereditiere” (Nm 27,1-11), la proprietà poteva essere ereditata anche da una figlia, se mancava un erede maschio; quindi la legge del levirato valeva ancora solo nel caso in cui il fratello morto non avesse lasciato proprio alcuna discendenza. Il levirato finì poi per scomparire definitivamente, ed è probabile che al tempo di Gesù non si trattasse – quello presentatogli dai sadducei – che di un'eventualità meramente teorica, una sorta di caso-limite, secondo lo stile usato dai rabbini, forse ispirato alle storie di Tamar (Gen 38) e di Ruth (4), in cui la prima fu costretta ad andare dal più lontano dei parenti, mentre la seconda si vide obbligata ad ingannare il proprio suocero.
Piuttosto era in questione, nella domanda sadducea, il ruolo che la donna (sposa di sette mariti) avrebbe avuto nell'aldilà: un problema che avrebbe spinto all'assurdo le difficoltà di una fede nell'idea di resurrezione. Si può quindi ipotizzare che tale querelle i cristiani di tendenza petro-paolina possono averla affrontata in quel periodo di tempo che va dalla morte del Cristo fino agli inizi della guerra giudaica.
vv. 20-22) C'erano sette fratelli: il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza; allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna.
La legge del levirato viene usata dai redattori cristiani solo come pretesto per una questione di diversa natura, per la cui soluzione s'è voluto scomodare direttamente il Cristo, al fine di darle maggiore autorevolezza. Qui non ci si deve soffermare più di tanto sul fatto che i sadducei abbiano posto una questione, scegliendo un esempio così inverosimile (basti pensare al numero dei mariti!), senza avere alcuna intenzione di discuterla liberamente, come invece avrebbero fatto i filosofi ateniesi sull'Areopago.
E non ci interessa neppure rilevare che la risposta del Cristo alla domanda sadducea contenga elementi deducibili da una posizione farisaica divenuta cristiana. Ciò che un esegeta laico non dovrebbe sottovalutare è piuttosto il fatto che qui il partito conservatore difende una posizione ateistica contro una religiosa, sostenuta dal partito petro-paolino.
Un esegeta laico non può non riflettere sul fatto che qui l'ateismo sadduceo è associato a una posizione politica retriva, mentre la fede cristiana appare in una forma più progressiva. In tutta la pericope si assiste a una sorta di passaggio dalla società patriarcale basata sul primato della terra, a una società più democratica, basata sul primato dell'attività artigianale-commerciale.
In questo passaggio ciò che prima veniva negato: l'esistenza di un'anima personale e quindi la possibilità di un riscatto nell'aldilà, viene ora affermato con forza. Non dimentichiamo che il successo del cristianesimo petro-paolino non dipese dal lato politicamente conservatore che aveva, né dalle proprie idee mistiche e spiritualistiche, ma dal fatto che sul piano sociale mirava a democratizzare i rapporti tra i propri aderenti, almeno queste erano le intenzioni nella fase iniziale.
v. 23) Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Poiché in sette l'hanno avuta come moglie”.
Vi è qui un uso del tutto vuoto e formale del paradosso, nel senso che si pretende una risposta già inclusa nella medesima domanda. Sul piano grammaticale si parla di “interrogazione retorica”. I sadducei non si aspettano una risposta diversa da quelle dominanti (del loro gruppo politico o di altri), ma strettamente dipendente dalla domanda.
Ora, considerando l'intricata questione da essi posta, le soluzioni, presumibilmente, dal loro punto di vista, avrebbero potuto soltanto essere due: “Non lo so” (al che essi avrebbero ribattuto confermando il loro scettismo materialistico); oppure – come probabilmente avrebbe fatto un fariseo ortodosso – “Al primo marito”. Ma in questo secondo caso i sadducei avrebbero sollevato un mare di controdeduzioni: infatti, se è vero che nella resurrezione tutti e sette i mariti ritornano in vita, ognuno di loro avrà il diritto di continuare a vivere con la donna sposata. Dunque anche in questo caso la conclusione che i sadducei potevano trarre era la stessa: la resurrezione non può esistere, poiché, se esistesse, creerebbe più problemi di quanti ne risolverebbe.
Essi in sostanza volevano far capire che a volte sulla terra si creano situazioni così complicate che se soltanto potessero continuare a ripetersi nell'aldilà rischierebbero di diventare ancora più assurde. Era difficile dar loro torto. Quindi delle due l'una: o l'aldilà non esiste, oppure, se esiste, non fa per l'uomo, cioè non è all'altezza di risolvere i difficili problemi della vita. Era questo un bel modo per dimostrare che la giustizia o la verità non possono esistere da alcuna parte: per concedere un privilegio a quella donna (di sposarsi ad libitum coi propri parenti) si era creata una situazione moralmente molto difficile da gestire.
Dunque, poiché la vita in sé presenta aspetti così controversi che una semplice resurrezione dei morti (senza nient'altro) non potrebbe minimamente affrontare e risolvere, è meglio assumere un atteggiamento disincantato e privo di illusioni, evitando di porsi domande che non possono trovare risposte adeguate. Se lo stato post-mortem è identico a quello terreno non solo non vale la pena crederci, ma vi diventa addirittura impossibile, in forza delle enormità che si potrebbero creare; e se non è identico, è inutile e anzi fuorviante pronunciarvisi.
v. 24) Rispose loro Gesù: “Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio?
Nell'Antico Testamento vi sono alcuni racconti di resurrezione in cui i principali protagonisti sono i due profeti Elia ed Eliseo (1Re 17,17-24; 2Re 4,18-37; 13,20ss.). Le strutture di questi racconti ritornano in Is 24 ed Ez 37 e fondano la teologia del Dio vivificatore (1Sam 2,6; Dt 32,39). Oltre ad essi, esiste il cosiddetto “linguaggio apocalittico”, che parla della partecipazione del Figlio dell'uomo alla gloria dell'Antico di giorni (Dan 7,13s.) e dei saggi risorti allo splendore trasfigurante della luce (Dan 12,1-3; cfr anche Is 25,7s.; Ab 1,12 e Ps 55,24).
Ovviamente i racconti di resurrezione relativi ai due suddetti profeti non venivano considerati, dalla teologia cristiana, dei validi antecedenti di quella di Gesù, in quanto i risorti del Vecchio Testamento tornarono a morire. Non è mai esistita una prova inconfutabile che una qualche resurrezione (intesa come nel Nuovo Testamento) possa realmente accadere e che sia segno visibile di una vita ultraterrena. Chiunque avrebbe sempre potuto pensare a delle tecniche terapiche di rianimazione, escludendo qualsiasi carattere sovrannaturale del fenomeno (le stesse compiute da Gesù, se veramente fossero state compiute, avrebbero potuto essere interpretate in tale maniera). Al massimo gli ebrei credevano in una resurrezione finale dei giusti, che ripetesse il modus vivendi paradisiaco descritto nella Genesi. Se vogliamo, è solo nei racconti apocalittici che si presume per la prima una sorta di trasfigurazione dell'esistenza umana.
Qui però i redattori, forti dell'esperienza della tomba vuota e della scomparsa misteriosa del cadavere di Gesù, rimproverano lo stesso i sadducei di non conoscere abbastanza le Scritture e quindi di non aver sufficiente fiducia nella potenza di Dio. Non vengono definiti “ipocriti” (come spesso si fa coi farisei) ma “ignoranti”, nel senso di un'ignoranza morale e intellettuale. È un'ignoranza incredula. Dalla loro stessa domanda, posta con malcelata ironia, lo si può capire. Gesù risponde con serietà a una questione che per i cristiani influenzati dalle tesi petro-paoline era di cruciale importanza.
Gesù non li critica per essersi lasciati determinare dal “relativismo dei valori” (che qui la Chiesa, con fare apologetico, farebbe volentieri dipendere proprio dalla sfiducia nell'idea di resurrezione), ma piuttosto per non aver capito che la legge del levirato ha solo un senso storico contingente e che quindi non può avere alcuna sostanziale relazione con la situazione che si verificherà nell'aldilà. Così facendo, viene posto in discussione il loro metodo interpretativo delle Scritture, che da letterale deve diventare allegorico, per essere cristianamente efficace. Di qui l'assoluta libertà che la Chiesa cristiana s'è sempre presa di interpretare l'Antico Testamento in funzione dell'evento-Cristo.
Paradossalmente, se ci si dovesse basare sulla “considerazione storica”, si dovrebbe addirittura sostenere che l'ateismo del Cristo era molto più vicino a quello sadduceo di quanto non sembri, non solo perché tutte le contestazioni ideologiche rivolte al Cristo, nei vangeli, provengono da ambienti farisaici, ma anche perché l'odio che i sadducei nutrivano per Gesù era prevalentemente politico, sin dal momento in cui egli aveva cacciato i mercanti dal Tempio.
v. 25) Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli.
Nella concezione sadducea del matrimonio (che poi rispecchiava la mentalità dominante dell'ebraismo di allora) esisteva solo l'idea di “generazione” e di “posterità”. Per l'ebreo la felicità coniugale e familiare era sinonimo di benedizione divina. Del matrimonio (che, in un certo senso, era obbligatorio e a cui Gesù poté sottrarsi solo col voto di nazireato) non si sottolineavano tanto gli aspetti relazionali e psicologico-esistenziali, quanto piuttosto quelli legali, di etica pubblica ed economici. Si credeva che nell'aldilà, nel migliore dei casi, vi fosse soltanto un accrescimento quantitativo di gioie terrene, una sovrabbondanza di quanto già si possedeva sulla terra (cosa poi ereditata dalla cultura araba, ma concedendo spazio all'eudemonismo gaudente).
La questione dell'amore coniugale e del completamento personale degli sposi restava un aspetto molto secondario rispetto agli interessi generali del popolo e della nazione. Chiedendo infatti “di chi sarà moglie”, i sadducei ponevano a Gesù una questione di natura eminentemente giuridica, strettamente vincolata a una concezione del matrimonio come strumento di procreazione e di bene sociale.
Gli ebrei – in questo caso i sadducei – non riuscivano a considerare la persona in maniera indipendente dal ruolo che sul piano sociale, professionale aveva o dalla funzione che doveva svolgere. Qui, nell'esempio ch'essi hanno scelto, è lo “statuto matrimoniale” che conta, non tanto l'identità di sé. Non è quindi da escludere che sotto la questione religiosa della resurrezione ve ne fosse una di tipo socio-esistenziale, relativa a un diverso modo (cristiano) di concepire il ruolo della donna e del matrimonio, più autonomo di quello vissuto nel mondo ebraico.
Gesù (o meglio il redattore cristiano) è costretto a ribaltare la problematica. Le necessità della terra non sono affatto quelle dei cieli. Se i sadducei conoscessero veramente la potenza di Dio (non semplicemente attraverso la lettura delle Scritture, ma attraverso l'esperienza proposta dal cristianesimo), capirebbero che nella resurrezione vi sarà una “nuova creazione”: non più quindi rapporti sessuali e coniugali, ma vita angelicata, asessuata, più spirituale, o comunque non esattamente identica a quella della natura innocente descritta nella Genesi. “Non ci sarà più né uomo né donna”, dirà Paolo ai Galati (3,28), escludendo quindi qualunque forma di riproduzione sessuale.
Certo, il paragone fatto in questa pericope difficilmente avrebbe potuto essere accettato dai sadducei, i quali non credevano non solo alla resurrezione ma neppure agli angeli e agli spiriti. Tuttavia qui non sembra si abbia intenzione di indurli a credere necessariamente in questo, quanto (visto che avevano posto una domanda circa la resurrezione) a immaginarsi una situazione post-mortem molto diversa da quella terrena.
Peraltro gli angeli erano presenti anche nel Pentateuco (Gen 16,7; 19,1; Es 12,23; 23,20; Dt 32,8). Per quale motivo, visto che ci si appellava a un'interpretazione letterale di questi testi, non considerare come effettivamente “reali” (e non puramente simboliche) queste misteriose presenze poste al servizio di Dio? (cfr anche Gb 1,6; 5,1; 33,23; Tb 5,4; 12,15; Dn 10,13; Ez 40,3).
Non solo, ma se si fosse interpretata in maniera “figurata” la stessa legge del levirato, ci si sarebbe accorti che proprio essa attesta, seppure in maniera indiretta, l'esigenza spirituale di una “vita eterna”, ovvero il desiderio della continua propagazione di sé attraverso lo sviluppo delle generazioni. Ma è dubbio che una mentalità razionalistica come quella sadducea avrebbe potuto prendere in considerazione un aspetto psicologico del genere.
Qui la posizione cristiana vuol sostenere che nell'aldilà non vi saranno rapporti sessuali e coniugali dettati da esigenze fisiche, materiali, riproduttive, in quanto l'esigenza del “benessere personale” verrà soddisfatta in modo “spirituale”, pur avendo gli esseri umani una “somaticità” sconosciuta agli angeli, che non li rende affatto inferiori a quest'ultimi. Paolo addirittura scriverà ai Corinti, nella sua fissazione maniacale sul valore assoluto della resurrezione finale, che gli uomini avrebbero “giudicato gli angeli” (1 Cor 6,3).
Verginità e matrimonio sono dunque destinate a trasformarsi da forme dello stato civile, condizioni esteriori dell'esistenza, ad aspetti ontologici interiori, che indicano, contemporaneamente, la realtà dell'io e l'esigenza di un rapporto col “tu”.
Si noti come a tali considerazioni esistenziali il cristianesimo petro-paolino giunse nonostante il tradimento politico del messaggio originario del Cristo, a testimonianza che ormai i tempi erano maturi all'interno dello stesso ebraismo. Già il Battista aveva rappresentato una chiara tendenza verso la moralizzazione della vita politica, l'esigenza di fare della liberazione nazionale anzitutto l'esito di una decisione personale, che doveva estrinsecarsi in una sorta di pubblica autocritica.
v. 26) A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe?
Al v. 25 Gesù, dicendo: “si vivrà come gli angeli”, aveva dato la risposta al problema di come bisogna immaginarsi la resurrezione dei singoli; un problema ch'era, in verità, più dei farisei, come farà capire Paolo quando litigherà violentemente coi sadducei (At 23,6ss.).
Ora invece egli dà la risposta al problema sadduceo se vi sia o no una resurrezione, e la risposta è: “dalle Scritture lo si viene a sapere, ma a condizione di saperle leggere”. Proprio prendendo un esempio tratto dal Pentateuco, quello del “roveto ardente” (Es 3,1ss.), Gesù dimostra che con una corretta esegesi è possibile individuare anche qui un riferimento, seppure implicito, alla vita eterna.
Nell'episodio in questione il Dio d'Israele confessa a Mosè d'essere il “Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, e Mosè, che sa della morte di quei patriarchi, crede con fiducia nella potenza di Jahvé, crede ch'egli sia “il Dio dei viventi”. Non soltanto quindi il Dio di un popolo o di una nazione che durerà nel tempo, ma anche dei singoli uomini che hanno vissuto per Lui.
Come i morti potessero ancora essere presenti agli occhi di Dio era per gli ebrei inspiegabile, in quanto indimostrabile che gli uomini fossero immortali o che una volta morti ritornassero in vita da qualche parte. Se anche per virtù di qualche speciale taumaturgo si poteva ipotizzare l'idea di un “ridestamento da morte”, non per questo si sfuggiva al destino che accomuna l'intera umanità. Secondo la credenza ebraica l'immortalità non appartiene al singolo, ma al popolo nella sua interezza. Al massimo si poteva pensare alla resurrezione dei soli “giusti” (profeti, legislatori, re e sacerdoti), quali rappresentanti del popolo (Gen 17,7), nella misura in cui il popolo li avesse ricordati nella memoria. Il popolo, in senso stretto, non ha bisogno di risorgere, in quanto non muore mai: il singolo è soltanto un'astrazione.
Quando l'apocalittica giudaica arrivò a ipotizzare la resurrezione dei singoli, la fisionomia del popolo d'Israele era già visibilmente in decadenza. Al tempo di Gesù le tribù rimaste erano due o al massimo tre.
È certo tuttavia che nella domanda posta dai sadducei la concezione di una resurrezione finale degli uomini e delle donne, singolarmente presi, appare già acquisita negli strati popolari della nazione. Gesù non la contraddice; semplicemente dicendo: “dei vivi”, esclude la validità della memoria quale unica giustificazione della resurrezione, altrimenti avrebbe dovuto dar ragione ai sadducei. I “vivi” qui non sono solo i “giusti”, ma il complesso dell'umanità. E questa non è una verità cui si può credere sulla base della percezione sensoriale della realtà: se si presume da un atteggiamento di fede, l'evidenza delle cose resta indimostrata.
Un processo analogo, d'altra parte, era già avvenuto nel mondo greco-romano, dove lo sfaldamento delle grandi famiglie patriarcali, in cui solo il capo poteva rivendicare il possesso di un'anima, portò, come forma di contestazione, a credere che ogni singolo componente della famiglia ne avesse una propria.
Da notare che se all'interno dell'ebraismo non fosse già stata presente questa sensibilità per i destini umani ultraterreni, che sempre si accentua nei momenti di crisi sociale e istituzionale, Pietro non avrebbe potuto tradire il messaggio di Cristo usando proprio il tema della resurrezione, che non risultava certo dominante nei dibattiti culturali di allora (la questione del rispetto del sabato era, p.es., molto più sentita); anche se nel vangelo di Giovanni non mancano episodi in cui il Cristo discute animatamente coi Giudei sul rapporto uomo-dio, ma in questo caso le conclusioni sono molto diverse da quelle petro-paoline, essendo tutte a favore dell'ateismo, contro la superstizione popolare. Di fronte a una problematica come quella qui sollevata, nel vangelo di Giovanni Gesù avrebbe risposto con un sorrisetto.
v. 27) Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore”.
Se i sadducei sono la dimostrazione lampante che una concezione laica della vita non è garanzia sufficiente di democraticità in politica, i cristiani, dal canto loro, sono soltanto capaci di spostare nell'aldilà la soluzione democratica delle contraddizioni sociali che riscontrano nell'aldiqua.
Se i sadducei sono la dimostrazione evidente che un'interpretazione letterale delle Scritture non favorisce lo sviluppo della cultura né garantisce una loro corretta interpretazione, i cristiani, dal canto loro, hanno dato alle Scritture un'interpretazione spiritualistica che sul piano politico risulta di molto inferiore a quella giudaica, anche se umanamente le è superiore, in quanto meno legata alle questioni economiche e giuridiche.
Nella posizione cristiana qui espressa s'intravede un'anticipazione di quella che sarà la concezione personalistica dell'essere umano. Solo che quando questa concezione verrà strumentalizzata per esigenze di potere politico, come farà la Chiesa romana a partire da Costantino, il fariseismo di detta confessione diverrà molto più complesso da smascherare.
Il cristianesimo costituì una rivoluzione culturale non perché ruppe i rapporti con l'ebraismo, ma perché, volendo continuare il messaggio di Cristo, dopo averlo tradito politicamente, non gli restava che riversare sul terreno culturale la portata innovativa di quel messaggio.
La storia, nonostante i tradimenti decisivi nei confronti delle idee di libertà e di giustizia sociale, è comunque andata avanti, favorendo l'approfondimento della coscienza personale.
II
Perché i cristiani parlano di “resurrezione dei corpi”, che dovrà avvenire il giorno del cosiddetto “giudizio universale”? Non bastava sostenere l'idea dell'immortalità dell'anima e della vita eterna? Questo famoso “giudizio” perché deve per forza riguardare un'anima con un corpo? Dante, nel suo Inferno, condanna le anime dannate prima ancora del “giudizio”, dicendo che, alla fine dei tempi, quando riceveranno il corpo, soffriranno ancora di più.
L'idea di “resurrezione corporea” (a parte i suoi riferimenti a taluni culti pagani) bisogna farla risalire alle lettere paoline, dove si sostiene, a più riprese che, siccome Gesù è “morto e risorto” (da notare ch’egli non parla mai di “misteriosa scomparsa di un cadavere”), dovranno per forza “risorgere” anche tutti i morti della terra e che se questa idea di “resurrezione dei corpi” fosse falsa, allora neppure Cristo sarebbe risorto, sicché del tutto vana sarebbe la fede del cristiano, proprio perché la morte (simbolo della schiavitù del peccato), entrata nel mondo per colpa di Adamo, è stata costretta a uscirne per grazia di Cristo (definitivamente lo sarà alla fine dei tempi, quand’egli ritornerà per il giudizio universale). Gli esseri umani sono stati creati da Dio in anima e corpo e tali devono rimanere.
Paolo cioè non riteneva possibile che il corpo potesse restare eternamente separato dall'anima. Per lui solo la resurrezione del corpo di Cristo attestava che questi fosse “figlio di Dio” (in via esclusiva). Se non fosse risorto, non si poteva avere una certezza assoluta della sua speciale figliolanza. Al massimo – vien da pensare – si poteva intendere l'espressione “figlio di Dio” in senso traslato, metaforico, come p.es. poteva esserlo in riferimento a un grande profeta come il Battista. Oppure ci si sarebbe dovuti accontentare di racconti di “riapparizione” di un Gesù la cui anima non poteva avere lo stesso corpo di un tempo, ma sarebbe stata evanescente, come una sorta di fantasma. Se il corpo non fosse scomparso dalla tomba, non si sarebbe potuto parlare di resurrezione e quindi, inevitabilmente, i racconti di riapparizione non sarebbero stati presi come qualcosa di “realistico”.
Invece quei racconti vengono scritti come se il lettore dovesse pensare a una loro assoluta veridicità. È quindi evidente che se non fosse stranamente scomparso, non si sarebbe potuto dire ch'era risorto, se non in senso metaforico, ma in tal caso i racconti di resurrezione sarebbero apparsi come qualcosa di “poetico”.
La mistificazione del cristianesimo sta appunto in questo, che, pur non avendo alcuna prova certa della “resurrezione del corpo di Gesù”, in quanto al massimo si sarebbe dovuto parlare di “scomparsa misteriosa di un cadavere”, la si è data per scontata, la si è spacciata come assolutamente vera, facendo altresì credere che i racconti di riapparizione fossero realistici e non poetici.
La parola “resurrezione” è un'interpretazione mistica e quindi arbitraria della tomba vuota, non è certo una semplice constatazione di fatto, in quanto il corpo redivivo del Cristo nessuno l'ha mai visto. Le descrizioni che ne vengono fatte potevano convincere solo un lettore che avesse già la fede, pertanto vanno considerate tautologiche, cioè ad uso interno. Di fatto l'idea di “resurrezione” ha sostituito quella di “insurrezione” (anti-romana e anti-sadducea).
E tuttavia qui ci si vuol chiedere: se il corpo fosse rimasto nella tomba, dopo la sua morte, si sarebbe potuto parlare di sola “immortalità dell'anima” (alla maniera greca), che è concetto abbastanza oscuro alla mentalità ebraica? Che prova se ne sarebbe avuta? Nessuna.
Non solo quindi non si sarebbe potuto parlare di “resurrezione finale dei corpi”, ma neppure di “immortalità immediata delle anime”. Cioè per parlare di “anima immortale”, si sarebbero dovuti elaborare dei racconti di riapparizione di Gesù che i cristiani, inevitabilmente, avrebbero considerato più poetici che realistici.
Questo spiega il motivo per cui l'idea di “resurrezione del corpo di Gesù” fu usata da Pietro e soprattutto da Paolo per distogliere il movimento nazareno dal proseguire l'attività politico-rivoluzionaria del Cristo. Cioè fu usata consapevolmente come idea principale per tradire il suo messaggio originario, con la differenza che mentre per Pietro il ritorno politico trionfale del Cristo sulla terra avrebbe dovuto essere più o meno immediato, in Paolo invece questa parusia, ad un certo punto, venne posticipata alla fine dei tempi. Nessuno dei due però ha mai messo in dubbio che il ritorno glorioso sarebbe avvenuto in un Cristo in carne ed ossa.
Questo corpo glorioso viene descritto da Paolo e nel quarto vangelo come capace di fare cose che agli umani, finché vivono sulla terra, non è assolutamente possibile: attraversare porte chiuse (Gv 20,19), assumere sembianze non immediatamente riconoscibili (Gv 20,14; 21,4), prevedere cose ignote agli uomini (Gv 21,6), sapere cose senza che nessuno l'avesse informato (Gv 20,26 ss.), trasmettere in qualunque momento i poteri dello Spirito Santo (Gv 20,22) e in genere poter apparire ovunque e senza preavviso (come p.es. sulla via di Damasco).
Il motivo per cui non fosse tornato subito in veste gloriosa, sconfiggendo gli occupanti romani e il clero collaborazionista, Paolo cercò di spiegarlo ai suoi discepoli col dire che il messaggio del Cristo doveva prima essere diffuso tra i pagani: il che doveva far capire agli ebrei che il loro “primato storico-politico” (in senso “teologico”) era irrimediabilmente finito e che, d'ora in avanti, la liberazione andava cercata insieme, ebrei e pagani, in forma esclusivamente “spirituale” (contro le “potenze dell'aria”), in quanto a quella “politica” avrebbe pensato personalmente il Cristo alla fine dei tempi.
La tesi della resurrezione doveva appunto servire anche a questo, a trasformare il Cristo da liberatore politico-nazionale a redentore morale-universale. I primi cristiani o, quanto meno, la corrente petro-paolina, divenuta maggioritaria, s'era fatta dell'idea di “corpo risorto” il pretesto per rinunciare definitivamente all'idea dell'insurrezione popolare contro Roma. Questo perché, probabilmente, si riteneva che il fallimento dell'iniziativa del Cristo fosse stato una grande tragedia, una grande occasione perduta, e anche perché si riteneva la potenza romana, una volta giustiziato il leader Gesù, troppo forte per essere abbattuta.
Non è neppure da escludere che i molteplici tentativi fatti dal Cristo di tenere unite le varie componenti della Palestina per opporsi ai Romani, avessero subìto un'improvvisa battuta d'arresto subito dopo la crocifissione. Cioè non è da escludere che soprattutto i Galilei e i Samaritani avessero ripreso a detestare i Giudei che nel momento cruciale, invece di liberare Gesù, avevano preferito Barabba: lo si può dedurre dal finale del vangelo marciano, ove viene detto che Gesù risorto avrebbe “preceduto” gli apostoli in Galilea (16,7).
Resta però da capire il motivo per cui Paolo non si limiti a parlare di “resurrezione del corpo di Gesù”, ma anche di resurrezione di tutti i corpi umani. Che bisogno aveva di farlo? Non sarebbe bastato parlare di “immortalità dell'anima umana”, assicurata proprio dalla resurrezione del Cristo? Evidentemente no. Per la mentalità ebraica non è pensabile che anima e corpo se ne stiano separati in eterno e neppure che non possa esistere una liberazione terrena.
Questo è forse l'aspetto più controverso della teologia paolina. Probabilmente, nella sua iniziale predicazione, Paolo, sulla scia di Pietro, attendeva una parusia imminente e, alla domanda che gli sarà stata posta circa la sorte di coloro che non avrebbero potuto beneficiare di tale parusia, essendo già morti, egli dovette inventarsi l'idea che i viventi, a lui contemporanei, non avrebbero avuto “alcun vantaggio” su quelli ch’erano già morti, in quanto questi sarebbero comunque “risorti nella carne”; sicché insieme, vivi e morti risorti, avrebbero regnato sulla terra (1Tess. 4,13 ss.).
Vi sono tuttavia delle difficoltà. Quali “vivi” e quali “morti risorti” avrebbero potuto regnare sulla terra? Se fossero stati solo i “cristiani”, che ne sarebbe stato di tutti gli altri? I “cristiani in anima e corpo” avrebbero regnato in Cristo sulla terra impedendo a tutti gli altri di ostacolarli?
Man mano che la parusia tardava, Paolo sarà costretto a trasferire questa idea di regno liberato e pacificato dalla terra al cielo e sarà anche costretto a dare a tutti i non-cristiani una seconda possibilità, in cielo, di credere nel Cristo. Nella misura in cui portava il suo messaggio a una sempre più marcata astrazione spiritualistica, si rendeva conto che sarebbe stato meglio per lui uscire di scena nei panni del martire.
Addendum
Per quale motivo l'apostolo Pietro non ha usato la sindone per avvalorare la sua idea di resurrezione, visto che essa, volendo, poteva prestarsi benissimo a una mistificazione del genere? Non è stata usata proprio perché essa non si prestava affatto a inserire elementi mistici nella predicazione umana e politica del Cristo. Occorreva qualcosa di derivazione pagana, come appunto l'idea di resurrezione, che Pietro doveva aver preso dagli ambienti ellenistici della Galilea.
La sindone, al massimo, poteva far pensare a un corpo stranamente o misteriosamente scomparso, non a una resurrezione vera e propria, voluta certamente da Dio. Il misticismo qui, probabilmente di origine orfica, sta proprio nell'idea di resurrezione, che prescinde da qualunque prova testimoniale, da qualunque fonte documentale.
Nella resurrezione bisogna credere per fede; e se vi è resurrezione, deve per forza esserci una parusia trionfale del risorto, altrimenti nessuna resurrezione ha senso. Ebbene, quando la parusia avverrà, il risorto saprà distinguere chi avrà avuto “fede” in lui, da chi non l'avrà avuta.
Nell'interpretazione petrina della resurrezione non è neppure importante che si parli di “apparizioni” ai credenti del Cristo risorto. Si dà infatti per scontato che il suo ritorno sia imminente: apparirà solo una volta e quella sarà decisiva per tutti.
Il cristianesimo paolino non può subentrare che in una fase successiva, quella appunto in cui, presa coscienza che la trionfale parusia imminente non è avvenuta, si decide di posticiparla alla fine dei tempi.
Tuttavia se si compie un'operazione del genere, so è costretti, in un certo senso, a ribaltare anche il cristianesimo petrino, depurandolo in maniera decisiva di tutti quegli aspetti provenienti dal giudaismo: di qui la rottura con Pietro ad Antiochia, poi ricomposta, quando Pietro avrà accettato tutte le tesi di Paolo. Il Cristo, per quest'ultimo, non è più un messia liberatore per gli ebrei, ma un redentore dell'umanità; il nemico da combattere non è Roma, ma il peccato originale, la morte, il demonio.
Gli aspetti mistici, sacramentali, teologici e quindi necessariamente paganeggianti del cristianesimo assumono un'importanza assolutamente prioritaria su tutto. Il cristianesimo, rinunciando definitivamente agli elementi giudaici della predicazione del Cristo (che non avevano nulla di religioso), pretende d'inverare gli aspetti migliori del paganesimo classico (che erano di natura orfica), restando quindi nell'ambito del misticismo.
Ecco perché il cristianesimo ha avvertito sia il giudaismo che il paganesimo come due correnti da estromettere dalla storia. Ecco perché oggi avverte il socialismo come il suo peggior nemico. Il socialismo infatti ha la pretesa d'inverare il cristianesimo, depurando di tutti i suoi aspetti mistici.
(torna su)Appendici
19) Ebraismo e cristianesimo sono due forme di ateismo?
Il massimo dell'ateismo possibile, restando nell'ambito della religione (e del monoteismo in particolare), è quello di equiparare un uomo a (un) dio.
È noto che sia l'ebraismo che il cristianesimo sono due forme di ateismo rispetto all'ingenuo politeismo pagano: l'uno rende Dio totalmente nascosto (o comunque percepibile solo in via del tutto eccezionale, in forme assai particolari, come accadeva ai patriarchi, a Mosè e ai profeti); l'altro lo rende sì visibile ma solo in Cristo, e tutti gli esseri umani devono passare attraverso di lui per avere un'esperienza della divinità. L'ateismo ebraico viene garantito, in un certo senso, dal monoteismo assoluto; nei cristiani invece viene garantito dal fatto che solo nel suo figlio unigenito Dio può rivelarsi.
Esiste quindi nel cristianesimo una sorta di materializzazione umanistica di Dio ovvero di autorappresentazione antropologizzata della divinità: non a caso i teologi parleranno subito di “Dio incarnato” (quale prototipo dell'umanità), dando così origine a una sorta di “bi-teismo”, che poi diventerà “tri-teismo”, quando s'introdurrà lo Spirito Santo nell'economia salvifica, quale terza persona della trinità (la femminile “sophia”, l'aspetto non istituzionalizzato della fede, in quanto “lo spirito soffia dove vuole”).
La divinità resta anche nel cristianesimo una realtà esterna all'uomo (seppure in forma meno assoluta), essendo l'uomo votato comunque al male, incapace di compiere il bene con le sole sue forze, a causa del peccato d'origine. Il fatto di voler accettare una presenza divina come forma estrinseca all'essere umano induce tutte le religioni, e quindi anche il cristianesimo, a non credere possibile una autenticità terrena. L'uomo deve semplicemente vivere di fede, confidando nella grazia divina che salva. La salvezza terrena è solo spirituale, poiché la morte, essendo inevitabile, rimanda all'aldilà la necessità di vivere secondo una piena libertà, materiale e spirituale. Nella propria mistificazione il cristianesimo considera la morte il principale effetto negativo del peccato d'origine, superiore alla stessa schiavitù sociale.
Una volta rotto con l'ebraismo, il cristianesimo petro-paolino rifiutò di abbracciare il politeismo pagano, in quanto lo riteneva una forma ingenua di superstizione, che arrivava ad attribuire caratteristiche divino-umane alla stessa persona dell'imperatore. Il cristianesimo affermò da subito che solo una persona poteva essere equiparata alla divinità, Gesù Cristo, il cui corpo, una volta sepolto, si diceva fosse “risorto”. Il massimo dell'ateismo possibile, in ambito cristiano, conservando il monoteismo ebraico, era quello di dire che esisteva un Dio-padre e un Dio-figlio (poi divenuto tri-teismo: una medesima natura in tre persone divine).
L'islam, che non possiede il concetto triadico perché ha rifiutato quello diadico, non ha fatto che semplificare al massimo l'ebraismo, rinunciando, di questo, ad alcuni fondamentali aspetti simbolici che mediavano il rapporto uomo/dio. Ha potuto farlo proprio perché in mezzo, storicamente, c'era il cristianesimo, che aveva già svolto l'opera di semplificazione dell'ebraismo, superandone il limite del nazionalismo etnico (l'universalismo ebraico, ereditato dall'islam, non è che un etnocentrismo allargato, in cui quasi non si distingue nello Stato la funzione civile da quella religiosa).
L'umanesimo laico, in tal senso, ha fatto un passo ulteriore, affermando che l'unico Dio esistente è lo stesso essere umano, artefice del proprio destino. Se vogliamo considerare Cristo un prototipo dell'uomo, dobbiamo anche affermare che il Nuovo Testamento è una mistificazione religiosa del suo messaggio laico e politico.
Oltre a ciò bisogna dire che nessuna religione è in grado di affermarsi in maniera universale, proprio in quanto è la religione in sé che implica una visione particolare dell'esistenza, soggetta a dogmi in cui bisogna credere per fede. Solo l'umanesimo laico, poggiando su valori umanamente riconosciuti, può aspirare a diventare una concezione universale dell'umanità.
(torna su)20) Sull'uso delle profezie nei vangeli
Tutti i riferimenti evangelici all'Antico Testamento sono falsi in quanto funzionali alla tesi della spoliticizzazione del Cristo. In particolare, essi sono stati elaborati dai cristiani di origine giudaica, ancora legati al concetto di “regno di Israele”, al fine di dimostrare che il messia liberatore era già venuto ma non era stato riconosciuto.
Quei riferimenti sono serviti per sostenere la tesi della “morte necessaria” del Cristo, cioè per trovare una qualche giustificazione al tradimento dei suoi seguaci nel momento culminante della rivoluzione.
È vero, anche Giovanni dice che il Cristo sulla croce “trionfò”, ma lo dice nel senso che sulla croce egli rimase coerente sino in fondo al suo ideale di democrazia. Non lo dice nel senso che morendo in croce il Cristo adempì alla “volontà del Padre” (questa interpretazione sarebbe, a dir poco, cinica).
Bisogna stare attenti con la religione, poiché essa usa concetti ambigui che possono significare cose del tutto opposte. Non che con questo si voglia affermare l'univocità dei concetti umani: ogni concetto di per sé è equivoco e può essere usato per scopi contraddittori. Anche i concetti religiosi, dietro la maschera della “spiritualità”, spesso giustificano cose assolutamente inaccettabili.
Facciamo qui un esempio. Dire che “il Cristo morì per le colpe degli uomini” non è cosa del tutto sbagliata se ci si riferisce alla scarsa determinazione politica dei nazareni al momento di compiere l'atto rivoluzionario a Gerusalemme durante la Pasqua. Ma se con quella frase s'intende dire che il Cristo morì per redimere l'umanità dal peccato originale, a causa del quale essa s'era allontanata da Dio, allora il discorso diventa del tutto metafisico.
Nell'ambito di un discorso del genere il massimo che si può accettare è la seguente tesi: l'obiettivo finale del Cristo era quello di far recuperare agli uomini un rapporto con se stessi e con la natura quale essi avevano vissuto prima della formazione delle società schiavistiche. Più di così non si può sostenere.
(torna su)21) Sul concetto di riproduzione sessuale
Quando Mc 12,25 dice che nel regno dei cieli non ci saranno né “moglie” né “marito”, perché si vivrà come “angeli”, sta dicendo una cosa sensata o molto strana? Nella Lettera ai Galati (3,28) Paolo, dicendo che “in Cristo” non c'è più né uomo né donna, si riferiva al presente, per indicare un'uguaglianza di tipo etico-religioso, non si riferiva necessariamente o esclusivamente al futuro ultraterreno.
Un ebreo non avrebbe mai fatto un'affermazione come quella riportata nel vangelo di Marco, tant'è che a Gesù, nel vangelo di Matteo (22,23 s.), posero una domanda ipotetica su chi sarebbe stato il marito di quella donna che, a causa delle continue vedovanze, ne aveva avuti sette. Qui Matteo non fa che ribadire la tesi religiosa di Marco: “Nella risurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo”.
Essendo il concetto di “riproduzione” insito nella natura umana, vien da chiedersi in che senso vadano intese parole del genere. Conoscendo la tendenza della religione ad associare sesso a colpa, parrebbe relativamente facile la risposta. Tuttavia, sotto questo aspetto l'ebraismo era assai meno morboso del cristianesimo, per cui ci si chiede da dove venga fuori una tale visione dell'aldilà.
È infatti difficile mettere in dubbio che là dove esiste un rapporto di coppia, è impossibile non prevedere una riproduzione sessuale, tant'è che, se la si vuole evitare, occorre ricorrere a strumenti artificiali. E non possiamo certo pensare che il cristianesimo primitivo ipotizzasse che nell'aldilà non fosse possibile alcun rapporto di coppia, alcun rapporto d'amore, se non quello, del tutto spirituale, nei confronti della divinità o di Gesù Cristo.
Indubbiamente è vero che l'uomo e la donna non si mettono insieme anzitutto per riprodursi, ma perché si amano, si sentono attratti reciprocamente, posto che il rapporto sia libero in entrambi. La riproduzione è solo una conseguenza: inevitabile, certo, se il rapporto è naturale, ma non prioritaria. La riproduzione è una conseguenza dell'amore reciproco: non va considerata un onere, né un dovere, ma un fatto naturale che dà gioia alla coppia, soprattutto se questa è libera di far crescere il figlio nel modo migliore o come desidera.
La riproduzione non può essere considerata come qualcosa di necessario solo perché esiste la morte. Se l'interpretazione dei passi di Marco e di Matteo deve basarsi sulla considerazione che nel regno dei cieli non può esserci sessualità (a fini riproduttivi) in quanto non esiste la morte, allora dobbiamo dire che siamo in presenza di una verità che di religioso ha molto poco. La religione cristiana non ha forse rinunciato al valore del materialismo in nome dello spiritualismo più puro? E allora perché negare la riproduzione facendo leva sul fatto che avremo un'esistenza individuale assolutamente eterna?
La riproduzione non dovrebbe mai essere concepita come una necessità, ma come il frutto della libertà. Ecco perché non si capisce perché nei vangeli venga detto che nell'aldilà non ci sarà né maschio né femmina. Si voleva forse dire che non esisterà l'amore? E che se anche esisterà, vi sarà comunque qualcosa che impedirà alla coppia di riprodursi? E questa sarebbe la spiritualità del cristianesimo?
Quanto meno sarebbe stato meglio dire che la riproduzione è indipendente dalla sessualità, cioè dal rapporto di coppia. Oppure che potranno esistere diverse “forme” di riproduzione. È assurdo pensare che uno spazio infinito come quello dell'universo possa essere popolato da un numero finito di esseri umani, quale sarà quello di noi su questo pianeta.
È vero, la sessualità noi umani, su questa Terra, la identifichiamo con la genitalità, ma, a partire da Freud, siamo stati indotti a considerarla come una forma di “passione” o di “pulsione”, che non necessariamente coincide con la genitalità. La pulsione dell'Es è una fonte di piacere in senso lato. Freud sbagliava a considerarla come del tutto priva di regole morali, di finalità etiche, di leggi sociali. La vedeva in maniera avalutativa (al di là del bene e del male), come qualcosa da controllarsi con l'Io e il Super-io, onde evitare che sfugga di mano e ci induca a compiere delle sciocchezze, in nome del proprio assoluto egoismo o egocentrismo.
Freud aveva intuito qualcosa di vero, e cioè che dentro ognuno di noi vi è una scintilla di luce che vuole ardere come un fuoco, ma aveva dato a questo istinto una lettura negativa, condizionata dalla filosofia irrazionale di Schopenhauer, oltre che dal fatto che con la prima guerra mondiale l'uomo europeo si era come autodistrutto.
Il fatto è però che gli esseri umani, nonostante quella spaventosa guerra, cui seguirà un'altra ancora più devastante, non smettono mai di desiderare di riprodursi. Vedendo così tanta distruzione, che porta con sé conseguenze deleterie per molto tempo, uno potrebbe pensare che, in un mondo del genere, sarebbe meglio riprodursi il meno possibile (un consiglio che già Paolo di Tarso nelle sue lettere dava). Eppure continuiamo a farlo, a volte senza neppure saperne con chiarezza le motivazioni: pensiamo di aggiungere un senso ulteriore alla nostra vita di coppia facendo dei figli. Cioè ci affidiamo al caso, dicendo che non li abbiamo cercati, ma anche che non li avremmo rifiutati se fossero venuti. Ci autoconvinciamo, forse non senza illusione, che i nostri figli saranno più saggi di noi, più razionali ed altruisti, per cui speriamo che il loro destino sia migliore del nostro.
Pensiamo queste cose senza essere capaci di fare qualcosa di concreto per rendere questo mondo davvero migliore, qui e adesso. Siamo terribilmente ingenui e fatalisti. Siamo convinti che la storia sia maestra di vita e che le lezioni del passato ci serviranno per non ripetere gli stessi errori. Privi come siamo di senso della realtà, preferiamo cullarci in una concezione magica del futuro.
Paradossalmente dovremmo avere una concezione della vita del tutto opposta a quella dei vangeli, e cioè dovremmo pensare alla riproduzione come a qualcosa che può realizzarsi con chiunque, in autonomia e in libertà, col consenso di chi vuole parteciparvi; qualcosa che, per funzionare, dovrebbe semplicemente sottostare a regole elementari, a limiti invalicabili, com'è naturale che sia, ma che in ogni caso non può non esistere, in quanto, se ciò fosse vero, sarebbe contrario a qualunque principio di umanità.
I figli fanno parte di una riproduzione il cui significato va ben oltre la sessualità. La riproduzione va intesa come un'espressione di creatività, per realizzare la quale la differenza di genere (maschile e femminile) è di capitale importanza, non è semplicemente un qualcosa di funzionale allo scopo, ma è all'origine di tutto. In principio non esiste l'uno solitario e indifferenziato, ma il due bipolare, i cui opposti si attraggono e si respingono.
(torna su)Conclusione
Se quanto dicono i vangeli sull'identità del Cristo corrisponde a verità, allora ci si potrebbe anche chiedere se gli ebrei non abbiano fatto bene a eliminare uno che pretendeva d'essere considerato alla stregua d'una divinità. La stessa pretesa già la contestavano agli imperatori romani, che proprio allora cominciavano a manifestarla. Perché mai avrebbero dovuto fare un'eccezione nei confronti di Gesù Cristo?
Una cosa infatti è averla come privato cittadino: uno può anche essere pazzo e non per questo essere politicamente pericoloso. Un'altra invece è pensare di poter organizzare un'insurrezione in nome di quella pretesa.
Certo, anche un privato cittadino può diventare, in nome del suo Dio o della propria pretesa “figliolanza divina”, una sorta di “giustiziere della notte” contro i peggiori criminali. I film americani sono pieni di figure del genere: esse non credono nella giustizia dello Stato e, pur non dichiarandosi delle divinità (perché dai tempi di Cristo, per fortuna, non son passati invano duemila anni di storia), di fatto si comportano come se lo fossero.
Tuttavia un soggetto di questo tipo resta infinitamente meno pericoloso di un leader politico che, propagandando la sua ideologia come l'unica verità esistente, riesce a convincere migliaia, decine di migliaia, se non milioni di persone, che possa essere facilmente realizzata. Quanti lutti e devastazioni ci saremmo risparmiati bloccando sul nascere, con le buone o con le cattive, personaggi come Hitler e Stalin?
Alcuni potranno obiettare che Cristo non voleva compiere alcuna insurrezione, né anti-romana né anti-giudaica, proprio perché non entrò a Gerusalemme in groppa a un cavallo ma a un asino, essendo un messia del tutto pacifico. Ma un'obiezione del genere non regge.
Se il Cristo non voleva liberare la Palestina dai Romani, qualcosa però di eversivo lo voleva fare, altrimenti avrebbe dovuto limitarsi a restare un privato cittadino. Se la sua rivoluzione era solo di tipo “religioso”, resta il fatto che – secondo gli evangelisti – pretendeva d'essere considerato una “divinità”. Sin dal primo vangelo, ove pur s'è teorizzato il “segreto messianico”, se ne parla in maniera molto esplicita. Mentre si trovava sotto le grinfie di Caifa, costui gli chiese: “Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?”. “Io lo sono! – rispose Gesù – E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. Tutti sentenziarono che era reo di morte (Mc 14,61 ss.).
Insomma il problema resta: è ridicolo pensare – come invece ci induce a fare lo stesso Marco – che i capi giudei l'abbiano ammazzato perché “invidiosi” (15,10) delle sue prerogative. Semmai, se proprio vogliamo spezzare una lancia a favore di Caifa, lo fecero perché temevano ch'egli potesse utilizzare le proprie capacità per distruggere tradizioni ebraiche consolidate (sulla cui liceità o legittimità Caifa non era disposto neppure a discutere). Ci riferiamo alle questioni, più volte dibattute nei vangeli, del Tempio, del sabato, dei cibi impuri, del tributo ai Romani ecc.
In fondo un messia poteva decidere d'entrare a Gerusalemme in groppa a un asino solo per ostentare un falso buonismo, per scelta tattica, non per convinzione etica. Chi potrebbe accusare l'ebreo di non aver accettato di credere nella sincerità di una persona che dichiarava d'essere “divina”?
Possiamo addirittura arrivare a dire – sempre per fare un favore al giudaismo istituzionale di quel tempo – che il Cristo meritava d'essere eliminato anche se, in nome della propria “divinità”, avesse voluto fare un'insurrezione anti-romana. Infatti, che senso avrebbe avuto liberarsi di un imperatore “figlio di Dio” per sostituirlo con un proprio messia divino?
Anche nel caso in cui questo messia, in forza della propria divinità, avesse compiuto straordinari prodigi, o addirittura avesse abbattuto l'impero, nulla in realtà avrebbe potuto assicurare ch'egli non si sarebbe mai servito dei propri poteri contro gli stessi ebrei.
Qui insomma bisogna rendersi conto che qualunque pretesa di considerare il singolo superiore al popolo, va guardata con sospetto, anche nel caso in cui questo singolo fosse davvero un Dio.
Ma ci sono altre due cose da considerare. Prima abbiamo detto che, poiché il Cristo pretendeva d'essere considerato una divinità, un ebreo avrebbe anche potuto pensare ch'egli volesse sostituire il proprio potere politico-religioso a quello dei sommi sacerdoti. 10
In tal caso Roma (impersonata da Pilato) l'avrebbe giustiziato soltanto per un tragico malinteso, cioè per non aver capito in tempo come servirsene per gli interessi dell'impero, essendosi lasciata condizionare, nell'interpretazione dell'evento Gesù, dalla lettura che ne davano i sommi sacerdoti. Cristo non sarebbe stato un “politico rivoluzionario” ma un semplice “riformatore religioso”, un novello Battista, benché nella Palestina d'allora si facesse poca differenza tra politica e religione.
D'altra parte, anche se non ci fosse stato questo condizionamento, non si può dar torto a Pilato: era nel suo diritto temere che la pretesa religiosa alla divinità potesse unirsi a una pretesa politica, che necessariamente si sarebbe posta in maniera alternativa a quella degli imperatori.
Ovviamente stiamo ragionando per assurdo, poiché da tempo l'esegesi laica sa bene che Pilato giustiziò il Cristo proprio in quanto pretendente al trono d'Israele in funzione antiromana (l'attesta il titulum della croce). E quella volta essere “contro Roma” voleva appunto dire essere avversi a ogni tendenza imperialistica. Pilato e i suoi successori sperimenteranno di persona cosa voleva dire essere ostili a ogni rappresentazione religiosa del potere politico contraria a quella ufficiale stabilita nel Sinedrio di Gerusalemme. Ma se avessero vinto i nazareni, cioè i seguaci del Cristo, i Romani avrebbero dovuto constatare un'avversione anche a qualunque nesso tra religione e politica: cosa che gli imperatori romani non accetteranno mai, tanto meno quando diventeranno cristiani. Per loro la religione andava considerata come uno strumento del potere politico.
Il secondo ragionamento da fare riguarda l'idea secondo cui il Cristo andò a Gerusalemme non per fare un'insurrezione contro Roma o contro il Tempio, bensì per farsi crocifiggere, dimostrando così che gli ebrei non avrebbero più potuto rivendicare alcun primato etico-religioso o storico-politico nei confronti dei pagani.
In sostanza la tesi (di derivazione paolina), sostenuta dai vangeli, è che gli ebrei non potevano non uccidere il Cristo, proprio perché non avrebbero mai potuto accettare che un uomo si facesse come Dio.
Questa versione ufficiale delle cose, oltre che irrazionale, in quanto fa dipendere la verità dal martirio, è profondamente antisemitica, in quanto condanna, senza riserve, un intero popolo, con tutta la sua cultura, a una maledizione eterna, dalla quale può sperare di liberarsi solo a condizione che smetta d'essere se stesso.
torna su1 Non dimentichiamo che tra gli ebrei si guarda anche la discendenza materna a motivo della purezza del sangue.
2 Negli ambienti ellenistici i miti partenogenici erano di regola accettati (Pitagora, Platone, Augusto, Perseo...), mentre in quelli ebraici erano decisamente rifiutati. Il giudaismo infatti non attendeva un messia nato da una “vergine”. Che i racconti natalizi siano posteriori alla predicazione paolina è documentato dal fatto che nel vangelo di Marco non si parla di annunciazione e nascita miracolosa del Cristo, anche se nella pericope del battesimo, del tutto inventata, i simboli religiosi sono numerosi. In Marco il Cristo diventa “figlio di Dio” solo al momento del battesimo, ma come se venisse “adottato” dal Dio-padre; in Matteo e Luca lo è invece a partire dal momento della nascita, per volontà dello stesso Dio-padre, espressa attraverso l'azione dello “Spirito”. Solo in Paolo e in Giovanni si parla di “eternità della divinità”.
3 Una per tutte: se un matrimonio è stato celebrato solo in civile, per la Chiesa romana è come se non fosse mai stato celebrato, per cui ci si può divorziare davanti allo Stato e passare per le seconde nozze al rito ecclesiastico, ovviamente non prima d'essersi pentiti del peccato d'aver contratto in precedenza il solo matrimonio civile.
4 Oggi l'irrazionalismo lo constatiamo, in ambito religioso, ogni volta che i credenti cercano a tutti i costi il martirio o si equiparano a Gesù Cristo.
5 I testi meno credibili vennero definiti “apocrifi”, lasciando così intendere che i “canonici” fossero attendibili in tutte le loro parti.
6 Il primo a parlare dell'esistenza di vangeli scritti è Papia di Ierapoli (morto verso il 140). Con Marcione (morto nel 160) nasce per la prima volta un canone del Nuovo Testamento, che poi spingerà la Chiesa a opporgli un proprio canone. Il suo comprendeva i seguenti libri: Luca, Romani, I-II Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, I-II Tessalonicesi e Filemone. In polemica con la setta marcionita e con gli ebioniti, Ireneo di Lione (morto nel 202) propone un proprio canone, accettando gli attuali 4 vangeli. Origene (morto nel 254) riconosce come autentici i 4 vangeli, gli Atti, 13 lettere di Paolo, I Pietro, I Giovanni e l'Apocalisse, e considerava controversi II Pietro, II Giovanni, Ebrei, Giacomo e Giuda. Il primo elenco completo dei 27 libri del Nuovo Testamento si deve ad Atanasio di Alessandria nel 367. Le definitive decisioni conciliari vennero prese a Ippona (393) e a Cartagine (397 e 419).
7 Se questa probabilità può risultare antistorica, in quanto la stesura definitiva del IV vangelo è avvenuta in un periodo in cui la catastrofe d'Israele poteva considerarsi definitiva, si può però pensare che in origine sia esistita una pericope scritta dall'apostolo, soggetta a successive e profonde modifiche.
8 Qui ovviamente si prescinde del tutto dalla questione se quelle guarigioni fossero alla portata di un essere umano o se dietro di esse si celassero situazioni di natura politica. Noi dobbiamo soltanto dare per scontato che con nessuna guarigione Gesù ha mai voluto dimostrare d'essere più che un uomo.
9 I vangeli addirittura accusano i Giudei di aver preteso una dimostrazione tangibile dell'origine divina del Cristo, come se non fosse patrimonio di certi pazzi ritenersi pari a una “divinità”!
10 Se ci pensiamo, in nome della divinità del Cristo, fu proprio il papato romano che, con l'idea di teocrazia, si sostituì all'ebraismo politico, usando in forme più evolute e a livello internazionale, gli stessi strumenti integralistici che quest'ultimo aveva usato a livello nazionale.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube