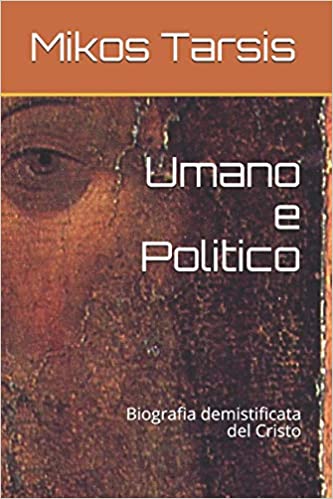
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
UMANO E POLITICO
Biografia demistificata del Cristo
Premessa - 1) Il prologo di Giovanni - 2) Il vangelo di Giovanni Battista - 3) L'opposizione contro il Tempio - 4) Critica dell'esegesi confessionale - 5) Gesù e Nicodemo - 6) La donna samaritana al pozzo di Giacobbe - 7) Esecuzione del Battista - 8) Inizio della predicazione di Gesù in Galilea - 9) Le tentazioni nel deserto - 10) Erode Antipa e Gesù - 11) Il mare della vita (Le folle al seguito di Gesù - Istituzione dei Dodici - I parenti di Gesù - Calunnie degli scribi - La madre e i fratelli di Gesù) - 12) Scienza e religione nella tempesta sedata - 13) La giornata di Cafarnao (Nella sinagoga - In casa di Pietro - Nel deserto) - 14) Matteo il pubblicano - 15) Le nozze di Cana - 16) I pani moltiplicati - 17) Discorso della Montagna - 18) Discorso sul Monte degli Ulivi - 19) Cristo e la legge mosaica - 20) Lazzaro di Betania - 21) L'unzione di Betania - 22) Il socialismo democratico del buon pastore - 23) Congiura contro Gesù - 24) L'ingresso messianico a Gerusalemme - 25) La morte come riscatto - 26) Misticismo e antisemitismo nel discorso sulla 'Luce del mondo' - 27) Antecedenti dell'ultima cena - 28) Lavanda dei piedi - 29) Il tradimento di Giuda - 30) Addendum (Si può parlare di estremismo politico nel tradimento di Giuda? - Il Giuda di Zullino) - 31) L'arresto di Gesù - 32) L'udienza da Anania - 33) Il rinnegamento di Pietro (A, B, C) - 34) Caifa, tra verità e falsità - 35) Il processo davanti a Pilato - 36) Barabba: ribelle o figura messianica? - 37) I vangeli e la passione di Gesù - 38) Crocifissione e morte del Cristo (La crocifissione - Il corteo al seguito di Gesù - L'iscrizione della croce - Il ruolo dei militari - La madre di Gesù - Il vino mirrato - Le frasi ingiuriose - Il colpo di lancia - L'ora della morte - Sepoltura di Gesù: ricostruzione ipotetica - La dichiarazione dei discepoli di Giovanni) - 39) Il significato della morte: riepilogo generale - 40) Appendici: In che senso il vangelo di Marco può essere definito 'vangelo di Pietro'? (Conversione dei primi apostoli - Guarigione della suocera di Pietro - Ritiro di Gesù nel deserto - I Dodici - La figlia di Giairo - Identità di Gesù - La trasfigurazione - Il giovane ricco - Il fico seccato - Le mura del Tempio - Sul Getsemani - La resurrezione) - 41) La nascita del monachesimo cristiano nei Discorsi di addio del IV vangelo - 42) I due dogmi su Maria
La parola "vangelo" – come noto – stava ad indicare, nel mondo greco-romano, la venuta di un grande personaggio o di un imperatore. Era l'annuncio di un'autorità politica. Non era una parola "rivoluzionaria", ma il cristianesimo più antico la fece diventare così, o almeno cercò di farlo.
La prese in prestito dal linguaggio conservatore della politica ufficiale dell'impero e la trasformò nel suo contrario. Il popolo non s'inventa solo delle parole nuove, ma è anche capace di dare un significato diverso alle parole vecchie, persino a quelle che in apparenza sembrano le meno indicate.
"Vangelo" era diventata una parola di speranza, soprattutto per gli ebrei della Palestina dei tempi del Battista e del Cristo. Una speranza di trasformazione sociale e politica.
Ma il fallimento del "vangelo" di Cristo portò ben presto i suoi seguaci alla disperazione, ovvero alla necessità di trasformare il vangelo politico dell'uomo-Gesù in un vangelo religioso del Cristo "figlio di dio". I cristiani, per attenuare le esigenze di una coscienza un tempo "rivoluzionaria", decisero di circoscrivere il valore del vangelo alla resurrezione (Paolo addirittura alla morte riparatrice dell'universale peccato originale, cioè alla morte intesa come riscatto "giudiziario" per placare l'ira di dio...).
Così facendo, i cristiani di allora (e ancora oggi nulla è cambiato) hanno dovuto celare i veri motivi di quella morte violenta, "uccidendo" il Cristo due volte.
Quando Gesù dice, in Mc 1,14-15, che "il tempo è compiuto", intendeva appunto riferirsi al suo tempo storico, concreto, contingente, e non al concetto metafisico di "tempo", quello per cui ogni "tempo" è buono, quello per cui si può sempre dire che il "regno" sia "vicino" (salvo poi smentirsi al momento della verifica).
Per i millenaristi di ieri e di oggi, il tempo per realizzare il regno è sempre presente – tanto non costa nulla! Essi non fanno distinzione fra condizioni obiettivamente favorevoli e sfavorevoli, fra situazioni di crisi o drammatiche e situazioni di relativa stabilità. Tutto può essere usato come occasione per condannare il "mondo perverso" e nulla vale veramente la pena d'essere utilizzato per "trasformarlo".
Così pure, quando Cristo diceva che "il regno (di dio) è vicino"1, intendeva riferirsi a un tempo immediatamente prossimo, a una liberazione politica e nazionale più o meno imminente. La cosiddetta "fine dei tempi" non coincideva certo, nella mente dei rivoluzionari ebrei di allora, con l’epilogo della storia, con l'apocatastasi dell'universo, con l'apocalisse dell'ultima ora.
Tutti questi concetti non sono che il frutto della disperazione e dell'estrema illusione: l'illusione che la liberazione debba essere non guadagnata con fatica ma attesa come un dono. Il cristianesimo post-pasquale, in questo senso, se ha distrutto il mito di un imperatore-dio, superiore ad ogni essere umano, ha alimentato il culto di nuovi duci e condottieri che in nome di "Cristo" promettevano liberazione agli oppressi.
Neppure il Precursore predicò mai concetti così astratti. Vi era senza dubbio del moralismo e del "socialismo legale" (cioè nell'ambito delle leggi vigenti) nella sua predicazione, ma l'istanza del rinnovamento era rivolta al presente, non al futuro, e le autorità che lo mandarono a morte o che non fecero nulla per impedirla, lo sapevano bene.
Persino i cristiani che pensarono alla parusia del Cristo appena scomparso dal sepolcro, la pensarono come imminente. Gli uomini infatti non si mobilitano per una liberazione che avverrà in un futuro incerto, troppo lontano per essere vero. Devono anzi essere sicuri che i loro sforzi, i loro sacrifici (che spesso sono enormi) porteranno a risultati tangibili, verificabili di persona. Padri e madri, se vogliamo, non lottano solo per garantire un sicuro avvenire ai propri figli, ma anche per se stessi.
Promettere a chi soffre umiliazioni e soprusi d'ogni genere che nell'aldilà sarà felice o che prima o poi il male finirà col perdere la partita col bene (eventualmente perché andrà al potere un altro "Costantino"), è come dirgli che fino al giorno della sua morte è meglio rassegnarsi che sperare. Non c'è molta differenza sul piano pratico.
Ecco perché il cristianesimo è diventata la religione degli sconfitti. È la religione di chi s'illude che il male non possa manifestarsi sino in fondo, in tutte le sue aberrazioni. È la religione di chi pensa che rinunciando all'idea della rivoluzione sarà meno doloroso sopportare l'egemonia delle classi oppressive.
Ecco perché oggi dobbiamo dire che la realizzazione del vangelo di Cristo implica necessariamente la fine del Cristianesimo.
(torna su)1) Il prologo di Giovanni
Gv 1,1-18
Se svolto con coerenza, persino uno dei testi evangelici più "mistici", il Prologo del vangelo di Giovanni, scritto in ambienti cristiani influenzati dallo gnosticismo, porta all'ateismo.
Infatti là dove esordisce dicendo che "in principio" non era "dio" ma il "Logos" o "Verbo" o "Parola", cioè l'esigenza primordiale dell'universo, della sua energia, della materia che lo compone, dell'intelligenza che lo caratterizza, l’esigenza di esprimersi, di manifestarsi, dando a tutte le cose un senso, proprio lì bisogna vedere un indizio di ateismo.
Se all'origine (ontologica) dell'universo vi è il "Logos" e la Terra altro non è che un piccolo puntino dell'universo, è assurdo per l'uomo pensare all'esistenza di un dio. Al massimo, in maniera traslata, si può ritenere che l'unico dio esistente sia lo stesso Verbo, di cui l'essere umano è parte.
Ma se è così, gli altri versetti, in cui si presenta dio come qualcuno di diverso dal Logos, sono stati aggiunti successivamente o sono comunque un'interpretazione clericale deformante.
Non ha senso infatti introdurre il concetto di "dio" in un contesto semantico in cui il suo ruolo è del tutto irrilevante, o comunque del tutto ininfluente rispetto a quello che ha avuto colui che viene fatto passare dal Prologo come "suo figlio unigenito".
Peraltro le migliori traduzioni del v. 3 non dicono affatto che "per mezzo del Verbo Dio ha fatto ogni cosa", ma semplicemente che "per mezzo di lui tutte le cose furono fatte", il che lascia supporre che autore delle cose fu lo stesso Logos, e non il "padre" attraverso la mediazione del "figlio". Proprio grazie a Cristo gli uomini hanno capito che qualunque riferimento a entità divine eterogenee, estranee alla natura umana, è per loro del tutto inutile.
Persino nel versetto iniziale: "il Logos era presso Dio", con la definizione "presso Dio" non si dovrebbe intendere un'entità diversa dal Logos, superiore a lui, che rende il Logos eterodiretto, ma semplicemente il suo lato umano. Nel Genesi s'era già capita la natura divino-umana del creatore, che passeggiava nell'Eden; ora finalmente si è in grado di attribuire tale natura al Cristo e, poiché nello stesso Prologo si afferma che "Dio nessuno l'ha mai visto", si dovrebbe arguire che l'unico dio esistente è lo stesso Cristo e l'uomo partecipa a questa divinità, essendo "a immagine e somiglianza" di chi l'ha creato.
Nel Prologo vi sono tracce evidenti della concezione eraclitea del Logos, che ha subìto però qui una sorta di personalizzazione antropomorfa. In fondo il cristianesimo non ha fatto altro che sintetizzare il miglior ebraismo escatologico con la migliore filosofia idealistica greca. In ciò sta la sua grandezza, ma anche – come noto – il suo limite, poiché esso si è servito dell'idealismo per negare la valenza politico-rivoluzionaria al profetismo ebraico.
E tuttavia Eraclito era meno viziato dall'intellettualismo dell'autore di questo inno. Egli infatti aveva capito che il Logos doveva essere concepito come "fuoco" e quindi non tanto in chiave religiosa. Il linguaggio più naturale, più completo, più espressivo, più profondo non era, per Eraclito, quello razionale ma quello interiore.
Questo per dire che se esiste un "dio" diverso dal "Logos", non è cosa che possa riguardare l'uomo. Qualunque discorso su "dio" è mera astrazione, è sicuramente fuorviante rispetto all'identità storica e naturale dell'essere umano.
Peraltro la stessa mistificazione clericale contiene un aspetto che fa finire tutte le speculazioni teologiche in un cul de sac, proprio perché in esse vi domina un'inevitabile tautologia. Infatti là dove è scritto che "in origine il Verbo era con dio e il Verbo era dio", si lascia chiaramente intendere che di questo dio non è possibile dire alcunché, per cui il fatto che il Verbo fosse "presso dio" o fosse egli stesso "dio" risulta essere, in ultima istanza, la stessa identica cosa.
Non è un'informazione in più dire che in principio non c'era l'uno ma il due, quando di uno dei due elementi non si è in grado di dire nulla. Se ci si fosse limitati a dire che tutte le cose sono state create dal Verbo, avremmo preso atto di questa affermazione, che resta comunque indimostrabile, e avremmo evitato di fare ulteriori speculazioni mistiche.
Inevitabilmente infatti il concetto di "dio" induce alla rassegnazione. Se il Prologo si fosse limitato a dire che il Logos s'incarnò per far capire all'uomo la sua identità originaria e che l'uomo però rifiutò questo messaggio continuando a vivere in maniera non-umana, noi avremmo concluso che la storia è tutta opera del genere umano e che non esiste affatto la possibilità di salvarsi limitandosi a credere in dio.
Non si diventa "figli di dio" con la fede, perché proprio questa fede allontana dall'esigenza di lottare contro la disumanità. La fede è rassegnazione, è speranza di una vita migliore solo nell'aldilà. Quanto più si parla di dio, tanto meno si parla dell'uomo.
Un Prologo storico-materialistico avrebbe dovuto limitarsi a dire che il Cristo propose un'esperienza di liberazione umana e politica che avrebbe potuto segnare una svolta decisiva per le sorti della Palestina, e forse per tutte le etnie e le nazionalità oppresse dell'impero romano, le quali, vedendo la resistenza ebraica, avrebbero potuto trovare più fiducia in loro stesse.
Purtroppo il tentativo fallì per il tradimento degli stessi seguaci del Cristo; ciò a testimonianza che il processo di liberazione, di emancipazione, di recupero dell'identità originaria resta un processo molto lento, faticoso, contraddittorio, con possibilità involutive molto pericolose.
Invece d’inventarsi improbabili connessioni metafisiche e relazioni ultraterrene, invece di dire, con fare spiritualistico, che il fine della missione di Cristo era quello di rivelarci l'esistenza di un dio che fino allora nessuno aveva mai visto né conosciuto, i redattori del Prologo avrebbero dovuto sostenere la necessità di proseguire quel tentativo di liberazione sociale, culturale e politica, rispettandone l'intenzione originaria, ch'era appunto quella di lottare contro gli antagonismi sociali, onde riportare l'uomo allo spirito collettivistico antecedente alla nascita delle civiltà schiavili.
Invece di dire che il Precursore riconobbe il Cristo come "Figlio di Dio", quando i fatti, in realtà, dimostrarono proprio il contrario, e cioè che il Battista, al momento di decidere la cacciata dei mercanti dal Tempio, non ebbe il coraggio di seguirlo, sarebbe stato meglio dire che il fine dell'esistenza è quello di realizzare una proprietà sociale dei mezzi produttivi, rispondendo ai bisogni del genere umano, nel rispetto integrale delle necessità riproduttive della natura.
*
Posto questo, si può qui aggiungere che il Prologo di Giovanni, essendo una sintesi spiritualistica di tutta la vita del Cristo, va considerato in realtà come un Epilogo e, a meno che non si voglia considerare il suo autore uno schizofrenico, esso è stato scritto da due tradizioni culturali molto diverse, di cui quella più arcaica inizia a partire dal v. 14.
Infatti mentre nella prima parte si è in presenza di una teologia di tipo ellenista (gnostico-dualista), nella seconda invece la teologia appare più politicizzata, alla maniera ebraica. Nella sintesi di ebraismo-ellenismo chi ci rimette è l'ebraismo.
La diversità d'impostazione filosofica e metodologica è rintracciabile nella descrizione stessa del "Verbo-Gesù", che, in chiave astratto-spiritualistica, viene definito, ponendo le basi della futura teologia trinitaria, uguale a "dio" ed esistente "presso dio", mentre in chiave storico-figurata si parla di "Verbo incarnato".
La sintesi a favore dell'ellenismo è stata resa necessaria sia dalla sconfitta del messianismo politico del Cristo nei confronti dell'oppressione romana che dal rifiuto della politica nazionalistica dei Giudei. Il vangelo manipolato di Giovanni, tuttavia, poiché vuole presentare la vicenda del Cristo come vincente su tutti i fronti, per dimostrare questa tesi non secondo l'ideologia ebraica ma secondo la nuova ideologia cristiana, ha bisogno di avvalersi dell'appoggio dello spiritualismo ellenico, che non a caso nel Prologo appare sin dai primi versetti.
La mistificazione più grande operata dal vangelo di Giovanni ai danni del vangelo di Gesù sta appunto nel fatto che qui vengano presentate le cose come se la vicenda del messia sia stata vincente anche dal punto di vista politico, benché non in conformità alle aspettative del mondo ebraico. Il Cristo giovanneo infatti è vincente in quanto "logos" non in quanto "messia".
Nessun altro vangelo esprime meglio questa sofisticata e insieme mistificata sintesi di ideologia pagana e ideologia ebraica. Questo a prescindere dal fatto che lo stesso Giovanni può essere stato a sua volta frainteso o addirittura manipolato dagli ambienti cristiani che hanno ereditato la sua versione dei fatti. Qui ha poca importanza sapere da chi il quarto vangelo sia stato scritto.
Ma vediamo ora in che modo l'esperienza del Cristo giovanneo risulta vincente anche sul piano politico. Quando alla fine del Prologo Giovanni afferma la superiorità di Gesù rispetto a Mosè (la grazia-verità superiore alla legge, v. 17), viene naturale aspettarsi di leggere qualcosa di molto grande dal punto di vista politico (p. es. una nuova liberazione dalla schiavitù, una ricostruzione ancora più grande del regno davidico, ecc.).
Niente di tutto questo. Con una semplicità disarmante Giovanni sostiene che la superiorità si è estrinsecata soprattutto nel fatto che Gesù ha "rivelato" la natura e la personalità di dio, rendendo così questa entità extraterrestre più accessibile agli umani (v. 18). Detto altrimenti: proprio nel momento in cui Giovanni avrebbe dovuto parlare esplicitamente di politica, ecco che il lettore si scontra con una deformazione riduzionistica di derivazione gnostica. Tutto il merito di Cristo starebbe in questa rivelazione teologica della natura di dio, che prima nessuno aveva mai visto (v. 18).
Naturalmente se la "pienezza" sta solo in questo, è facile per gli autori del quarto vangelo presentare un Cristo "vincente": egli avrebbe pienamente adempiuto il compito che il "padre" gli aveva affidato. Il fatto è però che gli uomini non hanno creduto in questa rivelazione e che hanno anzi preferito crocifiggere colui che a loro appariva come un impostore. Dove sta dunque la vittoria del Cristo? Siamo cioè assolutamente sicuri che la sconfitta di un tale impostore possa essere attribuita alla "dura cervice" degli ebrei?
Delle due l'una: o il Cristo non è stato quello che i vangeli ci dicono, e allora il suo messaggio politico andrebbe messo a confronto con quello degli ebrei; oppure, s'egli è stato quello che i vangeli ci dicono, bisogna in qualche modo rivalutare il ruolo dei Giudei. Sostenere infatti che la "grazia e la verità" sono superiori alla "legge" è troppo poco perché si possa dare soddisfazione a una istanza politica di liberazione.
Ammesso e non concesso che la posizione ebraica risulti "politicamente non corretta", a prescindere da quale sia stato l'effettivo "vangelo" del Cristo, dobbiamo forse per questo considerare "politicamente corrette" le argomentazioni di tipo gnostico profuse in questo Prologo?
Vediamole. Premesso che il "figlio unigenito" (vv. 14 e 18) altri non è che il "verbo divino" e che il "padre" ebraico equivale in sostanza al "dio" pagano, Giovanni si limita ad affermare che nel confronto drammatico col "mondo" (nell'accezione negativa usata in questo vangelo), di cui il verbo è "luce" (v. 9), il Cristo ne è uscito vincitore, poiché, pur avendo egli una natura divina che il mondo non ha voluto riconoscere, la crocifissione è stata da lui accettata consapevolmente e liberamente, sia per insegnare agli uomini la libertà di credere nella sua divinità, sia per insegnare l'obbedienza e l'umiltà nei confronti del "dio padre", che è di tutti gli uomini, avendo tutti la possibilità di diventare suoi "figli".
Il motivo per cui il dio-padre abbia scelto questo particolare destino per il proprio dio-figlio, non ci è dato sapere. Giovanni non arriverà mai a dire, avvertendo in questo un'eccessiva influenza anticotestamentaria, che il Cristo è morto per riconciliare col creatore una umanità totalmente incapace di bene dopo il peccato originale. Semmai è stato Paolo a sostenere che il dio offeso e tradito aveva bisogno di una sorta di sacrificio riparatore e, siccome nessun uomo avrebbe potuto farlo in maniera assolutamente innocente, lo pretese dallo stesso figlio, per il quale l'umanità era stata creata.
Nel vangelo di Giovanni invece si diventa "figli di dio" credendo nel valore umano di una morte accettata volontariamente, accettata per amore dell'uomo: c'è più "ateismo" qui che nella teologia paolina.
La mistificazione infatti, nel quarto vangelo, viene dopo, allorquando il redattore sostiene che se Cristo, con la sua divinità, non è risultato vincitore sul piano politico (secondo le categorie classiche del giudaismo), allora nessun altro uomo può pensare di sostituirlo, né si può pensare che sulla terra sia possibile realizzare un regno di giustizia e di libertà; si può diventare "figli di dio" solo se si crede che il Verbo, nonostante la sconfitta (che è stata solo apparente) continua a restare "presso dio", in quanto egli stesso è "dio".
In nome dell'amore la mistificazione raggiunge il suo apice: persino la figura del Battista, al quale si attribuisce la piena consapevolezza della divinità del Cristo, è del tutto alterata.
(torna su)2) Il vangelo di Giovanni Battista
Questioni irrisolte
La cosa più singolare dell'inizio del vangelo di Giovanni è che, da un lato, si parla di Giovanni Battista come del primo discepolo di Gesù, poiché viene fatto passare come il primo che lo ha riconosciuto come messia (Gv 1,26) e addirittura (ma qui si entra nella leggenda) come "Figlio di Dio" (Gv 1,34). Dall'altro invece, pur essendo stato l'apostolo Giovanni un discepolo diretto del Battista, non si fa alcun riferimento al battesimo di Gesù, di cui parlano con enfasi i Sinottici.
Non solo, ma il Battista non appare mai, in alcun vangelo, come un seguace del movimento nazareno. Anzi, in quelli di Matteo (11,3) e di Luca (7,19), egli fa sapere, mentre è incarcerato a causa del re Erode, che nutre dei dubbi sull’effettiva messianicità di Gesù.
Insomma, nei quattro vangeli canonici, nonostante che la storia del movimento nazareno abbia inizio col distacco dal movimento battista, il Precursore viene considerato come il principale consapevole anticipatore della venuta del Cristo.
Ipotesi interpretative
Si può ipotizzare che Giovanni Battista sia stato il "maestro di giustizia" di cui parlano i rotoli di Qumrân o comunque sia stato un importante leader della comunità monastica essena, nata nel 130 a.C. e distrutta dai romani nel 70 d.C.
È probabile che al tempo di Giovanni la comunità fosse arrivata a un bivio: o uscire allo scoperto, attenuando le rigidità del proprio stile di vita, ma auspicando un'esplicita lotta di liberazione contro la corruzione della casta sacerdotale del Tempio; oppure continuare a vivere al di fuori della società, in polemica coi sommi sacerdoti, ma rischiando l'estinzione proprio per l'incapacità di attecchire socialmente. Giovanni, col suo battesimo di penitenza lungo il fiume Giordano, scelse la prima strada.
I battisti costituiscono un'evoluzione verso una maggiore consapevolezza politica della missione contestativa (prevalentemente antiecclesiastica) che gli esseni s'erano promessi di realizzare.
Il movimento nazareno del Cristo nasce come "costola politico-rivoluzionaria" dell'essenismo del Battista. Forse l'epurazione del Tempio fu voluta e compiuta anche da molti battisti, insieme ai primi nazareni, oppure da quella parte di battisti che lasciò la guida di Giovanni e che divenne nazarena. L'epurazione però fallì perché il Battista, coi suoi seguaci, non volle parteciparvi, temendo conseguenze spiacevoli per le masse sul piano religioso: se l'avesse fatto, tutto l'essenismo probabilmente gli sarebbe andato dietro e avrebbe strettamente collaborato col messia Gesù. E così quella prima rivoluzione fallì per mancanza di determinazione da parte dei battisti (e per il mancato appoggio da parte dei farisei, salvo quello implicito di una piccola minoranza guidata da Nicodemo). Gesù, i fratelli Zebedeo e altri ancora furono costretti a espatriare in Galilea.
Quasi certamente dopo il fallimento politico del movimento nazareno (in occasione dell’ultima Pasqua del Cristo), vi fu tra i cristiani dell'ideologia petro-paolina e i battisti un riavvicinamento su basi ideologiche diverse: gli uni accettarono regole di vita monastica, riti di purificazione etico-religiosa, gli altri invece ammisero di riconoscere Gesù risorto come "figlio di dio".
Il Manifesto del Battista
Come noto, il Battista predicava l'ascesi morale, la giustizia sociale e l'attesa di un messia che liberasse Israele dall'oppressione romana (Gv 1,23). Probabilmente si era separato dalla comunità essena di Qumrân, che viveva in maniera monastica nel deserto, per poter iniziare un'attività più vicina alle masse: suo luogo privilegiato era il fiume Giordano, ove praticava un battesimo di conversione o di penitenza, ritenendo più che legittimo il desiderio di un'imminente venuta del messia liberatore.
Il manifesto etico-politico di Giovanni è ben descritto nel vangelo di Luca. In Lc 3,7-9 Giovanni contesta la posizione di chi riteneva di potersi sottrarre al peso delle contraddizioni di quel tempo, facendo leva su determinati privilegi, ereditati dalle generazioni passate ("Abbiamo Abramo per padre"): privilegi che, per Giovanni, altro non erano che false sicurezze, a livello ideale, morale e materiale.
Egli afferma che chi vuole affrontare con coraggio la crisi del suo tempo ("albero dai buoni frutti"), potrà svolgere un ruolo progressivo ("figli di Abramo"), anche se è di condizione umile o povera ("pietre"). Detto altrimenti: la liberazione del popolo ebraico sarà opera anche delle classi oppresse, emarginate, sfruttate dall'imperialismo romano; ciò ovviamente nell'ambito di una pura e semplice idea di messia restauratore dell'antico regno davidico.
In Lc 3,10-14 viene descritto il programma vero e proprio:
– giustizia economico-sociale: comunione dei beni nel mangiare e nel vestire (appello rivolto alle folle giudaiche);
– giustizia legale-impositiva: rispetto del diritto, giustizia etico-distributiva nella riscossione dei tributi (appello rivolto ai pubblicani, che operavano nell'interesse di Roma);
– giustizia esecutiva-militare: no agli abusi determinati dal possesso della forza (estorsione, violenza), no all'insubordinazione motivata da ragioni economiche (mercenarismo). L'appello era probabilmente rivolto alla guardia sacerdotale di Gerusalemme.
Come si può notare, manca in questo programma un progetto rivoluzionario vero e proprio. Si tratta di una sorta di "socialismo utopistico" ante litteram.
La popolarità del Battista
Che cosa aveva reso il Battista così popolare? Anzitutto il suo austero stile di vita. Marco dice che "si nutriva di cavallette e miele selvatico" ed "era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi", per il digiuno (1,6). Non dimentichiamo che, essendo figlio di un importante sacerdote sadduceo e di una donna discendente di Aronne, Giovanni avrebbe potuto tranquillamente aspirare a una brillante carriera ecclesiastica.
Oltre a ciò, Giovanni era stimato anche per la sua capacità di criticare il sistema dominante (religioso e filoromano), restando nell'ambito delle leggi vigenti.
Tuttavia, il motivo fondamentale che lo aveva reso così popolare era stato il fatto di essere riuscito a trasformare le rituali oblazioni purificatorie in un vero e proprio atto di conversione interiore. Egli infatti sperava che con un gesto simbolico o evocativo, la gente avrebbe potuto riflettere meglio su se stessa, cambiare vita e lottare più energicamente contro gli abusi del potere costituito.
Il battesimo di Giovanni aveva queste tre caratteristiche peculiari, che lo differenziavano da qualunque altro:
– si poneva come una purificazione morale interiore (e non solo rituale-formale);
– voleva essere un'iniziativa per intraprendere una missione riformatrice (quindi non si ripeteva);
– aveva un valore pre-politico, in quanto messo in relazione all'esigenza di una liberazione nazionale.
Il Battista era diventato così famoso da suscitare l'interesse anche dei farisei, che cercavano alleanze politiche per fronteggiare il principale partito avversario: quello sadduceo (Gv 1,24). Tuttavia egli rifiutò sempre le "etichette" che i farisei gli volevano applicare (Gv 1,25), anche per non essere costretto ad accettare di contestare il sistema solo alle loro condizioni. I farisei, infatti, volevano sì liberarsi dei Romani, ma per conservare vecchie tradizioni.
Il battesimo di Gesù
Stando a Lc 1,36 (ma solo qui se ne parla), Giovanni Battista e Gesù Cristo si conoscevano perché erano imparentati. Questo, di per sé, non può ovviamente significare che Gesù fosse un "seguace" del Battista. Il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano può anche essere stato inventato dai Sinottici (al pari dei quaranta giorni di digiuno nel deserto), per avvicinare cristiani e battisti in un comune impegno religioso (post-pasquale). Non a caso proprio mentre, in questo racconto, viene umanizzato il Cristo, facendolo inferiore al Battista, lo si esalta in maniera mistica, mostrandolo superiore a ogni uomo.
Sul piano storico, se anche ammettessimo che Giovanni sapeva che Gesù era un uomo intenzionato a impegnarsi attivamente in politica, proprio per questa ragione si dovrebbe escludere una particolare intesa tra i due. Del vangelo di Gesù, Giovanni rappresenta soltanto il momento "pre-politico" o, se vogliamo, il momento politico "pre-rivoluzionario".
La questione del battesimo di Gesù non è comunque di poco conto, poiché se esso fosse veramente avvenuto, sarebbe evidente la dipendenza del "vangelo" di Gesù da quello del Battista, almeno nella prima fase di costituzione del movimento gesuano o nazareno.
E tuttavia, proprio su questo aspetto il quarto vangelo sostiene il contrario, e cioè che l'ideologia politica del Battista non era così rivoluzionaria come quella del Cristo, in quanto su almeno due punti: il rispetto della legge mosaica e il valore religioso del Tempio, la differenza tra i due era netta. Il Battista, in sostanza, voleva una rivoluzione che salvaguardasse le due istituzioni fondamentali della civiltà ebraica.
Il vangelo di Giovanni inoltre precisa, nel racconto della cacciata dei mercanti, che Gesù "non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza sull'uomo" (2,25). Infatti, nella sua prima disputa coi farisei, a proposito della purificazione del Tempio (Gv 3,1 ss.), Gesù non si è mai servito della testimonianza, a suo favore, del Battista, che era sicuramente più autorevole della sua, in quel momento.
E, successivamente, in un'altra disputa coi farisei, egli, per dimostrare la verità del proprio vangelo, sostiene di non aver bisogno di alcuna testimonianza a suo favore: "Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove son venuto e dove vado" (Gv 8,14). Gesù insomma non si è mai servito di Giovanni come di un "trampolino di lancio". (Da notare peraltro che Luca parla del battesimo di Gesù solo "dopo" l'arresto del Battista, in 3,19 ss.). Al massimo egli si è servito del trattamento che il potere politico-religioso aveva riservato al Battista per un confronto con ciò che lo stesso potere stava già riservando a lui (cfr Mc 9,13; 11,30 ss.; Mt 11,18 ss.).
Battisti e Nazareni
Se accettiamo l'ipotesi che Gesù abbia frequentato il movimento battista, dobbiamo anche ammettere che la sua adesione durò molto poco, poiché i suoi primi due discepoli: Giovanni Zebedeo e Andrea, fratello di Simon Pietro, cominciarono a seguirlo subito dopo essersi staccati dal Battista (Gv 1,35 ss.).
In altre parole, se consideriamo vera la tesi secondo cui la prima comunità gesuana sia nata separandosi da quella battista, dobbiamo altresì considerare del tutto inverosimile che – come appare nel vangelo di Giovanni (1,35 ss.) – la rottura sia addirittura stata favorita dal Battista, il quale invitò Giovanni e Andrea a seguire Gesù. I discepoli del Battista, infatti, si consideravano rivali dei gesuani (specie quando anche costoro cominciarono a battezzare) e lo resteranno almeno sino alla morte del Cristo (cfr Lc 7,22 ss.; Mc 2,18 ss.).
È probabile quindi che non il Battista, bensì Andrea e Giovanni Zebedeo si siano accorti per primi che il messaggio di Gesù era politicamente più impegnativo di quello del Battista, poiché non limitava la lotta antiromana alla pura e semplice "metànoia". In questo senso si può tranquillamente affermare che Gesù non iniziò a predicare – come dicono i Sinottici – dopo l'arresto di Giovanni. Lo stesso quarto vangelo lo esclude, in almeno tre punti:
– il Battista dice chiaramente che Gesù "già" operava tra le folle giudaiche: "Tra di voi è presente uno che voi non conoscete" (Gv 1,26) – nel senso che non sanno o non vogliono "riconoscerlo" come messia;
– quando Andrea, Giovanni Zebedeo, Simon Pietro chiedono d'incontrarsi con Gesù, lo fanno con la speranza di trovare il "messia" (Gv 1,41);
– i discepoli di Gesù battezzavano e facevano più proseliti del Battista, prima ancora che questi fosse incarcerato da Erode (Gv 3,22-24; 4,1 s.).
Le debolezze del Battista
Il Battista si rendeva conto di non avere la forza sufficiente per poter svolgere il ruolo di "messia". Sentiva di non averne le capacità (Gv 1,20), anche se la folla che lo seguiva non avrebbe esitato a considerarlo come un "liberatore nazionale" (Lc 3,15).
Giovanni rifiutava esplicitamente non solo il titolo di "messia" (Gv 1,20), ma anche altri titoli ("Elia" e "il profeta") che la tradizione escatologica associava alla venuta del messia (Gv 1,21).
Da un lato egli declinava ogni offerta d'investitura politica; dall'altro però non voleva avvalorare mistiche credenze che gli apparivano decisamente superate. Giovanni voleva che l'impegno di modificare il presente fosse assunto responsabilmente da ogni individuo: "raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia" (Gv 1,23). Su questo non ci poteva essere contrasto tra lui e Gesù. [Da notare che Gv 1,29-34 è stato aggiunto in un secondo momento.]
Mt 11,11 ss. spiega bene (senza neanche rendersene conto) le debolezze del Battista, che diceva una cosa ma non aveva il coraggio di compierla: "Dai giorni di Giovanni Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono" (v. 12); "tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni" (v. 13).
In altre parole, la violenza diventa inevitabile quando il potere costituito non vuole accettare l'idea della democrazia. Giovanni esercitò la violenza su di sé, e in questo fu grande, poiché rifiutò consapevolmente la possibilità di una carriera politico-ecclesiastica. Tuttavia, "il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui" (v. 11).
Qui è sufficiente sostituire la parola "cieli" con la parola "terra" per capire che in origine i "minimi" o gli "ultimi" dovevano semplicemente essere gli oppressi che s'erano convinti ad usare la "forza" contro la violenza del potere costituito: ciò che appunto il Battista non era riuscito a comprendere.
Lo scontro sull'epurazione del Tempio
La dottrina del Battista era semplice e per molti convincente: prima di cambiare (politicamente) la società, dobbiamo cambiare (umanamente) gli individui. Una dottrina vera, ma parziale; infatti escludeva la contemporaneità del mutamento umano e politico.
Ecco perché Gesù e Giovanni si scontrarono sull'idea di "ripulire", con un gesto simbolico ma significativo, il Tempio di Gerusalemme dai mercanti e cambiavalute quotidiani. Gesù voleva far capire ch'era venuto il momento di attaccare direttamente le basi finanziarie del potere politico sacerdotale. Questa presa di posizione non venne condivisa da tutti i battisti, per la semplice ragione ch'essi non volevano fare politica che in maniera indiretta, a partire cioè da un discorso prevalentemente etico.
Probabilmente i seguaci di Giovanni che si unirono a Gesù: Andrea (che poi convincerà il fratello Pietro), Giovanni Zebedeo (e forse anche il fratello Giacomo), Filippo e Natanaele, rappresentano solo gli esponenti più significativi della rottura politica avvenuta all'interno del movimento battista.
In tal senso il racconto marciano della vocazione dei primi discepoli di Gesù (1,16 ss.), descrive una situazione successiva a quella dei primi capitoli del vangelo di Giovanni. Lo stesso Marco lo dice: "Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea a predicare il vangelo" (1,14). Questa "seconda chiamata" delle due coppie di fratelli: Andrea e Pietro, Giacomo e Giovanni, fu quella decisiva, dopo un breve momento d'incertezza a causa dell'arresto del Battista, benché nel IV vangelo (1,39-46) non sia Gesù che "chiama", ma il contrario: sono alcuni discepoli del Battista che chiedono di diventare suoi seguaci.
Indubbiamente i primi discepoli di Gesù pensavano ad un'azione più risoluta nei confronti delle autorità giudaiche, ritenute troppo remissive se non addirittura colluse col potere romano. Un'azione che il Battista non aveva avuto il coraggio d'intraprendere, perché forse temeva che senza un punto di riferimento oggettivo, istituzionale, per quanto corrotto fosse in taluni suoi rappresentanti, si sarebbe indotto il popolo a sbandarsi ulteriormente. Il Battista capiva la necessità di "epurare" il Tempio, ma gli apparivano troppo radicali i metodi che Gesù voleva adottare.
Tuttavia, dopo la prima semi-insurrezione del Cristo, che Giovanni colloca nel contesto della "prima Pasqua", contraddicendo apertamente i Sinottici, il Battista si decise a dare alla propria popolarità un risvolto più politico di quello che le poteva conferire la pratica del battesimo. Anche perché questa pratica si stava già scontrando con una certa concorrenza da parte di alcuni suoi ex-discepoli, passati dalla parte di Gesù (Gv 4,1 ss.).
L'inizio del declino del Battista
L'epurazione del Tempio costituì uno spartiacque non solo per il nuovo movimento gesuano, ma anche per quello battista, che, infatti, a partire da quel momento, nella persona del suo leader principale, Giovanni, iniziò a svolgere un attacco più diretto alle istituzioni di potere. Quanto, in questa decisione, egli fosse stato influenzato dalle defezioni di molti seguaci, passati nelle fila del movimento gesuano, è facile immaginarlo. Questi transfughi si misero a fare, seguendo Gesù, ciò che prima facevano insieme al Battista.
Il quarto evangelista afferma che Gesù non battezzava mai (4,2), ma permetteva ai suoi neo-adepti di farlo tranquillamente. Questo forse sta a significare che se da un lato Gesù non credeva in un particolare valore politico della prassi battesimale, dall'altro però la riteneva, in quel momento, una modalità ancora utile per avvicinare le masse. O forse la tollerava in quei discepoli che l'avevano praticata prima di seguirlo.
Fu appunto allora che "nacque – dice l'evangelista Giovanni – una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione" (3,25). Tale discussione non viene riportata, ma è evidente ch'essa si riferisce ai due diversi modi d'intendere l’epurazione: morale, quella dei battisti, attraverso la pratica battesimale; politica, quella dei gesuani, attraverso la cacciata dei mercanti. Dietro quell'anonimo "giudeo" si può facilmente scorgere qualche rappresentante del movimento gesuano, che cominciava ad avvertire la possibilità di affermare un'identità diversa, politicamente più incisiva, rispetto alla moderata opposizione dei farisei e alla relativa opposizione dei battisti.
Giovanni cercò di recuperare credibilità agli occhi del popolo, alzando il tiro delle sue critiche etico-politiche al sistema. Purtroppo, non essendo abituato alla lotta politica vera e propria, la sua tattica risultò subito perdente.
Non dobbiamo infatti dimenticare che il Battista scelse dapprima il deserto e successivamente il fiume Giordano come luogo privilegiato della sua missione: non era lui che andava in mezzo al popolo, ma era il popolo che andava da lui a confessare le proprie debolezze.
In sostanza, si può dire che il Battista se non fu per Gesù la soluzione pratico-politica per abbattere il potere istituzionale (ebraico-collaborazionista e romano), fu comunque la voce dell'intellighenzia più illuminata che urlava contro la corruzione dei potenti.
Giovanni scelse di morire appellandosi alla legge (contro il matrimonio illegittimo di Erode), cioè scelse un motivo etico-giuridico per opporsi al sistema. Non criticò mai Erode dal punto di vista politico, quale "collaborazionista" di Roma, oppure, se lo fece – ciò che nei vangeli non appare – è probabile ch'egli abbia sperato, in virtù del proprio carisma, in una metànoia anche da parte di Erode, il quale riteneva Giovanni – come dice, con enfasi, Mc 6,20 – un "uomo giusto e santo".
Il dubbio del Battista
Ai messi che il Battista incarcerato inviò a Gesù per sapere il motivo per cui il regno tardava a venire, Gesù rispose che la liberazione non avrebbe potuto essere il prodotto della sola volontà del messia ("Beato chiunque non si scandalizzerà di me" – Lc 7,23 –, cioè beato chi non si meraviglierà della volontà democratica del messia). Questo perché la liberazione politico-nazionale poteva essere solo il frutto di una volontà autenticamente popolare ("Ai poveri è annunciata la buona novella" – Lc 7,22 – e non ai potenti magnanimi e benevoli).
La liberazione – spiega qui Gesù – non è ancora avvenuta a causa dell'immaturità delle masse, che si sono lasciate fuorviare da "scribi e farisei" (Lc 7,50), e che invece di allearsi col Battista, hanno lasciato che di lui le autorità dicessero, vedendolo digiunare oltre lo stretto necessario, che aveva "un demonio" (Lc 7,33). Oggi quelle stesse masse, influenzate dai farisei, credono in un'altra diceria, quella secondo cui il Cristo, siccome frequenta "pubblicani e peccatori", è esattamente come uno di loro (Lc 7,34).
Il compromesso tra cristiani e battisti
Il fatto che nei vangeli canonici non esista alcun vero "dissenso" tra Gesù e Giovanni, va attribuito alla progressiva spiritualizzazione della figura di Gesù, che ha trasformato quest'ultimo in una sorta di "fratello maggiore" del Battista. Il cristianesimo post-pasquale (petro-paolino) ha recuperato la figura del Battista dopo aver tradito il vangelo di Cristo: quanto più forte è stato il tradimento, tanta maggiore è stata l'esigenza del recupero delle tradizioni esseniche di Giovanni.
Quando, con la svolta paolina, la divinizzazione del Cristo fu un fatto definitivamente acquisito, le due comunità, cristiana e battista, si riavvicinarono. La comunità cristiana, nata da una rottura in seno alla comunità nazarena, si servì di quella battista per spoliticizzare ulteriormente il vangelo di Gesù.
Potremmo naturalmente pensare che l'apologetica cristiana si sia indebitamente appropriata della tradizione profetica del Battista, senza tener conto della reale diversità di posizioni. Ma, poiché nei Sinottici non viene nascosta la differenza di atteggiamento da tenere nei confronti di argomenti come la purezza dei cibi e soprattutto il digiuno (Mc 2,18 ss.), preferiamo pensare che tra le due comunità, ad un certo punto, si sia venuti ad una sorta di compromesso, come d'altra parte appare negli stessi Atti degli apostoli, allorché Apollo di Alessandria, dopo aver predicato ad Efeso il battesimo di Giovanni, decise di diventare cristiano e, con lui, alcuni suoi seguaci (At 18,25 e 19,1 ss.). Negli Atti l'unica differenza che divide battisti e cristiani è la fede nella resurrezione di Gesù.
Il compromesso dovette basarsi sui seguenti presupposti: i cristiani, che già avevano rinunciato alla politica attiva, erano disposti a considerare il Battista il principale precursore del Cristo, a condizione che i battisti passassero definitivamente dalle tradizioni politico-progressiste del mondo ebraico a quelle spiritualiste del cristianesimo paolino. A quel punto fu facile per i battisti rinunciare all'idea che Giovanni fosse stato un semplice "precursore" dell'uomo Gesù: in cambio avevano ottenuto ch’egli venisse considerato come l'unico vero precursore del Cristo "Figlio di Dio".
All'espressione, più volte ripetuta nei Sinottici (Mt 3,11; Mc 1,7; Lc 3,16), del Battista: "Viene dopo di me uno più forte di me", il quarto vangelo aggiungerà le parole mistiche: "perché era prima di me" (1,30), motivando che la "forza" proveniva da una precedenza di ordine "divino" (ontoteologico, diremmo oggi). Col che il vangelo di Giovanni sembra risolvere radicalmente l'antinomia che caratterizzava la coscienza del Battista, in quanto da un lato gli si chiedeva di diventare "messia" e dall'altro egli non aveva il coraggio di diventarlo.
Sul piano più strettamente formale, la comunità cristiana primitiva si limitò a integrare il significato del battesimo di "acqua" con quello del battesimo di "spirito" (e "fuoco", aggiungono Luca 3,16 e Matteo 3,11). Lo stesso quarto evangelista (o il suo manipolatore) ha accettato questa interpretazione delle cose, benché proprio nel suo vangelo il Battista ad un certo punto dica che il "battesimo di acqua" è nulla a confronto di quanto Gesù avrebbe saputo fare (1,26 s.).
In coerenza con questa deviazione spiritualistica del rapporto politico tra Gesù e Giovanni, fu formulata, col tempo, la leggenda dell'insolita nascita del Precursore, che doveva fare da pendant al racconto, non meno mitologico, della nascita miracolosa del Cristo.
Benedictus e Magnificat
Più interessanti di queste leggende sono le differenze di contenuto politico-sociale fra il Benedictus di Zaccaria, che riflette molto probabilmente la sensibilità e le aspirazioni dell'ambiente battista, e il Magnificat di Maria, che riflette invece la sensibilità e le aspirazioni dell'ambiente cristiano post-pasquale.
La differenza principale sta nel fatto che mentre per il sacerdote Zaccaria il figlio Giovanni avrebbe dovuto limitarsi a dare "al popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati" (Lc 1,77); per la popolana Maria invece Gesù avrebbe dovuto fare molto di più, poiché dio, nel passato, aveva "rovesciato i potenti dai troni, innalzato gli umili, ricolmato di beni gli affamati, rimandato i ricchi a mani vuote" (Lc 1,52 s.).
A dire il vero nel Magnificat non è esplicitato che Gesù dovesse assolvere un compito di tipo "politico" (Maria si riferisce a "Dio"): ma la cosa può essere spiegata considerando che quando il Magnificat fu redatto, Gesù era già morto e la sua missione era fallita, poiché gli apostoli non avevano saputo proseguirla.
La differenza tuttavia resta, e la si nota anche laddove, in luogo di una semplice richiesta di "liberazione dai nemici" (Romani), fatta nel Benedictus (vv. 71 e 74), Maria chiede la liberazione dai nemici interni ed esterni, da tutti i potenti e tutti i ricchi, Romani ed ebrei collaborazionisti (Lc 1,51-54).
Il Benedictus è inferiore al Magnificat, proprio perché circoscrive il metodo della liberazione dai nemici alla mera "remissione dei peccati", senza peraltro specificare a quale classe sociale appartengano questi "peccatori".
D'altra parte anche il Magnificat contiene un messaggio rivoluzionario solo apparentemente: il desiderio emancipativo dei cristiani di origine umile è qui già consapevole del fallimento del messianismo politico di Gesù, per cui nel testo si è costretti a idealizzare la realizzazione di tale messianismo riproponendo, in maniera ancora più illusoria, il mitico regno d'Israele (Lc 1,54 s.).
In pratica il Magnificat si limita a far convergere il desiderio di una liberazione politica verso una prassi che assomiglia molto da vicino a quella prospettata dal Benedictus. Il futuro del Magnificat è la medesima "remissione dei peccati", proprio perché il presente viene cancellato nella rievocazione nostalgica del passato.
La differenza sta semplicemente nel fatto che la remissione dei peccati per i cristiani è cosa già avvenuta, una volta per tutte, sul Golgota, per cui non resta che attendere la parusia del redentore. L'esigenza di liberazione espressa dal Cristo era così alta che i cristiani, per poterla rimuovere senza ricadere nell'ebraismo, sono stati costretti a togliere all'uomo qualsiasi possibilità di realizzarla, facendo del Cristo l'unica vera divinità.
(torna su)3) L'opposizione contro il Tempio
Gv 2,13-25 - Mc 11,15-19
I
Le numerose offerte che quotidianamente si facevano nel Tempio di Gerusalemme e quelle soprattutto fatte in occasione delle feste principali, determinavano una grande richiesta di bestie sacrificali. A causa delle norme di purità relative a questi animali, i pellegrini erano in pratica costretti ad acquistarli direttamente presso il Tempio (venivano comprati anche legni preziosi, profumi e altri oggetti di lusso).
I sacrifici e gli olocausti venivano compiuti con tre specie di animali: grosso bestiame, bestiame minuto (pecore e capre) e uccelli (tortore e colombi), come da Lv 1,1 ss. Oltre a questi venditori di animali erano presenti anche i cambiavalute, che scambiavano il denaro romano, che recava l'effige dell'imperatore romano e che aveva corso legale, con la moneta ufficiale (antica e sacra) di Tiro, raffigurante la testa del pagano Melkart, permettendo così ai Giudei di pagare, una volta all'anno, la tassa al Tempio (come da Es 30,13).
Le autorità del Tempio, che avevano il monopolio della vendita degli animali sacrificali e che riscuotevano le tasse, avevano concesso che, nell'atrio dei gentili, separato con transenne e gradinate dal resto dell'edificio (cfr. Ef 2,14), vari mercanti potessero svolgere la loro attività. Ovviamente, sia per il clero, che dava le licenze per la vendita degli animali (fonti rabbiniche citano la famiglia del sommo sacerdote Anna), sia per i cambiavalute, che riscuotevano un aggio, il commercio nell'area del Tempio era fonte di cospicui guadagni.
Il Tempio era quindi il centro della vita economica del potere religioso di Gerusalemme e, di conseguenza, di tutta la nazione giudaica: numerose persone – le meglio pagate della città – vi lavoravano per il culto e la manutenzione. Il fatto stesso che tale commercio avvenisse così apertamente nei pressi del Tempio, anzi, all'interno del Tempio stesso (se è vero che la Mishna proibiva di utilizzare l'atrio dei gentili come scorciatoia per una questione di ovvio rispetto, peraltro ribadito da Mc 11,16), era sintomatico del generale decadimento che caratterizzava il complesso della chiesa giudaica.
Gli esseni, proprio a causa della corruzione dei sommi sacerdoti (peraltro tutti nominati e persino deposti dalle autorità romane), rifiutavano nettamente i sacrifici degli animali, anzi non partecipavano a nessun culto, e dalla loro comunità, che viveva nel deserto, usciranno i discepoli del Battista, che battezzavano lungo il Giordano, continuando a rifiutare il culto e i sacrifici del Tempio, e con molti discepoli del Battista si costituirà il movimento gesuano, poi nazareno, la cui prima iniziativa politica fu proprio l'epurazione del Tempio.
Posizione ancora più radicale la tenne il giudaismo gnostico ed esoterico, che considerava Aronne all'origine dell'idolatria e la costruzione del Tempio una vera e propria iattura (cfr le Recognitiones PseudoClementinae). Successivamente Stefano, che rappresentava negli Atti degli apostoli l'ala cristiana degli ellenisti, mostrerà con la sua requisitoria antigiudaica di aver ereditato integralmente questa posizione, pur avendola ribattezzata nel nome del Cristo post-pasquale.
Viceversa, l'ala cristiana del giudaismo, capeggiata da Giacomo, fratello di Gesù, continuerà a frequentare il Tempio sino al 70.2 Tale corrente assocerà la denuncia dei traffici economici presso il Tempio al fatto che questi traffici si svolgevano proprio nell'atrio dei pagani: il cortile, è vero, non era sacro, ma neppure interamente profano, e comunque, utilizzandolo in quel modo, le autorità religiose mostravano chiaramente di voler considerare i gentili come credenti di seconda categoria. Giacomo, a differenza di Paolo e in parte di Pietro, cercherà sino all'ultimo di ricucire lo strappo col giudaismo ufficiale, ma inutilmente, perché lo lapidarono.
Questa corrente farà sentire la sua voce là dove (nei racconti canonici della cosiddetta "purificazione del Tempio") si presenta un Cristo che, pur avendo la frusta in mano, non contesta tanto l'uso delle cerimonie sacrificali, quanto la presenza dei mercanti nel Tempio e che si limita a dire: "non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato" (Gv 2,16).
II
Nel vangelo di Marco il Cristo scaccia anzitutto i venditori e i compratori, cioè sia coloro che hanno gestito la corruzione che quanti non l'hanno impedita, poi rovescia i tavoli dei cambiavalute e dei venditori di colombe, infine non permette il transito di oggetti attraverso il Tempio, ovvero di usare l'atrio come scorciatoia.
Nel vangelo di Giovanni la situazione è più sfumata e rappresentata in maniera più realistica: vengono scacciati con la sferza solo i venditori e, di questi, il trattamento più duro lo subiscono i mercanti più ricchi e i cambiavalute, mentre quelli che venivano incontro alle esigenze dei più poveri (venditori di colombe) sono redarguiti e invitati ad andarsene.
È palese che nel vangelo di Giovanni il Cristo agisce sperando di ottenere il consenso degli acquirenti, che ovviamente costituivano l'anello più debole della corruzione. Tuttavia, mentre in Marco appare chiaro che le autorità del Tempio trovano nella folla un ostacolo alla cattura di Gesù, in Giovanni invece sono i Giudei in quanto tali che gli chiedono di motivare questa sua iniziativa e il Cristo alla fine del racconto mostra di non fidarsi di nessuno (vv. 24-25).
Stando a Marco ma anche a Giovanni, i discepoli non partecipano attivamente all'epurazione (anche se un servizio d’ordine dovevano per forza averlo assicurato), e tuttavia la loro presenza è innegabile, tant'è che il primo vangelo lo dice esplicitamente in tre versetti (15, 19 e 27). Tale incongruenza può essere spiegata col fatto che il vangelo è sì un testo politico, di teologia politica, ma dove i protagonisti della politica non possono essere quanti, attraverso la redazione dei vangeli, cercarono, dopo il 70, un compromesso col potere di Roma (prima del 70 il compromesso era stato cercato dal cristianesimo petrino coi soli Giudei, cosa che Paolo aveva rifiutato, avendo optato per soluzioni di tipo ellenistico).
L'attività del Cristo viene costantemente soggetta, da parte degli evangelisti (e di ulteriori redattori anonimi), a forzate reinterpretazioni con l'ausilio di alcuni brani dell'Antico Testamento. P. es. l'espressione "si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora" (Gv 2,17), non è che il v. 10 del salmo 69 –, cioè la cosiddetta "preghiera dell'oppresso", attribuita a Davide, che si può facilmente utilizzare per una situazione di carattere generale, in cui il concetto di "casa" non necessariamente deve riferirsi al Tempio costruito da Salomone.
L'esegesi confessionale ha voluto usare la citazione in maniera del tutto decontestualizzata, mettendola arbitrariamente in rapporto a un messia purificatore del Tempio (qualche esegeta vi ha visto addirittura un riferimento all'universalismo religioso di Zc 14,2, per il quale non solo il Tempio era sacro, ma anche qualsiasi cosa che l'uomo avrebbe considerato tale, nonché a quello di Is 56,7, per il quale il giudeo e il pagano adoreranno dio in verità). Altri forzati riferimenti sono stati cercati in rapporto a Ne 13,7 s., ove si fa l'esempio di una semi-profanazione del sacro compiuta da Tobia, e con Ml 3,1-4, ove si parla esplicitamente di un messia purificatore d'Israele (non del Tempio in particolare).
Tutte queste citazioni non riescono in alcun modo a dimostrare che l'epurazione possa essere messa in rapporto con l'ingresso messianico nella capitale, come vuole la cronologia sinottica: nella letteratura giudaica non è provata l'idea che il messia dovesse anche promuovere un rinnovamento del Tempio e di tutto il culto. Peraltro Mc 11,17 riporta un'espressione di Ger 7,11 che non pare possibile riferirsi agli abusi del Tempio in particolare, almeno non più che a quelli, in generale, di tutto Israele.
Non dobbiamo dimenticare che i Sinottici, essendo stati prevalentemente influenzati dall'ebraismo galilaico, tendono a dividere l'attività del Cristo in due grandi fasi: quella appunto galilaica (dove l'attività taumaturgica del Cristo prevale su quella politica e dove quest'ultima è ricondotta entro i confini del religioso) e quella giudaica (dove le accuse principali sono rivolte, da parte dei redattori, contro le autorità sinedrite, lasciando in ombra le responsabilità dei Romani). La prima fase è nettamente prevalente sulla seconda.
Posto questo schema, non avrebbe avuto senso collocare la purificazione del Tempio nella prima parte del vangelo. Ecco perché i redattori dei Sinottici non si rendono conto che se il Cristo avesse epurato il Tempio al culmine della sua popolarità, avrebbe fatto, in un certo senso, una cosa che molti potevano anche attendersi e che, proprio per questo, avrebbe tolto al gesto una vera carica eversiva.
III
Nel vangelo di Giovanni (a differenza dei Sinottici) è detto in maniera abbastanza chiara che l'epurazione comportò la rottura dei rapporti con le autorità politico-religiose del Tempio. Si ha anzi l'impressione che in Gv 2,13 ss. un secondo redattore abbia voluto accentuare la rottura politica del Cristo estendendola al giudaismo qua talis, trasformandola quindi in "rottura ideologica".
L'opposizione tra il Cristo e i "Giudei" è così forte nel quarto vangelo che l'epurazione viene rappresentata come una sorta di gesto simbolico dell'assoluta inconciliabilità tra due realtà antagonistiche, più che come un'occasione storica per credere possibile l'intesa delle forze progressiste di Israele. Il Cristo cioè appare come un estremista intellettuale, sostanzialmente isolato, che pone se stesso, nella propria individualità, in antitesi non solo al potere religioso che governava il Tempio, ma anche a tutta la società giudaica di allora, al punto che la conclusione è di un'amarezza senza scampo: egli rifiuta di accettare tra le file del suo movimento persino quanti mostrano di credere nel suo vangelo di liberazione (Gv 2,24 s.).
Viceversa, nei Sinottici l'odio redazionale maggiore è quello nei confronti delle autorità sinedrite, in quanto il popolo permette al Cristo di non essere catturato. In Gv 2,18 sono i "Giudei" sensu lato che lo interpellano, chiedendogli un "segno" che attesti la legittimità dell'epurazione; in Mc 11,27 sono invece le "autorità" (sommi sacerdoti, scribi e anziani) a farlo. Ma non è da escludere che il redattore del quarto vangelo intenda col termine generico di "Giudei" proprio le autorità politico-religiose.3
Nei Sinottici la rappresentazione redazionale del popolo ebraico è generalmente quella di una massa ingenua che, pur essendo istintivamente protesa verso il Cristo, si lascia, alla fine del vangelo, strumentalizzare e circuire dalle astuzie politiche delle autorità giudaiche e romane. Nel vangelo manipolato di Giovanni invece il popolo è consapevole di ciò che fa e decide la morte del Cristo con non meno convinzione di quella delle autorità. L'antisemitismo è più radicale.
Resta tuttavia il fatto che nei Sinottici il luogo semantico degli avvenimenti di questo racconto è completamente diverso da quello di Giovanni. In particolare Marco, da cui dipendono Luca e Matteo, avendo intenzione di sminuire la portata politica dell'evento, ha falsificato le coordinate temporali lasciando solo quelle spaziali. Grazie a Giovanni invece abbiamo capito che questo episodio avvenne all'inizio della predicazione del Cristo e non alla fine.
Inoltre Marco ha sostituito le parole che Gesù può aver pronunciato in quel frangente con frasi veterotestamentarie (anche un secondo redattore di Giovanni l'ha fatto) e, soprattutto, ha ricondotto un dibattito di natura politica entro l'alveo delle questioni religiose (cosa che anche in Giovanni si è cercato di fare).
La domanda del Cristo relativa all'autorevolezza del Battista, a parte il fatto che avrebbe avuto più senso agli inizi della diffusione del vangelo di liberazione, quando l'eco della personalità del Battista era ancora chiaramente udibile, è probabilmente il punto massimo in cui poteva arrivare il cristianesimo primitivo nell'affrontare un episodio così "politicamente" spinoso come quello dell'epurazione del Tempio. Infatti, finché i limiti entro cui muoversi erano solo quelli della contrapposizione ideologica tra Tempio di Gerusalemme e "tempio del corpo di Cristo", ovvero tra luogo fisico del culto e luogo spirituale della fede, sarebbe stato relativamente facile per il cristianesimo post-pasquale far valere il proprio punto di vista: in fondo si trattava soltanto di sostituire una religione politico-nazionalistica con una etico-cosmopolitica.
Il vero problema si poneva quando occorreva giustificare l'uso della violenza (il Cristo con la frusta in mano) ai danni dei mercanti ebrei: le categorie meramente religiose potevano apparire insufficienti. Per cercare di contenere al massimo la carica eversiva di questo episodio, i Sinottici sono stati costretti a inventarsi un improbabile dibattito sull'autorità del Battista (ad almeno due-tre anni dalla sua morte) e ben due parabole: quella del fico sterile (Mc 11,12 ss.), dove il Cristo maledice una pianta simbolica (il giudaismo) che, non essendo nella stagione giusta, non aveva ancora prodotto alcun frutto, ovvero non poteva più produrre frutti perché destinata perennemente dal Cristo a restare fuori stagione; e quella dei vignaioli omicidi (Mc 12,1 ss.), in cui il padrone della vigna (lo stesso messia) assicura che il primato di Israele è finito e che presto gli ebrei verranno sostituiti dai gentili.
Dulcis in fundo è, nei Sinottici, il dibattito sul tributo di Cesare (Mc 12,13 ss.): qui il Cristo è tassativo nell'affermare il riconoscimento esplicito, sul piano politico, dell'autorità romana, come se l’epurazione del Tempio fosse stata fatta da un pagano moralmente onesto e devoto a dio. Il valore politico di questi racconti è quasi nullo. Come del tutto fuori luogo sono le espressioni standard che s'incontrano nel vangelo di Giovanni laddove si dice che, "vedendo i prodigi che faceva, molti credettero in lui" (2,23). È sintomatico che nei vangeli il teismo redazionale diventi tanto più accentuato quanto più il Cristo voleva affermare i diritti dell'umanesimo integrale, sostanzialmente a-religioso.
IV
Più sopra si è detto che l'epurazione del Tempio non voleva apparire, in negativo, come una dimostrazione dell'assoluta inconciliabilità tra ebraismo progressista e vangelo di liberazione, ma, in positivo, come un tentativo di far convergere tutte le forze progressiste del paese verso un'intesa politica in funzione antiromana (una sorta di "fronte popolare nazionale").
Ecco, a tale proposito, ci si potrebbe anche chiedere, con la logica ipotetica del "se", cosa sarebbe potuto accadere se si fosse costituito tale "fronte", cioè che possibilità effettive avrebbe avuto la Palestina di liberarsi dei Romani, poiché nulla ci vieta di considerare come utopistico il programma del vangelo di Cristo e quindi come del tutto legittima l'opposizione al Cristo da parte del giudaismo ufficiale, ivi incluso quello più progressista, e dunque come inevitabile la trasformazione mistica di tale vangelo operata dai primi cristiani.
Qui infatti la questione si pone in modo cruciale: o la spoliticizzazione del Cristo è servita per ridimensionare delle pretese che altrimenti non avrebbero avuto alcuna prospettiva, e allora potremmo considerare la spiritualizzazione del suo messaggio come una sorta di tentativo di salvare il salvabile; oppure si è in presenza di un tradimento vero e proprio dell'istanza originaria, che non può essere giustificato né dall'opposizione ebraica né da quella romana, ma allora bisognerebbe studiare sino in fondo che tipo di resistenza antiromana avrebbe potuto condurre con successo un movimento come quello nazareno.
Insomma, dopo duemila anni di esegesi ancora non si è arrivati a spendere una parola significativa sull'effettiva possibilità che una popolazione sparuta come quella palestinese avrebbe avuto di opporsi con successo al più grande imperialismo del mondo antico.
Non solo, ma ci si può anche chiedere se l'antisemitismo del cristianesimo post-pasquale non dipenda anche dalla decisione di spoliticizzare al massimo la figura del Cristo. La domanda cioè sarebbe questa: se il cristianesimo avesse accettato il contenuto politico del vangelo di liberazione, avrebbe affermato un'opposizione di principio, ideologica, tra sé e l'ebraismo, con la stessa identica determinazione che ebbe quando si trasformò da movimento nazareno a movimento petro-paolino? Il fallimento della rivoluzione politica del Cristo, causato anche dall'opposizione di una parte dell'ebraismo, doveva per forza essere considerato un motivo sufficiente per spostare i termini del confronto tra cristianesimo ed ebraismo dal terreno politico a quello religioso, cioè dall'esigenza di liberarsi dell'imperialismo romano alla rimozione di tale esigenza?
Se è possibile studiare il vangelo come un testo politico in cui la politica di liberazione è stata volutamente rimossa, allora è facile rendersi conto come l'epurazione del Tempio vada considerata come il principale attacco contro la più importante istituzione ecclesiastica del giudaismo (il secondo sarà quello sferrato dalle truppe dell'imperatore Tito nell'anno 70), in cui il tentativo di minarne le basi economiche mirava a conciliarsi con la possibilità di una rigenerazione nazionale delle masse oppresse da Roma.
V
Del tutto inaspettato da parte delle guardie del Tempio e della guarnigione romana (che sorvegliava il Tempio dalla fortezza Antonia), l'attacco fu sostanzialmente condiviso a livello popolare: gli unici a protestare furono i sommi sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Neppure i mercanti reagirono. Questo a testimonianza che tantissimi Giudei nutrivano ormai un rispetto solo formale nei confronti di tale istituzione e dei suoi amministratori, i quali, pur di restare al loro posto, avevano accettato ampi compromessi con le forze occupanti.
Tuttavia nessun ebreo, prima di allora, aveva mai osato prendere un'iniziativa del genere, anche perché i mercanti e i cambiavalute agivano grazie alla copertura dell'alto clero. Chiunque l'avesse fatto avrebbe rischiato di passare, agli occhi del potere costituito, per un nemico dell'ordine pubblico, se non per un traditore della patria, soprattutto in quel frangente storico e non sarebbe certo passato inosservato da parte delle forze dell'ordine (come sembra nei vangeli, ma non in At 21,31 s., allorché Paolo venne aggredito).
Il significato di ciò che Gesù disse in quel momento va intuito, poiché sia la versione di Giovanni che quella dei Sinottici risentono di un intervento redazionale chiaramente apologetico. "Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere" (Gv 2,19) è un'espressione che può voler dire molte cose. L'interpretazione confessionale, priva di ogni fondamento storico, equipara il Tempio al corpo di Cristo crocifisso e i tre giorni a quelli che occorsero agli apostoli per accorgersi della tomba vuota. In questo essa non fa che ribadire la versione allegorica già espressa nella glossa di Gv 2,21 s.: "Gesù parlava del tempio del suo corpo".
In realtà se mai il Cristo abbia detto una frase di questo genere, è difficile pensare che, in un'occasione così cruciale per i destini della sua patria, egli abbia voluto porre un'ipoteca sulla sua comprensione, rimandando, quest'ultima, al giorno in cui egli non avrebbe potuto far niente per metterla in pratica (secondo le esigenze politiche del suo tempo). Tant'è che quando i Giudei gli obiettarono che un Tempio costruito in 46 anni non poteva essere facilmente sostituito (Gv 2,20), essi avevano capito bene che il Cristo (quello storico, non quello della fede) voleva sostituirsi al primato del Tempio. Senonché per loro era meglio avere un Tempio corrotto ma ben visibile, piuttosto che un leader onesto e coraggioso privo di autorità ufficialmente riconosciuta.
Qui dunque si può ipotizzare che il significato di quell'espressione iperbolica sia stato un invito a eliminare la corruzione, il clientelismo e il collaborazionismo aristocratico sacerdotale che amministrava il Tempio, e quindi a smettere di credere in un'istituzione che non avrebbe potuto in alcun modo aiutare la Palestina a liberarsi dei Romani. D'altra parte gli ambienti esseno, battista e zelota avevano già capito che aveva poco senso temere la fine del primato politico-religioso del Tempio quando, di fatto, esso era già stato distrutto dalla corruzione di chi lo amministrava.
Il vero problema era diventato quello di come trasformare l'uomo in "tempio di se stesso" (anche il Battista, con la pratica del battesimo, puntava allo stesso obiettivo). La rigenerazione morale degli uomini – preludio della rivoluzione politica – avrebbe dovuto sostituire la difesa ad oltranza di un'istituzione ormai superata (il Cristo lo dirà chiaramente alla samaritana del pozzo di Giacobbe). La differenza tra il Cristo e il Battista stava tutta nel fatto che quest'ultimo non arrivò mai a compiere il passaggio decisivo dalla strategia pre-politica (vissuta lungo le acque del Giordano e nel deserto) a quella propriamente politica (vissuta nel cuore stesso della capitale).
Purtroppo la reazione dell'intellighenzia politica progressista al gesto di Gesù non fu così positiva come ci si sarebbe dovuti attendere: la maggior parte del movimento battista non ebbe il coraggio di appoggiare politicamente l'iniziativa, pur condividendone le motivazioni etiche (alcuni leader però avevano già lasciato il movimento battista per diventare seguaci del Cristo – cfr. Gv 1,37 ss.). Un'insignificante minoranza del movimento fariseo (capeggiata da Nicodemo) si limitò a incontrare il Cristo privatamente, in forma del tutto ufficiosa (Gv 3,2), continuando a vedere nel Tempio una delle risorse insostituibili per l'aggregazione delle masse, specie in occasione delle grandi feste e ricorrenze (benché proprio i farisei avessero sviluppato molto l'uso decentrato e più democratico delle sinagoghe). Dell'atteggiamento tenuto dal movimento zelota nei vangeli, ovviamente, non si dice nulla (a tale scopo bisogna andarsi a leggere Giuseppe Flavio, che spesso è ancora più tendenzioso dei vangeli, soprattutto nei confronti degli zeloti).
Probabilmente i farisei rappresentavano allora il movimento popolare tradizionale più rappresentativo o almeno quello più influente sulle masse. Essi tuttavia erano molto scettici sulla possibilità di liberarsi dei Romani, o comunque aspiravano a un mutamento significativo che passasse attraverso le istituzioni della società giudaica, al cui interno, essi, non senza fatica, si erano costruiti una loro identità politica. Gesù, per loro, appariva troppo "radicale". Gli fecero infatti capire che avrebbero accettato le conseguenze della "purificazione" solo a condizione di vedere un altro gesto ancora più significativo, che dimostrasse in maniera inequivoca ch'egli era il messia tanto atteso. In Gv 3,18 la domanda che gli pongono è abbastanza eloquente: "Quale segno ci mostri per fare queste cose?".4
L'ipocrisia stava proprio in questo: che da un lato ci si rendeva conto delle contraddizioni insostenibili del Tempio, e dall'altro non si aveva il coraggio di risolverle in maniera decisiva e, nonostante ciò, ci si opponeva a chi prendeva una decisione senza il previo consenso di chi gestiva il potere. La domanda che nei Sinottici il Cristo rivolge alle autorità, in merito al destino del Battista, può, sotto questo aspetto, essere ribaltata nel modo seguente: "Se l'epurazione del Tempio è moralmente inaccettabile o giuridicamente illecita o politicamente inopportuna, perché chiedere un segno che ne legittimi il senso e non intervenire immediatamente manu militari contro chi l'ha organizzata?".
Atteggiamento analogo avevano tenuto le autorità religiose nei confronti del Battista (Gv 1,19 ss.). Ai farisei interessava non tanto il "manifesto" del Precursore quanto piuttosto l'ascendenza che il suo programma politico poteva avere sulle masse. Con questo fare strumentale, che è tipico di quanti sono abituati a ragionare secondo meri rapporti di forza, essi cercarono di rimediare all'errore di aver sottovalutato le capacità del neonato movimento gesuano. Se prima, con Nicodemo, s'erano limitati a un incontro informale, ora invece, essendosi accorti che, in seguito all'epurazione, il Cristo faceva più discepoli di Giovanni (Gv 4,1), volevano negoziare un'intesa vera e propria. Per tutta risposta il Cristo, coi suoi discepoli, "lasciò la Giudea – dice Gv 4,3 – e si diresse verso la Galilea".
Per concludere, l'epurazione del Tempio fu l'evento più importante del primo anno di propaganda attiva del vangelo di liberazione del Cristo. Praticamente si erano poste le basi di quella che sarebbe dovuta diventare una rivoluzione non solo culturale ma anche politica. Come "prova generale" della imminente sollevazione antiromana fu senza dubbio un fallimento e tuttavia molti cominciarono a vedere nel Cristo un nuovo leader politico. Fra questi i più convinti furono i Galilei, giunti a Gerusalemme a motivo della Pasqua (Gv 4,45).
(torna su)4) Critica dell'esegesi confessionale
Le tesi ricorrenti che l'esegesi confessionale ha dato di questo episodio sono sostanzialmente tre:
1. etica: il Cristo ha criticato il nesso di economia e religione, ovvero la strumentalizzazione della fede per interessi materiali e quindi ha condannato la corruzione degli amministratori del Tempio, ma non ha messo in discussione la necessità del culto a dio, né il fatto che debbano esistere dei mediatori specifici tra gli uomini e dio;
2. spirituale: il Cristo ha sostituito il culto presso il Tempio con il culto della sua persona, nel senso che ha posto le basi per il superamento del sacrificio degli animali e di un luogo fisico privilegiato per il culto;
3. pastorale: il Cristo ha voluto dimostrare che nell'ambito del suo vangelo l'ebreo e il gentile hanno pari dignità, in quanto il cristianesimo è una religione universale. Di qui l'importanza di dimostrare che anche l'area del Tempio riservata ai gentili, in cui avvenivano i traffici, andava considerata "sacra".
In realtà – come si è già visto – proprio in occasione di quell'avvenimento il Cristo romperà i rapporti, più o meno definitivamente, non solo col primato politico-religioso del Tempio e delle sue autorità ufficiali, ma anche con le tradizioni religiose del giudaismo, al punto che "sommi sacerdoti e scribi" – come dice Mc 11,18 – cominciarono a pensare al modo in cui eliminarlo (Mc 11,19 afferma che la sera stessa fu costretto a uscire dalla città, ritirandosi probabilmente a Betania), e in quell'occasione non poterono farlo solo perché fu loro impedito dalla folla.
Quanto all'universalismo a favore dei gentili va detto che se in questo racconto di Giovanni non è esplicita tale apertura, come invece in Marco, ciò rispecchia l'autenticità dell'originale: si badi, non nel senso che Gesù, in quanto ebreo, non aveva ancora maturato un'idea così aperturista nei confronti dei gentili, ma nel senso che, nel suo vangelo, ogni riferimento religioso a questo o quel culto, fosse esso giudaico o pagano, andava decisamente superato, specie in vista della necessità di liberare la Palestina dai Romani. Sarà piuttosto la comunità post-pasquale a sostenere, tradendo il suo messaggio, che questo umanesimo laico era in realtà una nuova forma di religione, più spirituale e più universale.
(torna su)5) Gesù e Nicodemo
Gv 3,1-15
I farisei si stupirono del coraggio manifestato da Gesù al momento di cacciare i mercanti dal Tempio di Gerusalemme (2,13 ss.). In effetti, opponendosi risolutamente al potere dei partiti ebraici conservatori, se non collaborazionisti con Roma, Gesù aveva saputo destare la loro attenzione, anche se questa non si era tradotta in un appoggio esplicito alla sua iniziativa. Uno dei loro capi, infatti, andò a trovarlo "di notte" (v. 1), cioè di nascosto, in privato.
La frase di Nicodemo, riportata al v. 2, riflette chiaramente l'intento d'incasellare quel gesto eversivo in uno schema precostituito, che lascia comunque supporre un'attività politica del Cristo "giudaico" antecedente all'epurazione, la quale ovviamente, vista la sua pericolosità, non poteva non essere stata debitamente preparata: "Sappiamo che sei un maestro venuto da Dio". "Sappiamo...", ma i farisei si guardarono bene dal mostrarlo pubblicamente.
"Sappiamo che sei un maestro...". Anche il Battista poteva essere considerato un "maestro di vita", eppure non appoggiò l'iniziativa di Gesù, il quale voleva piuttosto porsi come "leader politico" (Gv 3,25 ss.). I farisei, dal canto loro, non appoggiarono neppure la protesta morale del Battista (Gv 1,24 ss.).
"Sappiamo che sei un maestro venuto da Dio". Da quale "Dio"? Da quale "interpretazione" di Dio? Un uomo "timorato di Dio" avrebbe forse avuto il coraggio di opporsi al potere politico-religioso dei sacerdoti, fino al punto d'entrare con la forza nel recinto sacro del Tempio? Forse Gesù aveva voluto "purificare" il Tempio solo perché mosso da uno sdegno di tipo "morale"?
"Nessuno può fare i segni che fai tu – dice Nicodemo –, se Dio non è con lui" (v. 2).5 Ecco lo "schema" applicato alla realtà. Gesù, in sostanza, aveva potuto "purificare" il Tempio semplicemente perché la sua concezione di Dio non contrastava con quella farisaica. La differenza stava nel fatto che Gesù aveva compiuto un'azione che anche un vero fariseo, virtualmente, avrebbe potuto anzi dovuto compiere. Nicodemo era dunque andato a trovarlo per convincerlo a diventare un seguace del proprio partito.
Gesù declina l'offerta e ribatte: "Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio" (v. 3). Cioè a dire (con linguaggio moderno): per poter avere una teoria veramente rivoluzionaria occorre vivere una prassi rivoluzionaria. Il popolo non sa che farsene delle "buone intenzioni" dei farisei, se ad esse non corrispondono azioni concrete e coerenti.
Nicodemo si giustifica dicendo: "Come può un uomo nascere quando è vecchio?" (v. 4). Cioè a dire: è giusto pretendere una maggiore coerenza da un partito che lotta per la liberazione antiromana, ma bisogna anche considerare le grandi delusioni sofferte nel passato. Maggiore coerenza esisteva quando il movimento farisaico era giovane. Ora però si può sperare di sopravvivere solo cercando il compromesso. Ecco perché non si può appoggiare pubblicamente l'iniziativa eversiva.
Se le cose stanno così – obietta Gesù – il vostro partito non potrà far nulla per la liberazione d'Israele. "Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito" (v. 6). Il destino dei farisei, per Gesù, era segnato: o si rinnovavano o perivano. Ma per potersi rinnovare essi avrebbero dovuto accettare una verità difficile: "Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va" (v. 8).
In altre parole: o i farisei ridimensionavano la loro pretesa di porsi come unico partito alternativo al potere dominante, oppure sarebbero stati emarginati da nuove forze sociali, più giovani e più coraggiose, soprattutto più coerenti con gli ideali di giustizia e liberazione nazionale. O comunque avrebbero rischiato di vivere un ruolo subalterno, all'ombra dei partiti più conservatori.
Nicodemo insomma avrebbe dovuto accettare, secondo Gesù, l'idea di una pluralità di forze sociali, tra loro paritetiche, provenienti da esperienze eterogenee, in grado di opporsi, in maniera più o meno efficace, con mezzi e strumenti diversi, al sistema dominante.
Nicodemo però resta scettico: "Come può accadere questo?" (v. 9), cioè com'è possibile che forze non istituzionalizzate possano lottare per la realizzazione del "regno di Dio"? Come potranno queste forze, una volta cacciati i Romani e sconfitti i collaborazionisti, governare il Paese? Come può il popolo governare se stesso?
"Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?" – risponde Gesù (v. 10). Cioè, "se non sei capace d'insegnare al popolo ignorante come vivere senza padroni, come puoi pretendere che ti ascolti? Come potranno i farisei lottare per l'indipendenza nazionale se sin da adesso non sono capaci di democrazia"?
"Noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto" (v. 11) – dice Gesù –, poiché il suo movimento vive tra le masse e non nel "palazzo" o non solo nelle "sinagoghe". "Ma voi non accogliete la nostra testimonianza" (v. 11), "certamente non allo stesso modo dei partiti conservatori, che la rifiutano a priori. Se aveste appoggiato la cacciata dei mercanti del Tempio, ora saremmo per tutti degli interlocutori credibili, perché convincenti".
Dunque, il movimento gesuano, d'ora in avanti, da chi dovrà guardarsi maggiormente: dal partito sadduceo, che non nasconde il suo odio, o da quello fariseo, che dice di essere disponibile al dialogo solo a parole?
(torna su)6) La donna samaritana al pozzo di Giacobbe
Gv 4,1-42
I farisei cominciarono a interessarsi di Gesù solo quando s'accorsero – stando al vangelo di Giovanni – che, coi suoi primi seguaci, egli stava acquistando, specie in seguito alla cacciata dei mercanti dal Tempio, più popolarità del movimento di Giovanni Battista (4,1).
Essi erano ben consapevoli che, per togliere potere politico ai partiti ebraici conservatori o addirittura collaborazionisti con Roma, occorreva minarne le fondamenta economiche, e cioè il commercio nell'atrio del Tempio, ma quando videro coi loro occhi l'iniziativa di Gesù (2,13 ss.) chiesero soltanto, attraverso uno dei loro capi, Nicodemo, d'incontrarsi segretamente con lui (3,1 ss.), evitando di appoggiarlo ufficialmente.
I farisei, abituati a ragionare secondo la logica dei rapporti di forza, non ebbero, all'inizio, alcun vero interesse per l'attività di un uomo come Gesù, che ai loro occhi appariva poco credibile, in quanto di origini umili e senza una formazione culturale tradizionale. Viceversa, era la gente comune che, più spontaneamente, aveva capito che il suo messaggio politico poteva costituire una novità ancora più grande di quella del Battista, il quale non aveva avuto l'ardire di cacciare i mercanti dal Tempio (e che comunque sarà arrestato, per altri motivi, poco tempo dopo questo evento).
Ecco perché quando i farisei decisero di prendere contatti con la prima comunità di Gesù, che s'andava allargando a spese di quella battista, Gesù non poteva essere disponibile a un rapporto che avrebbe facilmente rischiato d'essere strumentalizzato da un partito che, in quel momento, godeva di una certa credibilità e che per "liberazione politico-nazionale" intendeva unicamente la restaurazione dell'antico regno davidico.
Non dimentichiamo che i farisei, alcuni decenni prima, erano stati duramente perseguitati dai Romani per essersi opposti al pagamento dei tributi a Cesare. Le rivolte di Giuda il Galileo e del fariseo Zadok avvennero quasi in simultanea e ben duemila ribelli furono crocifissi.
Questo per dire che il racconto della donna samaritana risulterebbe incomprensibile se non si capisse il motivo per cui Gesù rifiutò di scendere a patti coi farisei (i quali, peraltro, non sarebbero mai andati a cercarlo in una terra per loro "eretica"). Infatti in questo racconto, i Samaritani, a differenza dei farisei, accolgono Gesù per quello che è, senza ch'egli abbia preventivamente bisogno di dimostrare la sua autorevolezza politica.
Ovviamente con questo non si vuol dire che i Samaritani non avessero alcuna difficoltà ad allacciare rapporti con persone del mondo giudaico che non ponessero alcuna discriminante di principio fra le due etnie. Troppo tempo era trascorso perché fosse facile evitare i pregiudizi da ambo le parti. Tanto è vero che quando Gesù chiede da bere alla samaritana (v. 7), questa è la prima a meravigliarsi di una richiesta del genere da parte di un giudeo (v. 9).
Testimone di questo singolare incontro deve essere stato Giovanni, e forse il fratello Giacomo: altri apostoli infatti "erano andati in città (Sicàr, a pochi km dal pozzo di Giacobbe) a comprare da mangiare (v. 8), senza incontrarsi con la popolazione locale, in quanto non erano lì in missione, per cercare proseliti, né per stabilire intese o alleanze: erano solo di passaggio, essendo diretti in Galilea. Avevano scelto questo percorso, più faticoso di quello che costeggiava il Giordano, per motivi di sicurezza.
Il v. 10 lascia indirettamente capire che Giovanni deve aver assistito al dialogo tra i due protagonisti: esso infatti rappresenta non tanto ciò che Gesù disse di se stesso, ma ciò che un suo discepolo disse di lui (la locuzione "il dono di Dio" vuole qui anticipare ciò che più avanti dovrà apparire evidente, ossia che Gesù – secondo l'autore di questo racconto – è un messia di tipo "religioso").
Il contesto è relativamente facile da capire: verso mezzogiorno Gesù con alcuni discepoli si era fermato presso il pozzo di Giacobbe, mentre altri erano andati a cercare dei viveri nel paese più vicino. Erano molto stanchi, faceva molto caldo e il pozzo era troppo profondo per potersi abbeverare senza i mezzi adatti. Non restava che aspettare l'arrivo di qualcuno o il ritorno dei discepoli da Sicàr. È in questo lasso di tempo che avviene l'incontro, del tutto casuale, con l'anonima donna samaritana.
Dal modo come risponde alla richiesta di dissetare quegli "stranieri" (v. 11), la donna non appare, in un primo momento, più "elastica" dei farisei: alla frase di Gesù, riportata nel v. 10, cerca subito di opporre, come meglio può, le prerogative della propria gente (v. 12). Anche per lei, come per i farisei, nessuno può dirsi "grande" se non lo dimostra con un grande potere.
Probabilmente la donna temeva di avere a che fare con l'astuzia di un giudeo che cercava di "convertirla" al primato del giudaismo. Dalla sua tuttavia aveva l'attenuante di non aver veduto Gesù "liberare" il Tempio dalla corruzione. Questa donna effettivamente non sa che Gesù godeva già di una certa popolarità a Gerusalemme.
Nonostante ch'essa abbia anzitutto cercato di difendere il suo popolo e, col suo popolo, se stessa, senza lasciarsi incuriosire dall'affermazione ambigua contenuta nel v. 10, Gesù, con fare pedagogico, la stimola ugualmente a vincere il pregiudizio e a misurarsi in un rapporto paritetico. Quanto, in questo breve rapporto, la donna abbia rischiato di fraintendere le parole di Cristo, in un senso o nell'altro, non ci è dato sapere. Qui il redattore presenta il Cristo nei panni di un semidio che sa già tutto su di lei e che quasi si diverte a metterla in imbarazzo.
Deve aver avuto non pochi pregiudizi quel redattore cristiano di origine giudaica che, per dimostrare l'inferiorità dei Samaritani, ha deciso di aggiungere i vv. 15-18, nei quali afferma esplicitamente che la samaritana era una mezza prostituta (Gesù viene fatto passare, in maniera ridicola, per una persona onnisciente). In realtà i cinque mariti del v. 18 sono un chiaro riferimento alle cinque popolazioni pagane che il re d'Assiria, Sargon II (721-705), fece venire da Babilonia e da altre città pagane per trasformare la Samaria da regione israelitica a regione ellenistica: obiettivo che solo in parte riuscì, in quanto gli ebrei della Giudea costrinsero quelle popolazioni a convertirsi, almeno parzialmente, alla legge mosaica. Di qui il sincretismo religioso tipico dei Samaritani (cfr 2Re 17,24-41), che sul piano legislativo-religioso riconoscevano unicamente il Pentateuco, revisionato peraltro in più punti.
Ai tempi di Gesù l'odio tra le due etnie era abbastanza forte, poiché nel 128 a.C., quando il re Giovanni Ircano distrusse il tempio sul monte Garizim, i Giudei non mossero un dito per difendere l'indipendenza nazionale dei Samaritani. Mt 10,5 fa addirittura dire a Gesù che l'ingresso nelle città samaritane andava considerato interdetto per i suoi discepoli. È quindi evidente che anche quando i vangeli furono composti, dovevano esserci tensioni piuttosto forti tra cristiani e samaritani.
Se i passi aggiunti dall'anonimo interpolatore fossero tolti e si saltasse direttamente dal v. 14 al v. 19, il senso del racconto resterebbe del tutto coerente. Anzi, in tal modo si capirebbe meglio che la donna intuì subito che l'espressione "acqua viva" non poteva riferirsi a qualcosa di "materiale" (come invece appare nei versetti aggiunti), ma a qualcosa di "spirituale", cioè non poteva che essere elargita da un "profeta" o da un maestro di vita.
Viceversa, obbligandola a fraintendere il senso di un'espressione la cui simbolicità poteva apparire incomprensibile solo a una persona sprovveduta, il redattore non ha fatto altro che sminuire l'intelligenza di quella donna. In un posto semi-deserto, lontano dalla città, in nessun modo la donna avrebbe potuto capire che per "acqua viva" Gesù intendeva alludere a una scorta personale di acqua piovana o di altra natura, assolutamente miracolosa, in quanto capace di estinguere per sempre la calura della sete. Quindi Gesù dovette per forza di cose apparire alla donna come un intellettuale giudaico che aveva un messaggio da rivolgere al popolo samaritano.
La donna, infatti, sapendo di avere a che fare con un intellettuale, ne approfitta per imbastire una discussione impegnativa, che mal deve aver digerito il fazioso manipolatore di questa pericope. E la domanda ch'essa pone, in tal senso, è quella classica della diatriba interetnica: "Chi riuscirà a liberare Israele: i Giudei o i Samaritani?".
La cosa curiosa è che mentre in un primo momento la donna aveva difeso le prerogative storiche del suo popolo, ora sembra disposta ad ascoltare un'opinione diversa, ch'essa peraltro già conosce. Probabilmente essa, messa di fronte al problema di come affrontare e sconfiggere l'oppressione romana, da tempo doveva essersi chiesta se, per realizzare la riunificazione delle etnie, i primi a dover "cedere" e a scendere a patti dovessero essere i Giudei o i Samaritani (v. 20).
A partire dal v. 21 la tradizione cristiana ha preso il netto sopravvento su ciò che Gesù può aver detto in quella occasione e che ora solo molto indirettamente possiamo cercare d'immaginare.6 È comunque assai probabile che il Cristo abbia cercato di far capire alla donna del pozzo che i termini del problema da essa posto non erano da considerarsi più attuali, in quanto superati dalla drammaticità dei tempi. L'intesa tra Giudei e Samaritani non avrebbe dovuto realizzarsi sulla base di un compromesso momentaneo o tattico, né, tanto meno, in forza di una più o meno inevitabile annessione di un'etnia da parte di un'altra.
L'intesa doveva porsi su basi nuove, assolutamente paritetiche, in virtù delle quali ogni etnia avrebbe dovuto rinunciare a quelle caratteristiche (religiose, in primis) che la tenevano irrimediabilmente separata dalle altre. Di fronte a un comune nemico, l'unica possibilità di vincerlo era quella di affermare l'unità dei popoli, cioè l'unità delle loro forze e dei loro intenti democratici e egualitari. (La parabola lucana del buon samaritano – 10,30 ss. – è il tentativo di affermare la stessa cosa da un punto di vista squisitamente etico).
Cristo quindi poneva fine non solo al primato della Giudea e del suo Tempio, ma anche alla sacralità del monte Garizim e del pozzo di Giacobbe: la questione "religiosa" di sapere in quale luogo ufficiale dover "pregare" diventava improvvisamente la questione "politica" di sapere come "liberare" la Palestina dai Romani.
L'autore di questo racconto (o, se si preferisce, il suo "manipolatore"), pur cercando di trasporre questo obiettivo dal terreno politico a quello religioso, ha lasciato, senza volerlo, che la donna traesse delle conseguenze politiche e non religiose dal discorso di Gesù. È anche probabile, naturalmente, che l'autore abbia compiuto a bella posta tale operazione, per mostrare l'inferiorità dei "politici" samaritani rispetto ai "religiosi" giudeo-cristiani.
In realtà la donna doveva aver già intuito che, nella resistenza antiromana, la separazione tra Giudei e Samaritani non aiutava la causa nazionale e, in tal senso, essa, nelle parole di Gesù, aveva più che altro trovato una conferma esplicita alle proprie convinzioni.
Questa donna anonima s'era dimostrata molto più intelligente dei farisei incontrati da Gesù a Gerusalemme. Persino più intelligente di alcuni apostoli che, abituati, come i farisei, a ragionare in termini di schieramento politico, "si meravigliarono che Gesù parlasse con una donna" (v. 27): ovviamente non perché "donna", ma perché "samaritana".
Correndo subito in città ad avvisare amici e parenti, la donna dimostrava chiaramente che la situazione politica in Samaria era diventata esplosiva e che l'attesa di un messia liberatore era sentita da gran parte della popolazione. Infatti, subito "la gente uscì dalla città e andò da lui" (v. 30).
Non lo fece, ovviamente, perché – come si legge al v. 29 – meravigliata che un uomo potesse indovinare tutte le vicende personali di una loro compaesana. Anche qui l'autore di questo racconto s'è divertito a mettere in cattiva luce i Samaritani, che passano semplicemente per dei curiosi amanti delle ultime novità.
I Samaritani cercavano un messia che li aiutasse a liberarsi dei Romani; poco importava se questo messia fosse o no capace di leggere nella mente delle persone. "La gente uscì dalla città" semplicemente perché non riusciva a credere alle proprie orecchie quando la donna (che per queste ragioni non poteva certo essere una "prostituta") diceva che un intellettuale giudeo non aveva più intenzione di considerare il Tempio di Gerusalemme più importante di quello che avevano loro sul monte Garizim.
Persino gli apostoli lì presenti stentarono a credere che Gesù volesse accettare l'accoglienza dei Samaritani, abbassandosi per così dire al loro livello. Quando l'autore di questo racconto scrive che "i discepoli lo pregavano di mangiare" (v. 31), è evidente ch'egli sta mascherando un dissenso piuttosto esplicito fra Gesù e i suoi apostoli. Se avesse mangiato non avrebbe avuto motivo di non accettare la loro ospitalità.
Infatti, se i Samaritani potevano anche accogliere con entusiasmo l'idea che un intellettuale giudeo ponesse le due etnie sullo stesso piano, per un giudeo invece dovevano essere i Samaritani a "convertirsi": e su questo gli apostoli, almeno all'inizio della loro esperienza politica, non la pensavano diversamente.
Al dire degli apostoli i "tempi" per allacciare un'intesa coi Samaritani erano di là da venire, poiché, non essendo ancora stati stabiliti dei rapporti chiari e sicuri fra il movimento gesuano, poi nazareno (che aveva componenti anche galilaiche) e l'etnia giudaica, quest’ultima non sarebbe stata in grado di capire un'opzione preventiva a favore dell'etnia rivale. Secondo gli apostoli l'apertura universalistica nei confronti del "semi-eretico" paese limitrofo, avrebbe potuto essere solo la conseguenza di una liberazione dai Romani compiuta in terra anzitutto giudaica. (I Giudei nutrivano nei confronti dei Samaritani un disprezzo più forte di quello che nutrivano i Galilei; dovendo scegliere tra un galileo e un samaritano, il giudeo avrebbe sempre scelto il galileo, seppure anche in questo caso obtorto collo).
Viceversa, per Gesù i tempi erano già maturi per un'ampia intesa democratica con ogni popolo che soffrisse l'oppressione romana. "Le campagne – egli afferma – già son bianche da mietere" (v. 35). Il "seminatore" (il giudeo e il galileo, in questo caso Gesù e i suoi primi apostoli) deve rallegrarsi insieme al "mietitore" (il samaritano) – così al v. 36. I Samaritani, nella lotta contro i Romani, non erano meno impegnati dei Giudei, anche se vi erano stati casi in cui gruppi di loro s'erano alleati coi Romani in funzione antigiudaica.
Gli apostoli, in sostanza, erano caduti in quella trappola in cui facilmente finiscono i rivoluzionari astratti, ideologici, e cioè quella di credere che la coscienza rivoluzionaria delle masse (che serve per fare la rivoluzione) possa e anzi debba maturare spontaneamente, a prescindere dal contributo decisivo degli intellettuali.
Gesù offre qui una lezione eminentemente politica. Quando dice che "l'uno semina e l'altro miete" (v. 37), vuole appunto specificare la diversità dei tempi e dei ruoli rivoluzionari (benché in un lavoro agricolo fosse difficile immaginare uno che semina e un altro che miete). Compito degli apostoli è quello di "seminare" la coscienza rivoluzionaria: essi devono far questo senza poter sapere quando sarà il momento preciso per "mietere" la rivoluzione.
Dice Gesù con grande apertura mentale al v. 38: "Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete lavorato; altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica". Se i destinatari di questa frase erano gli stessi Samaritani, questi non avevano che da rallegrarsi: Gesù chiedeva loro di mietere ciò che altri (i Giudei) avevano seminato. Ogni primato politico, giurisdizionale o d'onore veniva dissolto.
Ma l'espressione di Gesù aveva in realtà anche un valore universale: gli stessi suoi apostoli stavano mietendo ciò che i discepoli del Precursore avevano seminato, e così i nazareni nei confronti dei farisei... È nella storia di tutte le rivoluzioni che alcuni pongano le basi e altri vi edifichino sopra delle costruzioni, il più delle volte, purtroppo, tradendo il messaggio originario, altre volte invece precisando questioni di cruciale importanza, trascurate dai movimenti precedenti.
L'incontro coi Samaritani, in questo senso, fu uno dei più felici della vita di Gesù. Ed è singolare che di tutto quello che in quei "due giorni" (v. 40) essi si dissero, non si faccia cenno alcuno. L'autore del testo si limita a dire che mentre all'inizio i Samaritani vollero incontrare Gesù perché stupìti delle capacità profetiche dimostrate nei confronti della donna del pozzo (v. 39), in un secondo momento si convinsero personalmente che Gesù era "veramente il Salvatore del mondo" (v. 42): frase, quest'ultima, così pregnante che avrebbe sicuramente meritato una qualche spiegazione.
(torna su)7) Esecuzione del Battista
Mc 6,17-29
v. 17) Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata.
Erode Antipa (4 a.C.- 39 d.C.), verso il 27 d.C., aveva conosciuto Erodiade a Roma, dove viveva, e l'aveva convinta a lasciare il marito Erode Filippo ("senza terra"), violando le severe leggi d'Israele (Lv 18,16; 20,21), poiché i due Erode erano figli dello stesso padre Erode il Grande.
Non solo, ma l'Antipa (che aveva ripudiato la prima moglie) era anche zio e cognato di Erodiade, in quanto questa era figlia di Aristobulo, altro fratello dell'Antipa (Erode il Grande aveva avuto sette figli da diverse mogli. Nella sua famiglia tali unioni consanguinee erano frequenti e spesso caratterizzate da eventi delittuosi).
Erode Antipa – dice Marco – aveva fatto "arrestare e incarcerare" Giovanni Battista a causa di Erodiade, nella fortezza del Macheronte, situata non lontano dalla riva orientale del Mar Morto, ai confini della Perea.
Giovanni non stava organizzando una rivolta armata contro Erode. E tuttavia la sua popolarità era troppo grande perché il tetrarca non temesse che la contestazione, pur condotta in ambito etico-giuridico, non rischiasse di trasformarsi, nelle mani del popolo, in occasione per ribellarsi al suo potere dispotico.
Lo storico Flavio Giuseppe lo dice chiaramente: "Attorno a Giovanni si era radunata una moltitudine che si entusiasmava a sentirlo parlare. Erode temeva che una tale forza oratoria potesse suscitare una rivolta, dal momento che la folla pareva disposta a seguire tutti i consigli di quest'uomo. Preferì perciò assicurare la propria persona prima che si dovessero verificare delle sommosse contro di lui, piuttosto che pentirsi troppo tardi per essersi esposto al pericolo, una volta che fosse avvenuta una sedizione. A motivo di questi sospetti di Erode, Giovanni fu spedito a Macheronte" (Antichità giudaiche, XVIII, 118-119).
È dunque solo per motivi indirettamente politici che l'Antipa decise di incarcerare il Battista. Marco, con l'espressione "a causa di Erodiade", preferisce accentuare i motivi "legali" del conflitto, poiché lo scopo del suo vangelo è quello di spoliticizzare la figura di Gesù e le persone che gli ruotano attorno. Non a caso nei Sinottici la vicenda del Battista è stata costruita sulla falsariga di altre due narrazioni: quella accaduta al profeta Elia, anch'egli perseguitato da una regina pagana (cfr 1 Re 19,2; 21,4 s.; 21,18 s.), e quella accaduta allo stesso Gesù Cristo, accusato non dal governatore Pilato, bensì dai sommi sacerdoti.
v. 18) Giovanni diceva a Erode: "Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello".
Giovanni non rimproverava a Erode il divorzio né, tanto meno, il suo modo di governare la nazione: semplicemente gli constatava una violazione della legge ebraica.
Ma perché Giovanni s'interessava così tanto alla situazione giuridica del tetrarca? Per quale motivo aveva indirizzato le sue accuse al sovrano, quando fino a quel momento aveva preso di mira solo gli scribi e i farisei? E perché aveva cominciato ad attaccare il potere politico filoromano quando si era sempre limitato ad attaccare quello dei capi religiosi? E perché proprio quello di Erode e non quello, molto più importante, di Pilato, che governava la Giudea? Come poteva sperare che l'Antipa si sentisse indotto ad osservare, lui che era legato agli interessi di Roma, le prescrizioni veterotestamentarie in materia di diritto matrimoniale?
Qui si può pensare che il Battista, probabilmente, si era ormai accorto d'aver raggiunto una popolarità tale per cui non poteva più fare a meno d'interessarsi anche della situazione (in questo caso etico-giuridica) del vertice governativo della Perea (il territorio ove il Battista aveva prevalentemente agito e sul quale Erode governava, oltre che in Galilea).
Oltre a ciò bisogna considerare che dopo la cacciata dei mercanti dal Tempio, ad opera di Gesù, molti seguaci del Battista avevano deciso di diventare "nazareni", per cui il Battista necessitava di recuperare un certo ascendente sulle masse, dal momento che non aveva accettato di collaborare attivamente col Cristo.
E comunque il Battista non cercò – come si suol dire – il "martirio": se così fosse stato, avrebbe certo usato un linguaggio più diretto ed esplicito. Da ciò che appare nel testo egli sembra essersi limitato a costatare i fatti, mediante una critica "indiretta", cioè pre-politica, suggerendo un modo "legale" per tornare alla "normalità". La sua insistenza sembra essere dipesa semplicemente dalla indiscussa autorità che il popolo gli riconosceva.
Tuttavia non bisogna dar troppo peso alla versione dei vangeli. Se Giovanni avesse ottenuto l'obiettivo sperato, la sua popolarità sarebbe diventata assolutamente eccezionale, ed è difficile pensare che Giovanni non potesse prevedere un caso del genere e come avrebbe pensato di gestirlo. Lo stesso Antipa non poteva non pensare che la vittoria avrebbe dato a Giovanni l'occasione per avanzare nuove rivendicazioni, questa volta anche esplicitamente politiche.
Esiste inoltre un'evidente contraddizione nei vangeli circa l'operato di Giovanni. Da un lato egli affermava di non essere degno di "sciogliere il legaccio del sandalo" di Gesù (Gv 1,27); dall'altro invece egli si sentiva degno di "fare le scarpe" al sovrano che gli erodiani volevano far passare come "messia d'Israele". Da ciò sembra apparire che la deferenza dimostrata da Giovanni nei confronti di Gesù, sia stata volutamente esagerata dalla primitiva comunità cristiana, e che in realtà Giovanni, proprio a partire dalla contestazione a Erode, stesse cominciando a porsi come "messia politico".
v. 19) Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva,
Erodiade era una donna senza scrupoli: come aveva accettato d'abbandonare il marito "senza terra" per un uomo padrone di una "quarta parte", così avrebbe fatto di tutto per conservare e, se possibile, aumentare il proprio prestigio di regina. Di qui l'odio nei confronti del Battista anche per motivi "personali", tanto che – dice giustamente Marco – voleva "ucciderlo", stimando insufficienti i provvedimenti presi da Erode.
In fondo se per Erode il matrimonio costituiva una delle sue numerose nefandezze, e lo scandalo, se non fosse stato per il Battista, non gli sarebbe pesato più di tanto; per Erodiade invece il matrimonio era stato il mezzo migliore per realizzare delle ambizioni e acquisire un potere.
Erode non aveva bisogno di giustiziare il Battista per restare sul trono e per essere temuto come tetrarca, a meno che la protesta di Giovanni non avesse assunto delle connotazioni politiche vere e proprie. Erodiade invece, se voleva guadagnarsi il formale pubblico rispetto, restando al potere, doveva a tutti i costi far tacere la bocca di quel grande accusatore. Non avrebbe potuto vivere a rimorchio del marito, fingendo, coperta dall'autorità di lui, una normalità che di fatto non esisteva. Certo, se Giovanni avesse rinunciato a ricordare la violazione compiuta, il peso dell'autorità di Erode col tempo avrebbe costretto il popolo a dare il dovuto onore alla moglie regina, ma non avrebbe certo potuto costringervi il profeta.
v. 20) perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui; e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
Secondo la versione romanzata di Marco, Erode aveva un atteggiamento ambiguo nei riguardi di Giovanni: lo ascoltava volentieri, ma non si convinceva; lo temeva, eppure lo aveva incarcerato; sapeva che era "giusto e santo" e tuttavia preferiva vigilare su di lui. Lo aveva rinchiuso in una prigione lontana molte miglia dalla Galilea, perché, conoscendo la sua grande popolarità, non si sentiva di giustiziarlo subito, e, nel contempo, sospettava che la moglie, con l'inganno, lo volesse fare al suo posto. Come ogni re di questo mondo, che ostenta di tanto in tanto la propria magnanimità, mostrava rispetto per i profeti, quasi si vantava di averne uno personalmente interessato alla sua condotta morale e di essere disposto a lasciarlo vivere, pur nelle ristrettezze della prigione.
L'atteggiamento di Erode descritto da Marco oscilla fra il timore superstizioso, la curiosità intellettuale e la simpatia umana: nel suo comportamento c'è poca strategia politica. È appunto qui che si ha la netta impressione che questa descrizione voglia ricalcare quella riferita alla passione di Cristo, dove Pilato, che afferma l'innocenza del "re d'Israele" (Gv 19,6b), non è molto diverso da Erode, e dove i sommi sacerdoti, con la loro invidia e gelosia (Mc 15,10), non sono molto diversi da Erodiade.
In realtà la versione di Flavio Giuseppe è molto più attendibile. Erode aveva fatto arrestare Giovanni non tanto per esaudire i desideri di Erodiade, o per proteggerlo dai suoi intrighi, quanto per impedire che la protesta di lui venisse usata da movimenti sociali e politici che mal sopportavano il suo collaborazionismo con Roma e che indubbiamente erano molto più ostili del movimento battista.
v. 21) Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea.
Era costume orientale che si offrisse un banchetto per il compleanno del re, cui invitare le persone più in vista del regno, benché nell'A.T. sia riportato un solo esempio di questo, quello del Faraone d'Egitto (Gen 40,20). La festa venne tenuta proprio nella fortezza del Macheronte. Il motivo per cui Erode non avesse scelto Tiberiade va ricercato forse nel fatto che uno sfarzo del genere, in quei momenti di grave crisi sociale, avrebbe potuto provocare risentimenti popolari, ma si può anche pensare che la scelta del luogo fosse finalizzata a un piano particolare. Non dimentichiamo che Macheronte e Masada erano le due fortezze che Erode poteva usare in caso di pericolo.
Ciò che appare strano è l'invito dei maggiori funzionari politici, militari e amministrativi della Tetrarchia per celebrare una festa che, tutto sommato, non era così importante. Vien quasi da pensare che Erode volesse in realtà "ufficializzare" il suo matrimonio, risolvendo una volta per tutte la difficile situazione in cui il Battista l'aveva posto. Forse voleva dimostrare che il suo interesse per Erodiade era superiore a qualsiasi divieto giuridico e che, in tal senso, sarebbe stato anche disposto a liberare Giovanni, se tutta la corte l'avesse chiaramente appoggiato contro le rivendicazioni popolari. Era forse un'ipotesi peregrina quella di credere che qualcuno, in seno alla corte, poteva anche approfittare delle critiche al suo matrimonio illegittimo per soddisfare proprie ambizioni di potere?
v. 22) Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: "Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò".
Nell'antichità, durante i banchetti, le danze erano molto in uso, ma vi si prestavano soprattutto le prostitute. Qui, essendo Salomè una principessa, la cosa appare, a dir poco, alquanto insolita.
Se l'episodio è davvero accaduto, la ragazza evidentemente ballò col consenso della madre, anche se di questo Erode non diede mostra di stupirsi; anzi, il fatto che lui abbia saputo subito approfittare delle prestazioni artistiche della giovane, promettendole una cosa che a nessun commensale avrebbe potuto promettere, fa pensare che, in qualche modo, egli non dovesse essere del tutto estraneo alle sorprese che il banchetto avrebbe potuto riservare.
Se effettivamente Erode voleva che la sua relazione amorosa fosse sanzionata senza indugi, allora il ballo di Salomè nella sala del convito stava appunto a confermare queste sue intenzioni e la promessa fatta alla ragazza non faceva che rincarare la dose. Egli in sostanza voleva far capire che il suo legame con Erodiade era così solido che avrebbe potuto concedere qualsiasi cosa alla figlia di lei. Peraltro di Salomè Marco dice che era una "ragazza" (di 13-14 anni?): Erode non poteva temere di farle una promessa spropositata.
v. 23) E le fece questo giuramento: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno".
Il giuramento di Erode, considerato ch'egli dipendeva da Roma, appare come una vera e propria "spacconata" e, come tale, sembra ricalcare il modello letterario di Est 5,3 e 7,2, in cui un re di Persia (anche in questo caso in un banchetto) rivolse alla regina Ester l'espressione: "Fosse pure la metà del mio regno".
Qui non si deve pensare, se il giuramento è stato fatto, che Erode volesse far mostra di uno sfrenato autoritarismo, stimando il proprio regno come un qualsiasi oggetto da usare ad libitum. Sarebbe stato assurdo che Erode promettesse a Salomè la metà del suo regno per il solo piacere della danza e proprio davanti a tutti i rappresentanti del suo potere.
Erode può aver fatto quella promessa in stato di semiubriachezza, alla fine della serata, convinto che Salomè non gli avrebbe effettivamente chiesto la metà del suo regno, ma un regalo molto meno impegnativo. Nel caso invece l'avesse preso in parola, Erode avrebbe sempre potuto giustificarsi in vari modi per non rispettare, alla lettera, il giuramento (il primo dei quali era che il regno non apparteneva a lui più di quanto non appartenesse a Roma).
Resta comunque curioso il fatto che Erode abbia voluto confermare la promessa con un esplicito giuramento: evidentemente voleva mostrare assoluta sicurezza in quello che diceva.
v. 24) La ragazza uscì e disse alla madre: "Che cosa devo chiedere?". Quella rispose: "La testa di Giovanni Battista".
Ci si chiede: Erode era già d'accordo con Erodiade sull'idea di far ballare Salomè e sul finale tragico del banchetto, oppure non aveva considerato l'eventualità che Erodiade potesse approfittare del suo giuramento "pubblico" al di là delle sue aspettative? Detto altrimenti: dietro questo episodio vi è stata una regia o tutto è avvenuto casualmente? Allo stato attuale delle fonti, nessuno è in grado di rispondere a questa domanda.
Facendo il giuramento Erode aveva messo alla prova la fiducia dei commensali nei suoi confronti, poiché se il suo matrimonio fosse fallito, la metà del suo regno sarebbe finita in mani estranee. Erodiade però fa di più: mette alla prova Erode di fronte a tutti. Egli infatti deve dimostrare che, se è veramente disposto a cedere la metà del regno, dev'essere altresì disposto a cedere ogni altra cosa che appartenga al suo regno, inclusa la testa del Battista.
Salomè si rivolge alla madre perché così le era stato detto di fare o perché non voleva rischiare di sprecare questa grande opportunità? Non rifiuta la proposta del patrigno, né si limita a chiedere qualcosa di simbolico e neppure sembra essere convinta dell'effettiva possibilità di chiedere quello che le è stato promesso con giuramento. Di fatto Salomè è nelle mani della madre, che può fare di lei quello che vuole.
v. 25) Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: "Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista".
Condividendo la decisione della madre, perché coinvolta indirettamente nello scandalo, Salomè rientrò in fretta nella sala e, con altrettanta solerzia, chiese che la testa del Battista le fosse portata "subito" su un vassoio.
Tutta questa premura sta forse a dimostrare che Erodiade temeva qualche ripensamento, ma può anche far pensare che effettivamente Erode non si aspettasse una richiesta del genere, non foss'altro perché non poteva pensare che l'odio della moglie per il Battista si sarebbe spinto fino al punto da mettere lui in evidente imbarazzo davanti a tutti gli invitati.
v. 26) Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto.
Qui i casi sono tre: o Erode era d'accordo con la moglie sin dall'inizio e questa sua tristezza è una finzione; oppure egli pensava di liberare il Battista servendosi del banchetto e dell'approvazione ufficiale dei commensali alle sue nozze con Erodiade; oppure quello che dice Marco è vero: Erode non era d'accordo con la moglie, non aveva intenzione di liberare il Battista e decise di eliminarlo solo perché aveva fatto un giuramento davanti a testimoni di prestigio.
L'unica cosa certa in queste tre ipotesi è la seguente: uccidere il Battista significava aspettarsi dei tumulti popolari, non farlo significava dimostrare di temerli (e questo sarebbe stato sconveniente di fronte ai suoi funzionari di corte).
Se Erode effettivamente temeva dei tumulti e, per tale ragione, non s'era ancora deciso a eliminare il Battista, è semplicemente incredibile che abbia deciso di farlo in un'occasione così frivola e mondana. Di fronte alla richiesta di Salomè il giuramento poteva ancora costituire un obbligo morale? Possibile che il giuramento avesse più importanza come "forma" che non come "sostanza"?
Supponiamo che Erode si fosse servito del banchetto per dimostrare la perfetta intesa matrimoniale con la moglie, il fatto ora di dover uccidere il Battista non doveva forse servire a dimostrare sino in fondo il valore di tale intesa? Se le cose stanno così, il Battista è stato ucciso per motivi politici, a prescindere dalle circostanze in cui ciò è avvenuto, proprio perché per Erode il suo matrimonio con Erodiade, pur essendo stato dettato da motivi personali e non da interessi di potere, aveva assunto un risvolto chiaramente politico.
Nel testo di Marco invece si ha l'impressione che Erode abbia fatto uccidere il Battista controvoglia, perché, come Pilato, raggirato da persone più astute di lui.
v. 27) Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa.
Per timore che i commensali fossero testimoni di uno spergiuro o di un dissidio in casa reale, circa la sorte del Battista, o di un'ammissione di debolezza, di fronte alla paura di conseguenze politico-sociali, Erode trasforma immediatamente i commensali in testimoni di un delitto.
La versione di Marco è poco attendibile. Benché "triste", Erode non chiese spiegazioni di sorta, non tergiversò, non s'indignò, non rifletté neppure molto sul da farsi: "subito" – dice Marco – inviò la guardia. E tra i commensali nessuna voce di protesta, neppure la più piccola considerazione di opportunità su una decisione così grave.
v. 28) La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, lo diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre.
Secondo Marco, Erodiade fu la vera artefice della morte del Battista (avvenuta nel 27 d.C.), lei il vero "motore" di tutta la macchinazione: si servì di Salomè prima e degli invitati dopo, per convincere Erode, e di Erode stesso per uccidere Giovanni. Come se i motivi "personali", di fronte a un caso nazionale come il Battista, potessero prevalere su quelli più strettamente "politici", per i quali responsabile ultimo della morte del Battista altri non poteva essere che Erode.
v. 29) I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
Non ci furono tumulti, non si approfittò della morte del grande profeta per provocare delle ribellioni: Erode aveva forse dato al movimento battista un'importanza che non aveva? S'era forse macchiato di un inutile delitto? Stando alla versione di Marco sembra proprio di sì. In realtà Giovanni costituiva un pericolo per Erode e la forte insofferenza dei Galilei per i governi filoromani non poteva permettergli di rischiare più del necessario.
Resta tuttavia il fatto che il Battista era morto per la sua fedeltà rigorosa alla legge: nel testo di Marco non si nota ch'egli avesse un ideale più alto. I discepoli pensarono poi a una forma di "giustizia divina" il fatto che l'Antipa venisse sconfitto militarmente dal padre della prima moglie, Areta IV re dei Nabatei, che voleva vendicare l'offesa del ripudio. In realtà l'Antipa riuscì a conservare il trono per 44 anni, e fu solo durante il regno dell'imperatore Caligola che suo cognato, Erode Agrippa I, manovrò dietro le quinte per ottenere la sua condanna. Si pensa che, spedito in esilio a Lugdunum (Lione) nelle Gallie, dove lo raggiunse Erodiade, fu poi eliminato da un generale romano, mentre i suoi domini passarono nelle mani di Agrippa, che dal 38 al 44 riuscì ad amministrare gli stessi territori di Erode il Grande, finché tutta la Palestina fu di nuovo gestita dai procuratori romani, generalmente venali e violenti, intenzionati a far scoppiare la guerra.
(torna su)8) Inizio della predicazione di Gesù in Galilea
Mc 1,14-20
La predicazione di Gesù, che nel primo vangelo viene fatta iniziare in Galilea, subito dopo l'arresto di Giovanni Battista, viene magistralmente sintetizzata da Marco in quest'unica frase divisa in due parti:
A) 1. il tempo è compiuto; 2. il regno di dio è vicino;
B) 3. convertitevi; 4. credete al vangelo.
È facile osservare come la parte A) costituisca l'aspetto teoretico dell'evento, una sorta di considerazione storico-politico-religiosa relativa alla situazione critica della Palestina, mentre la parte B) pretenda di offrire un'indicazione di metodo, soggettivo (per il punto 3) e oggettivo (per il punto 4), per l'affronto adeguato del problema della liberazione nazionale.
È appunto la parte B) che differenzia Gesù dal Battista, per il quale la metànoia coincideva col pentimento e il vangelo col battesimo. Il Precursore non aveva mai formulato un programma politico vero e proprio.
Le quattro affermazioni marciane sono strettamente legate fra loro: cioè come la 1 si riflette soprattutto nella 3, così la 2 nella 4. La 1 era riferita al passato più recente o all'attualità del presente; la 2 riguarda il futuro più o meno prossimo; la 3 richiama l'esigenza di un cambiamento di mentalità ai fini della realizzazione del regno (l'impegno soggettivo); la 4 esprime la necessità di credere in un progetto di liberazione nazionale, obiettivamente motivato (liberarsi dello straniero e dei partiti collaborazionisti). La 2 rappresenta l'obiettivo finale della 3 e della 4. Queste ultime rappresentano il metodo e il contenuto (soggettivo e oggettivo) per realizzare l'obiettivo della 2 e così via.
"Il tempo è compiuto" è affermazione che può essere interpretata in diverse maniere, ma tutte in pratica si ricollegano al fatto che per il messia è giunto il momento di reagire in modo costruttivo all'impotenza nei confronti dell'oppressione romana e del potere giudaico conservatore (tanto più che la missione del Battista è fallita). La promessa sta appunto nell'imminenza del regno terreno "di dio", unica vera alternativa al sistema dominante.
Il modo per conseguire tale obiettivo è quello di "credere" al nuovo vangelo (messaggio, buona notizia) del messia-liberatore (che qui ha una connotazione religiosa): oggettivamente quindi il tempo era compiuto, ma soggettivamente solo per chi credeva nel vangelo.
*
Le circostanze della pericope marciana vanno considerate inventate per almeno due ragioni:
1. Gesù e i suoi primi discepoli, usciti dal movimento battista, si erano recati in Galilea (dove avevano subito iniziato a predicare l'esigenza di un'insurrezione nazionale) non dopo l'arresto del Battista, ma dopo l'epurazione del Tempio;
2. Gesù non chiamò i primi discepoli in Galilea bensì in Giudea, facendoli appunto uscire dai battisti (che, a loro volta, erano usciti dagli esseni).
Dunque perché Marco dice due cose errate? Semplicemente perché vuol far vedere che i Galilei erano migliori dei Giudei, gli unici cioè in grado di proseguire quanto di meglio la Giudea aveva già espresso, appunto con la figura profetica del Battista.
Il massimo di attendibilità che si può concedere alla pericope marciana sta forse nel fatto che, dopo l'arresto del Precursore, i nazareni presero a muoversi con maggiore risolutezza, nella speranza di avere tra loro tutti i seguaci di Giovanni.
(torna su)9) Le tentazioni nel deserto
Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13
Nel racconto sinottico delle tre tentazioni di Cristo è racchiusa l’intera filosofia della storia dell’ideologia ebraico-cristiana. La possiamo definire "cristiana" solo riferendoci alle risposte che il cristianesimo ha messo in bocca al Cristo tentato dal Satana (risposte mutuate con le dovute varianti dal Vecchio Testamento). Tuttavia, se si prescinde da queste risposte, il contenuto di quel racconto sinottico ha un risvolto universalistico che può essere accettato anche da una filosofia "laica" della storia.
L’episodio – almeno per come lo riportano Matteo e Luca – è chiaramente leggendario, sia perché il fatto è visto, volutamente, in un’ottica metaforico-allegorica, sia perché, se è vera la versione di Mc 1,12 s. (e così come è stata scritta certamente non lo è), Gesù andò da solo nel deserto e nessuno, oltre a lui, avrebbe potuto riferirci quanto gli era accaduto.
Ora, nel vangelo di Marco tutto l’episodio è riportato praticamente in un'unica frase e non c’è alcun dialogo tra Gesù e Satana, né alcuno successivo tra Gesù e i discepoli. Il testo di Marco è anteriore a quelli di Luca e Matteo, anzi è la loro fonte principale, per cui è ad esso che bisogna prestar fede quando sorgono contraddizioni di tipo sinottico.
Non per questa ragione, tuttavia, dobbiamo ritenere credibile il racconto di Marco, che col suo parlare di "angeli" che "servono" Gesù, in compagnia di "bestie selvatiche" e per un periodo di tempo decisamente simbolico, "40 giorni" (cfr Es 34,28 e 1Re 19,18), si commenta da solo. Qui Gesù non rappresenta altro che un novello Mosè, ovviamente riveduto e corretto.
Quindi possiamo affermare con sicurezza che se il Cristo andò nel deserto (per superare ogni tentazione? per prepararsi spiritualmente alla vita pubblica?), gli evangelisti non possono dirci nulla di più del semplice fatto che vi andò.
Peraltro il fatto che un aspirante leader politico andasse a "purificarsi" nel deserto, era considerato del tutto naturale in quell’epoca: la solitudine del deserto non serviva soltanto per rifugiarsi dopo un atto di terrorismo politico, ma anche per temprare le proprie forze. Il Battista l’aveva addirittura scelto come luogo privilegiato di predicazione, per annunciare la necessità di costruire un nuovo regno d’Israele.
Viceversa, il Cristo si rivolgeva alle folle delle città e dei paesi di campagna. Il deserto era per lui occasione di rifugio quando le masse lo cercavano per chiedergli guarigioni ad oltranza (Mc 1,35) o quando volevano farlo diventare re (Gv 6,15), o quando le autorità lo cercavano per catturarlo (Gv 10,40; 11,54).
E tuttavia, tralasciando queste considerazioni sul valore storico dell’episodio, qui si vuole sottolineare che nei racconti di Luca e Matteo non ci si è affatto limitati a delineare quello che alcuni esegeti hanno definito col termine di "conflitto psicologico" del Gesù pre-politico, cioè del Gesù ancora indeciso se entrare o no in politica, ma si è voluto piuttosto delineare una vera e propria filosofia (religiosa) della storia, riassumendo molto sinteticamente, con grande efficacia, tutte le possibili tentazioni cui può andare incontro un individuo, o meglio un intero popolo che voglia essere protagonista attivo della propria esistenza.
In tal senso appare riduttiva anche l’interpretazione di altri esegeti che vedono nel gesto di Gesù "un’azione pedagogica" a favore dei discepoli (che in Marco, peraltro, fino a questo momento sono assenti), onde dimostrare che nessun leader può considerarsi immune dal virus delle tentazioni mondane.
La prima tentazione infatti rappresenta tutte le civiltà fondate sullo schiavismo e sul servaggio (quest’ultimo va considerato come una forma attenuata di schiavismo).
La tentazione di trasformare le pietre in pani (cfr Dt 8,3) è la tentazione di chi non ha altra aspirazione che quella di far valere l’uso della forza sul più debole, il proprio istinto sulla ragione... È la tentazione delle passioni più primitive, più elementari: la forza brutale, la libidine dei sensi, l’ingordigia, il narcisismo...
Questa tentazione, che ha caratterizzato l’intera umanità a partire dal momento in cui si sono costituiti i regimi schiavistici (ben rappresentati dal mito dell’Eden) sino al XVI sec., è stata negativamente superata da un’altra tentazione, più sofisticata: quella del potere economico, sorta col sistema capitalistico. Il potere politico della prima tentazione è dunque quello di tipo fisico, perché basato unicamente sulla forza e sull’istinto.
A tale potere il Cristo dei vangeli risponde con la saggezza ebraica: "L’uomo non vive di solo pane" (Dt 8,3), che è una risposta, anch’essa, al negativo, in quanto non viene esplicitata chiaramente un’alternativa alla prima tentazione. Cosa che però farà Mt 4,4, riportando, reinterpretata, la sentenza di Dt 8,3: "...ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio".
L’alternativa – lasciano comunque sottintendere entrambi i vangeli – è il rapporto di obbedienza religiosa a dio-padre, di cui Cristo viene detto "figlio": un rapporto più assoluto di quello ebraico, ch'era tra il popolo (privo di caratteristiche divine) e Jahvè, ma è anche un rapporto più individualistico, in quanto la salvezza si basa ora su un rapporto personale del credente col dio trinitario. Il popolo d’Israele s’era posto il compito di realizzare il regno di dio sulla terra; il popolo cristiano lo relega definitivamente nell’aldilà.
Per queste ragioni, nelle versioni di Luca e Matteo il Cristo sembra rifiutare l’idea del potere fisico semplicemente perché egli, in quanto "figlio", deve dipendere da un "padre", che dispone di ogni potere. L’invito, squisitamente religioso, è quello di affidarsi alla provvidenza di dio, che al momento opportuno, farà piovere la manna dal cielo. Il cristiano, a differenza dell’ebreo, si sente sicuro di questa protezione, perché ha già ricevuto una manna immortale: il figlio stesso di dio.
Altre potevano essere le risposte da dare, in maniera diciamo più "laica": p. es. "L’uomo va rispettato come tale", oppure "La forza va messa al servizio della debolezza"... Risposte del genere però non potevano essere messe in bocca a Gesù, poiché i vangeli hanno avuto lo scopo di spoliticizzare al massimo la sua figura.
Da notare peraltro che la risposta data in Matteo è ancora più clericale di quella data in Luca. Essa si differenzia in maniera sostanziale anche dal testo deuteronomico, poiché mentre qui si fa esplicito riferimento alla "manna", Matteo invece parla di "logos", di "verbo" che esce dalla "bocca di Dio". La liberazione cristiana è più spiritualistica e, quindi, più astratta di quella ebraica, benché sappia porsi in maniera più universalistica.
Il Cristo di Matteo parla come un sacerdote cristiano. Il che è un controsenso rispetto alla tipologia della prima tentazione, che non poteva implicare un livello di consapevolezza così elevato da parte della persona "tentata". Di fronte a un livello di consapevolezza del genere il tentatore sarebbe dovuto passare immediatamente alla terza tentazione.
Ma ora vediamo la seconda. Qui c’è un problema di difficile soluzione: la seconda tentazione è quella descritta da Luca o quella descritta da Matteo? I posti assegnati infatti si invertono: laddove per l’uno si tratta della seconda tentazione, per l’altro è la terza.
Proviamo a dar ragione a Luca. In che cosa consiste la tentazione? Semplicemente quella – come già detto – relativa al potere economico. "Se tu ti prostri e mi adori, tutta la potenza del mondo sarà tua".
Qui la differenza tra ebraismo e cristianesimo è netta. Luca infatti fa dire a Satana una frase che nell’Antico Testamento non avrebbe mai potuto dire: "Tutta questa potenza e la gloria di questi regni è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio" (4,6). Luca in sostanza dà per scontato che sia impossibile costruire – come invece volevano fare gli ebrei – un regno di giustizia su questa terra. Egli deve negare a priori che una qualunque aspirazione a ottenere da dio la cosiddetta "terra promessa" possa portare a un fine di bene.
L’uomo sottoposto alla seconda tentazione si lascia ingannare facendo affidamento non alla propria forza fisica, ma a un potere a lui esterno: il denaro. Infatti il demone promette la proprietà della terra in cambio della legittimazione del proprio operato. Poiché col denaro si può comprare ciò che si vuole – nella prospettiva del male –, Satana chiede d’essere riconosciuto non come "padre della menzogna", ma come "padre della verità".
D’altra parte un uomo solo non può governare il mondo: la sua forza è limitata, ma con l’aiuto di un mezzo particolare: il denaro, può farcela. Il denaro gli permetterà di trasformare la sostanza in forma e la forma in sostanza.
Nel periodo dello schiavismo l’uomo di governo considerava se stesso un dio, basandosi sul potere della propria forza, cioè sul numero di schiavi posseduti (un potere che, una volta consolidatosi, poteva anche essere trasmesso per via ereditaria).
Ora invece l’uomo può considerarsi un dio a prescindere dalla propria forza fisica: gli è sufficiente un mezzo che abbia valore universale, che cioè sia universalmente riconosciuto. La forza fisica (materiale, militare, esecutiva...) potrà essere comprata col denaro.
Probabilmente Matteo ha messo questa seconda tentazione come terza perché la risposta che in Luca dà il Cristo è squisitamente clericale. Cioè è una risposta molto più impegnativa di quella che nello stesso Luca egli dà alla terza tentazione.
Qual è questa risposta? "Adora il Signore tuo Dio e a lui solo rendi il tuo culto" (Dt 6,16). Cioè in pratica il Cristo matteano afferma che la tentazione del potere economico va rifiutata semplicemente perché l’uomo religioso ha già riservato il proprio culto a un altro ente esterno: dio.
Il Cristo qui non rifiuta il potere di "mammona" perché con esso avrebbe violato la giustizia sociale, l’uguaglianza tra gli uomini, la libertà di vivere un’esistenza dignitosa..., no, lo rifiuta semplicemente perché già gli appartiene un altro tipo di potere: quello religioso.
Matteo è un evangelista schematico, categorico: quale occasione più propizia di questa per sostenere l’idea che il Cristo (e quindi la sua chiesa) è migliore di qualunque altro sovrano non cristiano (e dello stesso Mosè) appunto perché si presenta come "Figlio di Dio"? In questo vangelo la chiesa non può incorrere nel peccato della cupidigia appunto perché "cristiana". Le basta dirsi "adoratrice" dell’unico vero dio per essere dispensata dall’onere di dover affrontare questa tentazione così meschina.
La terza tentazione è la più difficile da capire, e infatti Matteo, che ha sempre dato più peso all’etica economica che non alle posizioni politiche, non l’ha capita, altrimenti non le avrebbe assegnato il secondo posto.
Se la esaminiamo dal punto di vista della filosofia della storia, dobbiamo dire ch’essa non si è ancora manifestata a livello mondiale, ma solo a livello di singoli Stati nazionali e, per di più, solo per un periodo di tempo limitato.
Si tratta della tentazione del potere politico-ideologico, i cui due massimi esponenti negativi, singolarmente presi, restano ancora oggi Stalin e Mao. È la tentazione di dominare gli uomini non attraverso la propria forza fisica (militare), né attraverso un mezzo esterno, economico (che pur essendo universale conserva sempre un aspetto materiale, in qualche modo identificabile), ma attraverso un elemento del tutto spirituale (universale sì, ma immateriale): il pensiero o, se si preferisce, l’ideologia. (È meglio parlare di "ideologia", poiché essa rimanda a un'organizzazione collettiva).
Attraverso lo stalinismo e il maoismo si è capito che è possibile dominare gli uomini anche in condizioni di debolezza fisica e di povertà economica (Stalin e Mao non erano gli esponenti più brillanti o più in vista o più promettenti del loro partito).
Il nazi-fascismo, essendo un’ideologia individualistica (come tutte le ideologie occidentali), aveva bisogno della forza fisica (militare) e dell’appoggio finanziario dei potentati economici per affermarsi sulle masse. Viceversa ideologie di tipo collettivistico, seppure nella forma dello statalismo, come lo stalinismo e il maoismo, hanno invece avuto bisogno di un’idea e di un partito che le sostenesse, le divulgasse e le applicasse col consenso indotto, apparentemente volontario delle masse. Ecco il grande inganno che si è voluto trasmettere alle generazioni sotto la maschera del comunismo statale, amministrato dall'alto.
Nel vangelo di Luca, Satana porta Gesù sul pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e gli chiede di buttarsi giù, onde dimostrare al mondo intero che i suoi poteri sono infiniti, in quanto egli può disporre di aiuti eccezionali (gli angeli di dio), cioè di un consenso plebiscitario, assolutamente inattaccabile.
La risposta di Gesù è laconica: "Non tentare il Signore Dio tuo" (cfr Dt 6,13). Cioè a dire: per poter aspirare a un potere del genere, che è infinitamente grande, bisogna essere sicuri di se stessi. Per poter essere sicuri di ottenerlo, occorre un grande consenso popolare. Per poter ottenere l’appoggio incondizionato delle masse, bisogna avere un grande coraggio e delle idee veramente convincenti.
Può sembrare amara questa considerazione e troppo forzata rispetto al senso della risposta di Gesù. Eppure proprio quella risposta così vaga e generica autorizza una riflessione del genere.
Chiediamoci: il Cristo del deserto (per come è stato dipinto dalla chiesa) rifiuta la terza tentazione perché veramente ritiene che il miglior potere politico è quello democratico, cioè quello esercitato da tutto il popolo, oppure perché pensa di poterlo esercitare in nome di "altro" (ambizione personale, odio contro il genere umano ecc.)? Non si è forse comportata così la chiesa cattolica, quando ha esercitato nel Medioevo un potere politico col consenso delle masse? Lo stalinismo non va forse considerato come una variante "laica" del cattolicesimo romano? E il maoismo non è forse stato una variante rurale dello stalinismo industrializzato?
Perché queste forme particolari di potere ideo-politico oggi sono entrate in crisi, lasciando ampi margini di manovra alla tentazione "economicistica"? Semplicemente perché esse non sono state sufficientemente scaltre da darsi una parvenza credibile di democraticità (una parvenza che durasse nel tempo). O forse perché nell’uomo la capacità di ingannare le masse è, in ultima istanza, limitata.
Cattolicesimo romano, stalinismo e maoismo hanno compiuto delitti così orrendi che difficilmente l’umanità avrebbe potuto continuare a tollerarli. Essi però hanno posto le basi per lo sviluppo della terza tentazione, che ancora non sussiste a livello mondiale come la seconda (che è di pertinenza del mondo capitalistico), ma nuove ideologie avranno in futuro l’onere di portarla a compimento. E nuove posizioni umanistiche (veramente democratiche) avranno l’onere di smascherarla. E quando l'avranno fatto, chissà se vi sarà una quarta tentazione.
(torna su)10) Erode Antipa e Gesù
Mc 6,14-16
v. 14) Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: "Giovanni Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui".
Marco chiama Erode Antipa coll'appellativo di "re", ma egli era soltanto "tetrarca", cioè "signore di una quarta parte di territorio" (Galilea e Perea), che amministrava alle dipendenze più o meno dirette di Roma.
Erode risiedeva nel palazzo della capitale galilaica, Tiberiade, situata presso il lago di Genezaret. La popolarità di Gesù cominciò a preoccuparlo quasi subito dopo la morte del Battista.
Fra le tante, una diceria riteneva che l'anima del Battista fosse risorta e trasmigrata nella persona di Gesù – cosa che rendeva quest'ultimo capace di compiere "prodigi".
In effetti, il popolo aveva stimato molto l'operato di Giovanni e non si rassegnava a dimenticarlo. Pur non avendo voluto Giovanni diventare un leader politico, non si voleva rinunciare a considerarlo al pari dei grandi profeti del passato, capaci di mettere in discussione l'apparente solidità dell'establishment oppressivo.
Per conservarlo nella memoria si era persino giunti ad assegnare al "sosia Gesù" delle capacità che il Battista, in vita, non aveva mai manifestato di possedere. Così facendo, non solo si costruiva attorno alla sua persona un vero e proprio "mito", ma allo stesso modo si negava a Gesù la specificità che gli competeva. Insomma, si "abbassava" uno per "alzare" l'altro, mentre proprio il Battista, dopo aver costatato il coraggio di Gesù in occasione della cacciata dei mercanti dal Tempio, aveva sostenuto la necessità del contrario (Gv 4,30).
Tale trasposizione non era poi così strana. Il "vangelo" di Gesù, per essere accettato, esigeva un cambiamento di mentalità superiore a quello richiesto dal "vangelo" di Giovanni: ecco perché si preferiva metterli sullo stesso piano. Per chi, tra il popolo, coltivava pregiudizi o false attese, Gesù non era che la mimesi di Giovanni, l'oggetto su cui poter costruire il proprio transfert e attenuare l'angoscia di un'istanza emancipativa frustrata, quella con la quale non si era stati in grado d'impedire l'esecuzione del grande profeta.
Giovanni non doveva morire. Se Erode aveva potuto ucciderlo, era stato perché non aveva incontrato una vera resistenza. Molti avevano riposto delle speranze concrete di liberazione nella figura profetica del Precursore e si attendevano che lui stesso, ad un certo momento, decidesse di diventare "messia". È vero ch'egli aveva sempre rifiutato un esito esplicitamente politico del suo vangelo, ma di fatto la sua morte era stata "violenta", voluta dal potere politico filopagano e non ostacolata da quello religioso collaborazionista. Era difficile credere che con la sua morte tutto fosse finito.
Chi pensava che i tempi non fossero ancora maturi per condurre la crisi istituzionale verso il suo naturale sbocco rivoluzionario, in quanto la fine ingloriosa del Battista metteva a nudo i limiti organizzativi di un cospicuo movimento, non poteva comunque ignorare che la decisione di Erode di sbarazzarsi di quello scomodo personaggio, stava appunto a dimostrare che esistevano sufficienti ragioni per un'opposizione più risoluta al suo governo.
v. 15) Altri invece dicevano: "È Elia"; altri dicevano ancora: "È un profeta, come uno dei profeti".
Alla luce della considerazione storica, la seconda voce corrente su Gesù era meno importante, in quanto, pur essendo Elia l'archetipo ideale di tutti i profeti, di fatto Giovanni appariva, nel presente, come il più grande, come un maestro insuperabile. Per cui, equiparando Gesù a Elia si poneva Gesù al di sotto del Battista, fraintendendo maggiormente il suo messaggio politico.
L'equazione "Giovanni = Gesù" era, tutto sommato, più realistica, in quanto si lasciava sedurre meno dal fascino dell'utopia di quella di "Gesù = Elia". La morte del Battista lasciava forse presagire l'arrivo imminente del messia "glorioso"?
Viceversa, con la terza diceria riportata da Marco: "È uno dei profeti", sembra, per un momento, che ci si voglia allontanare dalla tentazione dell'utopia, ma il risultato appare ancora più avvilente. Non solo infatti viene rimossa qualsiasi istanza rivoluzionaria, ma si nega anche recisamente qualsiasi peculiarità al vangelo di Gesù, il quale diventa, per tale ideologia, un semplice "aiuto" mandato da Jahvè nel momento di maggior sconforto, come sempre si riteneva dovesse accadere al popolo d'Israele.
Nel suo presunto "buon senso", questa parte di popolo compie un'opera di demolizione, giungendo a dare del "messia Gesù" l'interpretazione più riduttiva.
v. 16) Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: "Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato".
Delle tre opinioni popolari (che schematicamente potremmo definire coi termini di ingenua, illusoria e scettica), Erode fa sua la prima. Si badi: non perché egli credesse in qualche "resurrezione dei morti" o "reincarnazione" che dir si voglia, ma semplicemente perché non poteva fare a meno di ascoltare le opinioni del popolo intorno alle figure politiche che più minacciavano il suo potere.
Egli non fa altro che appropriarsi della tesi più diffusa per volgerla a suo favore. Volente o nolente, infatti, Erode si sentiva legato alla persona del Battista, la cui morte, anzi, l'aveva reso ancora più tristemente famoso. Il Battista aveva lasciato dietro di sé un'impressione durevole. Erode aveva le sue buone ragioni per temere l'eventualità di una sommossa da parte dei discepoli e dei simpatizzanti di Giovanni.
Convalidando l'idea della trasmigrazione dell'anima, Erode, in un certo qual modo, contribuiva ad alimentare l'illusione dell'immortalità del Precursore, distogliendo così le masse dall'attribuire al movimento nazareno un'importanza superiore a quello battista.
Il fatto che la gente vedesse nel Cristo il Battista redivivo poteva essere usato, a giudizio di Erode, proprio per scongiurare l'eventualità di un'insurrezione conseguente all'esecuzione di Giovanni, che sicuramente era stata decisa con eccessiva disinvoltura (e ovviamente poteva anche servire per sminuire l'importanza del Cristo e del suo movimento).
E tuttavia, chi avrebbe potuto Erode trarre in inganno con questo "gioco delle parti"? Chi avrebbe potuto credere nelle "buone intenzioni" e nei "pentimenti" di un despota abituato a ragionare solo in termini di forza? Se egli ora conferma una superstizione popolare a favore di Gesù, onde cercare di evitare una sommossa per quello che aveva fatto a Giovanni, domani chi potrebbe impedirgli di decidere la morte dello stesso Gesù per favorire qualcuno il cui potere gli servisse da paravento? Non furono forse i farisei ad avvisare Gesù che quella "volpe" di Erode ad un certo punto cominciò a pensare che era meglio uccidere anche lui (Lc 13,31 s.)?
(torna su)11) Il mare della vita
Mc 3,7-35
Le folle al seguito di Gesù (vv. 7-12)
Saputo che erodiani e farisei avevano intenzione di "farlo morire", soprattutto perché violava continuamente il sabato con le sue guarigioni (stando almeno al vangelo marciano) e organizzava un movimento popolare ostile alle istituzioni, Gesù "si ritirò presso il mare coi suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea" (v. 7).
Le folle della Galilea sapevano mostrare riconoscenza e gratitudine: in un primo momento lo avevano cercato per le guarigioni, ma qui lo cercano perché avevano compreso che il suo coraggio di trasgredire il sabato e di contestare le autorità costituite andava premiato, andava protetto dalle insidie delle stesse autorità. Marco fa capire chiaramente che quanto più Gesù si esponeva alle accuse dei capi politico-religiosi, tanto più le folle che lo seguivano aumentavano di numero. La loro stessa consapevolezza politica cresceva.
Marco però, volendo distinguere queste folle da quelle non-galilaiche, afferma che ormai venivano da tutte le nazioni e da molte grandi città: Giudea, Gerusalemme, Idumea, Transgiordania (cioè la Perea), Tiro e Sidone; nazioni e città di varie tipologie: israelitiche, semi-pagane, totalmente pagane. Sembra che Marco abbia fatto l'elenco con l'intenzione di sottolineare le rispettive legittime priorità. Ma non è così. Di fronte a Gesù le scale gerarchiche dei valori spesso vengono rovesciate. Se quel che più conta è la disponibilità ad ascoltare il suo vangelo, non può avere molta importanza la posizione ufficiale di prestigio che ricopre questa o quella nazione e città. Basti pensare che se la prima nazione citata, in capo alle altre, è l'ortodossa Giudea, di fatto, gli avvenimenti in corso avvengono nella Galilea semi-pagana.
Le folle extra-galilaiche si recarono da lui – dice Marco – perché avevano sentito "ciò che faceva" (v. 8); esse cioè volevano approfittare del suo particolare potere di guarire i mali fisici (benché qui le guarigioni possano essere state usate dall'evangelista per censurare i suoi discorsi politici).
Tuttavia, nonostante questa considerevole differenza di atteggiamento, Gesù non rifiuta la propria disponibilità. "Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero" (v. 9). In effetti, ancora non riescono a comprenderlo per quello che egli vuole, faticano a capire il significato umano e politico del suo messaggio. Lo accettano, è vero, anzi lo esaltano come taumaturgo e, alcuni, dicono di riconoscerlo come "profeta", ma ancora non sanno scorgere in lui il "liberatore nazionale". La sua diversità di metodo e di contenuto dai tradizionali "messia d'Israele" è troppo marcata. Se fossero venuti come soggetti consapevoli del suo messaggio, e non solo come individui desiderosi di terapie, è da presumere ch'egli non avrebbe avuto bisogno di ricorrere all'espediente della barca: sia perché, verosimilmente, sarebbero stati di meno; sia perché, anche essendo in molti, non l'avrebbero schiacciato in quel modo.
Gesù comunque non si sottrae a questo tipo di folla, la quale, a differenza degli scribi e dei farisei, interpreti ed esecutori della legge, evita, così facendo, di precludersi la possibilità che lo si possa un giorno riconoscere per quello ch'egli veramente vuole realizzare. Certo, si tratta solo di una possibilità, giacché nessuna ricerca affannosa della terapia risanante può di per sé indurre a credere che, una volta ottenutola, si possa realizzare automaticamente nella persona la conversione della mentalità, ovvero la fiducia nella riuscita della rivoluzione.
Gesù da un lato permette che gli si gettino addosso affinché ottengano le guarigioni desiderate; dall'altro però non può non sapere che questo entusiasmo interessato un giorno potrebbe anche ritorcersi contro di lui. In quanto stratega della rivoluzione, Gesù sapeva che fino a quando l'ammirazione delle folle non si fosse trasformata in un assiduo impegno politico e umano, non avrebbe potuto contare pienamente sul loro appoggio.
Le folle tuttavia vanno educate, e il fatto di esaudire le loro richieste istintive, superficiali, può essere considerato come un metodo pedagogico per poter fare in seguito, con quelle stesse folle, cose ben più importanti. Non ha senso disprezzare le masse inconsapevoli, in attesa che maturino da sole.
Questo racconto però viene concluso – forse non da Marco – in maniera moralistica, mostrando cioè che l'unica liberazione possibile è solo quella "esorcistica", quella cioè in cui il riconoscimento del valore di Gesù è riferito alla sua presunta "divinità". È come se il redattore, per cercare di spiegare il così vasto afflusso di folle, avesse cercato di deviare l'attenzione del lettore dalle motivazioni politiche a quelle religiose, quelle per le quali la folla non è ancora pronta. Infatti sono solo gli "spiriti immondi" che lo riconoscono come "dio". Essi, "quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: Tu se il Figlio di Dio!" (v. 11). Col che il redattore esprime un giudizio fortemente pessimistico circa le capacità rivoluzionarie delle masse.
Le guarigioni quindi sembrano essere state usate secondo due motivazioni: censurare la reale attività politica del Cristo, rappresentare le masse popolari in una maniera negativa, in quanto interessate a meri favori personali.
Istituzione dei Dodici (vv. 13-19)
La scelta di un gruppo particolare di seguaci, ben addestrato e disciplinato, con funzioni di alta responsabilità morale e politica, partì evidentemente dall'esigenza di organizzare al meglio un movimento che andava progressivamente ampliandosi. L'immagine descritta da Marco è un po' idilliaca e carica di simbolismi (vedi ad es. la differenza tra "mare" – alla portata di tutti – e "monte", solo per i discepoli migliori; il numero stesso di "Dodici" ricorda troppo da vicino le tribù d'Israele per essere vero. È difficile pensare a un Cristo così legato al passato, quando il suo movimento, al contrario, voleva costituire una vera novità per il presente).
Molto suggestiva è l'espressione "chiamò a sé quelli che volle". Qui sembra che Gesù chiami non solo con "autorità" ma anche con "umana sensibilità", come se la sua vera forza fosse tutta interiore, spirituale. Qui l'identità e la differenza, l'intimità e la distanza si uniscono senza confondersi, si distinguono senza separarsi. Essi infatti – ha bisogno di specificare Marco, evitando di darlo per scontato – "andarono da lui". Se avessero aderito solo per motivi politici, non li avrebbe chiamati "vicino a sé", ma a una certa distanza, né Marco avrebbe precisato un'azione che, in questo caso, sarebbe stata ovvia (Luca infatti la pensa così in 6,13, e Matteo anche in 10,1). Siccome invece esiste un certo equilibrio tra "obbedienza" e "libertà", Marco è stato costretto a sottolineare che gli apostoli, stimolati dalla forza morale della sua personalità e convinti di poter contribuire, col loro impegno, a modificare la realtà esistente, scelsero liberamente di aderire alla sua chiamata.
Perché ne costituì proprio Dodici? La scelta di questo numero, che rappresenta un simbolo per la mentalità ebraica (dodici infatti erano i patriarchi che diedero origine alla storia del popolo ebraico, secondo il Genesi; dodici era state le tribù d'Israele, anche se al tempo di Gesù si erano ridotte a poco più di due): la scelta di questo numero, si diceva, è sicuramente nata in un ambiente giudaico-cristiano, allo scopo di dimostrare la continuità del cristianesimo rispetto all'ebraismo (al numero "dodici" gli ellenisti opporranno negli Atti il numero "sette").
Il Cristo qui viene considerato alla stregua di un "nuovo Mosè" (come nelle cosiddette "trasfigurazione sul monte Tabor" e "moltiplicazione dei pani"). È molto probabile che siano stati gli apostoli stessi a darsi, dopo la morte di Gesù, un'identità del genere, al fine di superare la crisi dell’originario progetto politico-rivoluzionario: essi cioè avranno cercato di valorizzare, con questo numero, il significato profetico-evocativo del suo vangelo, ponendo dei paralleli con la storia dell'antico giudaismo. Gli apostoli stessi potevano così vantare, agli occhi della comunità primitiva, una specie di rango equivalente a quello dei vecchi patriarchi.
Al massimo dunque si deve pensare che alcuni discepoli vennero incaricati da Gesù di assumere un particolare ruolo di responsabilità (politico-organizzativa e ideologica) nell'ambito del movimento nazareno, già abbastanza esteso. Naturalmente con tale incarico Gesù avrà tenuto conto non solo delle esigenze organizzative del movimento, ma anche della serietà rivoluzionaria dei discepoli scelti. In questo caso è da escludere che abbiano influito fattori estrinseci quali lo stato civile, la condizione sociale, professionale, economica, culturale, ecc. degli interessati. La differenza tra "discepolo" e "apostolo" stava semplicemente nel fatto che il primo soprattutto "imparava", mentre il secondo aveva anche il compito di "insegnare" (cioè dirigere, sensibilizzare, propagandare, attivare le forze del movimento). L'apostolo non rappresentava soltanto il riconoscimento da parte di Gesù di un'attività politica svolta con molta dedizione e sacrificio, ma rappresentava anche la possibilità di un impulso ulteriore allo sviluppo qualitativo e quantitativo del movimento.
Interessante altresì è il fatto che nell'istituzione dei Dodici, Marco non pone alcuna differenza di rango o di privilegio fra un apostolo e l'altro. Il collegio viene costituito da una sola persona, in uno stesso momento, in maniera pubblica, usando un'unica modalità di selezione e per uno scopo al quale esso era chiamato nella sua interezza. Gesù non chiamò all'apostolato uno o due discepoli delegando ad essi il compito di cooptarne altri.
Sul piano della "legittimità" (oggettiva) l'organo era perfettamente democratico, anche se questo implicava il riconoscimento di Gesù quale guida principale del movimento (in fondo il fatto che esista una "guida principale" non implica la presenza di elementi "autoritari" o "monarchici" all'interno del movimento, né il fatto ch'esistesse un "collegio" implicava la presenza di elementi "aristocratici". Monarchia e aristocrazia esistono quando gli esponenti di queste due forme di governo non possono essere rimossi dal popolo, anche quando le loro azioni sono ingiuste. Una volta affermato il principio della revocabilità, la democrazia, almeno in teoria, è più facilmente garantita).
Soltanto sul piano del "merito" (soggettivo) potevano sussistere delle differenze intracollegiali, il cui valore, naturalmente, andava messo costantemente in rapporto a circostanze particolari di tempo e di luogo. In alcuni casi l'apostolo Giovanni viene definito "prediletto", in altri viene severamente rimproverato; così è per Giacomo, Pietro, ecc. Spesso infatti si nota nei vangeli che la pariteticità dei ruoli, cioè l'assenza di gerarchie formali, non implica di necessità l'unanimità d'intenti. Forti polemiche spesso si verificheranno sia fra gli apostoli che fra questi e Gesù.
Che nessun apostolo, singolarmente inteso, potesse rappresentare gli altri (negando agli altri tale facoltà), ma che tutti insieme si autorappresentassero in quanto "comunità particolare", al servizio dell'intero movimento, è dimostrato anche dalla sostituzione che si operò nei confronti di Giuda suicida. Negli Atti degli apostoli è chiaramente espressa l'idea che l'istituzione degli apostoli è superiore alla volontà del singolo apostolo. Questo a prescindere dal fatto che proprio in questo testo si presenti dapprima un collegio perfettamente unanime e subito dopo ci si limiti a descrivere l'attività di un solo apostolo: Pietro.
Sarà dopo la morte di Gesù che gli apostoli cominceranno ad avvertire la possibilità di diventare superiori a tutto il movimento nazareno. Tuttavia gli ellenisti (cioè i discepoli cristiani di origine ebraica ma di cultura greca) contesteranno la pretesa dei Dodici di considerarsi come una casta privilegiata (una sorta di aristocrazia politico-religiosa, nettamente al di sopra del movimento cristiano post-pasquale).
Gli ellenisti, guidati da Stefano, cercheranno di emanciparsi dalla soffocante egemonia del collegio, il quale reagirà mostrando, con l'istituzione della "cresima", chiare tendenze alla burocratizzazione. La cresima infatti era una sorta di sacramento di "controllo" di un altro sacramento, che ogni fedele poteva liberamente impartire: il battesimo.
Negli Atti appare chiarissima la preoccupazione degli apostoli di salvaguardare la loro leadership su tutto il movimento, emarginando le forze che apparivano troppo politicizzate o poco concilianti col potere giudaico (come appunto gli ellenisti, che, prima ancora degli ebreo-cristiani di Gerusalemme, avevano rinunciato a qualunque rivendicazione politico-nazionale). Non a caso negli Atti chi svolge questa funzione di controllo è soprattutto Pietro, condivisa per un brevissimo tempo da Giovanni (8,14).
I compiti dei Dodici sono riportati da Marco in ordine d'importanza: 1. stare vicini a Gesù (cioè aiutarlo a dirigere e organizzare il movimento) e 2. andare a predicare, ampliando il movimento il più possibile. Il terzo compito: guarire gli ammalati o esorcizzare, è stato aggiunto semplicemente per far assomigliare gli apostoli al "Cristo della fede". Così facendo, il redattore pensò di fare un favore agli apostoli o all'idea della divinità del Cristo, senza rendersi conto che, sul piano politico, le terapie risananti erano per Gesù assai poco rilevanti, ammesso e non concesso che le abbia davvero fatte.
Gli apostoli – da quanto si può dedurre – non avevano nulla in comune coi successivi "vescovi" o "presbiteri": non tanto perché – come vuole la chiesa stessa – erano un gruppo a sé, unico e irripetibile, testimoni diretti, oculari, del Cristo e della sua cosiddetta "resurrezione", sostanzialmente "itineranti" nella vocazione; quanto piuttosto perché essi non avevano alcun compito religioso o sacramentale o ecclesiastico da svolgere. Questi aspetti sono subentrati appunto per sostituire le originarie funzioni politico–organizzative del movimento, che, fallito l'obiettivo rivoluzionario, furono progressivamente smantellate.
*
Gesù chiamò all'apostolato secondo l'importanza che questi discepoli, in quel preciso momento, avevano. Lo si comprende da una serie di ragioni:
– Andrea, pur essendo fratello di Simone e citato da Marco sempre al suo fianco, ora è posto dopo i figli di Zebedeo; quindi Marco non ha tenuto conto che Andrea era stato il "protoclito" (primo chiamato) – come vuole il vangelo di Giovanni (1,40) –, e che proprio lui aveva convinto il fratello Simone a seguire Gesù (Gv. 1,41 s.). Se Marco avesse preso in considerazione la precedenza cronologica o la semplice anzianità del rapporto con Gesù, l'elenco sarebbe stato ordinato secondo una motivazione estrinseca e formale.
– Pietro, Giacomo e Giovanni appaiono come una triade a se stante, differenziata da tutti gli altri; non tanto perché occupano i primi tre posti, quanto perché solo ad essi Gesù ha voluto imporre dei soprannomi (il che fa venire in mente le esigenze della clandestinità). I significati di "pietra" e di "tuono" paiono equivalenti, giacché entrambi sono segno di forza morale e intellettuale: forse la parola "pietra" può essere associata a un certo "schematismo ideologico" caratterizzante la personalità di Pietro. Da notare che nella Lettera ai Galati, Paolo fa capire, citando le "colonne" della chiesa, che il più importante, ai suoi tempi, era Giacomo, detto il Minore (uno dei fratelli di Gesù, non il fratello del quarto evangelista), cui seguivano Pietro e Giovanni (2,9). L'ideologia spiritualista di Paolo emerse quando nell'ambito della comunità giudaico-cristiana dominava l'indirizzo conservatore di Giacomo il minore.
– Giuda, il traditore, è stato messo per ultimo, a fianco di Simone il cananeo o lo zelote, cioè il sovversivo estremista, il terrorista pentito. È probabile che anche Giuda facesse parte di questo movimento, ma non è da escludere ch'egli fosse appartenuto all'ala progressista del partito farisaico giudaico. Marco non ha mai potuto scrivere la parola "zelote" perché ai suoi tempi l'associare questo movimento a quello nazareno non avrebbe giovato alla causa del cristianesimo nascente, tutto preoccupato a non farsi perseguitare da Roma per motivi politici. Luca, che scrive dopo circa un decennio dalla stesura del vangelo di Marco e rivolgendosi a un pubblico diverso, ha meno problemi nel citare nel suo elenco il titolo politico di "zelote" (anche perché era sicuro che il significato originario di questa parola ormai non lo si conosceva più).
A proposito di Giuda: Marco dice subito ch'egli tradirà Gesù non solo per dimostrare che la cosa era prevista dalla "prescienza divina" (o dalle profezie veterotestamentarie), ma anche per distinguerlo dall'altro Giuda, detto Taddeo. Sulla questione del tradimento ci sarebbe un lungo discorso da fare. Qui si può soltanto affermare che l'ipotesi di un tradimento non può mai essere scartata a priori all'interno di una comunità politica, per cui la previsione non può certo essere considerata come una prova della divinità del Cristo. Il fatto poi che Gesù avesse umanamente previsto ed anche tollerato il tradimento, non sta certo ad indicare la sua disponibilità alla morte inevitabile, necessaria, redentrice per tutto il genere umano, gemente – secondo l'interpretazione paolina – sotto il peso del peccato d'origine, né sta ad indicare un'esigenza che Gesù poteva avere di voler confermare a tutti i costi le Scritture (il che sarebbe davvero fantasioso, anche perché le profezie sono state utilizzate dai primi cristiani a posteriori, quando la crocifissione era già avvenuta). Gesù probabilmente ha voluto soltanto insegnare ai Dodici che l'appartenenza alla comunità era libera, cioè non vincolata da alcunché che non fosse la propria coscienza.
L'impegno cui Gesù chiamò ad un certo punto alcuni suoi discepoli, non voleva configurarsi come un dovere che si poneva sopra o contro la loro volontà: si trattava, più semplicemente, di una proposta di lavoro politico e organizzativo da assumersi con maggiore responsabilità. L'adesione doveva essere libera e spontanea e tale doveva rimanere anche dopo averla data. Gli apostoli non sono stati scelti da Gesù a caso né perché predestinati da qualche fattore costringente. Quando si deciderà di sostituire Giuda Iscariota, lo si farà in maniera democratica.
Talune posizioni, ideologiche e politiche, all'interno del movimento (o dello stesso collegio), potevano essere maggioritarie e minoritarie, ma questo non impediva assolutamente che il dibattito e il confronto dialettico continuassero e s'approfondissero. Nessuno, nel movimento nazareno, è mai stato "scomunicato". Il principio stesso dell'appartenenza non vincolata garantiva che nessuna defezione o nessun tradimento sarebbe stato oggetto di rappresaglia (anche se non è da escludere che il suicidio di Giuda sia stato messo per coprire una vendetta da parte di qualcuno degli Undici).
Gesù aveva intenzione di edificare un movimento libero, cosciente e responsabile, libero anche di dividersi e disgregarsi. L'unità infatti non può essere garantita da una qualche forma di costrizione: l'unica ammissibile è quella secondo cui la minoranza è tenuta a rispettare, dopo ampio dibattito, la volontà della maggioranza che di volta in volta si costituisce (nel senso che a una minoranza va sempre data la possibilità di trasformarsi in maggioranza). In questo senso, si può aggiungere, il tradimento di Giuda non avrebbe potuto intaccare tanto i princìpi della comunità quanto le finalità o gli scopi ch'essa si prefiggeva (quando una persona tradisce si pone, essa stessa, "fuori" della comunità).
L'elenco dunque è stato fatto da Marco alla luce della diversa disponibilità che, in quella determinata circostanza, gli apostoli avevano nei confronti del progetto di Gesù (questo anche considerando la tendenziosità dei vangeli in generale: basti p. es. pensare che mentre nei Sinottici l'apostolo più importante è sempre Pietro, nel quarto vangelo è sempre Giovanni, pur non essendo mai riportato il suo nome; nell'elenco di Matteo e Luca prima dei fratelli Zebedeo viene messo Andrea, fratello di Pietro; Giovanni, Andrea e Filippo, discepoli del Battista, sono sempre citati fra i primi posti; dei due figli di Zebedeo, probabilmente Giacomo, più anziano di Giovanni, doveva essere il più impegnato, ma stranamente di lui non sappiamo quasi nulla, se non che nel 44 circa fu catturato per ordine del re Erode Agrippa e messo a morte.
Il fatto che Pietro venga sempre citato per primo non vuol dire che al tempo dell'attività di Gesù fosse più importante di Giacomo o di Giovanni (Giacomo, p.es., è sempre citato per secondo, ma nei vangeli canonici non viene mai ricordato per qualcosa di particolare che abbia fatto, e quando lo è, insieme a Giovanni, in genere è per denigrarlo. Lo stesso si potrebbe dire di Andrea: è il protoclito, ma, pur essendo fratello di Pietro, di lui non si quasi nulla). È quindi probabile che Pietro appaia per primo perché fu la sua interpretazione della tomba vuota che divenne dominante. Il fatto che poi lui fosse galileo ha comportato una ulteriore emarginazione degli apostoli provenienti dalla Giudea.
Nel quarto vangelo risulta che l'importanza dell'evangelista Giovanni, nell'ambito del movimento nazareno, era assai superiore a quella di qualsiasi altro apostolo, per quanto appaia inverosimile che Giovanni scriva di se stesso d'essere il "prediletto". Probabilmente questo appellativo è stato messo per evidenziare che la linea seguita dalla comunità apostolica con a capo Pietro e soprattutto Giacomo il minore, non era condivisa da Giovanni.
Negli Atti Giovanni appare all'inizio con Pietro, ma non pronuncia alcun discorso e scompare di scena quasi subito. Giovanni probabilmente è stato vittima di una progressiva emarginazione in seno alla comunità apostolica, tant'è che quando è apparso il suo vangelo, una comunità ellenistica (di tendenza gnostica) s'è subito preoccupata di falsificarlo in maniera spiritualistica, impedendo così di far scorgere le vere differenze tra la sua posizione e quella degli altri apostoli.
Da notare che nell'elenco fornito da Luca in At 1,13, Giovanni viene posto subito dopo Pietro e prima del fratello Giacomo. Se dovessimo attenerci strettamente al vangelo di Giovanni, dovremmo dire che nell'elenco degli Atti si è consumato una sorta di "tradimento", poiché il Cristo sulla croce lasciò chiaramente intendere che il suo diretto successore alla guida del movimento avrebbe dovuto essere Giovanni e non Pietro (Gv 19,26 s.).
Anche sugli apostoli minori vi sono talune considerazioni da fare: Bartolomeo (o Natanaele), amico di Filippo, viene da Gesù stesso considerato "onesto" (Gv 1,47), cioè "leale", che allora voleva dire anche "fervente patriota". Tommaso, detto Didimo (cioè il Gemello), è affiancato a Matteo, che era un pubblicano. Giacomo di Alfeo, il minore, fratello o – come vogliono i cattolici – "cugino" di Gesù, ha scritto una lettera che è un manifesto di "giustizia sociale", ma all'interno di un'ottica meramente ebraico-nazionalista. A lui Marco ha associato il fratello Giuda Taddeo, detto anche Lebbeo, di cui non sappiamo praticamente nulla, se non che è l'autore di una lettera cattolica. Questa coppia è senz'altro il polo verso cui tende maggiormente Simone lo zelote, il quale però può anche essere avvicinato a Giuda, se "Iscariota" sta per "sicario" e non per una località geografica della Giudea (Kariot).
Molto significativo è il fatto che i discepoli per i quali la politica è "tutto", vengono posti in fondo all'elenco. La differenza tra questi apostoli e i primi in elenco stava probabilmente nel fatto che la triade suddetta aveva maggiori capacità di unire gli aspetti umani a quelli politici, anche se nel contesto dei vangeli la differenza viene fatta risalire, in realtà, a motivazioni di ordine religioso.
I parenti di Gesù (vv. 20-21)
Alcuni parenti di Gesù (inclusi i familiari stretti, ovviamente), sentito che, sballottato da gente avida soprattutto di terapie mediche, egli neppure riusciva a mangiare, vennero da Nazareth di Galilea per riportarlo a casa. "Si diceva" (o loro stessi "dicevano") ch'era diventato pazzo. Preoccupati della reputazione del casato e della sicurezza di tutto il parentado, essi vogliono impedire che Gesù, con le sue azioni, possa infastidire le autorità costituite. L'atteggiamento dei parenti è molto prudente: si fanno più scrupolo delle voci contrarie all'operato di Gesù che non della meraviglia del vasto movimento che in così poco tempo s'era costituito.
Questi parenti non entrano nel merito delle accuse: sulle cause della presunta follia tacciono, non esprimono giudizi, ma il loro atteggiamento parla da sé. Non vogliono rischiare in alcun modo di rimanere implicati in questa faccenda: perciò, facendosi forza della solidità dei rapporti tra consanguinei (cosa peraltro normale nella Palestina d'allora), decidono, spinti in questo anche da gruppi di persone opportuniste, non di andare a interloquire con lui, ma, in un certo senso, di "sequestrarlo". Già da tempo, probabilmente, avrebbero voluto farlo: ora è la vastità stessa del movimento che li obbliga a intervenire.
Il motivo per cui lo vanno a prendere non è tanto quello della "pazzia", in senso stretto, quanto il fatto ch'egli tende a esporsi troppo, mettendosi in evidenza, andando inevitabilmente incontro – com'era facile in quel paese votato, allora, alla politica più dura – a conseguenze che potevano essere spiacevoli non solo per lui ma anche per tutto il parentado.
Probabilmente essi avrebbero voluto che la gestione del suo potere taumaturgico rimanesse circoscritta nel loro unico distretto o addirittura nella mera città di Nazareth, alla stregua di una "pazzia" sui generis, inoffensiva, anzi per certi aspetti utile, in quanto risanante molte malattie: una specie di "grazia" particolare che dio aveva misteriosamente concesso loro, forse al fine di sopportare meglio l'oppressione romana; una grazia comunque che non avrebbe dovuto comportare nulla di rischioso o di compromettente. Ancora non siamo giunti a quella situazione, così bene descritta da Giovanni, in cui i parenti di Gesù esigono, proprio in virtù della sua ascendenza sulle masse (indipendente da qualunque guarigione), una loro affermazione pubblica come "gruppo parentale" (7,3 s.).
Qui invece, dopo aver atteso che qualcuno proclamasse e divulgasse la sua "follia", essi sono andati a sottrarlo, senza voler provocare grossi traumi all'esaltazione, ormai irrefrenabile, della folla, la quale, di fronte alle necessità "d'onore" del casato, pur restia ad ammettere la pericolosità d'un pazzo che sana e guarisce ogni malato, nulla avrebbe potuto.
L'ostilità dei parenti di Gesù è attestata da Marco anche in un altro episodio (6,1-6). Gesù era tornato nella città di Nazareth dopo molti mesi di assenza. Uno stuolo di discepoli lo seguiva. Con loro entrò in una sinagoga e si mise ad insegnare. Si scandalizzarono della sua predicazione e delle sue guarigioni non solo i parenti più lontani ma anche i familiari più stretti. Lo scandalo fu talmente grande che Gesù lo qualificò con la parola "disprezzo": la conseguenza fu che lì non poté operare "alcun prodigio", cioè alcuna guarigione veramente significativa. Si limitò semplicemente a "imporre le mani a pochi ammalati", come un qualunque taumaturgo.
Tuttavia Marco non spiega le ragioni profonde di questa incredulità di fronte alle sue terapie (che evidentemente qui sono state messe sul piano redazionale per nascondere il suo successo come leader politico): l'evangelista sembra addebitarle, indirettamente, alla natura delle cose, alla inevitabilità dei fatti. La mentalità gretta, chiusa e provinciale dei parenti di Gesù – così si deduce dal testo di Marco – è "fisiologica". Gesù se ne meraviglia, ma non più di tanto. Il che è davvero singolare, anche alla luce di quello che invece Giovanni, come sopra si è detto, sostiene; senza considerare che fra gli stessi apostoli v'erano alcuni parenti di Gesù e che proprio questi parenti guideranno la comunità post-pasquale, dopo la dipartita di Pietro da Gerusalemme.
Gesù giustifica l'incredulità rievocando un'espressione famosa: "Un profeta non è disprezzato che nella sua patria". Col che Marco lascia pensare che semplici sentimenti d'invidia o di gelosia si siano frapposti tra Gesù e i parenti, al punto d'impedire un'intesa morale, politica (Marco direbbe "religiosa"). I parenti cioè non riuscirebbero ad accettare l'idea che un ex-carpentiere possa ora fare da "maestro" o da "guida" di un grande movimento nazionale. Il provincialismo si manifesterebbe qui in una sorta di sfiducia nei riguardi dell'identità di Gesù, nel valore del suo progetto politico, che viene minimizzato.
Tuttavia, Giovanni, nel suo vangelo, fa capire meglio perché i parenti non capivano Gesù, cioè perché non lo seguivano com'egli avrebbe voluto. Il loro torto non stava tanto nel provincialismo quanto, al contrario, nell'avventurismo. L'avventurismo è infatti il modo in cui il provincialismo cerca di superare, spinto dagli avvenimenti, i propri limiti. Avventurismo e provincialismo sono le facce di un'unica medaglia: quella del soggettivismo. Solo a un individuo poco avvezzo al realismo politico può venire in mente, come soluzione del proprio provincialismo, quella di buttarsi a peso morto in un'impresa velleitaria.
Gesù infatti, alla richiesta che gli muovevano di andare a Gerusalemme in occasione della festa delle Capanne, esponendosi pubblicamente (Gv. 7,3 s.), risponde loro: "Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto" (Gv. 7,6). Che significato può avere questo, senza stare a scomodare le allusioni mistico-religiose? Semplicemente che per fare la rivoluzione occorre tattica, strategia, consapevolezza della crisi e organizzazione del movimento, e non spontaneismo e demagogia. A che servirebbe essere "visti" dal mondo intero, se poi non si saprà quale contenuto dare al desiderio di liberazione delle masse?
Infine non va esclusa l’ipotesi che nel vangelo marciano si metta in così cattiva luce la madre di Gesù, perché questa, dopo la morte del figlio, preferì stare vicina a Giovanni, evitando la comunità petrina, cui peraltro avevano aderito gli altri suoi figli, in particolare quel Giacomo il Minore che sostituirà Pietro nella guida della comunità cristiana di Gerusalemme.
Calunnie degli scribi (vv. 22-30)
"Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni".
Marco parla degli scribi di Gerusalemme con l'intenzione di dire non che "tutti" gli scribi della Palestina la pensavano allo stesso modo, ma che, di tutti gli scribi, quelli della capitale o, per meglio dire, quelli legati al potere istituzionale, avevano di Gesù l'impressione più sfavorevole.
Naturalmente il giudizio che su di lui potevano dare, sarebbe stato tenuto dal popolo in una certa considerazione, visto il potere che rappresentavano, per quanto la vastità del movimento nazareno stesse mettendo in seria discussione l'autorità delle istituzioni giudaiche. Qui è evidente che gli scribi rappresentano una delegazione mandata ufficialmente dal Sinedrio per verificare il grado di pericolosità del movimento, nonché il grado di disponibilità al compromesso politico da parte del suo leader principale.
L'accusa degli scribi non è così stravagante come a prima vista può sembrare: anzitutto perché nei casi di pazzia si riteneva, unanimemente, che il demonio avesse la sua parte; in secondo luogo perché, quando si è abituati a ragionare in termini di mero "potere politico", è difficile collegare la facoltà di guarire con i buoni propositi del terapeuta, specie se questo terapeuta è tenuto in grande considerazione dalle masse anche per il suo progetto di liberazione sociale e nazionale. Non a caso, costatando l'effettiva grandezza di tale facoltà terapica, unitamente alla grande popolarità che circondava il movimento nazareno, gli scribi attribuivano il successo di tutto non a un demone qualunque ma al "principe dei demoni" (secondo la mitologia di allora). Gesù cioè non sarebbe stato semplicemente un impostore, ma un "superindemoniato", in quanto, scacciando i demoni minori, cercava d'indurre al male gli ingenui e gli sprovveduti.
Normalmente chi aveva poteri taumaturgici godeva di buona reputazione, almeno fra la gente comune. E in ogni caso la sua attività non suscitava particolare dissensi fra i ceti elevati e le autorità politico-religiose (a parte le terapie compiute di sabato). Perché dunque questa dura ostilità, questa chiusura pregiudizievole?
Le ragioni possono essere state due: 1. Gesù, guarendo, non ricalcava i metodi tradizionali e quindi sfuggiva ai consueti canoni interpretativi. Egli infatti non sanava in nome di dio, usando scongiuri o particolari strumenti medico-sanitari. Egli agiva per virtù propria, con relativa facilità e senza chiedere nulla in cambio. 2. La seconda ragione era più fondata. Gli scribi temevano che Gesù volesse servirsi delle sue terapie per acquisire un consenso popolare che poi avrebbe potuto utilizzare per uno scopo politico sgradito al potere ufficiale.
L'attività di Gesù, essendo ormai nota in tutta la Palestina, non permetteva più alle autorità di restare indifferenti. Le alternative, ormai, erano diventate due: o si ammetteva l'onestà di fondo del guaritore-Gesù, ma allora ci si doveva confrontare anche col suo messaggio politico di liberazione; oppure lo si doveva accusare esplicitamente di ciarlataneria, ridicolizzando la portata delle sue terapie, minando altresì la credibilità del suo vangelo. Gli scribi, infatti, entrando nel merito della sua presunta follia, la giudicano incurabile e assolutamente incriminabile; per screditarlo fanno leva sulle paure istintive della folla, sui pregiudizi, sull'ignoranza, sulla superstizione. Il potere, temendo di essere giudicato, si difende attaccando: evita risolutamente di confrontarsi in modo dialettico.
Naturalmente non è affatto da escludere che in questione non fossero le sue guarigioni ma, in realtà, le sue parole contro la corruzione dei sacerdoti e il loro servilismo nei confronti di Roma, già dette peraltro durante il periodo giudaico. Qui, anche se a un vangelo "galilaico" e "antisemita" come quello marciano poteva far comodo metterle, il fatto ch'esse preludessero a un'organizzazione di tipo politico-rivoluzionario, era motivo sufficiente per tacerle.
In ogni caso Marco sostiene che Gesù chiamò gli scribi in pubblico, per un colloquio diretto, personale, senza alcuna intenzione offensiva, soltanto per dimostrare, con tolleranza e persuasione, il loro errore interpretativo, il loro pregiudizio. Gesù chiedeva solo di misurarsi democraticamente col potere istituzionale: ciò di per sé non sarebbe potuto bastare per dimostrare l'effettiva onestà dei propri fini, poiché non c'è ragione che possa convincere chi non vuole intendere, ma almeno sarebbe servito a chi ancora nutriva dei dubbi circa il suo operato. Gesù non usava i toni moderati e concilianti con la speranza di avere il "potere" dalla sua parte: certo, questa possibilità, benché altamente improbabile, non bisognava mai darla per persa. Ma la sua preoccupazione era più che altro di tipo pedagogico: dimostrare ai suoi seguaci in che modo rapportarsi con le istituzioni.
E così "parlava loro in parabole", cioè senza polemica, senza spirito di contrapposizione forzata, ma nella piena consapevolezza di costruire un'alternativa, quella che l'intolleranza del potere scriba obbligava a proporsi in maniera velata, ambigua. Non è che, parlando in parabole, Gesù possa dimostrare con evidente certezza di non essere pazzo o criminale: certezze di tal genere non si possono mai offrire in assoluto. Ci sono sempre dei maniaci che nascondono la loro follia dietro le metafore o le allegorie del loro linguaggio; ci sono sempre dei lupi che indossano i panni degli agnelli.
Gli scribi però avrebbero dovuto capire che Gesù poteva anche approfittare della sua popolarità per riprenderli in modo esplicito e diretto, senza alcuna forma di diplomazia. Parlando invece in parabole, egli, in un certo senso, si nascondeva, non per timore d'essere scoperto, ma per dare il tempo agli scribi di ripensare i giudizi di condanna e riprovazione che avevano formulato.
D'altra parte Gesù non ha mai diretto il suo vangelo contro i vizi di legittimità del potere giudaico, senza tener conto dei vizi di merito di questo potere. Il dialogo con gli scribi lo accetta sempre, non lo rifiuta mai a priori, pur conoscendo la loro indisponibilità a mettersi in discussione. Gesù non ha mai cercato di condannare il Sinedrio in sé e per sé, a prescindere dalle sue posizione politiche, di volta in volta espresse; in fondo l'uso delle parabole stava anche ad indicare il rifiuto della politica estremistica, anarchica, velleitaria.
"Come può satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso quel regno non può reggersi". Gesù qui usa il loro stesso linguaggio, ma per capovolgerne il significato. Per gli scribi il "bene" che Gesù compie, guarendo gli ammalati, è strumentale a un fine politico eversivo, cioè contrario agli interessi veri della nazione. Ecco, in questo senso, il verbo "scacciare" avrebbe per gli scribi un significato diverso da quello che gli ha voluto dare Gesù, avrebbe cioè il significato di un'operazione tattica, temporanea, di dubbio valore.
Che cosa vuole dire "regno diviso"? Gesù non vuole negare che anche il male sia capace di una certa coerenza, ma vuole sostenere che l'alienazione insita nell'esperienza del male, prima o poi viene alla luce. Il male può camuffare le proprie azioni, ma non in eterno.
Gesù in pratica fa capire che se il potere non comprende che le sue azioni sono per un fine di bene, è perché è "diviso" in se stesso; quindi non lui divide la società, ma è il potere che separandosi dalla società, la manda in rovina. Qui gli scribi accusano Gesù di destabilizzare il potere, ma Gesù risponde che se il potere non sa scorgere nelle azioni ch'egli compie un fine di "bene" per la società, è perché esso stesso si contrappone alla società. Se il potere odia i suoi figli, i suoi figli lo rovesceranno.
Il terrore degli scribi è quello che Gesù, con l'aiuto delle masse, voglia distruggere il potere giudaico, quel potere che, in virtù di mille compromessi con l'imperialismo romano, si regge in piedi con incredibile fatica. I loro timori, in un certo senso, sono fondati: Gesù vuole effettivamente distruggere la realtà di questo potere. Ma si tratta della distruzione di un potere "alienante", in quanto "separato" dalla fiducia delle masse. Gesù non vuole soltanto indebolire un potere già logoro e corrotto, vuole anche costruirne uno alternativo, che si basi sull'unità della nazione.
"Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi". C'è solo un modo, infatti, per resistere all'oppressione straniera: l'unità nazionale, la rinuncia ai vergognosi compromessi con l'impero. "Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire". Cioè se il potere giudaico rifiuta l'unità nazionale e non cerca di risolvere le rivalità interetniche e tribali, il suo destino è segnato, poiché la società ormai è sufficientemente matura per darsi un'altra forma di potere.
"Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa". Il tempo del potere giudaico sta per finire: la sua forza è solo apparente. Gesù non predica qui la conquista della casa, cioè del potere, in modo astratto, velleitario, ma si preoccupa anzitutto di affermare che "l'uomo forte" va catturato, cioè il potere giudaico va conquistato con la forza rivoluzionaria, in quanto tale potere non acconsentirà mai di essere rovesciato democraticamente. Non è sufficiente tenere la casa sotto controllo o limitarsi a circondarla: bisogna sfondare la porta e catturarne il proprietario. Queste parole sono quanto di più rivoluzionario Cristo abbia mai affermato in questo vangelo.
Il finale della pericope è stato aggiunto per smorzare il contenuto fortemente eversivo delle parole appena dette. "In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna. Poiché dicevano: È posseduto da uno spirito immondo".
L'accusa di Cristo, che era di tipo politico, anche se espressa con la formula diplomatica della parabola, è stata qui trasformata in un'accusa di tipo morale. Gli scribi meritano d'essere condannati perché negano l'evidenza, rifiutando la verità delle cose. La loro falsità è senza remissione. In realtà Gesù non esprimeva un giudizio di condanna morale: invitava soltanto a riflettere, a considerare cioè il fatto che contro il potere imperialistico dei Romani era indispensabile l'unità nazionale, la stretta coordinazione fra istituzioni e popolo.
C'è inoltre da dire che con l'ultima frase – chiaramente aggiunta al testo originale – si vuol togliere al Cristo la caratteristica d'essere un leader politico. Stando ad essa, gli scribi accusavano Gesù di "pazzia", senza il minimo riferimento alle questioni politiche. Viceversa, il concetto di "bestemmia antipneumatica" sembra rimandare a una concezione di Gesù teologo o filosofo (analoga a quella del vangelo manipolato di Giovanni). In questo caso gli scribi meriterebbero la condanna, perché si sarebbero rifiutati di accettare l'evidenza di una verità religiosa. Essi sarebbero colpevoli di un "peccato eterno", senza remissione, avendo attribuito al "male" delle opere di bene: le guarigioni.
La madre e i fratelli di Gesù (vv. 31-35)
"Giunsero sua madre e i suoi fratelli": anche loro da Nazareth o da Cafarnao? Giuseppe non è citato, forse perché già morto: qui sembra trattarsi di parenti più stretti di quelli visti in precedenza, oppure può trattarsi di un secondo tentativo degli stessi parenti, condotto però con una diversa modalità (forse l'unica eccezione è la presenza della madre di Gesù).
"E stando fuori, lo mandarono a chiamare". L'espressione "stando fuori" può essere intesa in due modi: 1. fisico, nel senso che non entrarono in un determinato luogo (ove Gesù era presente insieme ai discepoli e alla folla); 2. morale, nel senso che non vogliono compromettersi. Infatti, lo mandano a chiamare tramite un intermediario, uno che non fa parte del parentado, ma è al seguito del movimento di Gesù.
Le intenzioni di questi parenti sono meno intuibili di quelle degli altri visti prima, venuti a prenderlo perché lo si pensava "pazzo". Maria e i fratelli lo cercano: più che per "prenderlo", sembra siano venuti per "parlamentare". Lo mandano a chiamare per avere delle spiegazioni e dei chiarimenti direttamente da lui. Vogliono convincerlo con le buone maniere, probabilmente perché egli era riuscito a "sfuggire" al sequestro intentato dal gruppo precedente di parenti (o da un gruppo di parenti più esagitati).
"Tutto attorno era seduta la folla". I parenti rifiutano di entrare in questa assemblea, anche perché hanno intenzione di convincere Gesù a uscirne, abbandonando definitivamente tutto e tutti. Da un lato i parenti temono di restare coinvolti nell'accusa di follia o di eversione politica che pesa su Gesù e su tutto il movimento, dall'altro pretendono di far valere i loro diritti parentali, ponendosi al di sopra delle esigenze del movimento stesso.
Maria e i parenti rappresentano qui la posizione politica moderata, disposta al compromesso sulle questioni di principio. Lo si vede molto bene dal fatto che lo mandano a chiamare attraverso un intermediario.
"E gli dissero: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano". Se qui, coi termini "fratelli e sorelle", Marco intendeva riferirsi ai figli di Maria e Giuseppe, allora si può anche pensare che questi parenti siano più stretti di quelli precedenti. In ogni caso la decisione di "star fuori" e la pretesa di un'udienza poggiano sul cosiddetto "vincolo di sangue". I parenti di Gesù fanno valere chiaramente il concetto di "clan". Le loro intenzioni non sono molto diverse da quelle degli altri parenti: sono soltanto espresse con meno impulsività, con più tatticismo, ma appunto perché possono far leva su un più diretto legame di sangue.
Nel racconto di Marco si ha addirittura l'impressione ch'essi interrompano un'assemblea in atto, per farsi annunciare da un individuo (a noi sconosciuto) della folla. Essi s'intromettono in modo arbitrario in un gesto politicamente significativo, semplicemente per interromperlo. Avendo da porgli una domanda, perché non farlo in presenza di tutti, perché questo atteggiamento così aristocratico? Se si trattava di questioni personali, perché tanta fretta? Inoltre la notizia che reca il portavoce pare ambigua: non ha alcun vero contenuto. I parenti sembra vogliano imporsi all'attenzione degli astanti in virtù della sola loro presenza. La pretesa contrasta fortemente col fatto che molti discepoli di Gesù avevano già allentato i rapporti di parentela, pur di avere tempo e modo di seguirlo. In tanti si rendevano perfettamente conto che gli interessi e gli scopi del movimento erano di molto superiori a quelli tradizionali della tribù, del clan, della famiglia, del villaggio...
"Egli rispose loro: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?". Rispose all'intermediario con una domanda difficile, che obbligava a riflettere. I legami di parentela erano molto radicati negli ambienti palestinesi. Lo stesso messaggero sembrava voler dare per scontato che Gesù avrebbe interrotto (seppur momentaneamente) l'assemblea.
Gesù in sostanza doveva persuadere i suoi seguaci che, seguendo lui e il movimento, avevano abbandonato qualcosa che la mentalità dominante riteneva "decisivo", "irrinunciabile": lui stesso se n'era privato volentieri per il bene della causa rivoluzionaria. In ogni caso non si trattava di un effettivo abbandono, quanto piuttosto di un diverso modo di vivere i rapporti umani. Gesù voleva dare a questi rapporti un significato sociale e politico, facendoli uscire dagli angusti limiti del clan, del parentado. Le relazioni interpersonali, gli affetti familiari dovevano trovare un respiro sociale più ampio per potersi meglio approfondire.
In tal senso, è probabile che l'assemblea lì riunita abbia per un momento pensato che Gesù, questionando sulla vera identità dei suoi parenti, volesse contrapporre quelli d'origine (di sangue) a quelli acquisiti (i compagni di fede politica), premiando quest'ultimi, in modo esclusivo, per i sacrifici e gli sforzi sostenuti. In realtà non si trattava di porre alcuna contrapposizione.
"Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli". Chi gli sta "seduto intorno" e non sta invece "fuori in piedi", chi ha con lui una vera familiarità e non si scandalizza delle sue parole e delle sue opere, può diventare non solo suo "discepolo", ma addirittura "fratello" e "madre". Non c'è contrapposizione, poiché questa possibilità non è negata a nessuno, neanche ai parenti di sangue. L'unica contrapposizione esistente è quella posta dai suoi stessi parenti, che rifiutano di confrontarsi con questa nuova logica di vita.
Il finale, ancora una volta, è stato aggiunto: "Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre". Col che si toglie al progetto di Cristo una qualunque valenza sociale, una vera concretezza e finalità storico-politica. Il movimento nazareno rappresentava un soggetto politico specifico; il credente che fa la "volontà di dio" è invece un concetto astratto, generico. Anche i suoi parenti di sangue pensavano di fare la "volontà divina" cercando di sottrarlo al suo impegno politico. Se si resta nell'ambito puramente religioso, è difficile dire chi faccia di "più" la "volontà di dio".
In questo racconto, infine, Gesù sfata radicalmente il mito dell'amore intrafamiliare o della comprensione fra consanguinei, che un certo opportunismo ritiene sempre "garantito", "sempre presente", anche in un contesto socio-nazionale di crisi e di decadenza. Non solo, ma Gesù supera anche il pregiudizio della "naturale o inevitabile incomprensione" fra estranei. Superiore alla natura e al sangue è la virtù morale e politica. I figli non appartengono ai genitori né al parentado più di quanto non appartengano alla società, all'interno della quale maturano la loro personalità. Gesù non rinnega sua madre e i suoi parenti, vuol soltanto far capire che chi si estranea dalle esigenze di liberazione dell'intera società si rinnega da sé, si autoemargina.
Alcuni dei parenti si erano comunque già coinvolti nel progetto di liberazione proposto da Gesù: lo testimonia – come già si è detto – l'elenco dei Dodici, in cui sono inclusi due "fratelli" di Gesù, cioè Giuda Taddeo e Giacomo il minore. E se questi parenti avevano raggiunto il massimo grado di responsabilità nel compito della sequela, si può presumere che anche altri parenti lo seguissero, seppure in maniera meno impegnativa.
(torna su)12) Scienza e religione nella tempesta sedata
Mc 4,35-41
Di primo acchito è facile notare come l'autore di questa pericope, pur dando per scontato che la tempesta fosse imprevedibile anche per degli esperti marinai come Andrea e Pietro (nel vangelo di Marco sono "marinai" anche Giacomo e Giovanni), non lascia intendere ch'essa fosse così pericolosa da dover necessariamente impaurire tutti gli apostoli presenti in quella barca (seguita da altre barche). Ché, altrimenti, il sonno di Gesù apparirebbe non "simbolico" ma "colpevole".
Anche a prescindere dal fatto che è impossibile spiegarsi un sonno così profondo in presenza di un incipiente allagamento della barca, sballottata dai flutti del lago, resta comunque vero che se Marco non avesse voluto mostrare una situazione di "prova" (difficile ma non impossibile) per gli apostoli, l'atteggiamento indifferente di Gesù sarebbe apparso negativo. Il suo placido sonno, in realtà, vuole essere una sollecitazione a stare svegli, a contare sulle proprie forze, affinché l'imprevisto non turbi la coscienza.
È vero, se la tempesta non fosse stata così violenta non l'avrebbero svegliato, ma se lo era veramente perché Gesù continuava a dormire? Esiste quindi un punto in cui la libertà umana si gioca in tutta la sua interezza e profondità.
A tali conclusioni Marco probabilmente è giunto convinto che dalla mancanza di fiducia in se stessi si passa abbastanza facilmente al rifiuto delle difficoltà che s'incontrano: non comprendendone la ragione, ci si lascia influenzare dal loro peso. Anzi, la sfiducia emerge prepotentemente alla coscienza proprio nei momenti di "prova": gli apostoli, nell'angoscia che li caratterizza, svegliano Gesù accusandolo d'averli abbandonati con freddo cinismo. Eppure, poco prima, stando al racconto, essi l'avevano accolto nella barca "così com'era", cioè non come un toccasana a portata di mano, come un genio tutelare a proprio uso e consumo.
Fin qui comunque l'insegnamento morale del vangelo è accettabile. Marco inoltre, a differenza di Matteo (che è più cattedratico e teatrale), non fa svegliare Gesù anzitutto coll'intenzione di rimproverare i suoi seguaci, ma con quella di placare la tempesta. Non ribatte subito all'accusa di insensibilità mossagli dai discepoli sconvolti. Gesù si sveglia dopo ch'essi erano giunti sull'orlo della disperazione, cioè dopo ch'era stata scartata la legge dell'adeguamento proporzionale dei problemi alla forza degli uomini.
La tempesta non era il castigo divino per qualche particolare colpa commessa dai Dodici: essi hanno smesso di credere nella comoda e semplicistica equazione del rabbinismo, per cui malattie disgrazie o incidenti dipendono dal peccato di qualcuno.
In che modo allora il racconto sarebbe potuto finire per apparire ancora più catechetico di quel che è? Verosimilmente in due modi: o con un'azione miracolistica analoga da parte degli apostoli (o di qualcuno di loro che si fosse finalmente appropriato degli stessi poteri di Gesù, come quando Pietro chiede di poter camminare anche lui sulle acque); oppure con una considerazione di merito circa il fatto che, avendo essi fiducia di compiere un'importante missione storica per Israele (consacrata o no da dio può qui diventare un aspetto del tutto secondario), una morte così fortuita sarebbe parsa del tutto incomprensibile: dunque la seconda alternativa avrebbe dovuto essere quella di attendere con pazienza che la burrasca finisse da sola.
Fede quindi in se stessi, in mancanza della quale l'intervento di Gesù-maestro diventa inevitabile. Ordinando con naturalezza, mediante una sola parola di comando, senza invocare dio, né usando particolari strumenti di scongiuro, Gesù rappresenta la massima valorizzazione delle umane potenzialità. Egli non soltanto risolve i grandi problemi, ma toglie anche l'angoscia con cui in genere li si affronta. Bisogna dunque aver fiducia nei suoi poteri per essere sicuri dei propri... È stato appunto così, mattone su mattone, che la chiesa ha edificato i suoi fantastici sogni.
E tuttavia, proprio la presenza di questo miracolo, che è quanto di più antiscientifico si possa pensare, può indurre il lettore ad assumere una posizione passiva nei confronti dell'esperienza religiosa. Gesù – questa può essere la giustificazione dello "scettico" – ha potuto affrontare con successo il pericolo della realtà proprio perché l'evangelista l'ha trasformato in "figlio di dio", in superuomo. Non lui, quindi, ma gli apostoli, cui non si può chiedere una tale divinizzazione, rappresentano il vero comportamento umano.
Solo che la verità di questo comportamento sta più negli aspetti di paura e angoscia verso la minaccia di morte, che non nella capacità d'affrontarla. Ecco quindi negato l'insegnamento ottimistico, benché ingenuo e quindi fallace, della esistenziale pedagogia di Marco. Basta la sola fede per misurarsi con le difficoltà della vita? No, non basta. Occorrono anche delle condizioni materiali adatte. Per vincere la casualità della natura, e soprattutto la spontaneità dei rapporti umani antagonistici, occorre conoscere le leggi sociali e naturali, ma per conoscerle occorre produrre attività politica e scientifica, occorre "organizzazione".
Gli apostoli non hanno i mezzi adeguati per affrontare il pericolo. Marco insegna ad avere fiducia in Gesù per aver fiducia in se stessi, ma l'unico mezzo che dà per realizzare tale obiettivo è, tautologicamente, quello stesso della fede, cioè quella fede mediante cui si possono compiere azioni che in realtà – almeno per come vengono descritte nei vangeli – sono al di là di ogni umana capacità.
Soggettivamente dunque il racconto può anche aver ragione, ma oggettivamente ha senz'altro torto. Esso in sostanza riflette la posizione di quei gruppi sociali che hanno già rinunciato all'uso di mezzi naturali e sociali concreti per emanciparsi dallo schiavismo della società (qui simboleggiato dall'imprevedibilità della natura), cioè la posizione di chi, per non rinunciare a tale emancipazione, si affida a strumenti illusori, che non possono avere alcuna incidenza sulla realtà. Non a caso il cristianesimo si sviluppa solo dopo la completa disfatta del movimento rivoluzionario degli schiavi nei secoli II e I a.C.
Sarà proprio dalla constatazione di questo "scarto" fra la realtà e la finzione che maturerà presto nella storia della chiesa l'esegesi opportunista che diverrà presto dominante: la natura, i rapporti sociali, possono distruggere il corpo ma non l'anima.
E sarà proprio sulla base della considerazione che per risolvere determinati problemi non c'è che da attendere un miracolo, che nascerà il disprezzo della religione per la scienza e per la politica rivoluzionaria, disprezzo che porta a non valutare mai obiettivamente la natura dei problemi, il senso delle contraddizioni.
Il racconto di Marco, in definitiva (cui s'ispirano, ancora una volta, Matteo e Luca), esprime un desiderio che supera le possibilità effettive di realizzazione. L'esigenza di vivere rapporti umani secondo natura, l'esigenza di avvertire la natura come "madre" e non come "matrigna", non trovando nella società di allora una concreta attuazione, viene necessariamente sublimata, nel racconto evangelico, in chiave mitologica.
Mancando agli oppressi l'indispensabile capacità organizzativa, che solo una forte coscienza di classe può dare, l'esigenza di liberazione nei confronti della natura minacciosa (qui simbolo di rapporti sociali antagonistici) sfocia irrimediabilmente nell'utopia.
Affidando al miracolo il compito di risolvere il problema dell'affrancamento sociale, il cristianesimo di fatto privilegia la coscienza sull'essere, l'idealismo soggettivo sul materialismo oggettivo.
L'esortazione etico-religiosa di Marco, probabilmente rivolta più ai coloni che non agli schiavi veri e propri, si capovolge nel suo contrario, priva com'è di prospettive politiche rivoluzionarie e di riferimenti scientifici.
Pur prendendo coscienza delle possibilità di adeguare le loro forze alle difficoltà del loro tempo, i cristiani di duemila anni fa (e per molti è ancora così) preferiscono svegliare chi dorme tranquillamente sul suo cuscino, invitandolo a compiere qualcosa di spettacolare al loro posto, qualcosa da ricordare con timore e tremore: qualcosa che, ai cristiani di oggi, servirà anche per dimenticare i grandi miracoli che la scienza ha compiuto, e per non desiderare i grandi progressi che l'uomo collettivo, padrone dei propri mezzi produttivi, otterrà attraverso il socialismo democratico.
(torna su)13) La giornata di Cafarnao
Mc 1,21-39
La giornata di Cafarnao rappresenta un condensato delle principali attività svolte da Gesù all'inizio della sua missione politica e sociale in Galilea: predicazione e guarigione alle folle, stretto rapporto coi discepoli e confronto con le autorità locali. La tradizione religiosa ha aggiunto la preghiera e gli esorcismi.
La giornata si svolge in tre luoghi diversi: la sinagoga della città (ritrovata anche da scavi archeologici), la casa di Pietro e il deserto limitrofo. Cafarnao era una delle città più importanti della Galilea, situata sulla sponda nord-occidentale del lago di Tiberiade. È la più citata nei vangeli, dopo Nazareth, ma di quest'ultima non vi è traccia nell'Antico Testamento e nei testi di Giuseppe Flavio.7 Vi abitavano Pietro e suo fratello Andrea, di mestiere pescatori.
Nella sinagoga (vv. 21-28)
v. 21) Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare.
È qui descritta parte dell'attività pubblica di Gesù predicatore e maestro di vita. Fino a quando non ne sarà espulso, insieme ai suoi seguaci, le sinagoghe resteranno il suo terreno privilegiato per il confronto con le autorità religiose locali e l'intellighenzia laica. Tale opportunità verrà però sfruttata solo per un breve periodo di tempo: lo documenta il fatto che in tutto il vangelo di Marco sono soltanto tre gli episodi ambientati nelle sinagoghe (oltre a questo, quello dell'uomo dalla mano secca, che fu l'occasione per discutere sul valore del sabato, e quello riguardante il rifiuto dei parenti di riconoscere la sua autorità, in Mc 6,1 ss.). L'ultimo dei tre racconti, ripetendo in pratica i temi degli altri due (stupore e incredulità), è il meno significativo. Il vangelo di Giovanni dirà, più precisamente, che venivano espulsi quanti lo riconoscevano come "messia" (Gv 9,22 e 12,42).
Nella sinagoga di Cafarnao – stando allo schema redazionale di Marco – Gesù fa il suo esordio ufficiale in Galilea come predicatore e taumaturgo (ma la parte relativa all'esorcismo è stata aggiunta o trasformata in un secondo momento, molto probabilmente per censurare un dibattito di tipo politico). Secondo Giovanni la prima attività pubblica di Gesù avvenne non a Cafarnao, bensì a Gerusalemme, di cui la cacciata dei mercanti dal Tempio costituisce l'esempio più eloquente. La differenza tra i racconti di Marco e Giovanni sta nel fatto che mentre a Gerusalemme Gesù era intervenuto come profeta o leader politico, appena slegatosi dal movimento del Battista, a Cafarnao invece egli interviene sì come successore del Battista ma in maniera incidentale, estrinseca, senza una chiara e logica consequenzialità. Questo perché la tradizione cui si rifaceva Marco aveva scarsi rapporti con l'ambiente del Precursore.
Nella descrizione dell'esordio di Gesù a Cafarnao merita d'essere sottolineato un curioso modo d'esprimersi di Marco. Dapprima infatti egli afferma che Gesù e gli apostoli giungono insieme al paese (provenendo forse da Gerusalemme, per la Pasqua, ove era stata compiuta l'espulsione dei mercanti dal Tempio), poi afferma che solo Gesù entra nella sinagoga e, più avanti ancora, che dopo essere "usciti dalla sinagoga, si recarono in casa di Simone" (v. 29). Dunque se gli apostoli erano "usciti", erano pure "entrati". L'omissione di Marco è voluta e sta appunto a significare che mentre Gesù entrò per "insegnare", gli apostoli non avevano ancora l'autorità sufficiente per fronteggiare la resistenza che scribi e farisei opponevano alla predicazione del nuovo vangelo.
v. 22) Ed erano stupìti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.
Questo ingresso nella sinagoga sembra rappresentare, in verità, non tanto l'inizio dell'attività pubblica di Gesù predicatore, quanto uno dei suoi momenti più rilevanti, almeno nella città di Cafarnao, forse il primo momento ufficiale, di confronto con le istituzioni, dopo la predicazione alle masse galilaiche.
Il fatto che insegnasse "come uno che ha autorità" sta appunto ad indicare che prima di entrare nella sinagoga, Gesù aveva svolto il suo apprendistato tra la folla. In questo senso andrebbe letto 1,14: "Dopo che Giovanni fu arrestato [in Perea, terra di Erode], Gesù – dice Marco – si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio". Si trattava appunto di un apprendistato tra le folle galilaiche e giudaiche al seguito del Battista. Andrea, Giacomo e Giovanni (non Pietro) erano stati quasi sicuramente degli apostoli del Battista. Giovanni cita fra i primi chiamati da Gesù anche Filippo e Natanaele (1,43 ss.), probabilmente originari della Galilea.
Chi si "stupisce", nella sinagoga di Cafarnao, è il gruppo delle autorità religiose e laiche (in primo luogo i farisei), che probabilmente avevano avuto scarsi rapporti col Battista. È vero che in Marco la popolazione non ha ancora potuto costatare la forza dei suoi poteri terapeutici, ma è anche vero che la presenza stessa dei discepoli sta ad indicare che la novità del suo messaggio aveva già suscitato delle reazioni positive. Peraltro, stando a Giovanni, un gruppo di Galilei aveva già assistito ad alcuni "segni" fatti da Gesù a Gerusalemme per la Pasqua, il più importante dei quali doveva essere stata la purificazione del Tempio (Gv 2,23), benché un secondo redattore abbia aggiunto la guarigione del figlio di un funzionario di Erode, che è il secondo "segno" fatto da Gesù in Galilea, dopo le nozze di Cana, cui parteciparono i parenti di Gesù e pochi discepoli (così Gv 4,54): un evento, questo, del tutto fuori luogo rispetto al contesto.
Marco qui non si sofferma sul contenuto dell'insegnamento di Gesù, poiché già l'ha fatto, in modo lapidario, al v. 15: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo". Peraltro Marco non ama approfondire il contenuto politico del vangelo di Gesù.
Nel contesto di questo vangelo ciò che distingue Gesù dai farisei più progressisti non è tanto la diversità del messaggio di liberazione sociale, politica e nazionale, quanto il fatto ch'esso viene trasmesso con "autorità", cioè con la consapevolezza della sua possibile realizzazione. La differenza stava in primo luogo nell'atteggiamento di fiducia verso la rivoluzione, che per i farisei, sempre meno convinti delle capacità eversive del popolo, consisteva in una sentita attesa messianica.
Gesù possedeva grande autorevolezza non perché aveva studiato in una rinomata scuola rabbinica, né perché diceva cose assolutamente diverse da quelle dei gruppi politici più progressisti, ma perché il suo insegnamento era sociale, coerentemente vissuto, conforme alle esigenze delle masse: tutte le differenze di contenuto (la questione del digiuno, del sabato, del valore del Tempio, della legge mosaica, delle regole alimentari ecc.) partivano da questa particolare concretezza. Al tempo di Gesù i farisei, dopo le gravi sconfitte subite ad opera di Erode il Grande, si erano praticamente divisi in due gruppi: uno molto conservatore e moralista, fedele alla legge scritta e orale; l'altro, minoritario, più democratico e aperto a soluzioni ancora politico-rivoluzionarie, seppure in uno sfondo meramente giudaico-nazionalistico.
Il brano che va dal v. 23 al v. 28 è stato aggiunto in un secondo momento, al fine di giustificare la morte violenta di Gesù nell'ultima Pasqua dei vangeli. L'esorcismo infatti vuole dimostrare che non c'era alcuna possibilità di dialogo tra Gesù e l'ebraismo (Marco, a differenza di Giovanni, non fa distinzione tra farisei conservatori e progressisti). L'incompatibilità di fondo, ideologica, impedisce qui ogni intesa politica. Il "demone" dà per scontato che le intenzioni, i metodi, gli obiettivi di Gesù siano di per sé negativi, a prescindere dai risultati che ottengono o potranno ottenere. Non ci può essere confronto dialettico fra l'ebraismo e il cristianesimo: lo stesso uso del plurale "noi" (v. 24) sta appunto ad indicare che per il "secondo redattore" del vangelo di Marco, "tutto" il giudaismo era ostile a Gesù. È addirittura singolare il fatto che questo redattore abbia voluto inserire un "indemoniato" nella sinagoga, in grado di agire indisturbato, all'insaputa degli stessi astanti, del tutto incapaci di scorgerlo.
Gesù infatti non dialoga con l'ossesso, ma impone di forza la sua autorità: il che contraddice tutti i racconti di guarigione. Non solo, ma tale atteggiamento è anche in contrasto col fatto che Gesù era entrato nella sinagoga per parlare col potere costituito, per discutere e insegnare, cioè senza dare per scontata l'ostilità di questo potere.
L'aggiunta, tuttavia, è molto antica, poiché non accenna minimamente alla presunta "divinità" del Cristo. "Santo di Dio" sta per "profeta" o al massimo per "messia": anche il Battista lo era. Nel contesto del racconto Gesù è semplicemente il "nazareno".
Che si tratti di un'aggiunta, lo si comprende bene anche dal v. 27, allorché si ribadiscono pari pari le cose dette al v. 22. Gli astanti erano già stupìti dell'insegnamento di Gesù, prima ancora dell'esorcismo, e già avevano capito che si trattava di una "nuova dottrina"...
In casa di Pietro (vv. 29-34).
v. 29) E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni.
I "subito" di Marco possono apparire un po' pleonastici, ma qui non ha molta importanza. L'intenzione dell'evangelista è semplicemente quella di far notare al lettore la differenza di comportamento che c'è fra le autorità e i discepoli. La sinagoga, cioè il potere istituzionale a livello locale, è incapace di recepire la novità del nuovo vangelo, ma non per questo gli uomini che lottano attivamente contro le ingiustizie (in questo caso gli apostoli) devono sentirsi in diritto di condannare le istituzioni, rompendo qualunque rapporto. Prima di "distruggere" le istituzioni occorre che l'alternativa, almeno in nuce, sia già stata posta, altrimenti si cadrà nell'avventurismo. I discepoli cioè devono sincerarsi che all'interno delle loro "case" il pregiudizio, la sfiducia, il pessimismo siano, almeno potenzialmente, vinti, superati.
v. 30) La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.
Questo versetto sta ad indicare che le difficoltà di comprensione del nuovo vangelo esistevano anche presso gli apostoli, cioè presso gli ambienti più progressisti del popolo. Il racconto dell'esorcismo sembrava scaricare sulle istituzioni tutto il peso della crisi dell'ebraismo; ora invece appare chiaro che il peso dev'essere in un certo qual modo distribuito (seppur non in parti uguali) fra istituzioni e società, fra potere e masse. La contraddizione non si esprime tanto attraverso la diversa simbologia dei due mali: quello fisico della suocera e quello spirituale della sinagoga, quanto piuttosto nel fatto che gli apostoli chiedono a Gesù – dopo il confronto politico e intellettuale con le autorità – un favore personale, di secondaria importanza.
È vero che Simone e Andrea parlano a Gesù della suocera solo quando già erano entrati in casa, in quanto non ve l'avevano condotto appositamente. Marco però vuole anche evidenziare che, appena usciti dalla "sinagoga-di-chi-sa-solo-stupirsi-senza-credere", Gesù e i discepoli entrarono nella "casa-di-chi-non-sa-credere-sino-in-fondo". La sfiducia non aveva intaccato soltanto la coscienza delle autorità, dei partiti tradizionali, ma anche quella del popolo, seppure in forma meno grave. Essi infatti – se prestiamo fede alla cronologia di Marco – chiedono a Gesù di violare il sabato con la sua terapia: lo usano e in maniera magica.
v. 31) Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli.
La febbre doveva essere abbastanza alta, poiché la donna non ebbe neppure la forza d'avvicinarsi a Gesù. Essa viene guarita senza cerimonie particolari, senza riti di sorta, né scongiuri o formula magiche. Non c'è niente di religioso nelle guarigioni di Gesù.
Subito dopo, dimostrando che la febbre era stata completamente sanata, essa si mise a servirli. Quale scandalo! Che cosa si sarebbe detto di un rabbino che avesse accettato di farsi servire a tavola da una donna in giorno di sabato appena uscita da una malattia? Proprio qui, d'altra parte, stava la principale differenza tra le istituzioni e il popolo: l'inutilità di certe tradizioni, di certi formalismi, di certi precetti morali e norme rituali, era molto più avvertita dal popolo che non dalle istituzioni, che avevano bisogno di quelle cose per salvaguardare il potere costituito.
v. 32) Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.
"Dopo il tramonto del sole" non è una ripetizione di "venuta la sera", ma la specificazione che il sabato, secondo il computo ebraico, era già passato, e che quindi il divieto di lavorare (in questo caso trasportare barelle o aiutando malati non moribondi) era finito.
Qui però c'è qualcosa di strano: la folla accorre a chiedere guarigioni quando nel vangelo di Marco la prima è appunto quella della suocera di Pietro. Indubbiamente il fatto di avergliela richiesta, da parte dello stesso Pietro, stava ad indicare una conoscenza di questi suoi poteri, esercitati in precedenza, ma allora perché l'omissione o la lacuna del redattore? Di certo la folla non può essere accorsa solo dopo che si sparse la notizia della guarigione della donna: non lo avrebbe fatto in massa e in così poco tempo.
Probabilmente il redattore, condensando episodi avvenuti in tempi e luoghi diversi, ha voluto qui mettere in evidenza una diversità di atteggiamento tra i discepoli più stretti di Gesù e la folla. Infatti, dopo le molte guarigioni già ottenute o viste fare, la folla crede sì nei poteri di Gesù, crede anche nel suo vangelo, ma continua ad aver timore del giudizio delle autorità ufficiali. Solo "dopo il tramonto del sole" gli portarono i "malati" (malattie fisiche) e gli "indemoniati" (come allora ci si esprimeva per indicare le malattie psichiche). Iperbolicamente Marco parla di "tutti" i malati di Cafarnao.
v. 33) Tutta la città era riunita davanti alla porta.
Che tutta la città fosse riunita davanti alla porta della casa di Pietro appare davvero strano, poiché allora non si spiegherebbe il timore del giudizio delle autorità, relativo al precetto del sabato, e in ogni caso ciò non sta a significare che tutti i malati abbiano potuto essere guariti. Al massimo può stare ad indicare che la popolarità di Gesù taumaturgo era già grande, ovvero che questa popolarità rischiava d'essere soggetta ad atteggiamenti strumentali o addirittura che persino qualche autorità religiosa può aver utilizzato tale opportunità per chiedere qualcosa a favore dei propri congiunti o parenti bisognosi di cure (non si comporterà forse così l'archisinagogo Giairo?).
v. 34) Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano.
Per compiere queste guarigioni Gesù non chiede una fede matura nel suo vangelo, né s'intrattiene a parlare con gli ammalati o con i loro parenti. Non pone alcuna vera condizione preliminare. Gesù sa già che gli abitanti di Cafarnao, nella loro maggioranza, condividono le idee fondamentali del suo vangelo, anche se essi non hanno il coraggio di trasgredire il sabato. Non ha quindi senso ch'egli vieti di conoscere una cosa (la propria identità) a quanti già la conoscono ed è altresì insensato che agli inizi della sua missione egli vieti di divulgare il suo messaggio. Il "segreto messianico" – cui egli sarà costretto a ricorrere più avanti – era in funzione di una migliore ricezione del suo vangelo, onde evitare malintesi politici sulla sua strategia. In questo frangente il redattore ne parla solo per anticipare l’idea della figliolanza divina del Cristo.
Nel deserto (vv. 35-39)
v. 35) Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava.
Aspettandosi l'arrivo di nuovi postulanti, quelli che la sera precedente non erano riusciti ad ottenere la guarigione (al v. 34 Marco aveva detto che "molti" riuscì a guarire, non "tutti"), Gesù preferisce ritirarsi nel deserto limitrofo (la "preghiera" è stata aggiunta con intento apologetico). Spera che, vedendolo comportarsi così, essi capiscano (soprattutto i discepoli, poiché il gesto voleva avere un contenuto politico-pedagogico) che le sue "operazioni salutiste" non avevano come unico obiettivo la guarigione psicofisica della gente.
vv. 36-37) Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano!".
Si meravigliano di questa "fuga dalla facile popolarità", di questa rinuncia al dovere sociale, civile... Gli scribi si stupivano della sua autorità, la folla e i discepoli ch'egli non voglia usarla sino in fondo. Quello che Simone e gli altri apostoli non comprendono è che la salute è soltanto un "segno" di qualcos'altro, cioè un'occasione, un motivo per sperare in cambiamenti ben più significativi, in cui i malati stessi siano soggetti attivi, non passivi. Nel contesto è evidente il rifiuto di approfittare della situazione per acquisire un potere personale, per sfruttare la buona fede o l'ignoranza del popolo.
v. 38) Egli disse loro: "Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!".
Gesù motiva la sua dipartita dalla città di Cafarnao mostrando che l'attività terapeutica andava subordinata alla proclamazione del vangelo, che fosse la più vasta possibile. Già da questo si può intuire quale sarà il suo futuro rapporto con le masse. E se anche queste, in quel momento, possono non aver capito il vero motivo di questa sua tattica, l’importante era che lo capissero i suoi più stretti discepoli.
Dicendo: "la mia missione è rivolta a tutti, il vangelo non è per pochi", in pratica Gesù poneva la folla di fronte al pericolo del possesso esclusivo, unilaterale, dei suoi poteri taumaturgici o della sua autorità morale e politica. Probabilmente alcuni avevano capito che la possibilità di utilizzare i suoi poteri e la sua autorità poteva rendere molto più importante la città di Cafarnao. Altri, invece, con uno sguardo meno campanilistico, avranno pensato che i suoi poteri e la sua autorità andavano proposti e offerti a molte più persone, non solo a quelle della città galilaica. Oppure avranno pensato (gli apostoli) che Gesù, volendo soprattutto predicare, non poteva perdere molto tempo con gli ammalati.
In parte tutto questo era vero, ma il punto restava un altro. Gesù non cercava soltanto "molti villaggi" dove poter predicare, ma anche e soprattutto quelli che sapessero accogliere con maturità la forza morale e politica del nuovo vangelo. Chi non fosse riuscito ad avvertire l'esatta prossimità da lui desiderata, avrebbe continuato a vivere in un "villaggio lontano", e ad ogni villaggio egli sarebbe stato costretto a dire che doveva andare a predicare anche nei "villaggi vicini".
(torna su)14) Matteo il pubblicano
Mc 2,13-17
I
La chiamata di Levi-Matteo è un racconto molto indicativo della dialettica esistente tra valori universali e valori di classe. Levi è un esattore delle imposte al servizio del re Erode Antipa di Galilea, cioè un ebreo traditore che fa indirettamente gli interessi di Roma. L'appalto dell'esattoria veniva assegnato dai Romani all'esattore-capo che faceva l'offerta più alta: per far fronte agli impegni, costui doveva quasi costringere i suoi impiegati – gli esattori – alla disonestà. Cioè a dire, gli esattori versavano allo Stato la somma pattuita, ma in cambio potevano tenersi, frodando, il surplus delle riscossioni. A causa di ciò gli appaltatori e doganieri, con tutta la loro famiglia, venivano privati dalle autorità giudaiche di molti diritti civili, politici e religiosi, fra cui quello di rendere testimonianza.
Matteo si era forse deciso ad accettare tale mestiere perché aveva valutato realisticamente la potenza dei Romani e ritenuto inutile qualsiasi resistenza popolare, specie se condotta da un governo corrotto come quello giudaico o dai gruppi terroristici che pullulavano nei deserti della Palestina di allora. I fatti non gli avevano dato torto.
In quanto appartenente alla classe dei pubblicani, egli era un nemico del movimento nazareno di Gesù, ma il resoconto della sua conversione sta appunto a significare che dietro l'apparenza di una professione vergognosa può celarsi un desiderio represso di giustizia, di liberazione, sociale e nazionale.
Il brano è evidentemente l'epilogo di un rapporto preciso tra i due. Levi si aspettava d'essere "chiamato". L'incontro, anche se nel testo di Marco appare il contrario, non è stato casuale ed è avvenuto senza spettacolarità. Levi probabilmente voleva essere chiamato in pubblico, al fine di dimostrare ufficialmente la rottura col suo passato, e Gesù ha aspettato soltanto il momento opportuno per farlo.
In effetti, per chiamarlo alla sua sequela, Gesù doveva prima vincere le resistenze interne al movimento ed essere pronto ad affrontare, subito dopo, quelle, non meno forti e numerose, provenienti dall'esterno. Pregiudizi e riserve morali si sprecavano nei confronti dei pubblicani, considerati "impuri" a causa dei loro contatti coi pagani, "traditori" della patria, "peccatori" per antonomasia.
Viceversa, il testo documenta come, in nome di valori universali (l'esigenza di giustizia, di libertà), Levi abbia potuto compiere una scelta di classe progressista, mettendosi dalla parte del popolo rivoluzionario contro l'oppressore straniero e interno. Ed è stata una scelta così significativa che Gesù non ha avuto dubbi nel chiedere a Matteo di far parte del numero ristretto dei discepoli più fidati. Levi cioè non si era semplicemente riconciliato con la sua gente, ma aveva anche voluto assumere una responsabilità politica assai impegnativa, completamente antitetica al suo precedente modo di vivere. Anzi, senza questa possibilità d'impegno politico, probabilmente non ci sarebbe mai stata alcuna riconciliazione con i Galilei. Finché Matteo non avesse incontrato un movimento politico il cui programma fosse non solo praticabile, ma anche fondamentalmente onesto, egli avrebbe continuato a fare il gabelliere. Il suo desiderio era quello di veder realizzata una maggiore democraticità ed uguaglianza all'interno della società ebraica, non era quello di aprire maggiormente tale società alla cultura greco-romana.
Se Gesù avesse puntato tutta la sua attenzione sui valori di classe, non l'avrebbe neppure chiamato, poiché, senza la consapevolezza dell'esistenza dei valori universali, i valori di classe portano, tendenzialmente, a guardare le cose in maniera schematica, settaria, cioè portano a dare più peso all'oggettività del ruolo (sociale, professionale, politico) che non alla soggettività della coscienza e dell'esperienza personale. Matteo chiedeva appunto di non essere considerato solo dal punto di vista dei valori di classe, o comunque di non fare della "verità di parte" un motivo per discriminare una parte di uomini.
II
"Mentre Gesù stava a mensa in casa di Matteo [da questi invitato, dopo la chiamata al discepolato attivo], molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano" (v. 15).
Matteo poté dare un grande banchetto appunto perché era di famiglia agiata (o comunque lo era diventato). Ma questo è un pranzo d'addio alla professione e di congedo dalle compagnie di un tempo, non è un pranzo di rallegramenti e felicitazioni: al massimo potrà esserci stato un momento in cui Matteo, approfittando dell'occasione, avrà perorato la causa di Gesù e chiesto a qualche suo collega pubblicano di abbandonare il mestiere e di seguire il suo esempio. In fondo, la particolarità della conversione di Matteo sta anche nel fatto che nei vangeli egli è stato il primo "peccatore" ad aver ricevuto (e ad aver accettato) l'invito a seguire Gesù come attivo militante.
Molti commensali, probabilmente, erano, come lui, "peccatori" di rilevanza pubblica, cioè persone che – secondo la mentalità rabbinica – tenevano, proprio in forza della loro professione, una condotta morale riprovevole: il ruolo in sé li condannava. Qui essi non sono a tavola con Gesù perché suoi "seguaci", ma perché amici e colleghi di Matteo. L'espressione "erano molti che lo seguivano" è stata aggiunta da Marco, sulla versione originaria della tradizione, o da qualche redattore o copista per non scandalizzare un lettore di origine ebraica. In effetti, soltanto sulla base di una forte esigenza politica si può comprendere e giustificare un rapporto così confidenziale (un pranzo in comune!) tra Gesù e i cosiddetti "peccatori". La morale religiosa della comunità cristiana primitiva, che aveva appena smesso di credere nella transizione politica, non poteva facilmente tollerare la realtà di questi rapporti, specie se dominata da una forte componente ebraica.
L'aggiunta però è stata così infelice che se ne ricava una duplice sfavorevole impressione. Da un lato, infatti, sembra che, siccome "erano in molti", Gesù e i suoi discepoli si potevano anche permettere il lusso di fare cose "azzardate", cioè non conformi ai principî della mentalità dominante (il che però non è, in quanto la scelta di partecipare a un banchetto del genere sarebbe stata presa anche in condizioni di minore popolarità del movimento nazareno); dall'altro sembra, sempre a motivo del fatto che "erano in molti", che il redattore voglia far capire quanto fosse difficile per il movimento nazareno controllare "tutti", specie quegli elementi della cui presenza la comunità cristiana primitiva avrebbe fatto volentieri a meno.
Un'altra interpretazione, ancora più antistorica, vuole che i "molti" fossero già alla sequela di Gesù, seppure non come diretti discepoli, bensì come "semplici credenti" o "simpatizzanti". Il pranzo sarebbe appunto servito come pretesto per ufficializzare la presenza di questi neo-convertiti nelle file del movimento messianico.
Comunque sia, il copista (o un secondo redattore) con quell'aggiunta non ha fatto altro che giustificare il comportamento di Gesù agli occhi di coloro che, ragionando coi soliti preconcetti, si erano scandalizzati nel vedere quell'anomala festicciola. Gesù però – come già si è detto – era stato invitato da Matteo, insieme ai colleghi pubblicani, per celebrare un avvenimento importante: la conversione politica di un pubblicano alla causa del vangelo; per la partecipazione alla festa Matteo non aveva imposto alcuna condizione, né chiederà nulla quand'essa sarà terminata. Non doveva essere un incontro formale per negoziare qualcosa. Gesù aveva probabilmente accettato l'invito, sapendo benissimo chi sarebbero stati gli altri invitati. Si trattava quindi di una scelta, da parte sua, che non avrebbe potuto pregiudicare alcunché.
"Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani" (v. 16), andarono a protestare dai discepoli di Gesù. Scribi e farisei erano coloro che, attraverso l'interpretazione della legge, la pretesa coerenza morale, l'autorità politica e le pratiche rituali, miravano a presentarsi al cospetto del popolo come i veri riformatori dell'ebraismo. Da notare però che il termine "setta" è qui usato in senso spregiativo, ironico, per mettere appunto in risalto che, nonostante gli sforzi di affermazione socio-politica, questi riformatori non riuscivano ad essere molto popolari.
Tuttavia, anche questa parte del racconto è stata manomessa. È probabile, infatti, che siano stati gli stessi apostoli a porsi quella domanda imbarazzante, oppure che a loro, in questo caso, sia toccato l'ingrato compito di rispondere alle domande che il loro movimento si poneva. Gli scribi sono stati utilizzati come capro espiatorio, al fine di nascondere la pochezza intellettuale di alcuni discepoli, che ancora non comprendevano certe iniziative di Gesù o che ancora non sapevano cosa rispondere alle domande dei seguaci meno consapevoli, anche se è fuor di dubbio che Gesù non avrebbe potuto accettare l'invito di Matteo se i suoi discepoli non fossero stati disposti, almeno virtualmente, a capirlo.
Il redattore, dal canto suo, avrebbe anche potuto parteggiare per la posizione di questi discepoli dissenzienti, ma poi avrebbe trovato molte più difficoltà a spiegare quella di Gesù. Ecco perché si è limitato a dire che chi lo riprese erano i nemici di sempre, gli scribi e i farisei.
L'ironia comunque prosegue sia laddove Marco afferma che gli scribi lo biasimavano semplicemente "vedendolo" mangiare, cioè stando fuori della casa di Matteo; sia laddove gli scribi interrogano i discepoli di Gesù, non lui in persona. Per loro la "distanza morale" era così grande che non potevano neppure fisicamente incontrarlo.
Gli scribi accorpavano i pubblicani e i peccatori sotto una medesima categoria: i colpevoli noti al pubblico. Tuttavia, se il pubblicano per lo scriba era un peccatore "manifesto" in forza del proprio ruolo professionale (e, come lui, tanti altri che svolgevano mestieri interdetti), che dire di chi veniva tacciato pubblicamente d'essere un "peccatore"? Può forse il concetto di "peccato" appartenere unicamente alla "sfera pubblica"? Nell'identificazione arbitraria degli scribi (ovvero della mentalità dominante) c'è, a ben guardare, la pretesa di considerare peccatori solo quelli "ufficiali", socialmente noti (come ad es. le prostitute o i ladri colti sul fatto).
Non ogni uomo quindi era per loro "potenzialmente peccatore", ma solo quello il cui peccato fosse evidente, esplicito, appunto perché palesemente in contrasto con le leggi giudaiche. Il cosiddetto "male" veniva praticamente simbolizzato dagli scribi in un determinato schema di comportamento. Così facendo essi ritenevano e facevano credere che la "colpa" fosse una realtà ben definita e soprattutto definitiva, irreversibile. Certo, in astratto gli scribi non negavano la possibilità del ravvedimento, ma quando questa possibilità diventava realtà (e in un contesto ideologico del genere era cosa rara), essa non faceva altro che legittimare ulteriormente le istituzioni del potere giudaico: per la semplice ragione che se gli scribi potevano anche ammettere l'eventualità della riabilitazione, mai avrebbero accettato di dover ripensare questo modo di tipizzare e codificare il concetto di "peccatore". La credibilità del potere giudaico era così fragile che un ripensamento del genere avrebbe comportato una pericolosa reazione a catena.
Al cospetto di un potere del genere, corrotto, autoritario e compromesso con l'imperialismo romano, il cosiddetto "criminale" poteva anche arrivare a pentirsi del reato commesso, ma è difficile credere ch'egli avrebbe potuto farlo con la convinzione d'aver "sbagliato". Nelle società basate sull'antagonismo i "veri criminali" non sono forse quelli che dispongono del potere (politico o economico), cioè quelli che ufficialmente appaiono onesti e che quando vengono finalmente scoperti e denunciati godono sempre di ampie immunità? Di che cosa si dovrebbe pentire un criminale "comune": del proprio "egoismo" o della propria "ingenuità"?
Forse Matteo aveva accettato di fare il pubblicano proprio perché era giunto alle medesime conclusioni, che sono sì amare ma realistiche, seppure al negativo. Comunque sia, la proposta del movimento nazareno era stata proprio quella di trasformare il realismo da negativo a positivo, da distruttivo a costruttivo. Era forse un'utopia? No, perché il "criminale" Matteo poteva diventare, grazie a questa proposta (che in fondo era un progetto di vita), un militante che s'impegnava a combattere non solo per la liberazione nazionale, ma anche contro la logica degli scribi, dimostrando che non si può essere "giusti per definizione", per partito preso, in quanto la giustizia è un criterio la cui credibilità va continuamente dimostrata coi fatti.
Dunque, stando insieme ai pubblicani e ai peccatori, come fa Gesù a non diventare come loro? come può dimostrare di non essere come loro? Questa la domanda che gli scribi e la mentalità dominante si saranno posti. La confusione tra "forma" e "sostanza" nasce appunto dal fatto ch'essi hanno voluto identificare i due aspetti dal punto di vista della forma e non della sostanza, e l'hanno fatto in maniera così "integrale" da non tollerare alcuna "divergenza".
Il pranzo in casa Matteo aveva appunto lo scopo di mettere in discussione la pretesa scriba che non vi fossero alternative alla logica ufficiale del sistema. Gli scribi erano convinti che l'unica vera "sostanza" fosse il loro formalismo e che qualunque alternativa (non solo quella del Cristo) andasse considerata negativamente; non riuscivano cioè ad accettare l'ipotesi di una "sostanza" autentica che si potesse vivere all'interno di forme differenti, non tradizionali o non ufficiali. Il loro concetto di "purezza" andava di pari passo con quello di "separazione" dai cosiddetti "peccatori", i peggiori dei quali, secondo gli scribi, erano proprio i "pubblicani". Costoro infatti non facevano più parte della chiesa ebraica, formavano una categoria di gente a sé, per la quale il pentimento risultava praticamente impossibile, essendo impossibile sapere quante persone erano state "danneggiate" dalla loro attività. A causa del loro comportamento, quindi, essi erano considerati più "pagani" dei cosiddetti "peccatori" che esercitavano attività soltanto "immorali".
III
"Avendo udito questo, Gesù rispose: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori" (v. 17).
Qui l'ironia raggiunge un alto livello di criticità politica. Apparentemente infatti la risposta sembra essere molto diplomatica, in quanto da un lato Gesù ammette che i pubblicani sono "peccatori" e, dall'altro, che gli scribi sono "sani e giusti". Si tratta tuttavia di una mera apparenza, resa inevitabile dal fatto che Gesù, usando tatto e discrezione, non vuole rompere un rapporto con le istituzioni. Ma in realtà il giudizio (indiretto) è severo, poiché se i "malati", cambiando stile di vita, possono diventare "sani", tutti coloro che non accettano questa eventualità rischiano di diventare "malati", anche se ufficialmente non lo sono o dicono di non esserlo.
Si badi, Gesù non giustifica il realismo negativo dei pubblicani, i quali, conoscendo bene l'ipocrisia scriba, avevano scelto il loro proprio interesse, rinunciando ad ogni idealismo politico; però è evidente (e la conversione di Matteo l'attesta) ch'egli non vuole neppure considerare quei pubblicani divenuti tali per "protesta", alla stessa stregua di quelli che l'avevano fatto per esigenze di mero guadagno (un caso analogo a questo è quello di Zaccheo, descritto nel vangelo di Luca).
Altra questione riguardava la liceità dei mezzi. È vero, Gesù si stava cibando di vivande acquistate con denaro "sporco", proveniente da affari illeciti (lo sdegno degli scribi si poteva capire), ma quale denaro è completamente "pulito"? L'uomo si trova a vivere in una società che lo precede, per cui la scelta dei mezzi spesso non dipende dalla sua volontà. D'altra parte, non perché i pubblicani venivano accusati dagli scribi di "tradimento", avevano per questo cessato le loro attività.
Ma sul significato della suddetta ironia bisogna spendere ancora qualche parola. È anzitutto evidente che Gesù non poteva usare lo strumento dell'ironia per troncare il rapporto con gli scribi: sarebbe stato insensato precludere alla mentalità dominante la possibilità di superare i propri pregiudizi. L'ironia quindi, se nella formulazione redazionale del testo appare evidente, nell'espressione reale di Gesù sarà invece apparsa più sfumata, più ambigua.
Gesù non aveva esplicitamente contestato la posizione scriba (o della mentalità dominante), anche se aveva dato la possibilità di capire l'errore di questa posizione. Chi voleva comprendere il vero senso delle sue parole, avrebbe potuto farlo senza sentirsi particolarmente offeso. C'è da considerare infatti che qui siamo appena agli inizi della sua predicazione pubblica in Galilea. Se gli scribi, ascoltando le sue parole, avessero pensato che voleva dileggiarli, il dialogo non sarebbe neppure stato aperto. Ecco perché l'ironia di Gesù non è quella del redattore: laddove l'uno aveva bisogno del concorso di tutti gli ebrei (Giudei o Galilei che fossero) per opporsi ai Romani, l'altro invece dà per scontata l'indisponibilità degli scribi.
Questo problema ne introduce un altro, non meno significativo. Poiché il redattore scrive in un momento in cui l'ipotesi di un felice esito rivoluzionario della lotta di liberazione nazionale non andava più presa in considerazione, la distinzione tra "peccatori e giusti", tipicamente giudaica, non poteva più essere accettata, e con essa l'esigenza di tipo politico-nazionalistico del giudaismo ufficiale. Per cui la coppia "peccatori/giusti" andava di necessità attenuata – agli occhi del redattore – e sostituita con un'altra a sfondo più moralistico, proveniente dalla comunità primitiva di origine pagana: quella di "sano e malato".
Di conseguenza, l'ironia di Gesù, che in rapporto alla coppia "giusto/peccatore" conservava una serietà di fondo, suggerita dalla necessità di una liberazione nazionale, subisce, nella versione del redattore, per il quale è in gioco un comportamento meramente soggettivo, una sorta di banalizzazione. Lo stesso concetto di "peccatore" sembra vada inteso soltanto nella sua accezione etico-religiosa, nel senso cioè che "tutti" gli uomini devono sentirsi peccatori da redimere (anche quelli che sul piano economico sono onesti). Questa superficialità è molto evidente nelle due versioni di Matteo e Luca, posteriori a quella di Marco.
IV
Matteo, come noto, scriverà il vangelo (ad Antiochia o forse ad Alessandria) dopo la caduta di Gerusalemme. Sarà il vangelo preferito dalla chiesa primitiva, tanto che quello di Marco verrà considerato (almeno sino alla metà dell'Ottocento) un suo riassunto. In Italia è stato necessario un altro secolo prima di capire che la fonte principale del vangelo di Matteo era proprio il vangelo di Marco.
L'immagine che Matteo offre di Gesù è quella di un leader spirituale, carismatico, ecclesiastico, pacifista ad oltranza, che non userebbe la spada neppure per difendersi. Nel racconto dell'arresto nel Getsemani (26,47 ss.) Matteo aggiunge alla versione di Marco (ma la cosa è confermata anche da Giovanni) che fu un discepolo di Gesù a opporsi alla cattura, sguainando la spada e tagliando l'orecchio a un servo del sommo sacerdote Anna. L'episodio – secondo la versione di Matteo – servì a Gesù non tanto per scongiurare un massacro (come in Giovanni), quanto per ribadire la totale inutilità della violenza, ovvero la fatalità del destino, che in quel frangente vedeva trionfare le forze del "male". Gesù infatti afferma che se volesse si servirebbe di ben "dodici legioni di angeli" (Mt 26,53 s.): il non averlo fatto va dunque interpretato come una decisione di volersi far catturare.
Certo è che se Matteo visse ad Alessandria si può comprendere bene il motivo di questa sua posizione. Come narra lo storico Giuseppe Flavio (un ebreo filoromano), i capi della comunità ebraica alessandrina ebbero cura di prevenire, dopo il crollo di Gerusalemme, la ribellione del loro popolo, in mezzo al quale i profughi sopravvissuti di Giudea facevano circolare la loro propaganda sovversiva. Ciò significa che Matteo continuò ad odiare gli ebrei estremisti (o zeloti), nonché le autorità del Tempio e il partito farisaico, esattamente come prima d'incontrare il movimento nazareno del Cristo, con la differenza che dopo il crollo del 70 si sentiva ancora più giustificato in questo suo atteggiamento. Prima li aveva odiati passando dalla parte del "nemico", e quindi sentendosi angosciato per una scelta che in coscienza non avrebbe voluto fare e che il Cristo ebbe la forza di rimettere in discussione; invece dopo la crocifissione e soprattutto dopo il 70 li odia con più giustificazioni, mostrando che i veri "nemici" erano proprio loro, che con l'estremismo da un lato e il conservatorismo dall'altro avevano fatto fallire il realismo del movimento nazareno.
Non a caso l'intenzione di Matteo di scagionare Pilato dall'accusa di aver giustiziato un innocente, è ancora più forte di quella di Marco: lo indicano sia il sogno premonitore della moglie di Pilato, che doveva in pratica attestare una rivelazione divina sull'innocenza di Gesù (27,19); sia il gesto simbolico di lavarsi le mani da parte dello stesso Pilato (27,24), al quale le folle ebraiche risposero: "Il sangue suo ricada su noi e sui nostri figli" (27,25). In sostanza Pilato – nel giudizio di Matteo, più ancora che in quello di Marco – fu completamente vittima delle pressioni giudaiche. E Matteo non perse tempo nel considerare che se gli ebrei accettarono liberamente la colpa dell'uccisione di Gesù, allora la distruzione di Gerusalemme non era stata altro che la giusta punizione divina, da essi stessi invocata.
Matteo, che è il più ebraico dei quattro evangelisti, diventò così il più antisemita, o comunque lo diventò la tradizione che a lui fece capo. La militanza nel movimento nazareno non era stata sufficiente a fargli superare i drammatici risentimenti ch'egli provava verso i suoi connazionali. Secondo la tradizione cristiana, egli morì martire in Etiopia, ove, in seguito, la chiesa copta farà di Pilato addirittura un "santo". Matteo insomma, pur avendo rinnegato il "vangelo politico" del Cristo, non lo fece sino al punto di dover riconoscere "Cesare come Signore".
(torna su)15) Le nozze di Cana
Gv 2,1-12
Nel racconto delle nozze di Cana, che solo l'evangelista Giovanni riporta, vi sono due stranezze che non possono certo sfuggire a un qualunque lettore.
La prima è che qui Maria sembra già avere consapevolezza dei poteri straordinari di Gesù prima ancora che questi li abbia mai manifestati. (Curioso peraltro è il fatto che qui Maria dia ordini ai "servi dello sposo". Qualche esegeta protestante ha congetturato che lo sposo sia lo stesso Gesù, ma è più verosimile che Maria sia in grado di dare ordini in quanto strettamente imparentata con lo sposo.)
Come siano andati i fatti è difficile dirlo, ammesso e non concesso che siano effettivamente accaduti. Molto probabilmente Maria, accortasi che l'arrivo alla festa da parte di Gesù e dei suoi discepoli (quest'ultimi, probabilmente, aggregatisi all'ultimo momento) avrebbe potuto mettere in imbarazzo gli sposi se questi avessero constatato una quantità insufficiente di vino, si limitò a chiedere qualcosa che apparentemente sembrava di difficile realizzazione. Fatta la richiesta, cui Gesù acconsentì malvolentieri, perché avrebbe rischiato di esporsi per un motivo di carattere privato, Maria non si rese conto di nulla, se non appunto del fatto che il problema era stato risolto.
In secondo luogo Giovanni conclude il racconto con un'espressione che ha dell'incredibile: "Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui" (2,11).
Anzitutto, quali discepoli poteva avere con sé? Secondo Gv 21,2 Natanaele era di Cana. Altri discepoli avevano già lasciato il Battista: Andrea e Giovanni, ma anche Pietro e Filippo lo seguivano (cfr Gv 1,37-45): quindi probabilmente erano questi i discepoli che tre giorni prima erano partiti da Betania di Giudea, ove il Precursore battezzava, e che ora si trovavano lì.
Ma in che senso Giovanni può sostenere che i discepoli, vedendo questo prodigio, "credettero in lui" (2,11)? Il Cristo era già riuscito a convincere alcuni discepoli del Battista ad abbandonare quest'ultimo e a seguire lui (Gv 1,35 ss.). E in nessuna parte del vangelo di Giovanni, né in quello di Marco, il Cristo compie dei prodigi per convincere qualcuno a diventare suo discepolo. Con la trasformazione dell'acqua in vino non si manifesta alcuna particolare "gloria", poiché il Cristo, in quella occasione, sarebbe anche potuto apparire più come uno stregone che non come un messia. Se poi era davvero il primo miracolo e Gesù ancora non si era "manifestato", avendo qui agito in segretezza (solo la servitù poteva aver intuito qualcosa di molto strano), non si comprende in che cosa i suoi discepoli avrebbero dovuto credere.
Forse qui si è voluta sottolineare una diversità di fondo tra l'accoglienza dei Giudei, in occasione dell'epurazione del Tempio, che non si può certo definire entusiasta, e quella che invece gli tributarono i Samaritani prima e i Galilei dopo? Le simboliche "giare" sembrano rappresentare la vuotezza, l'aridità giudaica, che va riempita col fervore, con l'esuberanza dei Galilei.
Di questo particolare episodio (se esso è davvero accaduto, ma assomiglia troppo a quello mitologico di Filemone e Bauci) solo i suoi più stretti discepoli possono essere stati testimoni (forse il solo Giovanni, visto che solo lui ne parla). Il v. 9 dice, tra parentesi, che i servi dello sposo si erano accorti del prodigio; tuttavia – possiamo aggiungere –, poiché non vi fu in loro alcuna reazione, è giocoforza dedurre che anche questa precisazione sia spuria.
Il motivo per cui la pericope non è riportata nei Sinottici è probabilmente dipeso dalla sua scarsa importanza rispetto a quella, per certi versi analoga, dei pani moltiplicati. Se alcuni servi dello sposo avessero visto il prodigio di mutare 500 litri di acqua in ottimo vino, il "protagonista" del matrimonio sarebbe stato Gesù, non gli sposi: cosa che invece nel racconto non appare assolutamente (tuttavia a Cana egli vi ritornerà, stando a Gv 4,46, per compiere una guarigione a distanza per il funzionario erodiano Cuza).
Qui l'autore dà ovviamente per scontata la fede post-pasquale, cioè ragiona col senno (apostolico) del poi. Al v. 11 molto probabilmente è stata aggiunta la seconda parte da un redattore che non riusciva a spiegarsi la ragione per cui un racconto del genere (che, rispetto ad altri, è piuttosto insignificante) doveva essere tramandato semplicemente perché a Cana Gesù aveva compiuto il suo primo prodigio.
Questo, in realtà, fu un evento del tutto privato, legato all'ambiente parentale della famiglia d'origine del Cristo. Esso mette semplicemente in luce l'umanità di un leader politico, il quale soltanto tre giorni prima aveva rotto con un movimento (quello battista) che non voleva saperne di organizzare una manifestazione contro i mercanti del Tempio.
La frase di Gesù relativa alla "sua ora" è senz'altro coerente col fatto che solo dopo qualche mese, in occasione della purificazione del Tempio, egli cominciò a manifestarsi in pubblico. Ma l'autore di questo racconto può aver fatto dire a Gesù quella frase proprio perché sapeva che la sua prima manifestazione pubblica sarebbe avvenuta a Gerusalemme, in occasione della Pasqua. E comunque Maria non può aver compreso il significato di quella frase.
È insomma molto probabile che il racconto faccia parte di una tarda tradizione spiritualista, sempre presente nel vangelo di Giovanni, la quale affianca, come un parassita, tutti i racconti giovannei di origine ebraica, il cui stile è più realistico che simbolico. È stata questa tradizione spiritualista che ha stravolto il significato originario del racconto e anche di tutto il vangelo di Giovanni.
Se l'episodio è davvero accaduto, l'interpretazione che se n'è data è troppo metafisica per essere credibile. Cioè è categoricamente da escludere che il Cristo abbia compiuto un prodigio del genere per dimostrare la superiorità del suo vangelo rispetto alla legge mosaica, ed è altresì impensabile ch'egli abbia voluto equiparare il vino al sangue.
Al massimo nella versione più antica il redattore avrà semplicemente voluto evidenziare che la capacità di Gesù di operare prodigi poteva essere messa al servizio anche per cose che non riguardavano affatto il "regno" da costruire, ma semplici esigenze materiali. Il che però contraddice la natura strettamente politica dei vangeli. Che senso avrebbe avuto scrivere in un testo politico un episodio strettamente privato? E perché, nel momento in cui lo si è voluto caratterizzare politicamente, lo si è trasformato in un racconto spiritualistico con addentellati addirittura magici?
Il testo comunque è molto antico, poiché l'autore non ha scrupoli nell'affermare che a quello sposalizio erano presenti non solo la "madre di Gesù" (il padre era già morto?), ma anche i suoi "fratelli", che vengono citati separatamente dai suoi discepoli (2,12). In un altro contesto, Marco – e Mt 13,55 s. gli farà eco – dirà che Gesù ebbe almeno quattro fratelli e un paio di sorelle (Mc 6,3).8
Resta molto dura la frase che Gesù rivolge a sua madre: "Che ho da fare con te, o donna?". Sembra quasi che qui si voglia evidenziare una sorta di estraneità tra madre e figlio, come se lei rappresentasse l'ebraismo tradizionale e lui l'alternativa radicale al sistema, e il rapporto tra i due non fosse altro che la ricerca di un momentaneo compromesso. Inspiegabile peraltro l'assenza del padre Giuseppe in questo episodio di natura privata: si può quindi presumere che quando Gesù inizia la sua vita pubblica, Giuseppe fosse già morto o comunque non vivesse più con la propria famiglia.
*
Mettiamoci ora dalla parte di un redattore che scrive un racconto del genere, carico di cose false o inventate, per cercare di scoprirne le motivazioni, che possono essere recondite o palesi. Supponiamo che dietro la frase di Gesù: "Non è ancora giunta la mia ora" (v. 4), si celi un significato simbolico, una sorta di mistica identificazione tra vino e sangue. La pericope – se questa ipotesi fosse vera – che significato avrebbe?
È molto semplice: l'ebraismo o il giudaismo è rappresentato dalle sei giare di pietra vuote, preposte alle abluzioni rituali previste dalla legge mosaica (si tratta quindi di un'aridità esistenziale), anzi il fatto che siano vuote sta proprio a indicare la fine di una civiltà, che ha perduto le proprie risorse identitarie e che quindi si limita a un formalismo rituale privo di contenuto soteriologico. Solo il Cristo possiede vere risorse spirituali: esse coincidono col sangue vivificante che dovrà versare sulla croce. In attesa che ciò avvenga, egli può soltanto compiere un miracolo materiale, sperando che i discepoli credano nella sua origine extraterrena. Quindi se ora possono soltanto limitarsi a bere l'acqua trasformata miracolosamente in vino, verrà il giorno in cui, per sentirsi spiritualmente salvati, dovranno bere il sangue di Cristo identificato col vino eucaristico.
Da una purificazione fisica, praticata nel mondo ebraico, preludio o segno di una morale, si passa, in questo racconto, a una purificazione spirituale fonte di salvezza, la cui efficacia è garantita non dalla volontà umana, bensì dal sacrificio dello stesso Cristo, il quale elargisce la sua grazia a chi crede nella sua figliolanza divina, testimoniata unicamente dalla resurrezione.
Il misticismo, qui, è portato a livelli assoluti (anche in virtù di altre caratteristiche simboliche presenti in questo racconto molto particolare); di conseguenza la mistificazione nei confronti della politicità del Cristo è massima.
Una spiegazione del genere, tuttavia, è abbastanza banale: vi erano già arrivati vari esegeti, antichi e moderni. La vera domanda cui si dovrebbe cercare di rispondere è un'altra: perché di questo episodio non vi è alcuna traccia nei Sinottici? Anche qui le spiegazioni date sono state molteplici: tra i discepoli non era presente Pietro; la principale fonte di questo episodio è la stessa Maria, che nel protovangelo viene vista come un ostacolo alla missione di Gesù; vengono messi in cattiva luce tutti i Galilei, dicendo ch'era prassi comune che, nel corso dei matrimoni, si distribuiva inizialmente ai commensali del buon vino, per poi passare a quello più scadente.
Su quest'ultima spiegazione si potrebbe però precisare che Maria, Gesù, i suoi primi discepoli e forse gli stessi sposi erano originari della Giudea, per cui questo racconto, come altri del quarto vangelo, non poteva rientrare nella tradizione galilaico-cristiana. Semmai quindi dovrebbero essere accusati i Giudei di tale grettezza economicistica, che, associata al formalismo delle regole rituali, li rendeva invisi ai Galilei, più spontanei e trasgressivi, tant'è che è proprio in Galilea che Gesù può tranquillamente compiere i suoi cosiddetti "prodigi".
Esiste però un'altra spiegazione, che ci viene offerta da un altro racconto dello stesso vangelo, quello della guarigione del figlio di un ufficiale ebreo di nome Cuza, avvenuta sempre a Cana. Qui vengono fatte dire a Gesù delle parole storicamente inattendibili ma ideologicamente significative nel contesto: "Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete" (4,48).9
Se si unisce questa frase a quella riportata nell'ultimo versetto del cosiddetto miracolo di Cana: "I suoi discepoli credettero in lui dopo che aveva dato inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea", vien da pensare che questi racconti siano maturati in ambienti giudaico-cristiani di tipo monastico in polemica con gli ambienti urbanizzati della tradizione galilaico-cristiana. Cioè in questi racconti si sta denunciando il fatto che in Galilea si credeva in Gesù solo perché compiva prodigi straordinari. I cristiani di origine galilaica (o ellenistica) appaiono più superficiali dei cristiani di origine giudaica, meno dotati teologicamente, sicuramente meno legati alle tradizioni formali ma anche più venali e materialisti.
Infatti, mentre in Giudea cominciarono a credere in Gesù quando fece la purificazione del Tempio, cioè quando compì un gesto eminentemente politico, rivolto all'intera collettività, il miracolo di Cana invece viene fatto solo per soddisfare un'esigenza personale o familiare, come quella appunto degli sposi e dell'ufficiale erodiano.
(torna su)16) I pani moltiplicati
Gv 6,1-70 - Mc 6,30-44
I
Il quarto vangelo dedica ampio spazio alla descrizione di questo importante episodio della vita di Gesù, durato l'arco di due giorni, e questo nonostante che anche i Sinottici (soprattutto Marco) ne parlino estesamente (spesso infatti Giovanni interviene là dove i Sinottici sono o lacunosi o imprecisi).
Si può anzi con certezza sostenere che solo grazie a Giovanni si svela l'arcano di certe espressioni marciane, che tendono a circoscrivere l'evento in forzate speculazioni teologiche, maturate in seno alla comunità post-pasquale. P. es. Marco, quando afferma che gli apostoli "non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito" (6,52), non solo non offre maggiori delucidazioni rispetto a Giovanni, ma tende anche ad avvalorare la tesi religiosa che vede in questo episodio un'anticipazione dell'ultima cena o una prefigurazione dell'eucaristia. E in questo Luca e Matteo dipendono totalmente da lui. Persino il quarto vangelo è stato costretto a subire pesanti interventi redazionali di tipo censorio o correttivo in linea con le tesi petro-paoline riportate nel primo vangelo.
I tempi e i luoghi delle due versioni più interessanti, di Giovanni e di Marco, coincidono, più o meno. "Era vicina la Pasqua" (Gv 6,4), "c'era molta erba in quel luogo" (Gv 6,10; Mc 6,39), dunque era primavera. Il luogo era situato "sull'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade" (Gv 6,1); Mc 6,32 parla di "luogo solitario, in disparte" e di attraversata del lago "sulla barca".
La prima domanda che viene spontaneo porsi è proprio quella legata al luogo: perché Gesù e gli apostoli cercano un luogo solitario? Gv 6,2 dice che "una gran folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi". È difficile però credere che centinaia, forse migliaia di persone seguissero Gesù per una cosa che potevano ottenere solo con molta difficoltà. Qui infatti siamo alla fine della sua attività galilaica, che ha voluto essere anzitutto politica e non taumaturgica (ammesso e non concesso che Gesù abbia mai compiuto delle guarigioni che non fossero alla portata di un essere umano). Stando a Gv 4,43 ss., Gesù fece in Galilea una sola guarigione: quella del figlio del funzionario reale (che è a distanza e quindi interpretabile in maniera del tutto simbolica), mentre secondo Marco le ultime due guarigioni compiute in Galilea sono state quella del cieco di Betsaida (8,22 ss.) e quella dell'epilettico di Dabereth (9,14 ss.), entrambe quasi strappate con la forza.
Forse la motivazione della sequela può essere stata aggiunta, nell'ultimo vangelo canonico, da un redattore che nutriva un certo scetticismo nei confronti delle folle galilaiche o delle folle in genere, qui viste come interessate a favori di tipo personale, quando in realtà la sequela poteva aver benissimo delle motivazioni di tipo politico.
Mc 6,31, infatti, sostiene che siccome i discepoli erano molto impegnati a evangelizzare le masse, queste erano diventate molto numerose, al punto che i discepoli "non avevano più neanche il tempo di mangiare". (Singolare è il fatto che Lc 9,11 e Mt 14,14, pur dipendendo da Marco, ribadiscano lo stereotipo secondo cui la folla seguiva Gesù solo per le guarigioni). "Gli apostoli – dice Mc 6,30 – si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato". Questo è l'unico passo del vangelo di Marco dove i Dodici vengono chiamati col nome di "apostoli", cioè di "inviati". È un'indicazione precisa della loro attività propagandistica, non un titolo ufficiale, che solo più tardi s'imporrà in seno alla comunità primitiva.
L'efficacia del loro operato era evidente: il movimento nazareno contava già numerosi seguaci (Gv 6,10 e Mc 6,44 parlano di cinquemila uomini, un numero alquanto considerevole per quel tempo). La differenza tra gli apostoli e la folla stava semplicemente nel fatto che questa – come dice Mc 6,31 – "andava e veniva", quelli invece "facevano e insegnavano" (Mc 6,30). Gli apostoli rappresentavano, per così dire, l'avanguardia consapevole del movimento spontaneo delle masse.
Considerando che i vangeli sono testi politici che vogliono ridurre al minimo la politica rivoluzionaria del movimento nazareno, è dunque difficile dar loro retta quando dicono che le folle (qui a migliaia) seguivano il Cristo esclusivamente per la sua attività taumaturgica; tanto più, peraltro, che nella versione di Marco le folle seguono anche gli apostoli, che non hanno mai fatto alcuna guarigione.
Se qui cinquemila persone avessero seguito il Cristo e i Dodici soltanto per ottenere guarigioni (come lascia supporre Gv 6,2), la situazione sarebbe dovuta apparire ingestibile sin dall'inizio; non solo, ma l'atteggiamento di queste folle darebbe un'impressione fortemente negativa sul lettore del vangelo, al punto che si dovrebbe avvalorare la tesi della comunità post-pasquale secondo cui l'obiettivo politico del vangelo di liberazione era utopistico e andava quindi ridimensionato in chiave spiritualistica.
Viceversa, Marco lascia intendere che la folla li stesse seguendo con la speranza di ottenere qualcosa che andasse al di là delle semplici guarigioni. Anzi, essa sembra non comprendere le necessità dei Dodici di un momento di riposo dopo il tanto lavoro propagandistico, e con decisione cerca di raggiungerli da terra, costeggiando la riva del lago. "Molti li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero" (Mc 6,33).
Il singolare spostamento logistico di questa marea di persone porta a credere che la fama del Cristo e dei Dodici era diventata molto vasta in Galilea e che le contraddizioni sociali, le aspettative di indipendenza nazionale avevano raggiunto ormai il culmine. L'istintiva invadenza popolare è appunto tipica di quelle "pecore senza pastore" (di cui parla Mc 6,34) che seguono Gesù e i Dodici senza una chiara strategia politica, ma con un forte desiderio di liberazione.
Nei Sinottici, dominati da uno sfondo moralistico latente, Gesù si commuove, ha compassione di questi sbandati, mostrando di non sapere neppure lui come gestire quella situazione (Mc 6,34; Mt 14,14; Lc 9,11). In Gv 6,3 l'atteggiamento è invece più sicuro e distaccato: "Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli", cioè scelse un luogo da dove poteva essere facilmente visto dalla folla. Non "si mise a insegnare loro molte cose", come vuole il catechista Mc 6,34, che peraltro di queste cose non dice una parola, né guarì i loro malati, come vuole Mt 14,14, né fece entrambe le cose, come vuole Lc 9,11.
Che cosa su quel monte essi si siano detti, sino a tarda sera, si può solo immaginare. Con una folla di cinquemila persone in attesa di sapere quand'era il momento di agire in maniera risoluta, bisognava ad un certo punto prendere una decisione. Giovanni qui è esplicito nel descrivere lo stato d'animo dei protagonisti di quell'evento: dopo aver detto ch'erano saliti sul monte, al v. 6,4 dice una cosa che avrebbe dovuto mettere all'inizio del racconto, per contestualizzarlo nelle coordinate spazio-temporali; qui invece ha tutt'altro significato, e questo significato è di natura strettamente politica: "Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei": il momento migliore per andare a Gerusalemme e liberare la città dai Romani. Marco s'è guardato bene dal ricordarlo.
A questo punto le versioni di Marco e di Giovanni divergono nettamente: infatti, là dove Giovanni (6,5) afferma che la folla, stanca d'aspettare, cominciò a salire sul monte per sapere quale decisione era stata presa, Marco invece si limita ad affermare che "essendosi ormai fatto tardi, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendogli: Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare" (Mc 6,35 s.).
Marco fa dire ai discepoli una cosa che il Cristo avrebbe potuto tranquillamente intuire da solo. Mette il Cristo in una posizione insensata, poiché dopo aver detto ch'egli "insegnava alle folle molte cose", aggiunge che, invece di congedarle, finito il discorso, egli si sarebbe ritirato per alcune ore in un luogo solitario (il monte non viene mai citato) senza fare nulla, al punto che se alla folla non si fosse detto di tornarsene a casa, quella probabilmente sarebbe rimasta lì tutta la notte a bighellonare.
Avendo tolto a questo avvenimento una qualunque valenza politica, Marco è caduto in una serie di contraddizioni insostenibili. Di qui forse l'esigenza di Giovanni di precisare le cose. "Alzàti gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?" (Gv 6,5).
Qui appare evidente che non solo il Cristo sapeva che la folla, stanca d'aspettare, aveva cominciato ad aver fame in senso fisico e che non avrebbe trovato dei rifornitori molto facilmente, data l'ora tarda e il luogo solitario, e che con le loro risorse i Dodici non sarebbero stati in grado di sfamare nessuno, ma anche che il concetto di "fame" andava interpretato in senso metacognitivo. La folla ha "fame di liberazione" e ora vuole sapere, una volta per tutte, se Gesù e i Dodici costituiscono il "pane" con cui sfamarsi a Gerusalemme, per il momento fatidico della Pasqua.
A Filippo viene posta una domanda ambigua "per metterlo alla prova", dice Gv 6,6. Spesso le domande di Gesù appaiono strane perché sembrano presumere una risposta ovvia. In realtà la loro ambiguità, che si gioca sul doppio senso di certe parole o espressioni, obbligava a trovare delle risposte pertinenti, per nulla scontate.
Non a caso proprio grazie all'equivocità di molte parole o espressioni, la comunità primitiva ha poi avuto buon gioco nell'imbastire le proprie fantasie spiritualistiche. Qui s'è addirittura divertita a canzonare il povero Filippo che, fatto passare per un ingenuo, risulta incapace di cogliere al volo l'intenzione del Cristo di esibirsi in tutta la sua spettacolare maestria di prestidigitazione. E un secondo redattore ha voluto aggiungere l'inciso: "Gesù infatti sapeva bene quello che stava per fare" (Gv 6,6).
In realtà la prova era alla portata di Filippo, come di qualunque altro apostolo. Ed era ancora una volta di tipo politico: "Sono in grado i Dodici di gestire un'istanza di liberazione di così vaste proporzioni? Sapranno farlo rispettando le regole delle democrazia?". "Voi stessi date loro da mangiare", viene detto in Mc 6,37.
Nel racconto di Giovanni gli apostoli (per bocca di Filippo e Andrea) non comprendono la domanda, oppure la comprendono ma vi danno una risposta schematica, cioè l'atteggiamento di Filippo e Andrea può far pensare che tra i Dodici non vi fosse unanimità nel gestire quella situazione. Infatti, se prendiamo alla lettera il dialogo tra Gesù e gli apostoli, noteremo subito delle forti incongruenze, sia in Marco che in Giovanni, a testimonianza che qualcosa di molto strano doveva essere successo in quel frangente.
Nella versione di Marco, all'invito di congedare le folle, mosso dagli apostoli, Gesù risponde con una richiesta a dir poco paradossale, data l'ora tarda, il luogo isolato e il numero spropositato di persone da sfamare: "Voi stessi date loro da mangiare". Al che gli apostoli, come se si sentissero presi in giro, ribattono che con duecento denari non si sfamano certo cinquemila persone (un denaro era in genere la paga quotidiana dell'operaio). La domanda che pongono: "Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dar loro da mangiare?" (Mc 6,37), lascia trapelare un atteggiamento ambivalente, che un credente potrebbe interpretare come "aspettativa di tipo miracolistico" e un laico come "malcelata ironia".
Sia come sia il Gesù di Marco ribatte con una richiesta ancora più esigente e che, proprio per questo motivo, dovette risultare ancora più incredibile della precedente: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Cioè non occorreva comprare nulla, perché sarebbe bastato quel che già si aveva.
In Giovanni è lo stesso, almeno apparentemente. Alla domanda imbarazzante di Gesù: "Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?", che colse Filippo alla sprovvista, fa seguito una sorta di dialogo dell'assurdo tra Gesù ed Andrea: di fronte alla constatazione dell'apostolo circa la povertà dei loro mezzi di sussistenza, Gesù non si scompone e ordina di far mettere a sedere i cinquemila uomini. (Anche qui qualche esegeta ha avuto il coraggio di sostenere che Andrea, proponendo al Cristo i cinque pani e i due pesci, sospettasse che questi volesse fare qualcosa di speciale).
I due racconti apparentemente coincidono. La differenza, tuttavia, è molto grande, poiché quando Marco usa la parola "pane" pensa a qualcosa di religioso: il sacramento dell'eucaristia; Giovanni invece pensa a qualcosa di politico (il secondo redattore di Giovanni a qualcosa di metafisico). Delle due quindi l'una: o Gesù ha davvero compiuto il miracolo, a testimonianza della netta differenza che separava lui dai Dodici (ma allora entriamo nella fantascienza), oppure in luogo di questo impossibile prodigio è avvenuto qualcosa che doveva essere rimosso.
La prima ipotesi però andrebbe scartata a priori non solo perché umanamente inverosimile, ma anche perché su una cosa le domande non troverebbero una risposta convincente: come sia cioè possibile che quella folla, che in Gv 6,15, una volta sfamata, lo vuole proclamare "re", associando un evento miracolistico a un'esigenza di liberazione nazionale, sia la stessa che in Mc 6,44 non ha alcuna reazione, come se avesse assistito a una delle tante guarigioni. (Da notare che in Gv 6,30 la stessa folla che lo vuole "re", gli chiede un segno per poter credere in lui, come se il miracolo che aveva appena visto fosse stato una bazzecola!).
Viceversa, se consideriamo attendibile la seconda ipotesi, dobbiamo necessariamente arguire che la descrizione del prodigio ha sostituito il ricordo di un evento molto increscioso, in cui i Dodici apparivano come dei protagonisti negativi. Oppure qui si è preferito addebitare loro una parte del genere, in quanto nella realtà non avevano capito che la rivoluzione, in quella occasione, coinvolgendo unicamente masse originarie della Galilea, non poteva essere fatta con la ragionevole certezza del suo buon esito finale.
Se si accettasse l'esegesi confessionale noi dovremmo essere indotti ad affermare che la negatività degli apostoli stette proprio nel non saper sfamare quelle folle, ma se consideriamo vero il prodigio del Cristo, dovremmo necessariamente dedurre che tutta la negatività dei Dodici in altro non consistette che nell'incapacità di fare prodigi come lui. Il che, umanamente parlando, è insostenibile.
Tuttavia, poiché i racconti di Marco e del secondo redattore di Giovanni in sostanza lasciano trapelare questo tipo di interpretazione, qui si deve concludere che gli apostoli hanno ufficialmente accettato di far passare una versione redazionale che li mettesse in cattiva luce sul piano della facoltà di compiere prodigi, piuttosto che quella in cui si sarebbe dovuto mettere in chiaro la loro incapacità di guidare politicamente le masse.
Che cosa sia veramente accaduto è comunque difficile dirlo. Forse Gesù si aspettava che fossero i Dodici a congedare le folle con un discorso politico, spiegando a queste che i tempi non erano ancora maturi per compiere la rivoluzione: non dovevano forse gli apostoli diventare i "pastori" delle "pecore" che "vanno e vengono"? Forse è stato lo stesso Gesù a spiegare alle folle l'illusione di poter compiere una rivoluzione vittoriosa senza l'appoggio delle masse giudaiche e samaritane.
Quel che è certo è che esiste una differenza sostanziale tra Marco e Giovanni, in quanto mentre il primo tende a presentare un Cristo molto esitante sul piano politico o comunque una folla poco convinta nell'attribuirgli il ruolo di messia (cfr anche Mc 8,28), il secondo invece delinea un Cristo intenzionato a diventare un leader politico ma non secondo le aspettative spontaneistiche della folla.
Se accettassimo le versioni stereotipate dei redattori confessionali dovremmo dire che mentre in Marco Gesù cerca di accontentare con un fenomeno paranormale una folla che, pur seguendolo per motivi vagamente politici, si presenta come un gregge senza pastore; in Giovanni invece la folla, pur non seguendolo per motivi politici, ma solo per le guarigioni, vedendo il miracolo è disposta a proclamarlo re, cioè al fenomeno paranormale risponde col primitivismo politico, sperando di accontentare un messia che pare insoddisfatto del proprio ruolo di taumaturgo.
La stessa espressione giovannea, sicuramente realistica: "Sapendo che stavano per venirlo a prendere e farlo re, Gesù fuggì sulla montagna tutto solo" (6,14 s.), se l'avesse formulata Marco avrebbe avuto un significato molto diverso. In Marco infatti il Cristo si sarebbe nascosto per rispettare la strategia del "segreto messianico" (così come essa appare in vari passi del suo vangelo), mentre in Giovanni la fuga del Cristo vuole rispecchiare una incompatibilità di fondo tra il ruolo di stratega che gli voleva attribuire la folla, sulla scia dei grandi condottieri giudaici, e il ruolo, molto più democratico, ch'egli voleva attribuire a se stesso e ai suoi discepoli.
Come noto Marco ha trasformato il cosiddetto "segreto messianico" di Gesù da mero espediente tattico, utilizzato per non avvalorare propensioni avventuristiche da parte della folla, a una scelta strategica vera e propria, in cui praticamente e definitivamente veniva a riassumersi tutta la sua attività politica.
Non a caso nei Sinottici il miracolo dei pani è un racconto come altri (in Luca questo è molto evidente): nessuno tra la folla si stupisce di qualcosa, neppure tra gli apostoli, come se la folla avesse avuto una tale maturità politica da considerare episodi così spettacolari del tutto normali, quando, in realtà, è proprio la maturità politica che rende vani e inutili episodi del genere.
Presentando un Gesù impolitico, i Sinottici attenuano lo scarto fra quello ch'egli s'era proposto di realizzare e quello che effettivamente realizzò. Essi hanno accuratamente evitato di rispondere all'imbarazzante domanda che per forza di cose il lettore dei pani moltiplicati avrebbe dovuto porsi: perché in quell'occasione Gesù rifiutò di diventare re d'Israele e di marciare su Gerusalemme, come la folla gli richiedeva? I Sinottici non sono in grado di rispondere a questa domanda perché secondo loro Gesù non era destinato a diventare re. Essi cioè, non sapendo spiegarsi il motivo per cui un uomo che avrebbe potuto diventare il re d'Israele non riuscì a diventarlo, sono stati costretti a chiudere il racconto con un tono di tipo pietistico-moralistico: Gesù fece il miracolo perché vedendo quelle pecore senza pastore si commosse per loro (Mc 6,34).
Il vangelo manipolato di Giovanni – come noto – risolve la questione a modo suo, sostenendo che proprio nella morte di croce Gesù si manifestò come messia. In tal modo si attenua lo scarto tra l'essere e il dover essere con una tesi di tipo gnostico-spiritualistico. Il che non sarebbe sbagliato se con questa tesi non si volesse in realtà sostenere che il Cristo non voleva diventare "re di questo mondo".
Qui, nel racconto dei pani moltiplicati, se si desse per buona la motivazione giovannea secondo cui le folle seguivano Gesù soltanto per i suoi poteri (taumaturgici e miracolistici), si dovrebbe spiegare solo in un modo la decisione di rinunciare al trono: le folle erano immature appunto perché più interessate alle guarigioni che non al vangelo di liberazione. In tal senso la moltiplicazione dei pani sarebbe servita come surrogato alle guarigioni che in quel frangente non furono fatte.
Il resto può anche essere interpretato in maniera simbolica: là dove Gesù diede l'ordine di raccogliere "i pezzi avanzati" (Gv 6,12), ciò sarebbe dovuto servire come testimonianza che il prodigio aveva sì un carattere gratuito, ma non superfluo, nel senso che con esso si voleva porre un argine proprio all'attività terapica sui malati. Col che noi avremmo a che fare con una folla che ad un certo punto smise di seguirlo (Gv 6,66), soltanto perché costretta a prendere atto della indisponibilità del Cristo-sciamano a proseguire l'attività fin lì condotta. Una visione della folla, questa del secondo redattore di Giovanni, molto riduttiva. La si ritrova anche in Mc 6,53 ss., laddove si dice che la folla, dopo questo "miracolo", aveva interesse solo a una cosa: le guarigioni.
Una rappresentazione così pessimistica delle folle galilaiche può essere stata dettata dal fatto che in occasione di quell'avvenimento il movimento nazareno subì una grande sconfitta di credibilità. Probabilmente gli apostoli attribuirono il fallimento della rivoluzione galilaica più all'immaturità delle masse che non alla propria. Di qui la decisione redazionale di moltiplicare i pani in luogo di ciò che gli apostoli avrebbero dovuto fare. La moltiplicazione simbolica ha risolto il problema della pochezza politica.
Quale possa essere stato il motivo della rottura, peraltro momentanea, tra il Cristo e le folle galilaiche può essere solo intuito. Probabilmente esse si ritenevano sufficientemente numerose per compiere un'efficace sommossa antiromana che portasse alla liberazione nazionale, e tendevano a sottovalutare l'importanza di possibili intese con le forze giudaiche e samaritane e di altre etnie ancora. Oltre a ciò si può forse ipotizzare che le folle avessero un idealtypus di messia più vicino ai vecchi schemi giudaici, secondo cui per imporsi uno deve dimostrarlo con dei segni inequivocabili o deve comunque sapersi porre sulla scia dei grandi sovrani della tradizione giudaica.
Gv 6,70 addirittura sostiene che a partire da quel momento uno dei Dodici, Giuda, cominciò a pensare al modo come tradire Gesù, cioè – si può aggiungere (ma è solo un'ipotesi) – al modo in cui indurlo a compiere la rivoluzione nonostante l'immaturità dei tempi e lo spontaneismo delle masse. Ma non è da escludere che questo versetto sia stato messo semplicemente per dimostrare la natura divina del Cristo, quella per la quale egli sapeva in anticipo chi l'avrebbe tradito.
Pietro, che dichiara, obtorto collo, di voler continuare la sequela, nonostante la pesante defezione, esprime la consapevolezza di chi accetta di restare nella propria frustrazione, non vedendo di fronte a sé alternative praticabili. La distanza tra lui e il Cristo è tipicamente quella che si verifica ogniqualvolta si deve decidere quale valore attribuire ai due elementi fondamentali di ogni rivoluzione: l'attacco alle istituzioni e il cambiamento di mentalità. Quando nella decisione di ribaltare il sistema si privilegia nettamente il primo aspetto sul secondo, il fallimento della rivoluzione diventa inevitabile.
È vero, non esiste una netta antitesi in processi così strettamente interagenti; esiste tuttavia un prius da salvaguardare: le rivoluzioni vanno compiute da uomini che nella loro coscienza sono già qualitativamente diversi. Solo così, infatti, si può sperare che, una volta ribaltato il sistema, gli ideali non vengano immediatamente traditi.
II
Il prosieguo del racconto di Giovanni è per un verso molto simile a quello della versione di Marco (la camminata di Gesù sul lago) e per un altro si presenta in maniera molto più articolata, senza per questo avere maggiore attendibilità sul piano storico (il discorso presso la sinagoga di Cafarnao).
Vediamo la prima parte (Gv 6,16-21).
Dopo il clamoroso rifiuto di Gesù di diventare re, rappresentato con una sua fuga verso la parte più inaccessibile del monte, i Dodici si sentirono completamente abbandonati. Non sapendo cosa fare con la folla rimasta a valle, e avendo capito che Gesù voleva restare solo, decisero di ritornare sull'altra riva, "in direzione di Cafarnao", dopo averlo atteso invano. "Il mare era agitato perché soffiava un forte vento". Gli lasciarono una barca.
A questo punto deve essere successo qualcosa che ha fatto scatenare la fantasia redazionale della comunità primitiva e che l'ha portata a far camminare il Cristo sulle acque.
Ancora una volta l'unica spiegazione possibile di questa versione romanzata dei fatti la offre Giovanni, il quale sostiene che quando gli apostoli arrivarono a Cafarnao trovarono presso la sinagoga il Cristo che li aveva inspiegabilmente preceduti e che stava animatamente discutendo sulle condizioni per la sua candidatura al trono.
Più di così non si può argomentare. Cioè anche se qualcuno arrivasse a dimostrare che la natura umana, ben addestrata, è in grado di fare cose apparentemente impossibili, questo non lo autorizzerebbe comunque a trarre delle conclusioni sull'uomo Gesù che andassero oltre la sua natura umana.
Qui non è neppure il caso di enumerare le molte incongruenze e illogicità di questa pericope. Si ha solo l'impressione che la camminata sul lago stia all'immaturità politica dei Dodici, come i pani moltiplicati stiano all'immaturità politica delle folle galilaiche. Ma su questo dovremo dire altre cose più avanti.
Vediamo ora la seconda parte del racconto di Giovanni (6,22-70).
La lunghezza del discorso che il Cristo tenne nella sinagoga di Cafarnao pare inversamente proporzionale alla sua importanza storica. Si tratta infatti di una prolissa disquisizione sul concetto di "pane di vita", che l'ambiente gnostico-giovanneo ha applicato direttamente alla persona di Cristo più che al pane eucaristico (come invece hanno fatto i Sinottici).
Il Cristo del Giovanni "metafisico" arriva a sostenere che per credere nel suo vangelo i discepoli dovrebbero mangiare la sua carne. Egli parla in modo tale da non poter essere capito: lo scandalo è grande e la conseguente rottura politica inevitabile.
I fatti, come al solito, devono essere andati diversamente, e solo il Giovanni "politico" può in qualche modo illustrarceli. Poiché esistono precisi riferimenti a Mosè (vv. 31-32, ma cfr anche Mc 6,40, dove viene detto, rievocando la disciplina militare del deserto, come da Es 18,25, che la folla fu messa a sedere per gruppi di cento e di cinquanta persone), è probabile che il Cristo abbia chiesto alle folle galilaiche e alle autorità incontrate presso la sinagoga, di considerare come concluso il primato assoluto concesso alla legge mosaica, alle istituzioni giudaiche, alle tradizioni religiose connesse al culto del sabato, dei sacrifici di animali, della circoncisione, delle norme di purità rituale, o comunque di considerare come superata l'idea di poter realizzare l'indipendenza nazionale in nome di principi troppo particolaristici per poter essere condivisi da etnie non ebraiche.
La reazione fu molto negativa: "Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?" (Gv 6,60). "Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui" (v. 66).
III
La pesante mistificazione che nel vangelo di Giovanni s'è operata su questo episodio, passato alla storia col nome di "miracolo dei pani e dei pesci", si presenta come il rovescio della medaglia rispetto a quanto hanno fatto i Sinottici, di cui il principale resta il vangelo di Marco, portavoce dell'apostolo Pietro.
In entrambe le versioni è stato del tutto omesso il discorso che inevitabilmente Gesù deve aver pronunciato in quel momento, approfittando del notevole assembramento di seguaci, disposti a salire a Gerusalemme per compiere la rivoluzione armata.
Tuttavia, mentre in Marco l'evento politico è stato trasformato in un prodigioso episodio miracolistico, benché senza alcuna significativa conseguenza sul tipo di sequela al movimento nazareno (se si esclude il fatto, del tutto minimalista, che la popolazione voleva sempre più guarigioni), in Giovanni invece si fa capire che proprio in quell'occasione la defezione politica del movimento, di fronte al rifiuto di Gesù di diventare monarca d'Israele, fu drammatica e dipese dal fatto che le folle non avevano capito l'identità religiosa del messia.
In altre parole, mentre una versione mistifica le cose col silenzio assoluto sulla natura politica dell'evento, l'altra trasforma l'evento politico di natura laica in un qualcosa che unisce la mistica alla teologia.
Questo deve indurci a riflettere su almeno tre aspetti:
– il vangelo di Marco, pur essendo una falsificazione come quello di Giovanni, lo è in maniera più primitiva, meno teologica, ma, nonostante questo, esso detta le regole fondamentali per interpretare tutti gli eventi connessi alla persona del Nazareno;
– Marco non ha fatto ricorso a una teologia evoluta per mistificare l'evento politico, ma a una sorta di credulità popolare, secondo cui dei pani e dei pesci potevano essere tranquillamente moltiplicati dal "figlio di dio"; col che si può presumere che al tempo della stesura di questo vangelo si fosse già imposta, nell'ambito della chiesa primitiva, una direzione del movimento di natura autoritaria, capace di far leva sugli aspetti deteriori della demagogia, del populismo, del sensazionalismo carismatico;
– il redattore del quarto vangelo, pur avendo fatto capire che l'evento ebbe un risvolto politico, in quanto la folla voleva far diventare re il messia, accetta ugualmente l'impostazione magica che Marco (Pietro) ha dato dell'evento; tuttavia, pur potendo evitare, senza problemi di sorta, di dare una connotazione politica all'evento, limitandosi ad accettare la versione marciana, l'autore ha preferito aggiungere a questa versione una sofisticata riflessione teologica che ha trasformato la politicità del racconto in un raffinato misticismo.
In altre parole, mentre in Marco si comprende bene la censura operata, ovvero lo stravolgimento dei fatti e dell'interpretazione che se ne doveva dare, nel vangelo di Giovanni si ha l'impressione che alla stesura della narrazione abbiano partecipato più mani. Non si capisce infatti il motivo per cui l'evangelista sia andato a complicarsi la vita svelando il lato politico dell'evento, che Marco aveva invece sapientemente celato, quando avrebbe potuto benissimo farne a meno.
Che bisogno c'era di fare della teologia mistica (quella sul "pane disceso dal cielo") partendo proprio dalla politicità dell'evento? Non sarebbe stato sufficiente assumere come definitiva la versione marciana, ampliandone in maniera simbolico-religiosa il parallelo tra "manna nel deserto" e "pane di vita"?
Insomma qui è netta l'impressione che lo stesso Giovanni abbia scritto una versione dei fatti antitetica a quella marciana e che, proprio per questa ragione, sia stato sottoposto a un'abile manipolazione redazionale, che doveva tener conto della versione marciana e che poteva al massimo approfondirla in senso mistico, o comunque in direzione di una teologia politica che non contraddicesse nella sostanza quella canonica (petro-paolina).
Ora però bisogna cercare di capire che cosa può aver detto il messia in quell'occasione e il motivo per cui, alla richiesta di compiere la rivoluzione armata, egli abbia opposto un netto rifiuto. Questa è la parte più difficile, poiché se non siamo in grado di chiarire il suddetto rifiuto, stando entro i limiti di una rigorosa laicità e di una ancora più rigorosa concezione democratica della politica, si finirà inevitabilmente per cadere nelle maglie delle interpretazioni mistiche dei vangeli.
La tesi da dimostrare è che il Cristo si rifiutò di compiere l'insurrezione armata non perché i tempi non fossero maturi per i seguaci Galilei, ma perché non lo erano per i Giudei. Un'insurrezione nazionale che fosse partita dalla sola Galilea, senza l'appoggio strategico della parte più consapevole della Giudea, sarebbe stata un pericoloso avventurismo, anche se in quel momento la presenza romana nella regione non costituiva un ostacolo insormontabile, visto che i prefetti, per poter governare, avevano necessità di appoggiarsi su una leadership autoctona, abilmente corrotta.
Per poter compiere una vittoriosa insurrezione bisognava prima togliere qualunque credibilità ai dirigenti politico-religiosi del Tempio, cercando il più ampio consenso possibile tra le forze progressiste, e questo non poteva certo essere fatto imponendo la volontà galilaica a quella giudaica, ovvero chiedendo ai Giudei di accettare una decisione insurrezionale cui non avevano contribuito in maniera decisiva.
Una ribellione generale contro il più grande impero schiavistico mai apparso fino ad allora, non poteva che essere nazionale, cercando intese ed alleanze non solo tra Giudei e Galilei, ma anche tra questi e i Samaritani, per arrivare sino agli ebrei di origine ellenistica e agli stessi pagani che più duramente pagavano le conseguenze dell'oppressione imperiale.
Per dimostrare la fondatezza di questa tesi è sufficiente leggersi i primi quattro versetti del capitolo 6 di Giovanni, che danno le coordinate spazio-temporali dell'evento. Gesù e i suoi più fidati discepoli si trovavano in Galilea; era vicina la Pasqua; l'intero movimento nazareno era pronto a compiere l'insurrezione armata, dirigendosi verso Gerusalemme, cioè approfittando del momento favorevole della maggiore festività del paese, in cui l'afflusso dei fedeli era enorme. Con questa insurrezione si era convinti di poter espellere i Romani da tutta la Palestina e di epurare i luoghi del potere politico ebraico dai collaborazionisti.
Ora, siccome il testo parla di un movimento che solo sul versante maschile era composto di cinquemila persone, ci si può chiedere se a quel tempo una consistenza del genere sarebbe stata sufficiente per compiere un'operazione di così vasta portata. Qui ovviamente si ha a che fare con militanti ben consapevoli, disposti a qualunque sacrificio in nome della libertà nazionale, ma è non meno evidente che una marcia verso Gerusalemme di quella portata avrebbe ingrossato le file dei nazareni a dismisura, e ancora più l'avrebbero fatto le prime vittorie politiche e militari nella capitale.
Passare da cinquemila al doppio sarebbe stato relativamente facile. I Romani, colti di sorpresa, ci avrebbero messo non pochi mesi prima di prendere adeguate contromisure. Di sicuro i loro collaborazionisti ebrei sarebbero stati immobilizzati molto facilmente e in pochissimo tempo. Dunque per i Galilei esistevano tutte le condizioni per compiere la rivoluzione.
Per quale motivo invece vi fu una defezione di massa, al punto che il Cristo arrivò a chiedere ai Dodici se volevano andarsene anche loro (Gv 6,67)? Cosa lo trattenne dal compiere la rivoluzione? Per quale motivo insisteva nel dire che "il tempo giusto non era ancora venuto" (Gv 7,6)? Aveva forse paura che lo uccidessero prima ancora di poter portare a termine l'impresa, come chiaramente appare in Gv 7,1?
È probabile che i Giudei, sentendosi sufficientemente forti per fronteggiare da soli l'autoritarismo dei vari procuratori romani, non avvertissero l'esigenza di cercare coi Galilei una strategia comune. Molti di loro escludevano tassativamente che il messia potesse venire dalla Galilea (Gv 7,41.52).
Stando a Giovanni, infatti, Gesù decide di compiere l'insurrezione soltanto dopo lo smacco del movimento di Lazzaro, sul quale evidentemente i Giudei progressisti avevano riposto molte delle loro speranze.
Quando Gesù entra in pompa magna a Gerusalemme, poco prima della Pasqua, e quindi come minimo un anno dopo la defezione galilaica sul monte Tabor, aveva al suo seguito non solo i nazareni ma anche i seguaci di Lazzaro. Era quello il momento giusto per far scoppiare la rivolta decisiva: le due etnie principali, Giudei e Galilei, si trovavano finalmente sullo stesso piano, guidate da un leader che, pur essendo di origine giudaica, era stato costretto a vivere in Galilea. Era come un ritorno trionfale dall'esilio, iniziato subito dopo la fallimentare cacciata dei mercanti dal Tempio. Dallo smacco sul Tabor all'ultima Pasqua, Gesù – stando sempre al quarto vangelo – era salito a Gerusalemme solo in occasione di due feste: quella delle Capanne, in forma del tutto clandestina, scontrandosi, per questo motivo, coi suoi parenti, che invece avrebbero preferito la massima pubblicità; e quella della Dedicazione, in cui alla domanda politica circa il suo messianismo aveva risposto confermando il proprio umanesimo integrale.
La questione su cui ora però bisogna soffermarsi è la seguente: è possibile rintracciare nel racconto di Giovanni sui cosiddetti "pani moltiplicati" qualche elemento che faccia capire il motivo per cui Gesù rifiutò di compiere l'insurrezione nazionale? Noi abbiamo parlato di una mancata intesa strategica tra Giudei e Galilei, ma questa può anche essere una semplice congettura, e in ogni caso abbiamo il dovere di mostrare quali siano gli elementi testuali che in qualche modo la rendono plausibile.
Purtroppo di fronte a noi sembra esistere soltanto una pesante mistificazione redazionale, con la quale s'è voluta dare, alla nostra domanda, una risposta di tipo mistico, che si può riassumere nei seguenti termini: i Galilei abbandonarono Gesù perché, cercando in lui un leader politico, non avevano capito che il suo messaggio aveva come fine la salvezza spirituale dell'anima. Gesù voleva far capire di essere non un messia nazionale ma l'unigenito figlio di dio. Quello che i Galilei dovevano attendersi da lui non era tanto la giustizia economica ("mi cercate perché siete stati saziati", viene detto al v. 26), quanto la beatitudine eterna, che poteva essere raggiunta credendo in lui come redentore universale, credendo nella sua resurrezione dai lacci della morte, mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue nel sacramento dell'eucarestia.
Ora, è evidente che una ricostruzione del genere, essendo lontanissima da qualunque riscontro attendibile, non è assolutamente in grado di spiegare il motivo della massiva defezione. I redattori fanno parlare Gesù con le stesse parole che avrebbero potuto usare i due principali falsificatori della sua storia: Pietro e Paolo. Su questo non val neppure la pena discutere.
Bisogna piuttosto chiedersi se è ugualmente possibile, all'interno di tale mistificazione, risalire alla motivazione originaria (laica e umanistica) che può aver indotto il Cristo a rinunciare a compiere l'insurrezione: una motivazione che, secondo la nostra esegesi, va tenuta in stretta relazione all'esigenza di istituire rapporti strategici paritetici tra le due etnie fondamentali d'Israele.
Si può qui ricordare, en passant, che nel vangelo di Marco le ultime parole che le donne, giunte al sepolcro vuoto, ascoltano dal giovane vestito di bianco, sono: "Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea" (16,7). Il che, in sostanza, voleva dire che, a causa del tradimento dei Giudei, i Galilei si sentivano liberi di agire come meglio credevano; l'intesa politica era finita; i nazareni avevano smesso di credere nell'insurrezione nazionale, ma anche nel primato del Tempio, nella legge mosaica, nella circoncisione, nel sabato e nei precetti alimentari; ora l'unica possibilità che i Giudei avevano di riprendere un rapporto coi Galilei cristiani, era quella di credere nella divinità del "Figlio dell'uomo", unico vero messia d'Israele.
Chiusa la parentesi, torniamo alla questione di fondo, quella relativa al lato democratico della politica rivoluzionaria. Anzitutto va considerata semplicemente assurda l'idea che i Galilei volessero farlo diventare re perché avevano visto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. L'assurdità non sta solo nel miracolo in sé, ma anche nel suo preteso nesso con la politica. Cioè anche nel caso in cui il Cristo avesse saputo fare un prodigio del genere, nulla avrebbe potuto autorizzare le folle a comportarsi in quella maniera. Sarebbe stata una deduzione illogica, non pertinente. Non si fa diventare statista un uomo solo perché è un grande prestigiatore. A meno che non lo permetta una fortissima crisi di valori e di identità (come p. es. avviene negli attuali Stati Uniti, dove fanno diventare "presidenti" o "governatori" degli ex-attori di cinema).
Qui però è evidente che i redattori avevano altro per la testa. Partendo dal presupposto ch'egli era "figlio di dio", non hanno poi avuto scrupoli nell'attribuirgli qualunque tipo di azione fantastica. Anzi, in un certo senso si sono divertiti nel far credere che Gesù, volendo, avrebbe potuto stupire chiunque coi suoi effetti speciali, salvo poi sottrarsi con decisione alla facile popolarità che ne sarebbe inevitabilmente seguita, lasciando deluse le folle in delirio. Se vogliamo Gesù appare come un divo dello spettacolo che, dopo aver eccitato i fans con le sue performances, fa il prezioso mandandoli in bianco e facendo aumentare in loro il desiderio di rivederlo, e questo nella convinzione di poter recuperare gli applausi come e quando vuole.
Noi invece dobbiamo dare per scontato che l'idea di farlo diventare re sia stata conseguente a un discorso politico di grande respiro, non certo a un prodigio di tipo materiale, contrario a qualunque legge fisico-chimica della natura. L'idea che i redattori, censori e manipolatori, hanno avuto è stata quella di trasformare Gesù in un novello Mosè che compie una gigantesca eucarestia. La contrapposizione artificiosa è stata posta tra "manna piovuta dal cielo", che placò la fame nel deserto, e "pane di vita", che dà all'anima la salvezza eterna.
In particolare i redattori fanno dire a Gesù, rivolto ai suoi seguaci, una cosa davvero spiacevole: "mi avete cercato perché vi ho sfamato come Mosè, non perché avevo compiuto un segno miracoloso da interpretare in chiave mistica" (Gv 6,26 parafrasato). Egli dunque avrebbe rimproverato i nazareni d'essere dei volgari materialisti e di non capire le altezze spirituali del suo messaggio teologico. In sostanza i redattori hanno trasformato l'istanza politica di liberazione in una bassezza di tipo economicistico, per poi anteporre a questa una riflessione squisitamente religiosa.
Fatto questo revisionismo storico e ideologico, essi erano convinti di aver posto il lettore nell'impossibilità di individuare la differenza tra la concezione politica che i Galilei avevano della rivoluzione e quella del Cristo. E noi, in effetti, stante l'attuale condizione delle fonti, possiamo soltanto abbozzare dei semplici tentativi ermeneutici. Il primo dei quali è relativo all'opposizione di una politologia basata sulla democrazia a un’altra basata sulla monarchia. "Volevano farlo diventare re", viene detto chiaramente in Gv 6,15. Cioè in sostanza volevano una riedizione del glorioso regno davidico, da imporre con la forza delle armi non solo ai Romani ma anche agli stessi Giudei, che fino a quel momento avevano fatto di tutto per ostacolare l'attività politica del messia.
Contrapporre Galilei a Giudei sarebbe stato il modo peggiore per affrontare le agguerrite e ben organizzate legioni romane. I Giudei dovevano arrivare a capire da soli che in quel frangente la soluzione offerta dal movimento nazareno era la migliore possibile. Ecco dunque cosa è stato in realtà il cosiddetto "miracolo dei pani": una lezione di autentica democrazia politica.
IV
Riprendiamo ora il commento al brano genericamente chiamato dagli esegeti "Gesù cammina sul mare" (Gv 6,16-21), che poi, come noto, si trattava del lago di Tiberiade.
La pericope viene presentata dai manipolatori del quarto vangelo come se fosse un segno della divinità del Cristo, ma forse, più che di "segno", sarebbe meglio parlare di "sogno". Qui infatti la fantasia ha lavorato parecchio, come già d'altra parte s'era fatto nel racconto precedente, quello appunto dei pani cosiddetti "moltiplicati".
Questi due episodi surreali vengono messi insieme anche nel vangelo di Marco, per cui la loro struttura fondamentale è conservata anche nel quarto vangelo, con questa differenza, che mentre nel primo vangelo si è operata, sin dall'inizio, un'interpretazione del tutto mistificata del rapporto di Gesù con i Galilei sul monte Tabor, nel vangelo attribuito a Giovanni invece si è dovuta operare una forte manipolazione del testo originario, onde impedire che emergesse un'interpretazione più obiettiva dei fatti, di cui, allo stato attuale, si possono scorgere solo pochi addentellati.
Il racconto della camminata sul lago è infatti servito per censurare completamente la motivazione con cui Gesù avrà dovuto spiegare agli apostoli, che in quell'occasione erano quasi intenzionati ad andarsene, il suo rifiuto di compiere la rivoluzione antiromana a Gerusalemme, visto e considerato che una folla di cinquemila uomini della Galilea era disposta a marciare con lui. Il perché di questo diniego già lo conosciamo: Gesù riteneva che senza il concorso dei Giudei nessuna insurrezione antiromana avrebbe potuto resistere alla inevitabile controffensiva che avrebbe scatenato l'imperatore Tiberio. Gesù si era nascosto sul monte per non dover cedere alle pressioni avventuristiche di una folla disposta ad agire con o senza l'aiuto dei Giudei. Evidentemente essa, secondo lui, non aveva il senso della realtà, cioè non capiva che per resistere alle legioni di Roma non bastava vincere una battaglia.
Qui i manipolatori vogliono far capire che tra i discepoli (vicini e lontani) e Gesù vi era un abisso, dovuto al fatto ch'egli era di natura divina, quella che gli permetteva appunto di moltiplicare i pani e i pesci a proprio piacimento e anche di camminare sulle acque.
Quello che manca in questi vangeli è l'autocritica, nel senso che la larga massa dei seguaci e il gruppo più ristretto dei collaboratori vengono sì descritti negativamente, come se del Cristo non fossero in grado di capire nulla, ma la negatività non è affatto in relazione ai comportamenti effettivi che loro tenevano in determinati frangenti. Infatti che qui si fosse in presenza di quello che in politica viene chiamato lo "spontaneismo delle masse", appare evidente, ma i redattori si guardano bene dal mostrare che l'incomprensione da parte dei Dodici era proprio relativa a questo atteggiamento superficiale.
In altre parole qui siamo in presenza di un'autocritica del tutto decontestualizzata. I redattori ammettono la pochezza di fede degli apostoli (nei Sinottici addirittura si assiste a una folla venale che cerca Gesù solo per ottenere guarigioni); tuttavia l'incredulità non può che apparire inevitabile al cospetto di uno che moltiplica i pochi pani e pesci a disposizione per migliaia di persone e che, subito dopo, si mette a camminare sulle acque del lago, sconvolgendo ogni legge fisica e gravitazionale. Anzi, semmai ci si dovrebbe chiedere se non sia un controsenso aver paura di uno che cammina sulle acque dopo averlo visto moltiplicare i pani. Umanamente parlando, quale delle due cose è più difficile fare? Che qui esista una manipolazione del quarto vangelo da parte di teologi petro-paolini è testimoniato anche dal fatto che questo racconto viene ripreso, nella sua essenza mistica, da quello marciano, togliendo a quest'ultimo soltanto l'inutile teatralità (gli apostoli gridano che è un fantasma, erano rimasti molto turbati o enormemente stupiti).
In Marco addirittura viene detto che erano sbalorditi al vederlo camminare sull'acqua proprio perché non avevano capito il fatto dei pani. In sostanza il manipolatore è come se volesse far capire al lettore che i Dodici, non avendo intuito in Gesù la natura divina in seguito alla moltiplicazione dei pani, non riuscivano ad ammetterla neppure quando lo videro camminare sul lago. Ora, anche a prescindere da qualunque considerazione psicologica che si possa fare sulla natura di questi personaggi, i quali sembrano non rendersi conto che, in casi del genere, si ha a che fare o con un illusionista (che, se non dichiara subito i propri trucchi, è anche un impostore), o con una persona sovrumana, resta il fatto che per tali manipolatori l'incredulità degli apostoli doveva apparire al lettore interamente circoscritta in un'area semantica di tipo religioso. Questo peraltro è molto evidente già nel proto-vangelo, ove si lascia intendere ch'egli si era nascosto sul monte non tanto perché non voleva diventare re (come viene detto in Gv 6,15), quanto perché non accettava d'essere strumentalizzato come operatore di prodigi e guarigioni.
In Marco l'idea di fondo è che Gesù si comportava in maniera sovrumana soltanto allo scopo d'indurre a credere nella sua esclusiva figliolanza divina; tuttavia, una volta maturata la fede, non avrebbe più dovuto essere necessario continuare con tale strategia: la folla dei seguaci avrebbe dovuto capirlo, ma, a quanto pare, non vi riusciva. Nei vangeli (soprattutto nei Sinottici) non solo si è voluto rimuovere completamente qualunque attività politica del Cristo, ma si è anche fatto in modo di far passare gli interlocutori per degli sprovveduti totali, assolutamente incapaci di comprendere alcunché del suo messaggio soteriologico.
Anche nel vangelo di Giovanni la spiegazione dell'atteggiamento della folla, che continua a cercare Gesù dopo che si è nascosto sul monte, ha dell'incredibile: "Voi mi cercate non perché avete visto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati" (v. 26). Una spiegazione del genere è piuttosto indegna. Infatti è come se si fosse detto che la folla era così cinica e materialistica che continuò a cercare Gesù non tanto perché, constatando il portentoso miracolo dei pani, avrebbe dovuto intuire la natura divina del suo artefice, quanto piuttosto perché, al cospetto di quel prodigio, essa si era saziata, sicché, come fanno i bambini piccoli o le persone particolarmente avide, avrebbe voluto che Gesù elargisse altri favori materiali.
Una ricostruzione dei fatti, questa dei manipolatori, basata su una concezione molto negativa delle istanze emancipative delle masse popolari; è una concezione molto elitaria e, se vogliamo, nettamente antisemitica, in quanto fa passare gli ebrei per un popolo molto gretto, disposto a seguire Gesù soltanto per avere dei prodigi, i quali, di per sé, non potranno mai confermare – secondo loro – la sua figliolanza divina. Infatti nello stesso vangelo di Giovanni, di fronte alla richiesta di credere in tale figliolanza (v. 29), essi gli rispondono: "Quale miracolo fai tu, perché lo vediamo e ti crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto..." (vv. 30-31). La cosa assurda di questa richiesta è che la folla – stando agli stessi manipolatori – sembra non essere riuscita a capire che i pani erano stati moltiplicati in maniera miracolosa. Cioè non solo i Galilei non accettarono l'idea che unicamente una divinità avrebbe potuto moltiplicarli in quella maniera, ma non videro neppure che si era trattato di un prodigio. E allora – ci si può chiedere – perché erano accorsi in massa per rivederlo? E perché lo cercavano sul monte? e perché volevano farlo diventare re? Dice Giovanni al v. 14: "La gente, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo". E quindi tentano di rapirlo per farlo diventare un novello Davide, essendo convinti che con un sovrano così "super" sarà impossibile perdere contro Roma.
Mettendo a confronto la manna disceso dal cielo e i pani moltiplicati, che cosa sarebbe dovuto apparire più miracoloso? Qui i manipolatori han voluto far credere che la grande differenza tra ebrei e cristiani stava proprio nel fatto che per gli ebrei solo dio poteva fare miracoli e che qualunque prodigio che un uomo come Gesù poteva compiere non li avrebbe mai potuti autorizzare a credere che avesse una natura divina.
Come si può notare, in questo vangelo la controversia tra ebrei e cristiani è tutta circoscritta in una dimensione esclusivamente religiosa. Si tratta cioè di stabilire se, in virtù dei suoi spettacolari prodigi, Gesù poteva essere definito, con sicurezza, una divinità. Tutta la controversia tra ebraismo e cristianesimo è riconducibile alla categoria di "segno miracoloso", nel senso che gli ebrei non riescono a credere nella figliolanza divina del Cristo proprio perché egli si è sempre rifiutato di dimostrarla concretamente. I suoi prodigi non possono – secondo loro – essere considerati sufficienti, proprio in quanto egli non si rivolgeva a dio in persona per poterli fare: li faceva autonomamente, e questo per loro era un indizio di ateismo.
Dunque si faccia bene attenzione a come i manipolatori hanno ribaltato i termini del problema. Gesù, agli occhi degli ebrei, non appariva ateo in quanto nelle sue azioni, che non erano affatto miracolistiche ma semplicemente umane, non faceva alcun riferimento alla divinità, ma appariva ateo in quanto dichiarava d'essere, in via esclusiva, "il figlio di dio", senza che dio potesse, in qualche modo, confermare questa pretesa. Quindi non solo i manipolatori hanno misconosciuto l'attività politica eversiva del Cristo, sostituendola con una diatriba tipo teologico, ma all'interno di quest'ultima hanno dato all'ateismo del Cristo una connotazione esclusivamente religiosa, nel senso che Gesù appariva ateo solo agli ebrei, i quali, essendo un popolo chiuso, materialista, unicamente legato alle proprie leggi e tradizioni, non si sarebbero lasciati convincere della sua divinità neppure se l'avessero visto risorgere.
Se non è antisemitismo questo, che cos'è? Se questa non è un'ideologia spiritualistica di tipo pagano, che cos'è? Se questa versione dei fatti non è un tradimento su tutti i fronti del progetto politico di liberazione della Palestina che aveva Gesù, che cos'è?
(torna su)17) Discorso della Montagna
Ricostruzione ipotetica non scientifica
Matteo 5-7
Il Discorso della Montagna, detto anche "delle Beatitudini", è proprio del vangelo secondo Matteo e, ripulito degli elementi più semitici, è stato ridotto da Luca (6,20-49) ai princìpi fondamentali dell'amore di dio e del prossimo, e seppure Marco non lo riporti secondo lo schema matteano, basta leggersi i capitoli 7 e 10 per capire da dove Matteo abbia preso le proprie fonti.
Come noto, la cosiddetta "regola aurea" di Mt 7,12: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro", era già presente nell'Antico Testamento e nella letteratura pagana. È la versione in negativo dell'amore per il prossimo: la massima in cui il cristianesimo petro-paolino ha voluto racchiudere la propria caratterizzazione etico-sociale.
*
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, fece loro un discorso che doveva servire come programma politico generale per l'insurrezione armata.
È giunto il momento in cui i poveri saranno riscattati, gli afflitti saranno consolati, quelli che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché il regno di Israele sta per realizzarsi e finalmente si avrà la libertà dall'oppressione e la pace.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel regno che andremo a costruire. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Voi siete il sale della terra, la democrazia che altri cercano invano; ma se il sale perdesse sapore, che cosa glielo potrà mai rendere? A null'altro servirebbe che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Senza democrazia diretta, popolare, c'è solo dittatura.
Voi siete la luce del mondo: non può restare nascosta una città collocata sopra una montagna di ingiustizie, né si accende la lucerna della verità per metterla sotto il moggio dell'iniquità. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e vi seguano con convinzione. È il popolo che deve far la politica.
Guai dunque ai ricchi, perché pensano solo alle proprie ricchezze. Guai a quelli che sono sazi, perché avranno fame. Guai a quelli che pensano solo a se stessi, perché saranno afflitti. E fate attenzione quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i loro padri coi falsi profeti.
Non pensiate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. Non sto predicando l'anarchia ma la democrazia.
Chi pensa di poter trasgredire anche uno solo degli antichi precetti, anche minimi, col pretesto che ora tutto è possibile, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno che andremo a costruire. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, che hanno fatto della Legge e dei Profeti quello che hanno voluto, non entrerete nel regno.
Voglio una democrazia di sostanza, non di forma, non come quella scriba e farisaica, che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Dobbiamo dimostrare d'essere migliori di loro nell'applicare le leggi, per sentirci autorizzati a modificarle secondo le esigenze del popolo. Le leggi vanno modificate non tanto per renderle ancora più severe o più permissive, ma per dimostrare ch'esse devono rispondere a bisogni reali.
D'altra parte noi non c'illudiamo che per migliorare una società basti modificarne le leggi. Occorre cambiare stile di vita, mutare i valori, responsabilizzare le persone. Sono i rapporti umani che devono democratizzarsi, i rapporti sociali connessi al lavoro: le istituzioni devono diventare un riflesso di questo mutamento, altrimenti saranno sempre oppressive e chi le governa farà le leggi a proprio uso e consumo.
Non vi servono a nulla le prescrizioni, le offerte, il culto se non siete capaci di umanità col vostro prossimo. La legge vi punisce per delle trasgressioni evidenti, ma dovreste sentirvi in colpa anche per le semplici mancanze: quelle che la legge non vede e che però avvelenano i rapporti umani e distruggono col tempo il senso dell'uguaglianza, della democrazia.
Di fronte alla coscienza ogni mancanza è grave. Non tutti vedono le stesse cose in maniera uguale. Pensate ai torti che vi fate sul piano morale, a quelli che riguardano il rispetto della persona, e che la legge neppure contempla.
Certo, quando un popolo viene invaso da un altro popolo, il torto è evidente. Ma se non risolvete il problema di come migliorare i rapporti tra di voi, non vi libererete mai dell'oppressore, e se anche riusciste a farlo con le armi, non saprete impedire, per questo, nuove ingiustizie tra di voi. Ecco perché vi dico di guardare l'oppressore romano non solo fuori di voi ma anche dentro di voi, nella vostra coscienza, tra le fila del popolo d'Israele, che deve dimostrare con le buone pratiche d'essere migliore degli altri.
Io non dico che di fronte ai torti non ci si debba difendere, anche con la forza, se necessario: la difesa della libertà è un diritto sacrosanto di ogni nazione, di ogni persona umana. Vi dico soltanto di verificare attentamente se nel torto subìto non vi sia anche da parte vostra una qualche responsabilità. Vi chiedo soltanto di pensare se questa consapevolezza può aiutarvi ad affrontare meglio i rapporti col vostro prossimo.
E comunque quando fate giustizia, siate sempre proporzionati alla colpa, non eccedete mai per spirito di vendetta, anzi cercate sempre, con l'esempio, di recuperare il colpevole a una vita dignitosa. Nell'amministrare la giustizia non bisogna mai aver fretta, anche perché non si ottiene giustizia con una semplice sentenza. Ogni reato deve essere occasione per riflettere sulle comuni responsabilità e per migliorare i rapporti umani nella società.
Anzi, ciò che più conta non è tanto l'assicurare il colpevole alla giustizia, quanto migliorare il senso della libertà di coscienza. Non ci si può sentire liberi dentro quando al di fuori di noi i rapporti sono disumani, quando i rapporti e le cose ci impediscono d'essere noi stessi. Chiunque deve poter capire questo, anche il criminale.
Che la coscienza, in definitiva, sia più importante della legge lo capite da alcuni semplici esempi, che sono sotto gli occhi di tutti.
Gli antichi vi hanno detto di non commettere adulterio; ma io vi dico10 che chiunque guarda una donna come un oggetto da possedere, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Che significa questo? Significa che non ci sarà mai democrazia sociale e politica senza quella interpersonale, senza rispetto della persona. E rispetto della persona vuol dire anche rispetto della donna, poiché le nuove regole della convivenza civile non possono riguardare i soli uomini. Le donne sono lo specchio di tutti i rapporti sociali fra persone diverse, diverse per età, aspetto fisico, lingua, provenienza geografica, orientamento politico, culturale, religioso, sessuale...
Quando dico che non basta "non commettere adulterio", voglio dire che non bisogna fare di ogni cosa un'occasione per non rispettare l'altro, per affermare un proprio arbitrio. "Tradire" vuol dire tante cose, di cui il rapporto extraconiugale è soltanto una. Non rispettare è già tradire. L'unico modo per non tradire lo sapete già: è amare, sempre e ovunque, e non solo in negativo, rispettando il divieto dell'adulterio, ma anche in positivo, dimostrandolo con esempi quotidiani.
E non pensiate, come fanno gli scribi e i farisei, di poter aggirare il divieto dell'adulterio, favorendo il divorzio facile. Chi pensa di avvalersi della legge sul divorzio come pretesto per non essere incolpato di adulterio, s'illude. Non ha capito che il vero problema sta nell'amare il proprio coniuge e nel rispettarlo.
Certo, la separazione può apparire inevitabile quando l'altro tradisce, ma esiste anche il perdono delle colpe, il tentativo di riconciliazione. Senza uno sforzo volto a recuperare un rapporto difficile, ogni desiderio di separazione sarà dettato da motivazioni egoistiche, che sono poi quelle che ci rendono "adulteri", cioè traditori, anche prima di qualunque rapporto sessuale.
Badate che tradire è più che trasgredire un giuramento: è come uccidere. I tradimenti che voi fate, non rispettando i vostri giuramenti di fronte a dio, al confronto sono molto meno gravi. Infatti, quando voi giurate di fronte a dio è perché non vi fidate gli uni degli altri. Vi siete già moralmente uccisi e poi dite di aver bisogno di giurare davanti a dio, per dimostrare che la vostra parola è importante.
Se imparaste a fidarvi non avreste bisogno né di giurare né di chiedere di farlo. Quando si uccide qualcuno, i giuramenti non riportano in vita.
Per non tradire bisogna amare e per amare bisogna capire le ragioni del torto, bisogna fare in modo che il bisogno, sotteso a quelle ragioni, venga condiviso. La vendetta, la legge del taglione non miglioreranno i rapporti umani. Abolite piuttosto i rapporti di proprietà e vedrete quanti delitti in meno vi saranno. Abolite la divisione in ceti contrapposti e vedrete che non avrete neppure bisogno di predicare l'amore per realizzare la giustizia.
Che concezione vi siete fatti dell'amore? Pensate davvero che questo valore valga solo all'interno del proprio clan o della propria tribù? O forse pensate che per realizzare l'amore universale basti liberare la Palestina dai Romani?
Certo, dobbiamo anzitutto liberarci dall'oppressione straniera e da chi collabora con essa, ma, fatto questo, a che punto saremo? Per realizzare i princìpi di libertà, uguaglianza, fraternità, quei princìpi che rendono inutile il bisogno di accumulare ricchezze e proprietà, di apparire diversi o di pregare dio, resterà ancora molto da fare.
Anzi, dubito persino che si riesca facilmente a liberarsi dei Romani e di chi li appoggia, poiché voi guardate troppo il vostro particolare, cercate troppo, prima di tutto, una risposta ai vostri problemi personali. Non capite che prima vanno risolti i problemi più gravi e generali, che riguardano l'intera nazione, e solo quando questo sarà fatto vi saranno finalmente le condizioni per poter meglio affrontare i problemi personali.
Quando capirete che per risolvere i problemi generali ci vuole rispetto della diversità, tolleranza, collaborazione reciproca, spirito di sacrificio, capacità di autocritica, il resto vi sarà dato in più. Bisogna saper trovare le giuste mediazioni in vista di un obiettivo comune: liberarsi dell'oppressore.
Vi chiedo di non essere fanatici nelle questioni di principio, ma neppure superficiali. Dovrete vagliare bene con chi portare avanti le battaglie ideali. Non state ad aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Siate solerti nel cercare le giuste amicizie e alleanze, quelle che possono servire per creare un movimento combattivo, un grande consenso popolare.
Nelle questioni private avete già una massima universale da seguire (l'hanno anche i pagani): "non fate agli altri quello che non volete sia fatto a voi". Certo, non sarà con questa massima che faremo l'insurrezione, ma intanto mettetela in pratica nei vostri rapporti personali. Infatti basterebbe quella per smascherare gli ipocriti, quelli che dicono una cosa e ne fanno un'altra.
Badate che non sto dicendo che la coerenza sia di per sé sempre un bene. Noi non dobbiamo realizzare una società perfetta, ma una società in cui vi siano le condizioni effettive per migliorarla di continuo. Una stretta coerenza alla legge, come quella che i farisei chiedono di praticare nei confronti del sabato, può portare a non vedere quando trasgredirla è cosa utile e necessaria. Infatti, più che la legge è importante il bisogno, l'esigenza di soddisfarlo per il bene comune.
Non ha neppure senso sostenere che di fronte alla legge si è tutti uguali. Chi ha più bisogno è più uguale degli altri. Chiedete ai magistrati di rispettare l'uguaglianza sostanziale, quella che aiuta di più chi ha di meno.
È illusorio pensare di potersi mettere a posto la coscienza semplicemente rispettando la legge. Se non sviluppate l'interiorità, l'esteriorità non vi servirà a nulla. Pensare di potersi garantire una purezza interiore, una bontà d'animo, limitandosi a fare abluzioni prima di toccare cibo, ritenendo vietati alcuni alimenti, temendo di contaminarsi a causa del contatto con certe cose e persone, è insensato per un'intelligenza matura, che cerca in se stessa le ragioni del proprio agire. Non è quello che entra dalla bocca che contamina la coscienza, ma quello che vi esce.
Con queste concezioni non si riuscirà mai a costruire alcun regno di pace e di giustizia. Ditelo agli scribi e ai farisei.
(torna su)18) Discorso sul Monte degli Ulivi
Mc 13,5-37
Nei Sinottici il Discorso sul Monte degli Ulivi (Mt 24 e Lc 21, come noto, copiano essenzialmente da Mc 13), pronunciato poco prima dell'ultima Pasqua, è un discorso di tipo apocalittico o escatologico, quando in realtà avrebbe dovuto essere di tipo programmatico, essendo imminente la rivoluzione.
Appare quindi evidente che i redattori han trasformato un discorso politico, rivolto solo ai più stretti discepoli, che dovevano dirigere l'insurrezione nazionale, in un discorso mistico, rivolto, attraverso l'espediente dei suoi più stretti discepoli, ai cristiani in generale, soprattutto a quelli sopravvissuti dopo la sconfitta dell'insurrezione nazionale del movimento nazareno.
Il discorso viene collocato da Marco subito prima dell'ingresso messianico; lo spazio scenico è quello del Tempio di Gerusalemme e successivamente quello del Monte degli Olivi (Getsemani), un giardino collocato sul limitare della valle del Cedron, lungo l'odierna strada da Gerusalemme a Betania (si badi che infinite sono, ancora oggi, le discussioni sull'effettiva ubicazione del Tempio). Tuttavia un discorso del genere difficilmente può essere stato fatto presso il Tempio, alla presenza delle autorità giudaiche e romane; può invece risultare attendibile il riferimento al Getsemani, luogo di rifugio dei Dodici.
In Marco il discorso è fatto da un leader già consapevole che il suo tentativo eversivo contro l'occupante straniero andrà fallito. Non può quindi in alcun modo essere un discorso storicamente attendibile, salvo il fatto che il redattore ha effettivamente cercato di descrivere quello che sarebbe accaduto a Israele e a Gerusalemme in particolare dopo la disfatta della nazione. Quindi necessariamente tutto il discorso è stato redatto dopo il 70, e in effetti nessun esegeta mette in dubbio che l'intero vangelo di Marco sia stato scritto dopo questa data (l'intera comunità cristiana di Gerusalemme scomparve dopo il 70: secondo una tradizione una parte si rifugiò a Pella, città della Decapoli).
Naturalmente il redattore non poteva essere così ingenuo da far capire al proprio lettore che il discorso si riferiva a una situazione post-eventum. Non potevano esserci dettagli storici troppo concreti. Si doveva piuttosto cercare di far passare Gesù per una divinità in grado di leggere gli eventi del futuro, almeno con sufficiente chiarezza, se la massima lucidità non era redazionalmente possibile. In ogni caso le profezie dovevano apparire come se non potessero essere smentite, per quanto i Sinottici siano reticenti nell'attribuire la causa del crollo del giudaismo ai Romani.
All'autore di questo lungo discorso premeva ottenere due fondamentali risultati per l'ideologia religiosa della sua comunità di appartenenza: 1. dimostrare che Gesù era dio; 2. dimostrare che la sua morte in croce era stata inevitabile. Infatti un dio fattosi uomo che annuncia la fine imminente del proprio paese, rende legittima la tesi petrina della sua "morte necessaria", in quanto voluta direttamente da dio, vero artefice della fine del primato d'Israele.
Non deve essere stato facile elaborare un discorso apocalittico, revisionando quello politico originario, in modo tale da non rinunciare ad alcuni fondamentali riferimenti storici alla Palestina e in particolare al destino tragico del suo Tempio. Il discorso doveva essere astratto – come lo è ogni discorso di tipo religioso – ma sino a un certo punto. Il redattore infatti, scrivendo dopo il 70, voleva indurre il suo lettore a credere che quanto aveva scritto s'era puntualmente verificato.
È dunque evidente che nessun lettore sarebbe stato in grado di verificare, nel dettaglio, se quel discorso era stato effettivamente detto dal Cristo. Marco si rivolge a lettori che prevalentemente non sono ebrei, o che, se ebreo-cristiani (avendo accettato la tesi petrina della morte necessaria e della resurrezione del messia), non risiedono più in Palestina, e che in ogni caso nutrivano un odio così grande nei confronti dei Giudei che non avrebbero avuto scrupoli nel fare carte false per indicare unicamente in loro i principali responsabili della morte del Cristo e della distruzione del loro paese.
Vediamo ora il contenuto del discorso, al quale le versioni di Luca e Matteo non sembrano offrire varianti significative.
Gli apostoli citati da Marco sono quattro e in quest'ordine: Pietro, perché fu lui a dirigere la comunità post-pasquale subito dopo la morte del Cristo; Giacomo, che dovrebbe essere il fratello di Giovanni ma che forse qui è il fratello di Gesù, quello che sostituì Pietro quando questi fu fatto evadere dal carcere ed espatriare per sempre dalla Palestina; Giovanni, che fu ben presto emarginato dalla comunità di Pietro e che qui risulta presente solo perché non si poteva escluderlo, e Andrea, fratello di Pietro, anche lui misteriosamente scomparso negli Atti degli apostoli.
L'occasione del discorso è un'espressione di meraviglia manifestata dai discepoli per la robustezza delle mura del Tempio e dell'intera città (cosa che sarebbe stata particolarmente utile per difendersi dalla controffensiva romana successiva all'insurrezione). Ovviamente Gesù avrà confermato, sul piano tecnico, il valore strategico della città e delle sue imponenti fortificazioni (a quel tempo in fondo gli ebrei erano gli unici a resistere con coraggio al dilagare dell'imperialismo romano). Qui però doveva apparire il contrario, essendo tutto il discorso finalizzato a mostrare la debolezza di quelle costruzioni, che di fatto non riuscirono a reggere l'impatto dell'assalto delle legioni.
Se è esistito, ed è facile che lo sia stato, in quanto l'insurrezione anti-romana nei piani del Cristo doveva partire per forza dalla capitale di Israele, un discorso politico-militare su un argomento logistico come questo, deve essersi svolto sulla base di considerazioni che qui non potevano essere presenti, avendo Marco in mente di propagandare l'immagine di un messia redentore e non liberatore.
Il discorso originario, com'è facile immaginare, doveva aver posto sulla bilancia questioni di natura tecnica e questioni di natura umana. Sarebbe stato infatti illusorio pensare di poter resistere a un grande impero come quello romano, che fino a quel momento aveva incontrato ben poche resistenze, facendo leva esclusivamente sull'imponenza delle mura della città, che peraltro erano già state varcate dalle legioni di Pompeo.
Occorreva una direzione strategica delle operazioni belliche ben organizzata, che permettesse non solo di resistere agli assedi delle legioni romane, ma anche di cacciarle definitivamente dalla Palestina. E una direzione del genere doveva poter contare, più che sull'imponenza delle mura (come invece pensarono di fare gli zeloti nel corso della guerra giudaica), sulla collaborazione del popolo, che, a vario titolo, avrebbe dovuto sostenere le truppe regolari e irregolari, fiancheggiare le operazioni militari vere e proprie e quelle di guerriglia. Nessun esercito riesce a vincere una guerra se non ha l'appoggio della popolazione in grado di nutrirlo, assisterlo, proteggerlo nei momenti più critici.
La resistenza doveva essere nazionale e non concentrata soltanto nella capitale. Indubbiamente il segno per farla scoppiare poteva essere offerto dall'insurrezione armata a Gerusalemme, in virtù della quale si poteva facilmente disarmare la guarnigione romana lì presente. Dopodiché si sarebbe occupata la città nei suoi gangli vitali, estromettendo l'aristocrazia sacerdotale da qualunque gestione politica del Tempio e della città. Ma il vero obiettivo restava la liberazione dell'intera Palestina. P. es. il quartier generale di Pilato, stanziato a Cesarea, andava immediatamente bloccato, onde impedire qualunque comunicazione con Roma.
Qual è la principale contraddizione del racconto di Marco, che ambisce a conciliare aspetti umani con aspetti religiosi? È il fatto che da un lato Gesù, qui presentato come un dio, spiega per filo e per segno cosa dovrà accadere nell'imminenza della fine non solo della Palestina ma del mondo intero; dall'altro però egli non è assolutamente in grado di prevedere il momento in cui tutto ciò avverrà, in quanto – a suo giudizio – solo dio può saperlo.
Qui è evidentissima la dipendenza di Marco dall'ideologia petro-paolina, che all'inizio cercò d'imporsi parlando di "morte necessaria" del messia, di sua "resurrezione" e di una sua "imminente parusia trionfale" e che poi, vedendo gli inspiegabili ritardi di quest'ultima, fu costretta a ridimensionare le proprie sicurezze, posticipando a data da destinarsi il momento epocale del riscatto definitivo (i cui segni anticipatori non sarebbero stati solo di tipo "storico" ma anche, in maniera contestuale, di tipo "naturalistico").
Ecco perché lo stesso Gesù che viene reso profeta della catastrofe finale di Israele, la cui causa viene qui addebitata ai Giudei, che non hanno creduto in lui, non può profetizzare nulla sulla catastrofe del mondo intero, in quanto il suo ritorno trionfale, da parte dei primi discepoli, è andato deluso. Un Cristo risorto, che invece di tornare per vendicarsi dei Romani e dei Giudei collaborazionisti, se ne ascende in cielo, non può certo essere considerato un messia liberatore, anzi rende illusoria qualunque aspettativa politica (non a caso nel vangelo di Marco, che è quello del "segreto messianico" per eccellenza, Gesù rifiuta sempre di qualificarsi come "messia").
Ma se non era un liberatore – fa capire Marco – è inutile prendersela coi Romani. Se i Giudei non l'hanno riconosciuto, la principale responsabilità ricade su di loro. Se l'avessero accettato come messia politico, la Palestina si sarebbe liberata dei Romani; non avendolo fatto, non ha più senso continuare a parlare di "messia liberatore": tutta la Palestina è stata occupata dai Romani e i cristiani emigrati devono continuare a vivere sotto le grinfie dell'impero. Una liberazione politica, agli occhi degli ebrei e degli stessi primi cristiani, avrebbe avuto senso se fosse stata "nazionale". Ma dopo il 70 ogni tentativo di continuare a parlare di un "Cristo politico" andava decisamente superato.
La prima domanda che i discepoli Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea rivolgono a Gesù è quella tipica di chi vive un'esperienza religiosa in una situazione sociale ai limiti della sopportabilità: "Dicci quando avverrà la fine di tutto". È la classica domanda di chi è politicamente rassegnato.
Il lato comico di questa domanda è che essa viene posta subito dopo aver osannato la magnificenza delle imponenti mura del Tempio di Gerusalemme, lasciando così credere che fossero inespugnabili. È come se il redattore avesse voluto far parlare i quattro discepoli dapprima come seguaci di un partito politico e subito dopo come seguaci di una setta religiosa. La constatazione dell'imponenza delle mura è forse l'unica nota realistica del tradizionale discorso del Cristo, nel senso che l'idea dell'insurrezione generale non poteva non avvalersi del contributo logistico-difensivo che avrebbero potuto dare quelle mura.
Dunque in pochissime battute i quattro discepoli passano dalla convinzione di poter resistere ai Romani, alla certezza della loro propria sconfitta. Si smontano in maniera subitanea proprio perché il Cristo agisce come se fosse onnisciente. Evidentemente il redattore s'era sentito in obbligo di far apparire come del tutto naturale al lettore che il discorso apocalittico sulle sorti di Israele dovesse essere, nel contempo, un discorso d'addio del Cristo, cioè un discorso sulla propria stessa sorte. Egli infatti dà qui per scontato che il messia sarebbe morto prima della distruzione di Gerusalemme e che solo i suoi discepoli avrebbe potuto constatarla coi loro occhi.
Non è escluso che il redattore abbia qui usato, come modello letterario, una parte dell'Apocalisse giovannea, cronologicamente anteriore. La differenza tra le due apocalissi è che mentre quella giovannea indica un ritorno imminente del messia glorioso, quella sinottica la posticipa sine die. Si può anzi sostenere – ma questo andrebbe dimostrato con uno studio specifico – che tutte le manomissioni operate sull'Apocalisse di Giovanni sono state fatte sulla scorta di quanto scritto nel discorso apocalittico elaborato da Pietro e materialmente redatto dal suo discepolo preferito. In Giovanni infatti tutto quanto viene detto per non rendere imminente la parusia del Cristo è ideologicamente in linea con quanto scritto nel primo vangelo.
Dopo il tragico momento della croce Pietro volle comandare il movimento nazareno, ponendosi in alternativa alla posizione giovannea, che invece chiedeva di proseguire la strada dell'insurrezione armata. Fu lui, con la sua idea opportunista di "parusia", che obbligava a starsene passivamente in attesa, il principale responsabile della disfatta del movimento nazareno (in questo seguito a ruota dall'ex fariseo Saulo di Tarso). E fu sempre lui che ideò la trovata geniale di attribuire al Cristo un vaticinio catastrofico non tanto o non solo per la Palestina ma anche e soprattutto per l'intero pianeta, facendo in modo così di salvaguardare le proprie idee di "morte necessaria", di "resurrezione" e della stessa "parusia", che avrebbero continuato ad avere un valore non tanto sul piano storico quanto piuttosto su quello metastorico, essendo proiettate verso un tempo indefinito.
Anche noi oggi sappiamo che il sole ha una vita di circa tredici miliardi di anni e che ne sono già trascorsi cinque dalla sua nascita e che tra altri cinque inizierà la sua agonia, quando non vi sarà più idrogeno nel suo nucleo: che cosa ci costa dire che tra sei-sette miliardi di anni vi sarà la parusia del Cristo? Chi potrebbe smentirci? Ma soprattutto: a chi interesserà un evento del genere? Anche Paolo, che pur aveva creduto imminente la parusia, dopo vent'anni di folle predicazione, sarà costretto a inventarsi degli impossibili segni premonitori, che ne avrebbero anticipato la venuta, tra cui, niente di meno, che la conversione generalizzata degli ebrei al cristianesimo!
Tutta questa "piccola apocalisse" sottostà a una precisa filosofia deterministica, essendo dominata dalla categoria della necessità storica. Gli eventi storici e naturali appaiono come ineluttabili, inevitabili, predestinati da dio-padre, cui neppure il figlio può opporsi. I sopravvissuti alla generale apostasia saranno quelli predestinati alla salvezza. I giorni della catastrofe cosmica verranno abbreviati solo per fare un favore agli eletti, i quali non avranno il potere d'impedire alcunché. Loro compito principale sarà soltanto quello di resistere il più possibile. Non ci sarà infatti possibilità di realizzare alcuna rivoluzione politica o insurrezione armata sulla terra, proprio perché la liberazione dalla schiavitù non potrà essere "umana" ma solo "divina", fatta direttamente dal figlio dell'uomo, che scenderà dall'alto dei cieli. Sicché mentre nell'Apocalisse di Giovanni gli eletti devono tenersi pronti a un decisivo scontro armato (non a caso essa fu scritta nell'imminenza della guerra giudaica), qui invece devono soltanto attendere passivamente il trionfo del Cristo redivivo.
Pietro ha mentito alla sua generazione, al suo movimento e ha continuato a mentire alle generazioni future, quelle che per credere nella "divinità" del messia hanno rinunciato a lottare per migliorare le loro condizioni di vita.
Prima della parusia – dice Marco – occorreranno molti falsi Cristi (v. 6), molte guerre tra nazioni e tra regni (v. 7), molti terremoti e carestie (v. 8), molte persecuzioni anti-cristiane (v. 9) e soprattutto una predicazione del vangelo a tutto il mondo (v. 10). Bastava anche solo quest'ultima cosa per capire che la generazione contemporanea a Gesù non avrebbe mai potuto vedere alcuna parusia.
Per convalidare l'impossibilità di questa attesa, Marco aggiunge, per bocca di Gesù, che dovranno accadere cose mostruose, raccapriccianti, come i crimini tra consanguinei (particolarmente vergognosi per il popolo ebraico) e, peggio ancora, una generale apostasia dai propri convincimenti di fede (il cosiddetto "abominio della desolazione"), in cui, in un certo senso, il bianco verrà creduto nero e viceversa. In nome di un'ideologia opposta a quella cristiana, fatta passare per quella veramente cristiana, si finirà col compiere le persecuzioni più orribili, che non daranno scampo a chi non vi crederà in maniera del tutto passiva.
Per non demoralizzare irreparabilmente i discepoli, il Cristo aggiunge che la devastazione sarà sì intensa ma non così lunga da indurre tutti gli "eletti" a cedere. Sarà dio stesso in persona ad abbreviarne i tempi e lo farà attraverso disastrosi fenomeni naturali, in cui tutti periranno: oppressi e oppressori. Il sole, la luna, le stelle e tutto il creato subirà un cataclisma epocale. Solo a questo punto avverrà la parusia trionfale del Cristo, al cui seguito vi saranno coloro che hanno avuto la forza di non tradirlo.
Se un cristiano l'avesse letta in questi termini, tale descrizione degli eventi escatologici non avrebbe lasciato molte speranze: il riscatto degli oppressi sarebbe potuto avvenire solo dopo la morte di tutti, nei secoli o nei millenni a venire. Qui deve per forza esserci stata un'obiezione da parte di qualcuno, altrimenti è difficile spiegarsi il significato della frase che ad un certo punto Gesù è quasi costretto a dire: "In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute" (v. 30).
Dunque una speranza c'era, magari se non proprio per se stessi, almeno per i propri figli. Sarebbe stato infatti difficile pensare di poter trovare dei proseliti tra gli oppressi prospettando loro un destino di morte e distruzione. Certamente non sarebbe loro bastato sapere che mentre il cielo e la terra erano destinati prima o poi a collassare, le "parole del Cristo" sarebbero invece durate in eterno (v. 31).
Tuttavia va considerato alquanto riprovevole l'aver attribuito al Cristo l'affermazione secondo cui non sarebbe passata la propria "generazione" prima che tutte queste disgrazie fossero avvenute (Mc 13,30). Che bisogno aveva Marco di dire una cosa del genere quando quella generazione sapeva benissimo che la parusia non c'era mai stata? Il motivo è semplice: Pietro ha voluto far credere che quando predicava la parusia imminente lo faceva solo perché gli era stato comunicato dal Cristo. "Morte necessaria", "resurrezione", "parusia": sono tutti concetti che nel vangelo di Marco vengono fatti propri direttamente dal messia, tutti concetti che sono serviti per mettere a tacere un movimento che chiedeva perché di fronte all'avanzata romana in Palestina le indicazioni dall'alto erano quelle di non fare nulla.
Dunque chi poteva smentire Pietro dopo il 70, quando non solo molti apostoli della prima ora non esistevano più nell'ambito del cristianesimo petrino e quando persino quella stessa generazione, testimone delle azioni del Cristo, si era ormai ridotta all'osso? Solo Giovanni poteva farlo, e infatti lo farà in un racconto di resurrezione del suo vangelo (c. 21), che per passare al setaccio del canone i suoi seguaci dovettero ambientarlo in un contesto saturo di misticismo: lì viene detto che mentre il discepolo prediletto poteva essere esonerato dal ricominciare la sequela al Cristo, in quanto non l'aveva mai tradito, per Pietro invece era un'altra storia.
Nel vangelo di Marco, come in tutti i documenti del Nuovo Testamento, noi abbiamo a che fare con una comunità politicamente sconfitta, che cerca di sopravvivere arrampicandosi sugli specchi, inventandosi cose assurde, anche perché non vuole rassegnarsi a non poter svolgere alcun ruolo politico. E, per quanto dal punto di vista ateistico possa apparire una cosa irrilevante, le va comunque attribuito il merito d'aver cercato d'opporsi, con l'idea di un Cristo "divino-umano", alle pretese teocratiche degli imperatori romani. Là dove nel discorso si parla di "abominio della desolazione" si deve appunto intendere la trasformazione del Tempio ebraico in un Tempio pagano, votato a Zeus.
La parte finale di questo discorso (di cui quella allegorica può essere considerata posticcia) da un lato ha dovuto in qualche modo smentire che la generazione coeva a Gesù avrebbe visto, con sicurezza, il suo ritorno trionfale, nella cui imminenza s'era in effetti creduto, in un primo momento, come testimoniano anche le lettere paoline; dall'altro però ha cercato di rimediare a uno stato emotivo di frustrazione sulle sorti della propria vita e della propria fede. "Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre" (v. 32). Cioè l'unica sicurezza è che la parusia avverrà, in quanto il mondo (persino il sistema solare) è destinato a finire, ma non si può sapere il momento esatto, in quanto all'origine di tutto non vi è il Figlio ma il Padre.
Un modo, questo, di vedere le cose, antitetico persino ai manipolatori del vangelo di Giovanni, per i quali – così scrivono nel Prologo – "ogni cosa è stata fatta per mezzo del Logos" (1,3). Tale differenza si spiega col fatto che mentre i suddetti manipolatori avevano a che fare con un testo che presentava chiaramente un Gesù politico e ateo, Marco invece (che si posiziona sulla linea petro-paolina) s'è limitato a enfatizzare l'immagine mistica di un Cristo figlio di dio, nel senso che quanto più Cristo è dio tanto più si possono attribuire a dio delle qualità o delle prerogative che appartengono solo a lui (p. es. la stessa idea di considerare "necessaria" la morte in croce del proprio Figlio o appunto l'idea che la fine del mondo neppure il Figlio può saperla).
Ora, se può apparire comprensibile l'esigenza di rimandare a un futuro non precisato la possibilità di una rivincita politica e militare, per quale ragione non si incontra mai nel Nuovo Testamento neanche la più piccola espressione di autocritica nei confronti di quanto la leadership del movimento nazareno fece dopo la morte del Cristo?
Il Nuovo Testamento appare come una colossale opera di falsificazione, una sorta di revisione redazionale di tutto quanto era stato pubblicato sull'argomento della rivoluzione, analoga a quella che viene raccontata da G. Orwell in 1984 e molto simile a quanto fece lo stalinismo dopo la morte di Lenin, a partire dal suo Testamento politico. Il Nuovo Testamento è l'espressione di una dittatura ideologica e politica che, partendo dalle posizioni petrine, s'è conclusa con quelle paoline, trovando soltanto in quelle giovannee una debole resistenza.
(torna su)19) Cristo e la leggemosaica
Mt 5,17-20
In Mt 5,17-20 è poco chiaro se il cristiano debba restare fedele alla legge mosaica o debba superarla definitivamente. Infatti il redattore, che è di origine giudaica, fa dire a Gesù: "Non pensiate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti,... ma per portarli a compimento" (v. 17).
Nel vangelo di Giovanni appare esattamente il contrario: "La legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo" (1,17). Quindi per un cristiano non è sufficiente rispettare la legge mosaica, se vuole definirsi tale, come non lo fu per il giovane ricco quando incontrò Gesù, il quale infatti gli disse: "Se vuoi essere perfetto, offri tutti i tuoi beni ai poveri, poi seguimi, poiché il regno di dio non è per i ricchi". E quello, pur dicendo d'aver sempre rispettato la legge, se ne andò via sconsolato, dimostrando così che il rispetto della legge rende solo formalmente "buoni", non "buoni" sino in fondo, in maniera sostanziale.
Questo, in poche parole, voleva dire che il rispetto della legge non è sufficiente per risolvere i problemi sociali o per realizzare il valore dell'altruismo. Rispettare la legge vuol dire semplicemente non fare determinate cose negative, di rilevanza sociale o pubblica, ma lascia irrisolta la modalità con cui, in positivo, si può essere davvero autentici, umanamente se stessi. La legge mosaica permetteva al giovane ricco di restare agiato e onesto: il che a un cristiano appariva una contraddizione in termini.
Per quale motivo Giovanni sostiene che la grazia e la verità sono nettamente superiori alla legge? Proprio perché sono aspetti positivi, ancorché nel suo vangelo vengono usati per negare l'esigenza di una prassi politico-rivoluzionaria. Grazia e Verità sono usate in senso mistico, ma restano comunque superiori alla Legge.
In Matteo invece Gesù viene a portare a compimento la legge mosaica. In che senso? Matteo dà per scontato che sulla terra non sia possibile vivere un'esistenza senza legge, per cui rimanda alla fine dei tempi la realizzazione di ciò che può superarla. Cristo avrebbe messo soltanto sull'avviso: "Non è possibile la salvezza etico-religiosa o la propria giustificazione, limitandosi al semplice rispetto della legge". Il suo Cristo religioso sembra fare una promessa dal tono minaccioso: chi viola la legge mosaica, anche se cristiano, non si salverà. Quando il Cristo tornerà, lo punirà.
Di questa piccola pericope è però soprattutto la parte finale oggetto di maggiore controversia: "se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli" (v. 20). Ma come possono i cristiani superare gli scribi e i farisei se devono rispettare la legge mosaica come loro? In che modo i cristiani devono superare gli scribi e i farisei?
Probabilmente Matteo aveva in mente soltanto una modalità operativa: mettere in pratica gli insegnamenti della legge. Cioè per lui la vera differenza tra i cristiani e gli ebrei stava nel fatto che quest'ultimi andavano considerati degli ipocriti, in quanto incoerenti: dicevano di rispettare la legge, ma poi, nella sostanza, non lo facevano. Se l'avessero fatto, non avrebbero dovuto giustiziare Gesù. È quindi solo una questione di coerenza fattiva, sostanziale.
Matteo è un cristiano di origine giudaica che non crede possibile su questa terra la liberazione politica dalle ingiustizie sociali, e che però pretende di restare più coerente ai precetti della legge di quanto facciano gli scribi e i farisei. Questo perché si fida della promessa che Gesù ha fatto di realizzare un regno di liberazione nei cieli.
In pratica Matteo fa capire che gli ipocriti sono coloro che non credono in tale promessa: ecco perché non riescono a essere fedeli ai propri propositi di coerenza morale.
In un certo senso Matteo è un moralista mistico. Infatti, di fronte al comandamento fondamentale della religione ebraica: ama il prossimo tuo come te stesso, fa capire che solo in nome della promessa di Cristo, cioè in nome di un fine superiore si può davvero amare il prossimo. Non è possibile amarlo per quello che è, o comunque non è possibile restare coerenti in questo amore fine a se stesso. Si può restare coerenti solo se si pensa che il proprio impegno ad amare riceverà un premio nell'aldilà.
Questa morale è utilitaristica non in senso volgare, ma, appunto, in senso mistico. Il prossimo non viene amato per realizzare un regno di giustizia sulla terra, ma per poter far parte di un regno analogo nei cieli. Il rispetto della legge (in cui è previsto l'amore del prossimo) è soltanto una pre-condizione per accedere a qualcosa che sulla terra non può esistere. Di qui l'esigenza d'essere anche minacciosi. Posto che un regno terreno di liberazione non può essere realizzato, non ci si deve illudere di poter ottenere una salvezza morale rispettando la legge solo formalmente, come appunto fanno gli scribi e i farisei.
(torna su)20) Lazzaro di Betania
Gv 11,1-44
Perché questo racconto, in cui si narra un episodio assolutamente eccezionale, non trova alcun riscontro nei Sinottici? Generalmente l'esegesi confessionale più superficiale sostiene che nei Sinottici il parallelo va cercato nel racconto della figlia di Giairo (Mc 5,21 ss.) o in quello del figlio della vedova di Nain (quest'ultimo riportato solo da Lc 7,11 ss.).
Questi paralleli tuttavia hanno poco senso: sia perché in quello di Giairo Gesù non appare come un vero e proprio resuscitatore di morti, in quanto la fanciulla non era ancora stata giudicata assolutamente morta dai parenti; sia perché nell'altro racconto si rimanda, anche abbastanza scopertamente, a un'analoga guarigione compiuta da Elia in 1Re 17,23, per cui è difficile ritenerlo attendibile. Tra l'altro nel racconto di Lazzaro, che è cronologicamente posteriore agli altri due, non si ha nessuna consapevolezza che il Cristo potesse anche resuscitare i morti.
Altri esegeti ritengono che il miracolo di Lazzaro non venga riportato nei Sinottici perché il suo parallelo è, secondo l'impostazione redazionale dei tre evangelisti, la guarigione di Bartimeo (Mc 10,46 ss.): questi infatti rappresenta l'ideale del discepolo che vince i suoi dubbi circa il lato umano della messianicità del Cristo e decide di seguirlo fino a Gerusalemme per l'ingresso trionfale. Il che sarebbe più significativo, sul piano etico-politico, che credere in un messia resuscitatore di morti.
Senonché l'episodio di Lazzaro va ben al di là del semplice evento prodigioso, in quanto anch'esso – come quello di Bartimeo – coinvolge aspetti che riguardano, insieme, la sfera politica e quella dei sentimenti umani. Questa pericope, se vogliamo, avrebbe dovuto intitolarsi non "resurrezione di Lazzaro" ma "manifestazione dell'umanità del messia".
Un minimo più credibile è l'ipotesi avanzata da qualche esegeta secondo cui la resurrezione di Lazzaro sarebbe stata in origine una semplice guarigione, forse avvenuta in un momento diverso da quello descritto dal quarto vangelo, il cui significato è stato gonfiato da redattori prevalentemente di origine giudaica. La pericope peraltro è stata collocata nell'imminenza dell'ultima Pasqua, anche per rispondere al racconto, di matrice politica, non meno fantasioso, dei pani miracolati, che redattori cristiani di origine galilaica avevano elaborato nei Sinottici, in riferimento alla Pasqua precedente. Questo per dimostrare che Gesù aveva dato il meglio di sé non solo in Galilea ma anche in Giudea.
Si può in un certo senso dire che il racconto della presunta resurrezione di Lazzaro ha un'importanza pari a quello della presunta moltiplicazione dei pani. Con questa differenza: in Galilea Gesù, con solo appoggio dei Galilei, senza quello dei Giudei, aveva fatto capire di non essere intenzione a compiere alcuna liberazione nazionale, e il redattore, di origine galilaica, ha mistificato la cosa usando l'arma del miracolo di due sostanze materiali: i pani e i pesci; in Giudea invece decide di compierla, proprio perché sa di poter avere l'appoggio di tutti i Giudei, Galilei e Samaritani intenzionati a liberarsi dello straniero oppressore, e qui il redattore, di origine giudaica, ha subìto una manipolazione da parte di un altro redattore giudaico-cristiano, che ha mistificato il racconto usando l'arma del miracolo più grande che si possa compiere: resuscitare un morto. Quindi se la fonte o la tradizione più originaria della pericope va ricercata nella Giudea, come per gran parte dei racconti giovannei, il testo è stato sicuramente manipolato a più riprese da altri redattori cristiani influenzati dalle culture giudaico-mistiche e gnostico-ellenistiche, allo scopo di censurare il lato politico della predicazione messianica del Cristo.
Ora, prima di analizzare il racconto, che sicuramente è di una straordinaria complessità, è bene fare una precisazione di metodo. Nel vangelo di Giovanni nessun racconto ha uno spessore così solido, dal punto di vista umanistico, come questo. E tuttavia questo è uno di quei racconti che meno di altri può essere accettato così come è descritto. Il fatto stesso che un racconto di questo genere (in cui il Cristo appare come un "dio") non abbia trovato alcun riscontro nei Sinottici può essere indicativo della sua scarsa attendibilità, almeno per come esso ci è giunto.
Va di sicuro escluso che un evento del genere sia stato scritto in un momento in cui qualche testimone oculare avrebbe potuto smentirlo. Quindi o l'evento è veramente accaduto, con pochissimi testimoni a riguardo (di tutti gli apostoli il solo Giovanni, di tutti i parenti la sola Maria), oppure è molto tardivo (o comunque sono tardivi i passi più miracolistici aggiunti a un nucleo originario che forse prevedeva un'azione meramente terapica o, addirittura, una semplice presa d'atto del decesso di un compagno di lotta politica). Una base storica deve comunque esserci, non foss'altro che per una ragione: gli apostoli che, con Gesù, si erano nascosti in Transgiordania per timore d'essere catturati, poterono osservare di persona questo evento. Tra essi vi era sicuramente Pietro, anche se vengono citati col termine generico di "discepoli" (il solo di cui si riporta il nome è Tommaso), e Pietro è la fonte principale del vangelo di Marco: pertanto, visto che se ne parla soltanto qui, o questo episodio è stato completamente inventato, oppure non è accaduto esattamente come è stato raccontato.
L'attendibilità di questo racconto non può ovviamente essere data dalle motivazioni dell'esegesi confessionale, secondo cui le parole e le opere del Cristo sono tanto più vere quanto più rispecchiano le tradizioni acquisite dal cristianesimo primitivo: si è addirittura arrivati a dire che proprio il fatto che l'autore di questo racconto voglia rimandare esplicitamente alla morte e resurrezione del Cristo depone a favore della storicità del racconto!
In realtà se c'è una cosa che nega ai vangeli una qualunque attendibilità è proprio questa forte convergenza tra quanto viene attribuito al Cristo e quanto era d'uso comune presso i cristiani influenzati dall'ideologia paolina, quella che nel dibattito tra le varie correnti proto-cristiane risultò vincente. Sotto questo aspetto, se accettiamo l'ipotesi che i vangeli altro non siano che una ricostruzione letteraria della comunità primitiva in rapporto alla fede post-pasquale, ovvero se la preoccupazione della comunità primitiva, dal punto di vista redazionale, è stata quella di dimostrare, in questo e altri racconti miracolistici, che il Cristo era davvero il "Figlio di Dio", diventa difficile immaginare che possa esistere qualcosa che ci impedisca dal ritenere come puramente inventati tutti i racconti in cui avvengono cose straordinarie o umanamente impossibili. Se vogliamo, proprio la pretesa di vedere in Gesù un dio toglie storicità anche a quegli eventi che forse potrebbero essere considerati umanamente accettabili (sempre che nell'aggettivo "umano" si consideri tutto ciò che sarebbe possibile se l'uomo fosse davvero se stesso).
Dal canto suo, l'esegesi non strettamente confessionale pretende di trovare nei vangeli, in virtù di un lavoro di epurazione dei testi da tutto ciò che può apparire artificioso, apologetico ecc., quei versetti che da soli autorizzano una ricostruzione sufficientemente realistica degli eventi. Ma anche questa posizione pecca di semplicismo. Spesso l'operazione di falsificazione redazionale da parte degli evangelisti non si limita ad aggiungere frasi o azioni che nella realtà non sono mai state dette o fatte, ma omette parole o frasi che potrebbero apparire imbarazzanti per un'ideologia spiritualistica come quella cristiana, e soprattutto trasforma parole e azioni storicamente attendibili in cose del tutto inventate, conservandone elementi sufficienti a credere che siano veramente accadute.
In generale si può affermare questo: quanto più forti sono gli artifici letterari dei redattori, specie quelli del quarto vangelo (p. es. l'ambiguità intenzionale nell'uso di determinate parole o espressioni, che porta inevitabilmente a malintesi e incomprensioni tra Gesù e gli interlocutori, onde accentuare la distanza che li separa), tanto meno credibili appaiono i racconti sul piano storico.
Generalmente i manipolatori del quarto vangelo non intervengono inventandosi cose mai accadute, ma preferiscono modificare quelle già esistenti, e lo fanno in due maniere, aventi una medesima finalità: quella di sostituire gli aspetti politici del progetto di liberazione del Cristo con aspetti religiosi inerenti a un progetto di redenzione morale. Un modo è quello di cambiare particolari concreti molto importanti con altri del tutto fittizi, l'altro è di commentare i particolari reali in maniera distorta. In questo lungo racconto, che ha un ruolo centrale nel quarto vangelo, hanno fatto entrambe le cose.
Ovviamente l'esegesi confessionale non potrebbe ammettere una tesi del genere, ma, se per questo, essa fatica alquanto a trovare una risposta convincente anche alla seguente domanda: se il Cristo non fosse scomparso dalla tomba e avesse fatto in vita le guarigioni descritte nei vangeli (ivi incluse quelle più improbabili), sarebbe stata elaborata ugualmente una "teologia della salvezza" o ci si sarebbe limitati a una semplice "filosofia di vita", al pari di quelle elaborate da e per tanti altri santoni e sciamani del mondo orientale?
A favore dei vangeli noi possiamo dire che pur avendo i Romani crocifisso migliaia di schiavi ribelli, di nessuno di questi abbiamo una letteratura così cospicua, sia essa totalmente o parzialmente inventata, come quella sul "ribelle Gesù". Ciò significa che qualcosa di realistico deve esserci nei vangeli, altrimenti dovremmo ammettere, per assurdo, che sin dall'origine una mente diabolica è riuscita a imbastire la più grande truffa letteraria della storia. E, se così fosse, dovremmo chiederci il motivo per cui sino ad oggi nessuno l'abbia ancora scoperta con prove alla mano.
In realtà tutti sanno che le truffe in generale e quelle letterarie in particolare appaiono credibili solo quando sono basate su fatti probabili. È poi compito dell'esegeta cercare di scoprire quando si può parlare di verosimiglianza e quando di mera invenzione. Indubbiamente, sotto questo aspetto, il racconto della cosiddetta "resurrezione di Lazzaro" è uno di quelli che più mette a dura prova le capacità di discernimento del lettore.
D'altra parte un'esegesi che si limitasse a commentare l'interpretazione cristiana post-pasquale degli eventi pre-pasquali non servirebbe a nulla, perché sarebbe inevitabilmente apologetica. La premessa da cui partire è quella di mettere in discussione che l'interpretazione cristiana degli eventi post-pasquali sia l'unica possibile e soprattutto l'unica vera.
*
Quando Lazzaro s'ammalò (forse perché ferito in uno scontro militare) al punto da impensierire seriamente le due sorelle Marta e Maria, queste poterono mandare un'ambasciata ad avvisare Gesù solo perché sapevano ch'egli non era molto lontano da Betania (forse un giorno di cammino). Gesù e i suoi discepoli, in effetti, soggiornavano in Perea, nei pressi del Giordano, dove il Battista era stato arrestato qualche anno prima e dove anche loro tentavano di sottrarsi all'ennesimo mandato di cattura (Gv 10,40). I tre protagonisti di Betania erano sicuramente al corrente delle peregrinazioni dei leader nazareni.
Intorno a Lazzaro i vangeli non offrono alcuna testimonianza: in nessun luogo egli pronuncia una benché minima espressione. Questo silenzio pare sospetto, tanto più che qui il redattore usa il termine di "philos" (v. 11), come se volesse indicare che Lazzaro non era solo un amico personale del Cristo, ma addirittura un seguace del movimento nazareno o comunque un compagno di lotta (vv. 3, 5 e 11).
Lo stesso dicasi di Marta e Maria, le due vere protagoniste di questo racconto, che qui vengono introdotte come se il lettore già le conoscesse o, se vogliamo, come se tra loro e il Cristo vi fossero stati dei precedenti molto significativi. In realtà anche di loro non sappiamo quasi nulla. Dei Sinottici il solo a fare un piccolo riferimento è Lc 10,38-42.
Si ha l'impressione che il redattore, citando per prima Maria e ricordando che fu lei a profumare i piedi del Cristo, in seguito a questo episodio, consideri quest'ultima più importante di Marta, dando così conferma del famoso passo di Luca che descrive una Maria contemplativa, disposta ad ascoltare il "verbo" e una Marta troppo presa dalle faccende domestiche per poter essere una vera discepola del Cristo. In effetti, e lo vedremo meglio in seguito, Marta sembra qui rappresentare, in maniera simbolica, l'incomprensione del lato umano del messia.11
In ogni caso un intervento redazionale a più mani è ben visibile sin dagli esordi di questa lunga pericope. E le contraddizioni che nascono in seguito a queste manipolazioni sono subito stridenti. Appena sentito ch'era malato – dice il v. 6 – Gesù "si fermò ancora due giorni nel luogo dov'era". Se questo è vero, lo stesso redattore deve averne frainteso il motivo, perché al v. 4 tenta di spiegarlo in una maniera del tutto fantasiosa: Gesù si era fermato apposta perché non aveva intenzione di compiere una semplice guarigione ma addirittura una resurrezione!
Avendo in mente un Cristo impolitico, che fa della politica il regno dei corrotti, il redattore tende ad attribuirgli dei pensieri e delle azioni del tutto innaturali per una persona comune (in questo caso politicamente impegnata), e che però vogliono essere consoni alla rappresentazione immaginaria di una persona dalle caratteristiche divino-umane.
Questo redattore, di cultura ellenistica, è talmente estraneo alla politica che piuttosto che pensare – come ha fatto un altro redattore di questa pericope, questa volta di cultura ebraica – che il Cristo (sempre secondo un'interpretazione fantasiosa) avrebbe potuto utilizzare la tragedia della morte di un amico come occasione per compiere qualcosa di convincente anche per i Giudei più scettici circa la verità politica del proprio messianismo, ha preferito credere che la resurrezione abbia qui avuto, come unico scopo, quello di dimostrare che il Cristo era "Figlio di Dio".
Tale considerazione ci induce ad aprire una piccola parentesi per dire che la stretta identità di "Dio" e "Figlio di Dio" (si veda il v. 4), fa parte in un certo senso dell'ateismo ingenuo del cristianesimo primitivo, il quale, invece di limitarsi a vedere Gesù come uomo, sospendendo il giudizio su quegli aspetti che potevano apparire di natura controversa, ha deciso di paragonarlo, stricto sensu, a un dio, facendo coincidere l'espressione "gloria di Dio" (che per un ebreo aveva significato esclusivo: solo Jahvè è Dio) con l'espressione "glorificazione del figlio di Dio" (che per un ebreo equivaleva a bestemmiare). Queste sono aggiunte posticce al racconto originario (ivi inclusa quella dell'appellativo "Signore"), poiché noi sappiamo da Giovanni che Gesù non si è mai considerato "Figlio di Dio", né "Dio" in persona, e neppure suo rappresentante religioso. Il Cristo di Giovanni voleva gli uomini indipendenti da qualunque giudizio o volontà divina. Il suo era un ateismo umanistico, estraneo a influenze di tipo religioso.
Dunque, stando al v. 6 si ha l'impressione che il Cristo si fosse fermato "ancora due giorni nel luogo dov'era" proprio perché voleva che Lazzaro morisse e poterlo così risorgere. Invece di affrettarsi ha preferito tardare e per poter convincere gli apostoli che aveva intenzione di compiere qualcosa di speciale, è stato costretto ad affermare, al v. 14, che Lazzaro era già morto, mostrando di saperne più lui, circa la malattia mortale di Lazzaro, dei messi inviati da Marta e Maria.
Qui il redattore è intervenuto pesantemente. In realtà l'attesa di Gesù fu dovuta a un'esitazione giustificata, come si evince molto bene dai vv. 8 e 16, dove i discepoli (in particolare Tommaso) temono che il messia venga arrestato e loro con lui. Essi devono aver pensato che la sua iniziativa, in caso di insuccesso, avrebbe potuto risultare molto più costosa dei benefici che avrebbe potuto ottenere in caso contrario. In altre parole: se Lazzaro era davvero gravemente malato non sarebbe valsa la pena rischiare l'arresto; se invece non lo era, non sarebbe valsa la pena lo stesso, perché prima o poi sarebbe guarito. Questo il senso del v. 12.
Una cosa però è che siano loro (semplici esseri umani) ad avere questi timori e a fare questi ragionamenti, un'altra – deve aver pensato il redattore – è che sia lui (il "Figlio di Dio") a comportarsi così.
Ecco dunque qual è stata – secondo il redattore – la risposta del Cristo alle obiezioni dei discepoli: "Se uno cammina di giorno non inciampa" (v. 9). Il che, nel linguaggio apologetico, sta a significare: "il Cristo morirà solo quando sarà la sua ora". Parabola, questa, che rimanda esplicitamente a quella di Gv 9,4 s.
Viceversa, quale può essere stata la risposta qui omessa e che si può facilmente intuire dal contesto? "Lazzaro è uno dei nostri, dobbiamo rischiare, però non c'è bisogno che rischiamo tutti. Se non rischiassimo, qualcuno potrebbe pensare che abbiamo anteposto interessi politici a quelli umani".
Al v. 14 il redattore è esplicito nella sua falsificazione: il Cristo aveva tardato a intervenire proprio perché sperava che i discepoli, vedendo Lazzaro risorgere, credessero definitivamente nella sua "figliolanza divina". Tesi, questa, che ne comporta molte altre: quella della "morte necessaria", del "regno in un altro mondo" ecc. La falsificazione viene ripetuta ai vv. 25-26 e al v. 42, allorché si sostituiscono i discepoli, come target di riferimento dell'efficacia del prodigio, prima con Marta, poi con i Giudei imparentati con le sorelle di Lazzaro.
Il redattore ha praticamente voluto dimostrare che la resurrezione di Lazzaro seppe venire incontro a esigenze di tipo personale (espresse dalle due sorelle Marta e Maria) e di tipo pubblico (espresse dai Giudei lì presenti – cfr il v. 37).
Alcuni esegeti confessionali hanno sostenuto – condividendo la tesi di uno dei redattori – che questo miracolo doveva servire per la causa nazionale, cioè per dare la possibilità di credere nella messianicità del Cristo anche ai Giudei più scettici. Quindi, pur senza mettere in gioco la volontà di dimostrare la propria divinità, da parte del Cristo, tali esegeti sono convinti che il prodigio abbia avuto lo scopo di evidenziare che esistevano tutte le condizioni per credere nelle capacità rivoluzionarie del movimento nazareno.
Questo modo di ragionare, pur essendo più vicino alle tesi dell'umanesimo integrale, resta comunque apologetico, poiché non scalfisce di una virgola il principio secondo cui non vi è nulla che possa obbligare qualcuno a credere in qualcosa. Sotto questo aspetto qualunque guarigione o prodigio o miracolo compiuto da Gesù nei vangeli non è in grado di dimostrare alcunché, né sul piano etico né su quello religioso.
Il dialogo fittizio tra Marta e Gesù sembra, in tal senso, che rappresenti la forbice entro cui può muoversi l'interpretazione cristiana di questo episodio, sia essa condizionata dalla cultura ebraica o ellenistica. Nel senso che, comunque la si metta, in ultima istanza lo scopo del racconto è quello di indurre il lettore a credere nella divinità del Cristo. L'oscillazione interpretativa non va al di là di questi limiti. E la cosa è talmente evidente che le parole di Marta ricalcano quasi alla lettera antiche confessioni cristiane di fede.
In sostanza l'unica vera prova che il redattore ha potuto usare circa la morte di Lazzaro è costituita dal riferimento temporale dei quattro giorni. Considerando che i messi avranno impiegato un giorno per arrivare al nascondiglio di Gesù, se ad esso si aggiungono i due giorni che questi ha lasciato passare e l'altro giorno per arrivare a Betania, i conti in effetti tornano, sempre che ovviamente si dia per scontato che Lazzaro sia deceduto appena i messi erano partiti. Essi avevano raggiunto Gesù convinti che Lazzaro fosse ancora vivo e Gesù si era mosso (e con lui alcuni discepoli, tra i quali sicuramente Giovanni) nella convinzione di poterlo sanare, come aveva già fatto per altri casi.
Qui va sottolineato che per gli ebrei una persona veniva considerata veramente morta solo allo scadere del quarto giorno, anche se a motivo del clima molto caldo i morti venivano messi nelle tombe sin dal primo giorno. Il periodo di lutto era di sette giorni. Il redattore ci dice che quando Gesù arrivò a Betania molti parenti erano già giunti da Gerusalemme, distante poche miglia, per consolare le sorelle di Lazzaro.
Delle due la prima che viene informata dell'arrivo di Gesù è Marta, che non si preoccupa di avvisare anche Maria (rimasta in casa) e che evidentemente è a conoscenza del carattere di riservatezza della visita di Gesù, il quale, come un clandestino ricercato dalla legge, è rimasto nei pressi del villaggio a chiedersi come avrebbe potuto guarire l'amico malato senza farsi notare. O forse qualcuno l'ha già informato che Lazzaro era morto.
Quel che Marta può aver detto a Gesù è già molto se riusciamo a intuirlo tra le righe pesantemente manipolate dai redattori. La prima cosa ovviamente deve essere stata quella relativa al decesso, avvenuto quattro giorni prima. La seconda cosa non rappresenta solo una forma di convinzione personale, come apparentemente può sembrare: "Se tu fossi stato qui, lui non sarebbe morto" (v. 21), ma anche una forma di giudizio critico: "Il fatto che tu non ci fossi posso capirlo sul piano politico, ma faccio fatica ad accettarlo sul piano umano".
In altre parole, sembra che per Marta questa mancata guarigione non pregiudichi il compito rivoluzionario che il messia Gesù deve realizzare, tuttavia essa avrebbe preferito che, in nome dell'amicizia per Lazzaro, Gesù avesse agito diversamente. Marta in sostanza qui si comporta come Bartimeo, prima che questi dica "Rabbunì".
Giovanni comunque contraddice apertamente l'opinione di Lc 10,38 s. che vede in Marta una donna insensibile alla predicazione del Cristo, anche se – e lo vedremo – conferma che sul piano umano Maria le era superiore. Si può forse dire che per Marta l'umanità del Cristo era strettamente correlata alla sua messianicità.
Tutte le risposte che le dà Gesù, riportate nella pericope, vanno considerate fantasiose, per cui si può pensare che l'unica cosa credibile che le abbia detto sia stata quella di andare a chiamare Maria (v. 28). Una donna politicamente impegnata come Marta facilmente avrebbe potuto capire che quando sono in gioco i destini di un'intera nazione, i drammi o le tragedie personali vanno considerati come incidenti di percorso, nei cui confronti non si può rivendicare un interessamento particolare da parte dei dirigenti politici. L'invito del messia sarà dunque stato quello di rassegnarsi oppure di sperare che i seguaci di Lazzaro si convincessero ad accettare il progetto insurrezionale dei nazareni, invece di agire per conto proprio.
L'esegesi confessionale sostiene che Gesù ha accettato di risorgere Lazzaro per dimostrare a Marta la propria profonda umanità, che poi coincide – per detta esegesi – con la sua divinità, ma se così fosse si dovrebbe considerare del tutto inverosimile che alla fine della sua vita Gesù fosse ancora circondato da discepoli incredibilmente ostinati a non credere nella sua umanità e continuamente ansiosi di vedere prodigi sempre più spettacolari per arrivare, in sostanza, a non credere mai nel suo vangelo. Non meno stupefacente è che il Cristo si presti qui ad accettare, poco prima di compiere la rivoluzione armata, queste vergognose forme di ricatto morale.
I redattori dei vangeli vogliono far sembrare paradossale a un lettore ingenuo che anche di fronte a fatti così straordinari, come appunto la resurrezione di un morto, l'opinione su Gesù restava incerta, ambivalente, e che solo una parte dei testimoni, in definitiva, sceglieva di credere in lui. In realtà nulla a questo mondo può convincere della verità di una determinata posizione, se manca un coinvolgimento di tipo personale, in cui la libertà svolga un ruolo decisivo, e qualunque rappresentazione della personalità o del comportamento del Cristo che si avvalga di elementi di tipo sovrumano, utilizzati per indurre a credere in lui, rende inevitabilmente ridicoli o riprovevoli tutti i personaggi che lo circondano, a seconda che aderiscano o meno al suo vangelo.
Se infatti considerassimo vere le parole dette da Gesù a Marta che idea dovremmo farci di quest'ultima? Il dialogo tra i due è di un'assurdità fuori del comune. Al v. 22 il redattore si è divertito a equivocare sul significato dell'oggetto del desiderio di Gesù e sul momento in cui ottenerlo: infatti non si capisce se Marta sia convinta che a Gesù basti chiedere a Dio di far risorgere Lazzaro, oppure che, nonostante la morte di Lazzaro, Gesù ha comunque il potere di chiedere qualunque cosa a Dio per la realizzazione della sua missione.
Gesù, a sua volta, continua a equivocare assicurando a Marta che Lazzaro sarebbe risorto, ma senza precisarle il momento. Al che lei, pensando di aver ottenuto una magra consolazione, risponde di sapere già il momento, quello dell'ultimo giorno, quando verranno risorti tutti i morti della terra (da notare che per gli ebrei l'idea di resurrezione è sempre stata piuttosto peregrina, anche se, in effetti, era un cavallo di battaglia dei farisei, il che può anche far pensare che Lazzaro fosse un leader politico del partito farisaico).
Ora però il redattore fa parlare Gesù chiaro e tondo: "Io sono la resurrezione e la vita" (v. 25). Frase, questa che, portata all'estremo, potrebbe anche voler dire che Dio non c'entra nulla circa la possibilità che Gesù aveva di far risorgere Lazzaro.
Marta cade dalle nuvole e risponde, serafica, come per assecondare uno che ha le traveggole: "Sì, credo che tu sia il messia, il figlio di Dio" (v. 27), che in altre parole starebbe per: "Se ti sei offeso che ho messo in dubbio la tua messianicità e divinità, me ne pento e riconfermo entrambe esplicitamente". Strano che dica questo, perché poco dopo si mostrerà molto esitante a far aprire il sepolcro, in quanto il cadavere aveva iniziato a decomporsi (v. 39).
Cristo prende atto di questa confessione di fede politico-religiosa ma non risorge Lazzaro: la coscienza di Marta non è abbastanza profonda. Ecco perché le chiede di far venire la sorella Maria. Marta, in sostanza, nella mente fantasiosa dei redattori cristiani, non ha ottenuto la resurrezione di Lazzaro perché aveva messo in dubbio le capacità di trasformare la materia da parte di una persona divino-umana.
È da ritenersi comunque realistico il fatto che solo quando vede Maria Gesù non si sente giudicato. Da notare che sino a quel momento pochissime persone si erano accorte della sua presenza. Marta aveva avvisato Maria "sottovoce" – dice Gv 11,28 – appunto per proteggere la riservatezza dell'incontro con Gesù; i parenti la seguivano da lontano pensando che si recasse al sepolcro.
Quando vede Gesù, Maria gli si getta ai piedi e piange amaramente: le parole che dice sono le stesse di Marta ma l'atteggiamento è diverso (v. 32), tant'è che la commozione diventa generale: dei parenti e dello stesso Gesù, ad eccezione di alcuni che malignano dicendo: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?" (v. 37).
La differenza tra Marta e questi parenti sul piano politico è netta: Marta non mette in dubbio che il Cristo debba comunque diventare il messia d'Israele, nel senso che i difetti ch'egli può avere sul piano umano non possono incidere – secondo lei – sulla giustezza del suo messaggio politico e sulla necessità ch'egli abbia di governare il paese. Per alcuni parenti invece il dubbio permane e non a caso viene detto che questi informarono i farisei dell'accaduto (v. 46), mettendo a repentaglio l'incolumità del messia.
L'atteggiamento di Maria ha invece convinto Gesù che, nonostante il suo indugio ad assistere prontamente Lazzaro per timore d'essere arrestato, egli veniva accettato pienamente anche come uomo e non solo come politico. Per lei la morte di Lazzaro rientra semplicemente nel dramma della vita e anche se Gesù, quale compagno di lotta, avrebbe potuto evitarla, il non averlo fatto non mina la fiducia che occorre riporgli come uomo e come messia.
La pericope avrebbe potuto chiudersi col v. 37 che nulla si sarebbe tolto al valore spirituale dell'episodio. I redattori invece hanno preferito sostituire un messia politicamente sconfitto con una divinità trionfante: di qui l'esigenza di fargli compiere il prodigio. Se si fossero fermati alla normale prosaicità dei fatti, essi avrebbero dovuto mettere in risalto la grandezza interiore dell'uomo Gesù, uscito politicamente sconfitto dallo scontro con le forze governative (anche se nella fattispecie del racconto ancora non era detto). Questo però appariva storicamente inaccettabile. Ecco perché sono stati inseriti degli elementi magico-religiosi. La grandezza del Cristo non stava nell'aver dimostrato che le questioni umane meritano di essere prese in considerazione in qualunque momento della lotta politica, ma nell'aver dimostrato che, grazie alla propria onnipotenza, egli non aveva paura di niente e poteva permettersi qualunque azione prodigiosa.
Qui possiamo anche competere con l'abilità redazionale di saper equivocare sul significato delle parole, semplicemente dicendo che Gesù voleva dimostrare che quanto faceva era in grado di farlo perché "vero uomo"; se poi questa profonda umanità la si vuole considerare equivalente a una forma di "divinità", lo si faccia, ma a condizione di accettare che tale divinità appartenga, virtualmente, a ogni essere umano.
Detto questo, i vv. 38-44 difficilmente si possono ritenere attendibili. E per una serie di ragioni. Il redattore:
– ha voluto creare un'atmosfera di particolare tensione facendo di nuovo "fremere" Gesù in se stesso (v. 38);
– ha voluto inutilmente precisare che la tomba era una grotta chiusa da una pietra rotolante, alla maniera ebraica (un ebreo l'avrebbe dato per scontato);
– ha avuto bisogno di ricordare l'informazione contenuta al v. 17, secondo cui era morto da quattro giorni;
– ha immaginato un cadavere avvolto da bende e sudario (secondo il modo di seppellire ebraico) e non si è reso conto che un uomo così conciato non avrebbe potuto uscire da solo dal sepolcro;
– ha rappresentato l'azione scenica in maniera così teatrale da rendere incomprensibili tutte le precauzioni di riservatezza prese da Gesù fino a quel momento;
– e soprattutto non si è reso conto che al vedere una cosa di questo genere tutti i testimoni sarebbero dovuti uscirne terrorizzati e invece di continuare a credere nel Cristo avrebbero dovuto cominciare a pensare che di umano egli non aveva assolutamente nulla.
Insomma, proprio i particolari che più dovrebbero convincerci dell'attendibilità degli eventi sono quelli che fanno pensare a una forzata montatura, probabilmente elaborata dopo che i testimoni di quell'episodio erano tutti scomparsi. La chiusa, del tutto fittizia, è analoga a quella dei pani moltiplicati (l'espressione liturgica "levàti gli occhi al cielo" del v. 41 è addirittura identica). Si può anzi dire che quanto più grande era la volontà di Gesù di prendere delle iniziative di tipo politico, tanto maggiore era la volontà del cristianesimo primitivo di mistificarne la natura. E alla fine questa volontà è talmente grande che la forza degli eventi spettacolari compiuti dal Cristo viene presentata come inversamente proporzionale al valore della fede dei Giudei.
I cosiddetti "miracoli", cioè quegli eventi che prescindono dalle umane capacità (almeno per come vengono rappresentati), sono stati utilizzati non solo per dimostrare la divinità del Cristo, ma anche per attestare che tra ebrei e cristiani il fossato che s'era aperto dopo la crocifissione del messia, era assolutamente incolmabile. In tal senso essi non solo vogliono circondare di un'aureola divina un personaggio che nel corso della sua vita si comportò in maniera assolutamente umana, ma vogliono anche gettare una luce sinistra su un popolo, quello "ebraico", che viene colpevolizzato proprio in quanto tale.
L'antiebraicità dei vangeli, a tutto vantaggio del filoellenismo, è troppo scoperta perché possa essere condivisa. Se per realizzare una liberazione politica o, al contrario, se per rinunciarvi definitivamente gli uomini avessero bisogno di credere in eventi e manifestazioni prodigiose, probabilmente non vi sarebbe mai alcuna forma di emancipazione e noi dovremmo credere che gli ebrei, pur coi limiti del loro nazionalismo e della loro religione, nutrivano sul piano politico delle aspettative molto più interessanti di quel che non si pensi.
*
Come poi le cose siano effettivamente andate è difficile dirlo. Probabilmente Lazzaro era un alleato del Cristo, forse aveva tentato una sommossa non concordata con lui, che in quel momento si trovava in clandestinità insieme ad alcuni suoi discepoli. Lazzaro anticipò i tempi, agendo autonomamente, e fu ferito mortalmente.
Poiché la frustrazione popolare era stata davvero grande, Gesù decise d'intervenire personalmente, rischiando la cattura. Andò a consolare Marta e Maria, assicurando i discepoli di Lazzaro ch'era giunto il momento per l'insurrezione armata a Gerusalemme, nell'imminenza della Pasqua. E chiese la loro collaborazione per preparare l'evento, deciso a Betania. L'ingresso messianico sarà trionfale, poiché né i Romani né le guardie del Tempio avranno il coraggio d'intervenire.
La "resurrezione" di Lazzaro, se in origine era stata scritta in maniera "realistica", è sicuramente stata riscritta allo scopo di mistificare la decisione di realizzare la rivoluzione armata. Non era "risorto" Lazzaro, ma l'idea della liberazione nazionale, di cui Lazzaro era stato grande propugnatore tra i Giudei. Era venuto finalmente il momento di associare Galilei, Samaritani e Giudei in un obiettivo comune.
(torna su)21) L'unzione di Betania (fonti)
Gv 12,1-8 - Mc 14,3-11
Probabilmente il motivo che ha spinto il quarto evangelista a scrivere una pericope del genere, che nel complesso non si può dire molto significativa, sono state le gravi imprecisioni riportate nelle versioni parallele dei Sinottici.
Su alcune inesattezze, in verità, si sarebbe anche potuto prescindere, non foss'altro perché i Sinottici non sanno nulla di una "resurrezione di Lazzaro": la cena avvenne "sei" giorni prima della Pasqua e non "due", come dicono Mc 14,1 e, sulla sua scia, Mt 26,2; la casa era quella di Marta, Maria e Lazzaro e non quella di "Simone il lebbroso" (Mc 14,3 e Mt 26,6), né quella di un certo fariseo anch'egli chiamato Simone, come vuole Lc 7,36, l'evangelista medico, che non avrebbe mai potuto accettare l'idea di veder tanta gente mangiare attorno a un malato così infetto e che si rifiutò di costruire un parallelo cronologico a questo episodio perché probabilmente non ne capì il vero significato. Non furono "alcuni" tra i commensali che si sdegnarono contro Maria (Mc 14,4), né "tutti" i discepoli (Mt 26,8), ma solo l'apostolo Giuda Iscariota.
Se vogliamo, anche su un'assurdità di Luca (l'aver equiparato a una prostituta la donna che unge i piedi di Gesù) si poteva soprassedere, perché leggendo la versione di questo evangelista si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un episodio di diversa natura e, se vogliamo, anche molto inverosimile.
Su altri due aspetti, tuttavia, il quarto evangelista poteva sentirsi in dovere di fare le debite precisazioni. Anzitutto il brano dei Sinottici non ha una collocazione spazio-temporale giustificata, cioè non si riesce a comprendere minimamente il motivo per cui un'anonima donna abbia avvertito l'esigenza di cospargere i capelli e i piedi di Gesù di un profumo costosissimo (il brano di Luca non può neppure essere considerato parallelo a quello di Marco); in secondo luogo la motivazione che i Sinottici danno di questo gesto è del tutto fantasiosa: la donna avrebbe compiuto quel gesto perché voleva anticipare profeticamente il rito dell'imbalsamazione, prevedendo che di lì a pochi giorni il Cristo sarebbe morto in croce. Cioè la donna (che nei Sinottici non ha un nome né una parentela con chicchessia) meritava d'essere ricordata perché aveva profeticamente anticipato, con un gesto simbolico di natura non politica ma religiosa, la sconfitta del movimento nazareno e quindi la crocifissione del messia! Una tesi, questa, che viene interpolata, non senza fatica, nella stessa pericope giovannea, e che fa da puntello all'altra tesi, vero pilastro di tutto il cristianesimo, secondo cui il Cristo "doveva morire".
*
L'incipit del redattore del quarto vangelo ha invece un valore sia cronologico che politico: sei giorni prima dell'ingresso trionfale nella capitale e quindi della sua ultima Pasqua, il Cristo si trovava a Betania, presso la casa di Marta, Maria e Lazzaro. Mc 14,1s. sostiene, e in questo trova ampie conferme da parte di Giovanni, che le autorità volevano eliminare Gesù prima che entrasse nella capitale, temendo esse un tumulto popolare.
Nonostante quindi esista un mandato di cattura che pesa sulla sua testa, cui le folle, a quanto pare, non hanno dato molto peso, Gesù e i suoi più stretti collaboratori si possono permettere una cena a poche miglia dalla capitale, nella piena consapevolezza di avere un seguito sufficientemente ampio per poter entrare relativamente indisturbati nella città in festa. Se così non fosse, difficilmente si riuscirebbe a capire il motivo per cui un "fuorilegge" voglia rischiare di essere catturato in un frangente così banale come può essere quello di una cena. Tuttavia, stando a Mc 10,46, che pur fa uscire Gesù da Gerico, diretto verso Gerusalemme, insieme a lui vi erano "i discepoli e molta folla" (e che i discepoli fossero armati non ci piove).
Un secondo redattore del quarto vangelo ha voluto precisare che alla cena in oggetto vi era anche Lazzaro e naturalmente ha ribadito ch'era stato resuscitato, senza che questo inciso abbia alcuna relazione col resto della pericope. In origine infatti al v. 1a seguiva immediatamente il v. 2, ove la presenza di Lazzaro veniva constatata senza riferimento alcuno alla presunta resurrezione.
Non è da escludere che la figura di Lazzaro sia stata messa perché, avendo già detto nel racconto precedente ch'era stato risorto, ora non avrebbe avuto alcun senso dimenticarselo. Anzi i redattori hanno voluto insistere sulla tesi della resurrezione, dicendo che nell'occasione dell'arrivo di Gesù, molti da Gerusalemme andavano a trovare non solo lui, al fine di organizzare, in tutta sicurezza, l'ingresso nella capitale, ma erano anche interessati a vedere il Lazzaro redivivo, al punto che le autorità religiose avevano deliberato di far morire anche lui. In queste assurdità inevitabilmente si cade quando si vuol restare coerenti ad ogni costo a delle falsità formulate in precedenza.
In tutto il racconto di Giovanni le cose principali che risultano poco chiare sono sostanzialmente due:
A) il motivo per cui Maria abbia voluto usare in anticipo un unguento profumato che lei stessa aveva riservato per il giorno della sepoltura del Cristo (stando almeno a quanto viene detto nella pericope, ma l'unguento poteva anche essere stato acquistato per ringraziare Gesù di qualcosa, senza riferimenti forzati a sepolture improbabili di un uomo poco più che trentenne).
L'esegesi confessionale, sulla scia delle versioni fantasiose dei Sinottici, ritiene che Maria stesse subodorando una morte imminente del Cristo, ma questo va escluso nella maniera più tassativa, non foss'altro perché in quell'occasione, in cui nessuno stava certamente pensando a una sconfitta politica del movimento nazareno, sarebbe stato un gesto molto indelicato, foriero di cattivi presagi.
In realtà qui le possibili ipotesi interpretative sono due, che forse non sono neppure tra loro in alternativa:
– Maria voleva ringraziare il Cristo per il favore ricevuto, che non era stato "grande" perché – come vuole l'ideologia cristiana – Lazzaro era davvero morto, quanto perché Gesù aveva rischiato, accettando di assisterlo in un momento e in un luogo per lui molto rischiosi, di mandare all'aria il proprio piano insurrezionale;
– Maria riconosce al Cristo la possibilità reale di diventare messia e, col suo gesto, vuole anticiparne simbolicamente l'evento. Il che può far pensare che in realtà, nel racconto precedente, non si sia trattato di alcuna guarigione né, tanto meno, di alcun miracolo, ma semplicemente del fatto che le idee (zelote?) di Lazzaro, morto in uno scontro coi Romani, avevano trovato nel Cristo l'erede politico, sicché il movimento guidato da Lazzaro non era più destinato a disperdersi, bensì a fondersi con quello nazareno, ed è quindi probabile che i seguaci di Gesù abbiamo preparato insieme a quelli di Lazzaro l'ingresso messianico nel corso della festività pasquale.
Se diamo per scontato che Lazzaro fosse effettivamente morto e che la sua resurrezione sia stata frutto di una manipolazione dei redattori cristiani, allora dobbiamo interpretare il gesto di Maria non tanto come un'espressione di ringraziamento per il favore personale ottenuto, quanto piuttosto come una dimostrazione di riconoscenza della profonda umanità del Cristo, che aveva comunque rischiato l'arresto pur di venire ad assistere l'amico. Sotto questo aspetto che Lazzaro sia o non sia morto fa poca differenza, e ancor meno che sia o non sia "resuscitato". Non è neppure da escludere che Lazzaro fosse stato solo ferito e che abbia fatto l'ingresso messianico insieme a Gesù. Anzi, se ciò fosse vero, si potrebbe capire il motivo per cui i sommi sacerdoti volevano far fuori anche lui (ma il v. 10 di Giovanni può essere stato messo a titolo di ringraziamento per quei seguaci del partito di Lazzaro che dopo il 70 accettarono di diventare "cristiani"; cosa che nei vangeli venne fatta anche per alcuni seguaci del Battista e per i farisei progressisti seguaci di Nicodemo).
B) La seconda cosa poco chiara è relativa al ruolo stesso di Maria: come mai proprio una sorella di Lazzaro aveva conservato un unguento molto costoso per la sepoltura di Gesù? Che rapporti c'erano tra i due? È abbastanza singolare la confidenza o la familiarità che qui una donna, di cui i vangeli non dicono quasi nulla, può esibire nei confronti del messia. È stata l'unica, peraltro, che sia riuscita a farlo commuovere.
È difficile trovare una risposta a queste domande, se non appunto pensando che l'unguento non era stato acquistato per la sepoltura del Cristo, ma solo a titolo di ringraziamento per un favore personale ottenuto in circostanze drammatiche, o forse Maria lo teneva in casa pensando di usarlo per il fratello il giorno in cui fosse diventato messia. Fu dunque solo dopo la morte di lui che Maria decise di usarlo per Gesù, proprio perché se lo immaginava messia al posto di Lazzaro, come suo naturale e legittimo successore. Si può in sostanza ammettere che il profumo, certamente non destinato alla sepoltura del Cristo, sia stato qui usato secondo una finalità di riconoscimento della sua grandezza morale, oltre che politica: questo perché le due sorelle parteggiavano per gli ideali etico-politici sia di Lazzaro che del Cristo.
Tra l'altro, se davvero Maria voleva serbare l'unguento per la sepoltura del Cristo, poteva limitarsi a sciogliere il sigillo messo nel foro d'apertura, usando solo una parte del profumo; invece – lo dice anche Mc 14,3 – il vasetto di alabastro venne spezzato e tutto il suo contenuto fu messo sulla testa di Gesù (Gv parla solo di "piedi"), inondando di profumo l'intera dimora.
Sia come sia, alla vista del gesto di Maria, l'apostolo Giuda Iscariota si scandalizzò, interpretandolo come uno spreco. Da economista quale doveva essere, Giuda era riuscito a stimare il valore di mercato di quell'olio pregiato in circa 300 denari, che allora corrispondevano al salario medio di dieci mesi di lavoro. È dunque verosimile che Giuda abbia fatto una rimostranza del genere, anche perché era vicina la Pasqua e se il ricavato ottenuto dalla vendita del profumo fosse stato effettivamente dato ai poveri, avrebbe potuto esserci una positiva ricaduta d'immagine per il movimento nazareno.
Molto meno verosimile è la motivazione con cui Giovanni (o, come è probabile, un secondo redattore) spiega la rimostranza da parte di Giuda, il quale s'era indispettito della cosa perché solitamente rubava nella cassa comune dei Dodici. Qui infatti appare assai poco credibile che il Cristo avesse affidato a un ladro la gestione dei fondi. E neppure ha senso credere che il Cristo potesse chiamare tra i suoi più stretti collaboratori, gli "apostoli", una persona ipocrita e disonesta, uno che non aveva neppure il senso della "giustizia sociale".
In realtà se Giuda può anche essere stato un "ladro", non può però aver continuato a rubare una volta chiamato alla sequela del movimento nazareno, altrimenti un analogo sospetto dovremmo nutrirlo anche per Matteo, che prima di convertirsi faceva l'esattore delle tasse per il collaborazionista Erode Antipa. Per poter aspirare al ruolo di stretto collaboratore del messia, Giuda doveva possedere notevoli qualità personali, la prima delle quali era sicuramente una forte istanza di liberazione nazionale. Gesù può anche avergli affidato l'incarico di amministrare i beni, pur sapendo ch'era ladro, ma è assai dubbio ch'egli abbia fatto questo solo per metterlo alla prova: evidentemente Giuda aveva anche uno spiccato interesse per la materialità della vita, ovvero per la giustizia socio-economica. In nessuna parte dei vangeli viene detto che, prima di convertirsi, egli svolgeva un qualche mestiere riprovevole.
In ogni caso, anche supponendo che Giuda, prima d'incontrare Gesù, fosse stato ladro perché proveniente da ambienti marginali o deprivati (gli apocrifi in realtà sostengono fosse figlio del fratello del sommo sacerdote Caifa), e che, avendo contratto l'abitudine a rubare, di tanto in tanto attingesse indebitamente alle sostanze della cassa comune, si può forse, solo per questo, dedurre che la sua rimostranza fosse unicamente dettata da basse motivazioni di ordine personale?
Ci si può cioè chiedere, in altre parole: l'obiezione di Giuda può avere un senso di per sé, a prescindere dall'ipotesi ch'egli sia stato nel passato o fosse ancora nel presente un ladro? Il redattore, evidentemente, non si è posto questa domanda e col cinismo tipico delle persone schematiche ha voluto infierire, facendo sembrare Giuda peggiore di quello che era o che poteva essere. Lasciandosi suggestionare dal cosiddetto "effetto alone", il redattore ha voluto dare una risposta decisamente negativa alla seguente domanda: "poteva un traditore, che, stando ai vangeli, ha venduto il messia per 30 denari, nutrire delle idee a favore dei poveri?".
Gesù prende le difese di Maria e, in un certo senso, di se stesso dicendo che quel profumo era "già suo", in quanto Maria lo aveva destinato al giorno della sua morte (i cadaveri venivano unti e profumati). Non considera quindi del tutto impropria l’obiezione di Giuda, il quale ovviamente non conosceva la destinazione di quel profumo.
L’obiezione poteva apparire fuori luogo solo pensando che Giuda avrebbe dovuto capire la grande sensibilità di Maria. Ma forse che per questa mancanza di tatto (che neppure Gesù volle sottolineare), Giuda meritava d’essere trasformato da "economista" a "ladro"? È possibile sostenere che siccome la colpa del tradimento è la più grave che un uomo possa compiere, è del tutto naturale supporre che Giuda fosse anche un ladro?
Possiamo addirittura sostenere che tutta la costruzione mitologica della chiesa primitiva circa la "necessità" della morte del Cristo (che qui Maria avrebbe simbolicamente anticipato) è stata fatta, in un certo senso, a spese della personalità di Giuda, del cui tradimento si vorranno presto dimenticare le istanze politiche strettamente connesse, sino a inventarsi la vergognosa richiesta dei 30 denari. La divinizzazione del Cristo non è forse andata di pari passo con la demonizzazione dell'Iscariota?
Dunque che risposta plausibile può aver dato Gesù alla seguente domanda: se Giuda non fosse stato un ladro, la sua obiezione a Maria sarebbe stata giustificata? Da un lato infatti Gesù mostra di apprezzare politicamente i rimproveri mossi dall'apostolo (e forse da qualcun altro), in quanto evidentemente si rendeva conto che i poveri costituivano il problema n. 1 della loro missione. Dall'altro però gli fa capire che i rimproveri non hanno senso, in quanto quel profumo era già destinato a lui, per cui ai poveri non era stato tolto niente. Cosa che ovviamente Giuda non poteva sapere.
Un'altra osservazione però, molto più importante, Gesù poteva aver fatto: visto cioè che con la morte di Lazzaro si rende possibile un'intesa tra i suoi seguaci e i nazareni, nella prospettiva imminente di una insurrezione armata, è così importante rimproverare una donna che, a modo suo, ha voluto anticipare l'imminente evento, nella convinzione ch'esso avrà il successo meritato? Accusandola d'aver sprecato il profumo non si sta forse ammettendo, implicitamente, che la rivoluzione fallirà o che non è il momento di compierla?
Se il racconto fosse finito qui non si capirebbe neppure il motivo per cui sia stato inserito da Giovanni nel suo vangelo. Si ha come l'impressione che tra il momento in cui è iniziato il banchetto e quello in cui (presumibilmente alla fine) Maria ha iniziato a cospargere Gesù di profumo, manchi qualcosa. Possibile che nel corso di un'intera serata, nell'imminenza di un'insurrezione antiromana, i commensali non abbiano avuto altro da dirsi che disquisire se vendere o no un profumo che apparteneva a Maria e che questa aveva destinato a Gesù?
Se davvero Maria, col suo gesto, avesse voluto indicare il timore o il rischio di una possibile conclusione tragica dell'ultima Pasqua del Cristo, probabilmente l'unguento, che serviva appunto per imbalsamare i cadaveri, l'avrebbe conservato per il momento più opportuno o comunque avrebbe potuto scegliere una diversa modalità profetica. Qui è evidente che il redattore ha voluto far capire una cosa completamente diversa da quella effettivamente accaduta.
La stessa frase di Gesù riportata nella pericope ha un significato poco chiaro: "Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura" (v. 7). Evidentemente qualcuno ha voluto rendere ambigua un'espressione che in origine non lo era. Invece di usare il passato ("l'aveva conservato") si è preferito mettere il presente ("lo conservi"), facendo così credere al lettore che il Cristo si riferisse alla propria imminente sepoltura. Col che, peraltro, non si riesce a comprendere il motivo per cui Maria abbia sprecato una cosa che avrebbe dovuto usare il venerdì successivo.
In realtà il motivo qui gli evangelisti lo danno e, con loro, gli stessi manipolatori del quarto vangelo, che di fronte a un testo del genere si comportarono in maniera alquanto maldestra: essi hanno voluto caricare il gesto di Maria di un significato simbolico che in quel momento non poteva avere. In tal modo s'è potuto rifiutare il rimprovero di Giuda proprio perché contrario alla "necessità" che il messia aveva di morire. Se la morte di Gesù doveva essere imminente, il rimprovero di Giuda a Maria si opponeva, in ultima istanza, a questo destino metafisico.
Si è perfino arrivati a mettere in bocca a Gesù, senza alcuna motivazione plausibile, se non quella di voler infierire contro Giuda, una frase ch'egli non può assolutamente aver detto: "I poveri li avrete sempre con voi" (un versetto, peraltro, che in molti codici non è neppure riportato).
Con una frase di questo genere il Cristo avrebbe scandalizzato i discepoli molto più di quanto non aveva fatto Maria col suo inconsueto gesto. E per almeno due ragioni: 1. gli apostoli si sentivano militanti impegnati a modificare anche i rapporti sociali e non solo quelli politico-istituzionali; 2. un leader politico non può legittimare lo spreco neppure in casi eccezionali (a quella frase infatti egli aggiungerà: "me non mi avrete sempre", lasciando presagire – secondo i vangeli – una fine imminente).
Il redattore non solo non ha capito che la differenza tra Giuda e Gesù stava in un diverso modo di apprezzare il valore delle cose e nella necessità di approfittare del momento per compiere l'insurrezione antiromana, ma ha anche dimostrato di avere meno sensibilità di Giuda per le questioni di carattere sociale.
Dunque per quale motivo Gesù fu indotto a mentire dicendo che quel profumo era destinato al giorno della sua sepoltura? Il motivo forse lo si può capire cercando di rispondere a quest'altra domanda: s'egli avesse detto che le cose non hanno solo un valore "materiale" ma anche "spirituale", fino a che punto Giuda sarebbe stato in grado di capirlo?
Maria aveva voluto ringraziare il Cristo per la decisione d'essere venuto a trovare Lazzaro rischiando d'essere catturato e per la decisione di proseguire il messaggio di liberazione del fratello morto, il cui sacrificio, così, non sarebbe stato vano: per un favore personale e nazionale, etico e politico, così grande, non poteva esistere – secondo lei – un valore equivalente con cui ricambiare. La cosa più preziosa che possedeva: l'ampolla di nardo purissimo, poteva essere offerta solo a titolo simbolico, poiché tutto il suo vero valore stava unicamente nell'intenzione che aveva mosso il gesto.
Forse per questo Gesù aveva mentito: sia per tutelare Maria che per non mettere in imbarazzo lo stesso Giuda, che con difficoltà avrebbe compreso il valore profondo di quella intenzione.
Se questa interpretazione è vera, allora è anche vero che non può essere considerato inferiore all'elemosina nei confronti dei poveri un gesto d'amore nei confronti di una persona che, col suo messaggio di liberazione, avrebbe anche potuto risolvere il problema della povertà.
Il torto di Giuda, in sostanza, si riduce al fatto di non aver compreso che le esigenze umane di Maria non erano in contraddizione con quelle politiche del movimento nazareno. Esprimendo nel suo personalissimo modo quali sentimenti umani si potevano nutrire nei riguardi del messia, Maria aveva mostrato, forse involontariamente, di credere meglio di Giuda nella possibilità che Gesù aveva di realizzare una società economicamente più giusta, in cui non ci sarebbe stato bisogno di fare l'elemosina per alleviare (peraltro temporaneamente) le sofferenze dei poveri.
Il criterio di valore che aveva Giuda era di tipo "economicistico" o "riformistico" (a favore della giustizia sociale nei limiti dell'oppressione dominante, in attesa del momento opportuno per rovesciare il sistema) e viene usato per opporsi a una insurrezione immediata, giudicata prematura: quella che Cristo voleva compiere proseguendo la missione di Lazzaro.12
Il criterio di valore che manifesta Gesù era di tipo "politico" (una sconfitta, quella di Lazzaro, può trasformarsi in vittoria). Maria lo ringraziava per il grandissimo favore ricevuto: la resurrezione simbolica degli ideali politici del fratello Lazzaro, che era un rivoluzionario, ben conosciuto da Gesù sin dai tempi in cui era vissuto in Giudea; un favore per il quale non c’era un valore equivalente con cui ricambiare, proprio perché Gesù si esponeva di persona, volendo proseguire quegli ideali con una insurrezione armata, che Giuda riteneva forse prematura, anche se aveva rischiato, insieme a Gesù, d'essere catturato a Betania.
Giuda insomma avrebbe avuto ragione solo se per i poveri non ci fosse stata altra alternativa che l'elemosina, ma non per aver avuto torto meritava d'essere trasformato da "economista" a "ladro", ammesso e non concesso ch'egli si sia effettivamente scandalizzato per quello che aveva visto. Anche perché questa è praticamente l'unica pericope dei quattro vangeli in cui l'apostolo Giuda Iscariota viene delineato a prescindere dallo stereotipo, consolidato in tutto il Nuovo Testamento, di traditore del messia.
Gli ultimi tre versetti ci paiono difficilmente credibili, almeno per come sono stati scritti: per quale motivo i sommi sacerdoti volevano uccidere un uomo come Lazzaro che in nessuno dei quattro vangeli ha mai proferito la benché minima parola? Chi era Lazzaro? Un personaggio influente tra i Giudei? L'idea dei redattori cristiani di farlo risorgere è forse venuta in mente per caratterizzare simbolicamente la decisione dei suoi discepoli di aiutare il Cristo a entrare nella capitale in maniera trionfale? È stato Lazzaro che ha preparato l'ingresso messianico e che ha convinto Gesù che il consenso era sufficientemente ampio per tentare un'insurrezione armata contro i Romani e il potere collaborazionista? La conversione di Lazzaro alla causa rivoluzionaria di Gesù è forse stata gestita in maniera simbolica dai redattori cristiani al pari di quella di Paolo di Tarso alla causa antirivoluzionaria? È forse questo il motivo per cui dell'uno non sappiamo quasi nulla e dell'altro quasi tutto?
Insomma è assai probabile che Giuda si sia scandalizzato di quello che a lui appariva uno spreco semplicemente perché nessuno avrebbe potuto essere matematicamente sicuro che l'insurrezione sarebbe riuscita. Egli non era contrario all'idea in sé di "sollevazione popolare antiromana", ma ne vincolava la riuscita all'atteggiamento che il partito più importante della città avrebbe tenuto, quello farisaico, in cui, quasi certamente, lui stesso, un tempo, aveva militato. Il fatto di vedere a Betania una "grande folla di Giudei" al seguito di Gesù non lo rassicurava in maniera decisiva. Giuda doveva essere uno che amava calcolare, soppesare di ogni cosa i pro e i contro.
(torna su)22) Il socialismo democratico del buon pastore
Gv 10,1-21
Nel vangelo di Giovanni una pericope denominata "Il buon pastore" viene generalmente classificata o come parabola o come allegoria.
Come noto le parabole vengono considerate come una sorta di discorsi di edificazione morale o filosofica, piuttosto astratti, in quanto con riferimenti a personaggi del tutto immaginari, oppure, se reali, difficilmente individuabili, specie per la generazione successiva a quella cui le parabole erano state indirizzate. Non è escluso che Gesù, per difendersi da un potere ostile, abbia fatto ricorso a immagini figurate o allusive, attraverso le quali l'attacco alle istituzioni risultasse per così dire indiretto.
Tuttavia la pericope del "buon pastore", in cui Gesù parla esplicitamente di se stesso, non appare tanto di tipo etico o filosofico quanto di tipo politico, e più precisamente come una sorta di autocandidatura alla direzione governativa della Palestina, per liberare quest'ultima sia dalla presenza colonialista dei Romani che dal collaborazionismo degli elementi ebraici più opportunisti.
Il fatto di aver voluto trasformare in "parabola" un discorso squisitamente politico, rientra in quel processo redazionale, ben più generale, di mistificazione ai danni dell'operato di Gesù da parte di quegli apostoli la cui ideologia post-pasquale, che interpretò la tomba vuota come "resurrezione", risultò, ad un certo punto, prevalente: ci riferiamo ovviamente a quella petro-paolina.
In altre parole, se Cristo ha usato lo strumento linguistico delle parabole non l'ha fatto con intenti etico-filosofici astratti, ma semplicemente perché quando, nell'immediato, non si dispone ancora della forza sufficiente per contrastare la resistenza di un governo autoritario, può essere necessario trasformare il linguaggio contestativo da esplicito ad allusivo. Le parabole cioè non venivano usate per attenuare l'esigenza della rivoluzione nazional-popolare, ma per farla sopravvivere in un contesto politico sfavorevole. Usare un linguaggio con riferimenti diretti in circostanze sfavorevoli significa fare dell'avventurismo, ovvero illudersi che il proprio estremismo possa essere percepito come una forma di coraggio.
A ben guardare invece questo discorso rappresenta la parte politica di quello successivo, di tipo culturale, dedicato all'argomento dell'ateismo. Qui Gesù parla di "socialismo democratico", mentre nell'altro parlerà di "umanesimo laico".
In che senso "socialismo democratico"? Nel senso espresso sin dal primo versetto: "chi non entra per la porta [cioè rispettando le regole della democrazia] nell'ovile delle pecore [il popolo], ma vi sale da un'altra parte [usando cioè la frode o l'inganno] è un ladro e un brigante". Per realizzare il socialismo occorre la democrazia, la quale ha le sue regole da rispettare: non vi sono scorciatoie.
La democrazia è la prima istanza, il socialismo la seconda: una è metodo, l'altro è fine. Quando un leader si comporta in maniera democratica non avverte se stesso come insostituibile e certamente il popolo l'avverte come affidabile.
Il guardiano dell'ovile non rappresenta soltanto il luogotenente del pastore, cioè colui che di notte custodisce le pecore nel recinto, ma rappresenta anche una sorta di delegato popolare, in quanto ha il compito di aprire la porta dell'ovile soltanto a chi ne ha diritto. Prima dev'essere lui a riconoscere il legittimo pastore, poi saranno le pecore, che usciranno dall'ovile non perché costrette ma dopo aver riconosciuto il particolare richiamo del loro pastore.
Gesù si pone come leader popolare, democratico: non vi è nulla di religioso in questo suo discorso, e il popolo lo segue con fiducia appunto perché lo riconosce come proprio leader: non a caso qui si parla di "pastore", non di un ricco proprietario terriero.
Che la pericope non possa essere definita come "parabola" né come "allegoria", ma al massimo come "similitudine", è dimostrato anche dal fatto che nella sua seconda parte Gesù, vedendo che non l'avevano capito adeguatamente, si spiega in maniera più esplicita e diretta.
Che gli astanti non avessero capito il significato generale del paragone appare un po' strano, poiché anche nell'Antico Testamento risultava pacifica l'equazione politica di "pastore di greggi" e "pastore di uomini": basta leggersi Ez 34 per convincersene, o i primi otto versetti del cap. 23 di Geremia.
I veri "pastori d'Israele" sono i leader politici autenticamente democratici, quelli che devono riunire il gregge che si è disperso, e devono farlo per amore della giustizia e dell'eguaglianza. La differenza tra Gesù ed Ezechiele è che quest'ultimo si limita ad auspicare la venuta di un pastore novello Davide, mentre Gesù sostiene d'essere il pastore democratico che il popolo attende (Davide era un dittatore militare).
Quindi ciò che gli astanti non capivano non poteva essere tanto il significato simbolico della parola "pastore", e neppure l'esigenza politica di avere una guida adeguata per ricostituire un popolo unitario. Quello che non capivano era probabilmente il riferimento concreto alla candidatura di un ruolo specifico: Gesù stava forse parlando esplicitamente di sé oppure a favore di altri, come p. es. aveva già fatto, prima di lui, il Battista, rimasto sempre riluttante ad accettare la qualifica di messia? E come poteva riferirsi a se stesso con sicurezza, senza alcun avallo istituzionale? senza ch'egli militasse in alcuno dei tradizionali partiti giudaici? Dubbi di tal genere a chi altri potevano venire in mente se non ai farisei? se non cioè a quel partito per il quale il rispetto delle regole voleva anzitutto dire "attaccamento fanatico alle tradizioni"?
Gesù ribalta qui il concetto di democrazia, sostenendo ch'essa si realizza non quando si antepone il glorioso passato al corrotto presente, ma quando si risponde alle domande di giustizia del popolo. Egli, nella parte iniziale della spiegazione, non sostiene esplicitamente d'essere il "pastore politico" che cercano (una pretesa del genere sarebbe stata contraddittoria all'idea stessa di democrazia), ma semplicemente ch'egli si pone come "porta dell'ovile" per chiunque voglia diventare leader nazionale. Il che, in altre parole, voleva dire che chiunque nel movimento nazareno avrebbe potuto diventare "pastore" se avesse rispettato le regole della democrazia, quelle regole rappresentate appunto dalla "porta".
Può apparire forte la frase: "tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti" (10,8), ma è probabile che una frase del genere trovi la sua motivazione nell'urgenza del momento storico per Israele, ed è altresì probabile ch'essa sia stata detta al cospetto di un uditorio non più disposto ad obbedire ai demagoghi di turno, e che quel "tutti" si riferisse soltanto ai politici istituzionali della sua stessa generazione, che effettivamente s'erano rivelati incapaci di liberare Israele dall'oppressione interna ed esterna. Infatti, subito dopo egli esalta il popolo dicendo che, benché dei leader politici disonesti abbiano cercato di ingannarlo, esso ha saputo ugualmente difendersi: "le pecore non li hanno ascoltati" (ib.).
Se il popolo chiede chiarezza, quando sono in gioco aspetti essenziali per il proprio destino, ebbene il linguaggio non può che essere inequivoco. Ciò tuttavia non esclude che il v. 8 non possa essere considerato spurio, anche perché al seguente si ripete quanto già detto al v. 7, e cioè che Gesù si considerava "porta dell'ovile", strumento di democrazia.
D'altra parte che qui il linguaggio non sia figurato che sino a un certo punto, è dimostrato anche dall'evidente affermazione di tipo messianico secondo cui Gesù rivendica a sé il ruolo di "pastore politico". Col che non si precisa soltanto la regola della democrazia ma anche il suo indicatore di direzione: la garanzia è il popolo, ma il popolo ha bisogno di una guida, altrimenti si disperde. E la guida deve dimostrare d'essere all'altezza del compito, deve impegnarsi in una promessa d'alto profilo: mettere a disposizione tutta la propria vita per il bene del gregge. Il leader deve operare per un ideale superiore, restando incorruttibile.
I pastori della nazione d'Israele, se vogliono liberare il popolo dallo straniero che l'opprime e da chi lo tradisce schierandosi dalla parte del nemico, non devono frodare ma praticare la giustizia, non devono uccidere ma far vivere, non devono distruggere ma costruire, in una parola non devono essere "mercenari" ma "idealisti".
Il mercenario, quando vede venire il "lupo", colui che usa violenza e inganno per devastare e dominare, "abbandona le pecore e fugge". Qui l'esegesi confessionale ha subito approfittato dell'espressione "dare la vita per le proprie pecore" (vv. 11 e 15), per sostenere che il Cristo intendeva riferirsi alla propria morte.
In realtà sarebbe stato assurdo che gli ascoltatori di quelle parole le interpretassero alla lettera in quel momento. "Dare la vita per le proprie pecore" voleva semplicemente dire "essere coerenti coi propri ideali di giustizia". Il popolo aveva bisogno di un leader edificatore di una nuova società, non di un martire.
Infatti un qualunque politico strettamente legato a interessi di potere, non può mai essere coerente quando sono in gioco gli obiettivi della giustizia sociale. I politici mercenari predicano la giustizia solo per ottenere i consensi necessari a dominare, ottenuti i quali le promesse fatte in campagna elettorale diventano carta straccia. È la differenza tra democrazia e demagogia.
Il finale della pericope è ampiamente manomesso, specie là dove s'introduce il rapporto tra "padre" e "figlio", ma anche là dove si parla di "altre pecore" (v. 16), cioè di "pagani", che dovranno far parte del medesimo ovile. D'altra parte là dove più è forte la rivendicazione politica della liberazione nazionale, maggiori sono i tentativi di mistificazione compiuti dai redattori.
Sono stati introdotti due elementi tipicamente post-pasquali, facenti parte dell'ideologia petro-paolina. Da un lato si è voluto far risalire la credibilità di Gesù a un suo presunto rapporto diretto con dio-padre, contraddicendo così l'idea stessa di democrazia politica, che non ha bisogno, per essere giustificata, che di se stessa; dall'altro si è voluto far credere che per il Cristo non sarebbe stato un problema la chiusura e l'ostilità del popolo ebraico, in quanto egli avrebbe sempre potuto rivolgersi, e con successo, ai "gentili": col che si antepone all'obiettivo della liberazione politico-nazionale quello della generale redenzione morale dell'umanità (benché non si possa escludere a priori che il Cristo volesse indicare gli elementi migliori del paganesimo come partner indispensabili della rivoluzione ebraica contro l'imperialismo romano).
Manipolazioni così pesanti inducono inevitabilmente a credere che il discorso di Cristo sia stato effettivamente pronunciato. Un'esegesi laica deve però essere in grado di smascherare la pretesa di far apparire grande un uomo non in quanto coerentemente democratico, ma in quanto "padrone della propria vita e della propria morte".
Paradossalmente infatti, se davvero il Cristo avesse affermato d'essere uguale al dio-padre, in grado di morire e risorgere come e quando gli pareva, si dovrebbe dar ragione a quegli ebrei che nel finale della pericope sostengono ch'egli "ha un demonio ed è fuori di sé" (v. 19).
Non a caso i redattori han dovuto aggiungere, sommando falsità a falsità, che di fronte a un uomo che rivendica a sé non un ruolo "politico" ma "teologico", è lecito chiedersi come sia possibile che "un indemoniato possa aprire gli occhi ai ciechi" (v. 21). In tal modo venivano completamente ribaltati i termini della questione: non si trattava più di credere o meno nella messianicità del Cristo, ma piuttosto nella sua divinità.
La credibilità del messia non passerebbe tanto attraverso il rapporto fiduciario tra il popolo e il proprio leader rappresentativo, ma attraverso la stretta identificazione di azione pratica e ideale astratto (che nella fattispecie è di natura religiosa), sicché le parole del Cristo-pastore andrebbero accettate non per il loro riferimento alla realtà concreta, in cui si gioca il rapporto dialettico tra masse e potere, ma per una loro intrinseca e formale coerenza, di tipo appunto teologico o comunque metafisico.
Il Cristo andrebbe creduto perché azzarda un'ardita speculazione intellettuale: l'uguaglianza di dio-figlio e dio-padre, resa possibile sul piano umano in quanto possibile su quello divino: cosa che troverebbe conferma nell'accettazione volontaria della croce, trasformata in trionfo della resurrezione.
(torna su)23) Congiura contro Gesù
Gv 1,45-57
È da escludere categoricamente che la decisione da parte delle autorità sinedrite di assassinare Gesù sia da collegarsi alla presunta resurrezione di Lazzaro, come invece appare nel vangelo di Giovanni; a meno che col termine di "resurrezione" non s'intenda, in maniera metaforica, qualcosa di eversivo che sul piano politico voleva compiere lo stesso Lazzaro, che però in quel momento era già morto, per cui, al massimo, possiamo pensare a un provvedimento, da parte del partito sadduceo, contro i suoi seguaci e contro chi voleva far "risorgere" l'idea di un'insurrezione antiromana (in tal caso Gesù e i suoi seguaci).
Di certo noi sappiamo che il rapporto di Gesù con Lazzaro (o coi seguaci di quest'ultimo), qualunque esso sia stato, nell'imminenza dell'ultima Pasqua comportò non solo la decisione di organizzare un ingresso trionfale nella capitale, al fine di porre le condizioni per la liberazione nazionale contro i Romani, ma determinò anche la scissione dei Giudei, politicamente impegnati, in due partiti, dei quali uno credeva possibile un'insurrezione armata guidata da Gesù, l'altro no. I "molti" del v. 45 e gli "alcuni" del v. 46 riflettono in un certo senso la composizione delle forze in campo: gli uni sono maggioritari nella piazza ma minoritari nel palazzo, gli altri il contrario.
Gli esponenti dei partiti sadduceo e fariseo (la maggioranza degli scribi era affiliata al partito farisaico, mentre l'altra parte a quello sadduceo), nonché gli anziani (cioè i capi delle famiglie nobili e più ricche della Giudea, cui il procuratore romana poteva anche togliere la proprietà) e i sommi sacerdoti (scelti dal procuratore romano tra le quattro famiglie principali devote a Roma), avendo il controllo del Sinedrio (v. 47), possono decidere la condanna a morte del Cristo, in particolare la necessità di eliminarlo prima che entri in città, senza che ciò però abbia alcun effetto.
Nell'ambito del Sinedrio solo una parte minoritaria resta incerta sul da farsi: probabilmente si tratta dell'ala più democratica degli scribi-farisei (Nicodemo, Gamaliele, Giuseppe d'Arimatea, Giairo...)13. Essi temono Gesù perché riconoscono la sua grande popolarità, ma, poiché non ritengono mature le condizioni per l'insurrezione nazionale, temono anche che questa popolarità possa inasprire l'oppressione da parte delle forze occupanti.
Caifa invece (il sommo sacerdote che restò in carica dal 18 al 36 d.C. e che in quell'occasione rappresentava il partito conservatore dei sadducei), sostiene che se i nazareni della Galilea e i farisei progressisti della Giudea vogliono porsi alla testa dell'insurrezione armata, la prima cosa che devono fare è eliminare il Cristo, perché col suo avventurismo da "falso messia" egli rischia di mandare all'aria ogni prospettiva rivoluzionaria. Al delitto politico dà una giustificazione che è un capolavoro di cinismo: la salvezza dell'integrità nazionale è la ragion di stato che legittima la fine di un pericoloso destabilizzatore.
Caifa in sostanza, ritenendo improponibile una strumentalizzazione efficace del movimento nazareno e praticamente conclusa la fase del confronto democratico, reputa più facile da gestire la reazione dei seguaci del Cristo alla sua sommaria esecuzione ("è meglio far morire un solo uomo per il popolo") che non la reazione dei Romani a un'insurrezione da lui guidata ("che far perire la nazione intera").
Caifa non può non ricordare che in occasione della decapitazione del Battista, avvenuta tre anni prima, i seguaci di quest'ultimo non organizzarono alcuna manifestazione di vera protesta. Egli inoltre sa benissimo, sin dal giorno dell'espulsione dei mercanti dal Tempio, che gli interessi del movimento nazareno sono diametralmente opposti a quelli della casta sacerdotale.
Un secondo redattore di questa pericope ha voluto interpretare le parole del sommo sacerdote in maniera distorta, col solito ragionamento post eventum. Le considerazioni dei vv. 51-52 sono non solo di natura misticheggiante (Caifa avrebbe profetizzato proprio in quanto "sommo sacerdote"), ma anche chiaramente apologetiche, in quanto si vuole attribuire a Caifa l'involontaria profezia circa il destino universale del messaggio evangelico; destino che in realtà era implicito nel vangelo stesso di Cristo e che non avrebbe avuto bisogno di una morte cruenta per realizzarsi.
Faremmo davvero una cattiva esegesi del messaggio di Gesù se dicessimo ch'egli aveva in mente una pura e semplice restaurazione dell'antico regno davidico: in realtà nel suo vangelo erano già contenuti alcuni elementi universalistici che sarebbero emersi anche dopo il successo dell'insurrezione nazionale. È stato il cristianesimo primitivo che ha voluto interpretare tale universalismo solo come conseguenza della crocifissione e quindi come un aspetto più etico-religioso che politico. "Riunire insieme i figli dispersi" è un'espressione che sta appunto a significare l'uguaglianza degli uomini di fronte a dio, certamente non di fronte a se stessi.
Peraltro Caifa aveva in mente la salvezza della nazione israelitica e non profetò, neppure involontariamente, qualcosa che andasse oltre questi confini. Anzi, s'egli avesse previsto che i Romani non si sentivano legati ai loro trattati internazionali più di quanto un carnefice non si senta legato a un determinato strumento di tortura, forse avrebbe evitato di nascondere i propri privilegi di potere dietro l'idea dell'integrità nazionale e avrebbe capito che il collaborazionismo, in ultima istanza, pagava meno di un'ipotesi insurrezionale.
In tal senso il cinismo del redattore non è inferiore a quello di Caifa, in quanto ha voluto dare una patente di legittimità a questo delitto politico, dicendo che proprio in virtù di esso tutti gli uomini della terra (ebrei e gentili) hanno potuto sentirsi "figli di un unico Dio".
Portando alle estreme conseguenze una posizione del genere si finisce col credere che il Cristo volle entrare nella città santa proprio perché sapeva che l'avrebbero ucciso: dunque il valore del suo vangelo starebbe anche nell'esigenza di ottenere una forma di rinomanza o comunque di valorizzazione del proprio operato attraverso la scelta del martirio.
Da ultimo si può far notare che i vv. 54-57 contengono delle stranezze poco decifrabili:
– il redattore conclude la pericope dicendo che "Gesù non si mostrava più in pubblico tra i Giudei". In realtà già da tempo la situazione per lui era diventata molto critica; sono numerosi i passi in cui Giovanni dice che i Giudei avevano intenzione di arrestarlo se non di ucciderlo: 5,16; 5-18; 7,1; 8,59; 10,31; 10,39-40; 11,8, e che per questa ragione egli era costretto alla clandestinità;
– il secondo rifugio qui citato è Efraim, nei pressi del deserto di Giuda, non molto distante dai confini della Samaria. All'inizio del racconto di Lazzaro, Gesù e i suoi si trovavano invece in un rifugio della Perea. Se accettiamo l'ipotesi di Efraim possiamo presumere ch'egli si diresse successivamente coi discepoli a Gerico, dopodiché fece una sosta a Betania, ove Maria gli unse i piedi. Ma questo non spiega il momento e la dinamica dell'incontro con la "molta folla" di cui parla Mc 10,46, che avrebbe seguito Gesù dalla Galilea fino a Gerusalemme passando appunto per Gerico, ove venne guarito il cieco Bartimeo: una folla "stupìta" al vedere Gesù così deciso e anche "timorosa" di seguirlo – dice Mc 10,32, mentre quella descritta da Lc 19,11 è convinta che il nuovo regno si sarebbe manifestato di lì a poco;
– il v. 57 è del tutto pleonastico rispetto al v. 53, anche perché si continua a parlare di "arresto" quando l'ultima delibera era stata favorevole alla "condanna a morte" in gran segreto.
(torna su)24) L'ingresso messianico a Gerusalemme (fonti)
Gv 12,12-50 - Mc 11,1-11
Gesù decise di entrare pubblicamente a Gerusalemme, insieme ai Dodici e a molti altri discepoli (ivi inclusi quelli di Lazzaro), solo dopo aver visto che, grazie all'appoggio popolare che aveva ottenuto, le autorità, giudaiche e romane, non avrebbero potuto arrestarlo alla luce del sole. La folla già presente in città, e che a motivo della Pasqua proveniva da tutta la Palestina, gli andò incontro come se lo aspettasse, ed era così numerosa che i farisei, sbigottiti e amareggiati, esclamarono: "Vedete che non concludete nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro!" (Gv 12,19).
Mt 21,8 parla infatti di "folla numerosissima" e di "tutta la città in agitazione" (21,10); Mc 11,8, più genericamente, parla di "molti" e Lc 19,37, volendo specificare che si trattava di "tutta la folla dei discepoli", dice una mezza verità, in quanto questa volta il consenso andava ben al di là dell'adesione fattiva al movimento nazareno.
I riferimenti redazionali alla resurrezione di Lazzaro falsificano le motivazioni di quell'accorrere festoso ed esultante, perché ne nascondono le motivazioni più vere, che non erano tanto quelle di rivedere un uomo che per molti mesi aveva dovuto agire nella clandestinità, né quella di congratularsi con chi aveva tolto un uomo dalla tomba (come vogliono i vv. 17-18 di Giovanni), quanto piuttosto quella di poter constatare che, sul piano sia oggettivo che soggettivo, esistevano finalmente le possibilità di una insurrezione armata contro i Romani. Lc 22,36 descrive bene i momenti preparatori dell'ingresso in una frase piuttosto esplicita: "Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una".
La guarnigione romana, colta del tutto impreparata, non mosse un dito, anzi, considerando che la Pasqua, per essa, era il momento più critico di tutto l'anno, in quanto gli ebrei affluivano copiosi in città, rendendo facilmente possibili gli attentati e le sommosse, viene da pensare che molto forte dovette essere la preoccupazione di una imminente sollevazione popolare.
Non accaddero incidenti, al momento dell'ingresso, non perché – come vuole l'esegesi confessionale – il corteo non sembrava avere alcuna finalità politico-eversiva, ma perché era talmente imponente il numero e inaspettata l'iniziativa che il potere istituzionale restò come paralizzato.
Il Cristo venne accolto al pari di un re (Gv 12,13; Lc 19,38) o come se dovesse ricostituire il regno di Davide (Mc 11,10; Mt 21,9). Tutta la festa assomiglia a quella che si faceva per l'intronizzazione degli antichi re d'Israele: la folla stese i propri mantelli (Mc 11,8; Mt 21,8; Lc 19,36) come quella che in 2 Re 9,13 consacrò re Jeu; l'uso dei "rami di palme" (Gv 12,13; Mc 11,8; Mt 21,8) è analogo a quello di circa 170 anni prima, in occasione della decisiva rivolta popolare guidata dal leader Simone contro l'occupazione seleucida di Gerusalemme (1 Mac 13,51): praticamente dall'epoca maccabaica il vincitore veniva accompagnato così in città (2 Mac 10,7). La stessa espressione "uscirono incontro a lui" (Gv 12,13) indica una sorta di regola protocollare per l'intronizzazione regale di un capo carismatico. Persino la semplice espressione "Osanna" (Hoshia'-na), che in origine era un grido d'aiuto e che col tempo era diventata un'acclamazione solenne, qui sta a significare "Salvaci, aiutaci, donaci la vittoria!" (2 Re 6,26; 2 Sam 14,4). Insomma la folla di Gerusalemme mostrava di avere di Gesù una concezione chiaramente politico-militare.
Gesù non rifiuta le acclamazioni: l'unico paletto che pone al cospetto di questo atteggiamento esuberante è quello relativa alla scelta dell'asino. Una scelta anch'essa politica: il nuovo re d'Israele voleva presentarsi in maniera democratica, così come aveva espresso il miglior profetismo ebraico: "Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina" (Giovanni sintetizza Sof 3,16 s. e Zc 9,9, ma cfr anche 1 Re 1,33 s., ove si narra dell'intronizzazione di Salomone che cavalcava una mula). Questo per indicare che una rivoluzione contro i Romani avrebbe potuto essere vincente solo col consenso della grande maggioranza della popolazione ebraica. Una cosa infatti era estromettere la guarnigione acquartierata presso la capitale, un'altra resistere alla controffensiva di Tiberio: una nazione piccola come la Palestina avrebbe potuto opporsi efficacemente contro l'impero romano solo a condizione di restare unita.
Forse qui si può sottilizzare dicendo che mentre in Giovanni la scelta dell'asino sembra essere dettata da considerazioni fatte sul momento stesso dell'ingresso, in Marco invece, a motivo dell'ampio spazio che si dedica a questa scelta, si ha l'impressione dell'esistenza di un piano preordinato nei dettagli.14 La cosa strana tuttavia è che mentre in Giovanni Gesù entra in città senza simboli di sorta e la scelta dell'asino viene fatta proprio per attenuare le aspettative di un puro e semplice revival d'intronizzazione anticotestamentaria; in Marco invece la rappresentazione che viene fatta di Gesù è quella di un grande profeta o comunque di un messia del tutto pacifico, che in nessun modo avrebbe usato la violenza per liberare Israele dai Romani: Gesù quindi vuole di proposito utilizzare l'asino al fine di tutelarsi preventivamente da pressioni che possono andare oltre questi rigorosi limiti di operatività; tant'è che mentre in Giovanni i discepoli non comprendono questo tipo scelta, anche perché essi si stavano giocando la loro stessa vita, in Marco invece agiscono come se quella fosse stata la scelta migliore, quasi con la consapevolezza che il destino del messia nella capitale fosse già segnato.
Non dobbiamo infatti dimenticare che per i Sinottici l'immagine di un messia religioso, che cavalca un'asina proprio per non diventare messia politico, è conseguente, in maniera necessaria, al fallimento del progetto di liberazione nazionale, per cui la falsificazione doveva essere presente nella stessa premessa della pericope marciana (che fa da modello alle altre due, di Matteo e Luca). I Sinottici dipingono un quadro mitico ogniqualvolta quello realistico non può essere rappresentato.
Viceversa, in Giovanni l'immagine resta quella del messia politico, ma la politicità di questo messia viene considerata pienamente vera solo in una prospettiva metafisica (questo è soprattutto vero in quei passi che hanno subìto più interpolazioni). Ecco perché lo stesso Cristo crocifisso che nei Sinottici desta scandalo, in Giovanni esprime un senso di vittoria, in quanto è rimasto coerente coi suoi principi e non ha tradito la sua missione. La descrizione può rimanere realistica proprio perché è soltanto sulla motivazione con cui si devono interpretare i fatti della passione che deve intervenire il mito.
I manipolatori del vangelo di Giovanni hanno voluto aggiungere la tesi classica della "morte necessaria", là dove fanno capire ai discepoli la scelta dell'asino solo dopo la crocifissione del messia, proprio per escludere a priori la possibilità di uno svolgimento armato dell'ingresso messianico. E, in tal senso, l'esegesi confessionale ama fare continui riferimenti al cap. 53 di Isaia, in cui si parla, in maniera "incredibilmente profetica", del tragico destino del "servo sofferente".
Tuttavia, questo modo di ragionare contraddice apertamente la volontà espressa in vari passi evangelici relativi alla possibilità di una resistenza antiromana che andasse al di là di una posizione non-violenta ipostatizzata. Lc 22,49 sostiene che al momento della cattura di Gesù gli apostoli erano tutti armati. Mt 11,12 fa dire a Gesù che "dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono". E in 10,34: "Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada". E in Lc 12,49: "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!". Insomma la violenza come "legittima difesa" dal sopruso non è mai stata negata nei vangeli.
Gli apostoli possono essersi scandalizzati della scelta dell'asino non perché erano dei "violenti", ma perché sapevano che con la non-violenza ad oltranza non si sarebbero liberati dei Romani. Ciò che non compresero è che chi compie la rivoluzione, prima ancora di compierla, deve comunque fare di tutto per porre un'alternativa alla violenza in atto e a quella che si potrebbe scatenare.
Giovanni è l'unico evangelista ad affermare che in quell'occasione il movimento nazareno allacciò dei rapporti politico-diplomatici con alcune realtà del mondo ellenico, anch'esse evidentemente interessate a un'opposizione antiromana. È tuttavia singolare che questo incontro, che peraltro attesta l'universalismo implicito nell'ideologia nazarena, non comporti alcuna conseguenza nel contesto della pericope. Nei vangeli si è fatto di tutto per porre una netta incompatibilità tra progetto di liberazione nazionale (che lo si è voluto circoscrivere entro gli angusti limiti del veterogiudaismo) e possibilità di un fronte comune interculturale (che lo si è voluto caratterizzare in maniera esclusivamente spiritualistica a partire dallo sviluppo del paolinismo).15
*
Il silenzio su questo episodio fa da contraltare alla riformulazione del discorso pronunciato nella capitale di fronte ai capi della folla osannante. Probabilmente in quell'occasione si verificò la disputa più importante sostenuta da Gesù con quei gruppi politici disponibili a considerare l'ipotesi di un'insurrezione armata generale.
La disputa verteva sulla questione della gestione del potere rivoluzionario: quale doveva essere la modalità più idonea? È molto difficile rispondere a questa domanda. I redattori hanno qui elaborato un discorso teologico sull'unità divina tra Padre e Figlio che molto probabilmente aveva lo scopo di sostituirne uno di natura politica relativo all'unità nazionale. È evidente che quanto più forte era nelle parole del Cristo la tensione verso un'azione rivoluzionaria, tanto maggiore doveva essere la revisione redazionale di quelle parole in senso antirivoluzionario. Quanto più è vicina la possibilità di un successo politico, tanto più esplicita deve diventare la tesi della "morte necessaria".
Il "principe di questo mondo" che deve essere subito gettato fuori (Gv 12,31) non è più Cesare ma "Satana" e la glorificazione del Figlio dell'uomo non è che la sua imminente crocifissione. Lo stesso riferimento alla "elevazione" andrebbe interpretato: in effetti o questo è argomento di natura teologica e quindi del tutto fittizio e non meritevole di particolare interesse, oppure va considerato come un argomento politico soggetto a manipolazione, e allora bisogna cercare di scoprirne il significato recondito.
Il tema dell'attrazione e del raduno nonché dell'innalzamento era già stato usato nel giudaismo classico per indicare la necessità di un messia-re che riportasse Israele agli antichi splendori (Ger 31,1 ss.; Ez 11,1-25; Os 2,16). La parola più difficile da interpretare è hupsôthô (da hupsôsis), "elevare da terra". L'unico precedente nel quarto vangelo è il paragone col serpente di rame che Mosè si costruì per convincere gli ebrei dei suoi magici poteri: "Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo" (Gv 3,14). In lingua italiana è stato usato il verbo "innalzare", ma sarebbe stato meglio mettere "esaltò", indicando, col gesto, anche il suo significato evocativo.
Il redattore dell'ingresso messianico è comunque consapevole dell'ambiguità del termine, per questo può usarlo anche per indicare qualcosa che oscilli tra la crocifissione e la resurrezione o l'ascensione. In effetti la parola greca "ύψωθώ" (Gv 12,32) è molto particolare e di difficile traduzione. Si rischia facilmente di cadere o nel moralismo: "chi si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato" (Mt 23,12: Lc 1,52) o nella banalità della traduzione inglese "lifted up", usata in riferimento agli occhi, alle mani, alla voce e allo stesso corpo umano che si alzano o si sollevano!
La versione latina "exaltatus" si ritrova soltanto in At 2,33 e 5,31, in un contesto ovviamente teologico: il Cristo è stato "innalzato alla destra di Dio come capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati", ma è facile risalire all'originaria etimologia politica del verbo in questione. Così come d'altra parte appare nell'Antico Testamento: in 2 Cr 32,23 "exaltatus" viene usato con una finalità chiaramente politica, nel senso che il re di Giuda Ezechia "aumentò in prestigio agli occhi di tutti i popoli"; in 1 Mac 11,16 la parola indica il trionfo del re Tolomeo.
Questo per dire che se il termine greco "ύψωθώ" viene usato da Giovanni in un'accezione politica (che i redattori hanno poi stravolto in chiave teologica), resta comunque da chiarire il vero significato politico di questo termine, in quanto il suo equivalente latino rimanda a una modalità di affermazione politica o troppo tradizionale o scopertamente teologica perché si possa pensare che fosse la stessa nelle intenzioni del Cristo.
Dietro questo termine può nascondersi il significato di una vera e propria "sollevazione popolare", in cui il popolo stesso avrebbe dovuto esserne protagonista. Solo successivamente i redattori hanno circoscritto l'accezione del termine all'individuo-Cristo attribuendogli un significato religioso o comunque ambiguo. Spesso infatti nei vangeli si tende a denigrare politicamente le masse per poter esaltare misticamente il Cristo, oppure si esaltano solo quelle masse che accettano la tesi della "morte necessaria": "Io, quando sarò elevato da terra [cioè crocifisso], attirerò tutti a me" (Gv 12,32).
È dunque probabile che il Cristo abbia prospettato la necessità di una insurrezione popolare armata, da gestirsi in maniera democratica, in opposizione non solo al potere romano ma anche a quello colluso della casta sacerdotale, dei sadducei, e anche a quello opportunista ed esitante dei farisei.
Che cosa sia successo in quell'occasione, allo stato delle fonti, possiamo solo immaginarlo. Giovanni dice esplicitamente che "sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui" (v. 37). Col termine "segni" è facile qui pensare ai "miracoli"; tuttavia, anche senza scomodare la mitologia, è fuor di dubbio che tra i leader politici, a differenza delle masse, vi era una certa riluttanza ad appoggiare in maniera decisa e pubblica la sua piattaforma politica. Al v. 42 Giovanni afferma che, "tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga".
Cioè da un lato erano consapevoli della corruzione del governo in carica e del lato fortemente conservatore delle forze egemoni nell'ambito del Tempio e del Sinedrio; dall'altro temevano che senza un appoggio esplicito della forza sociale più significativa: quella farisaica, non si sarebbe potuta condurre a buon fine alcuna insurrezione.
Si ha addirittura l'impressione che sotto l'ambigua espressione: "Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo?" (v. 34), si celi una certa difficoltà a comprendere il significato della parola "democrazia", che pur in Asia Minore e in Grecia era conosciuta sin dal VII sec. a.C. È come se questi capi politici chiedano al Cristo un "segno" che attesti in maniera inequivoca che il messia è in grado d'imporre la propria autorità e quindi di garantire l'esito della rivoluzione. L'espressione "Cristo eterno", cioè capo invincibile, sembra contrapporsi all'esigenza di un "figlio dell'uomo elevato dal popolo in rivolta" (si badi che nei 100 passi in cui nell'A.T. viene usata l'espressione "figlio dell'uomo" il suo significato principale è sempre quello di "uomo", cioè di un essere dalle molte capacità ma anche dai molti limiti).
Insomma, da un lato la situazione sembrava davvero favorevole all'insurrezione, poiché il consenso delle masse, pur dominate dallo spontaneismo, era davvero grande; dall'altro però vi era una certa esitazione da parte dei leader politici, la cui coscienza rivoluzionaria appariva inadeguata al contesto. Probabilmente tutto il discorso teologico dei vv. 44-50 di Giovanni altro non voleva essere, in origine, che un caldo invito a non sprecare un'occasione grande come quella.
La conclusione comunque fu amara: "Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro" (Gv 12,36). L'incredulità dei Giudei dovette apparire a Giovanni un fenomeno così paradossale e crudele che solo considerandola come inevitabile, anzi necessaria, riuscì a esorcizzarla nella sua coscienza.
In realtà la scarsa determinazione e l'immaturità politica che portarono al fallimento della rivoluzione non furono una caratteristica solo delle masse popolari e dei loro capi politici, ma anche degli stessi apostoli, una parte dei quali, infatti, rappresentati da Giuda, volle andare oltre il "contenuto democratico" della "buona notizia".
(torna su)25) La morte come riscatto
Gv 12,20-50
I
Non può essere un peccato desiderare di morire. Si desidera vivere, ma solo finché ci sono le condizioni per farlo. Quando la sofferenza è troppo grande, si preferisce andarsene.
È il dolore che toglie la speranza. Ma forse, più che il dolore, che comunque oltre un certo limite non può essere sopportato, è la solitudine, la sensazione di non poter contare sull'aiuto di qualcuno nel momento della sofferenza più terribile. È la mancanza di sicurezza, di protezione, di assistenza che porta ad abbandonarsi, a preferire la soluzione estrema. Non riusciamo in queste condizioni di isolamento a sopportare una sofferenza troppo prolungata, neanche nel caso in cui non sia molto forte.
Una sofferenza molto forte può essere sopportata meglio se abbiamo la percezione che sarà breve. Anzi, se la percezione è una convinzione relativamente sicura, accettiamo la sofferenza, anche quella più acuta, come una prova da superare: ci mettiamo in gioco quasi volentieri. Contiamo sul fatto che con l'aiuto di qualcuno, prima o poi la prova verrà superata.
Se non possiamo contare su qualcuno, la nostra capacità di resistenza si riduce di molto; anzi, quanto più si è soli, tanto più facilmente ci si arrende. Si è addirittura portati a ingigantire i problemi: si perde l'obiettività delle cose. Si comincia a fantasticare in negativo. Questo perché noi non siamo fatti per vivere soli, siamo animali sociali, abbiamo bisogno di compagnia, di fare qualcosa con qualcuno. Abbiamo bisogno di fidarci di qualcuno e che qualcuno si fidi di noi, per farci sentire importanti, o almeno utili.
Noi non siamo come gli animali, abbiamo bisogno di motivazioni per vivere. Non riusciamo a vivere basandoci semplicemente sull'istinto, anche perché è proprio il nostro istinto di sopravvivenza che ci spinge a cercare qualcosa di emotivo o, se si preferisce, di spirituale. Dentro di noi alberga una fiamma che ha bisogno di energia per ardere e questa energia da soli non possiamo darcela. Sono gli altri la nostra energia. A volte lo sono così tanto che quasi ci convinciamo che ciò che noi in vita abbiamo fatto, non andrà perduto. Ci piace sognare che qualcuno proseguirà i nostri progetti esattamente come noi li abbiamo pensati e sviluppati. Ci illudiamo che, anche se siamo stati traditi in vita, non lo saremo dopo morti.
II
Questa premessa poetica è in relazione alla tristezza infinita nelle parole che a Gesù vengono fatte pronunciare nel capitolo 12 del vangelo di Giovanni. Proprio nel momento del trionfale ingresso a Gerusalemme, interpretato dalla popolazione come l'inizio della rivolta armata contro Roma, i manipolatori del vangelo di Giovanni, influenzati dalla tradizione sinottica, fanno dire a Gesù che l'ora della sua morte era vicina, rompendo, peraltro, in maniera brusca le espressioni con cui Gesù reagisce alle richieste dei Greci. Mistificano cioè con l'idea di "morte necessaria" la rivoluzione tradita, il fallimento dell'insurrezione nazionale.16
Ora, che cosa ci si può domandare di fronte a tale mistificazione? Non tanto se questo atteggiamento autodistruttivo di Gesù abbia una qualche parvenza di verità (poiché sappiamo che non ne ha), quanto piuttosto se l'atteggiamento dei redattori cristiani possa in qualche modo essere giustificato, possa considerarsi umanamente accettabile.
Qui infatti non si è soltanto in presenza di una mancata autocritica da parte della comunità post-pasquale, ma anche di un rivolgimento interpretativo dei fatti. L'insurrezione avrebbe potuto essere compiuta anche dopo la crocifissione di Gesù: non era forse stato lui a insegnare che il movimento nazareno andava gestito e guidato in maniera democratica? e che la rivolta armata non avrebbe dovuto avere come obiettivo il ripristino della monarchia davidica?
I suoi più stretti discepoli, in particolare Pietro (che, in questo, non è stato meno "traditore" di Giuda), invece di proseguire il mandato ricevuto, avevano cominciato a sostenere che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di vincere la dominazione romana senza la guida di un leader come Gesù, e che, siccome il suo corpo dalla tomba era sparito, era lecito pensare che sarebbe tornato, presto e in pompa magna. Non solo si tradì il suo messaggio, non solo si evitò di ammettere le proprie responsabilità, denunciando la propria pochezza rivoluzionaria, ma si prese a elaborare una ricostruzione dei fatti del tutto fantasiosa.
Nel vangelo di Marco si sostiene che la morte del messia era stata voluta da dio e che dio l'aveva risorto e che lui li avrebbe preceduti in Galilea. Per fare cosa non viene detto, ovviamente, in quanto le idee politiche di Pietro non avevano portato a nulla. Probabilmente Pietro, per un certo periodo di tempo, era rimasto in attesa di una parusia trionfale del Cristo redivivo (almeno così appare negli Atti), ritenendo che l'unica cosa da fare fosse quella di limitarsi a predicare ai Giudei l'idea di un "messia risorto". Era convinto, così facendo, che i Galilei avrebbero potuto continuare a giocare, agli occhi dei Giudei, un ruolo ancora significativo.
Ma i Giudei non credettero affatto alle sue parole, anzi, al sentire parlare di "resurrezione", decisero di incarcerarlo. Stando agli Atti, Pietro se ne andò definitivamente da Gerusalemme dopo essere stato fatto evadere dal carcere. Il che non esclude ch'egli abbia rifiutato, in seguito, la possibilità di tornare nella città santa, proprio perché la sua idea di una parusia trionfale del Cristo non aveva avuto alcun seguito e molti nazareni avevano cominciato ad abbandonare il movimento.
Poi subentrerà Paolo, che parlerà non solo di "Cristo risorto", ma anche di "unigenito figlio di dio". Anche lui, in un primo momento, una volta divenuto cristiano, era convinto che Pietro avesse ragione quando parlava di imminente parusia messianica, ma poi, vedendo che questa non si verificava, aveva deciso di procrastinarne il momento fatidico all'ultimo giorno della storia, facendola coincidere col giudizio universale. Tale inversione di rotta è molto evidente nelle sue lettere.
Le idee di Pietro e di Paolo divennero dominanti all'interno del movimento nazareno, che, quando ormai la sua definitiva spoliticizzazione era stata compiuta, assunse il nome di "cristiano". Ed è certo che quelle idee revisioniste furono osteggiate dalla corrente che faceva capo all'apostolo Giovanni, il quale scrisse un proprio vangelo per rimettere le cose a posto, dando una versione più obiettiva dei fatti, opposta a quella che aveva dato Pietro, attraverso il discepolo Marco, il cui vangelo aveva enormemente influenzato le versioni di Matteo e di Luca, nonché quelle di tanti altri vangeli che però non supereranno la prova della canonicità.
Ci vollero molti anni prima di poter togliere dalla circolazione l'originario vangelo di Giovanni e di riproporlo alla cristianità in una forma completamente riveduta e corretta. Ci vollero anche dei redattori molto capaci, conoscitori della mentalità ebraica, filosofi e teologi di professione, in grado di mistificare le cose con grande acume intellettuale. In questo vangelo infatti non si parla soltanto di "morte necessaria" ma anche di "morte gloriosa", cioè di realizzazione di sé proprio in virtù della croce.
Sembra una sfumatura di poco conto, ma non è così. Nei Sinottici Cristo avverte la morte come una decisione insondabile di dio, che lui accetta per obbedienza, perché dio è suo padre, perché sa che in questa maniera gli uomini potranno "riconciliarsi" col loro creatore, perché, vedendo lui "risorgere", capiranno che dio non li ha abbandonati nell'incapacità assoluta di compiere il bene a causa del peccato originale.
Dio-padre nei Sinottici ha voluto la morte del figlio per far capire agli uomini che nella loro incapacità di essere sono stati perdonati, che il peccato originale non li ha condannati a morte, alla disperazione, anche se la loro liberazione definitiva sarà possibile solo nell'aldilà. Il peccato originale li ha resi strutturalmente incapaci di bene, ma ora sanno che di questa impotenza non devono disperarsi, poiché hanno ricevuto una caparra spirituale per la salvezza futura, quella ultraterrena. Il sacrificio di Cristo ha offerto una grande consolazione morale.
Nel vangelo di Giovanni le cose sono più sottili, più complicate, proprio perché vi era l'esigenza di censurare qualcosa di più vero, di più profondo. Il Cristo non può limitarsi ad accettare la morte per dovere divino, per fare un piacere al padre, che ha avuto un lungo e travagliato rapporto col popolo ebraico, ma deve essere convinto che un certo modo di sacrificare la propria vita è una grandissima beatitudine, un vero motivo di orgoglio, che pochi possono capire, poiché qui la soddisfazione di sé rischia di apparire come una sublime follia, come una forma di disperazione mascherata da una finta indifferenza.
Per il Cristo dei manipolatori di Giovanni è la morte che permette la glorificazione di sé, l'autoesaltazione. "Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto" (v. 24). Più chiari di così i redattori non potevano essere.
Quello che parla è un Cristo disperato, che pensa di essere più utile morendo che vivendo. Infatti, se non muore resta solo, misconosciuto dai più; se invece muore di morte violenta, atroce, lui che era innocente, il mondo s'impressionerà e forse comincerà a credergli. Quello che non ha potuto fare in vita, lo farà da morto, attraverso un esempio di solenne accettazione del proprio destino.
"Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna" (v. 25). Non si può essere contenti di sé, vivendo, poiché il mondo è dominato dall'egoismo e non permette ai più alcuna felicità; quindi l'unica alternativa è quella cercare di uscire da questo mondo e di farlo il più presto possibile, nella maniera più giusta, che è quella di far ricadere sui poteri dominanti l'origine della propria frustrazione, della propria incapacità di vivere.
Il cristiano non si suicida, ma mette il potere in condizione di eliminarlo, facendolo diventare un martire, un testimone della verità, che è condizione privilegiata di chi vuol dimostrare la fondatezza delle proprie convinzioni. Un Cristo così non può avere seguaci, se non altri martiri come lui. Il sacrificio di sé è la testimonianza più radicale della fermezza con cui si crede nelle proprie idee. Il martirio cercato a tutti i costi sublima l'incapacità di compiere una rivoluzione dei rapporti esistenti.
Nell'insignificanza di una vita umanamente e politicamente sconfitta, il momento magico della morte, violentemente subita, riscatta di colpo ogni cosa: ci fa apparire del tutto diversi. Il Cristo di questi falsificatori della verità non si angoscia del destino che l'attende, anzi, se ne vanta, se ne gloria, perché è finalmente riuscito nel suo intento: mettere il nemico (qui il giudeo, in quanto la contrapposizione vuol porsi solo sul terreno religioso o di politica religiosa) nelle condizioni di eliminarlo, senza che lui abbia mai violato le leggi della democrazia.
"Ora l'animo mio è turbato; e che dirò? Padre, salvami da quest'ora?" (v. 27) – com'era appunto avvenuto nei Sinottici, dove vediamo un Cristo tremare, pregare, sudare sangue? No, qui è proprio il contrario: "è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre glorifica il tuo nome" (ib.). Il che, in altre parole, è come se avesse detto: "Mi sono incarnato, sono venuto tra gli uomini per insegnare loro che il momento più bello della vita è morire martiri, dare consapevolmente, liberamente la propria vita per un fine superiore, per un ideale che si chiama dio-padre".
La rivoluzione non si compie con le armi, ma trasformando in vittoria ciò che agli occhi del mondo sembra una sconfitta. "Ora avviene il giudizio di questo mondo [incapace di riconoscere chi l'ha creato]; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo" (v. 31).
Il mondo non appartiene agli esseri umani, ma al demone che ha introdotto il peccato (la nascita dello schiavismo) con l'inganno. Questo demone viene sconfitto dando agli uomini la consapevolezza, attraverso la resurrezione, che con la morte non è finito tutto e che se loro non hanno più la possibilità d'essere felici su questa terra, lo saranno certamente in un'altra dimensione, ove il demone non potrà far nulla.
A chi gli obietta che questa vittoria spirituale è in fondo una magra consolazione, poiché intanto sulla terra continua a trionfare il male, Gesù fa capire che non gli interessa il consenso di chi non crede. A chi non comprende il valore purificatorio, catartico della morte, il destino serberà di vivere nelle tenebre.
III
Ormai individuare la mistificazione, nei vangeli, è diventato relativamente facile. Il vero problema sta nel cercare di scoprire quale possibile discorso è stato censurato o manomesso. Qui p. es. c'è un versetto che ha tutta l'aria d'essere originale: il 42 ("ciononostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui; ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga").
Un versetto del tutto contraddittorio con la reazione che secondo i redattori la folla ebbe al sentire parlare di autoimmolazione da parte di Gesù. Dunque per quale motivo i redattori l'avrebbero lasciato? Sembrerebbe non avere alcun senso far vedere che tutta la folla non credeva in Gesù, quando alcuni capi politici sarebbero stati disposti a farlo, anche se temevano il giudizio dei farisei. Di regola era il contrario: i capi non credevano mai, salvo eccezioni, mentre tra la folla era relativamente facile trovare ampi consensi.
Probabilmente i redattori hanno lasciato questo versetto perché in esso vengono messi in cattiva luce i capi giudaici. Ma è da presumere che Giovanni in realtà volesse dire che mentre il discorso del Cristo trovò le folle giudaiche alquanto favorevoli, riscontrò invece una certa ostilità da parte delle autorità, ovviamente non solo da parte di quelle che gestivano il Tempio, poiché ciò sarebbe stato scontato, quanto piuttosto da parte di quelle che svolgevano apparentemente un ruolo progressista (p. es. i farisei), a motivo delle persecuzioni subite nei decenni precedenti. Giovanni dunque voleva dire che, nonostante un forte consenso popolare, i capi giudaici gli erano, nella loro maggioranza, ancora ostili.
La risposta che Gesù rivolge a quest'ultimi appare, nel capitolo, di tipo eminentemente religioso, quindi è da presumere ch'egli abbia lanciato un appello di tipo politico, il cui significato doveva in qualche modo essere favorevole all'insurrezione armata e non alla resa di fronte al nemico.
Se il Cristo avesse fatto un discorso di resa, facendo leva sulla popolarità acquisita, i Giudei avrebbero avuto dei buoni motivi per toglierselo di torno. Paradossalmente le autorità a lui favorevoli sarebbero state i collaborazionisti, mentre i farisei, al contrario, sarebbero apparsi come i rivoluzionari. Che senso avrebbe una lettura del genere? Nessun leader politico si sarebbe rivolto alle masse per invitarle ad affrontare la loro crisi nazionale e istituzionale dedicandosi esclusivamente alla fede in dio e al rispetto delle leggi.
L'ultimo discorso di Gesù, in questo capitolo, ha completamente sostituito un discorso andato perduto. Invitare i Giudei a rinnovare la propria religiosità, passando dalla fede in Jahvè alla fede nel figlio unigenito di Jahvè, è stata una scelta redazionale che difficilmente potrebbe trovare plausibili giustificazioni. Qui non vi è una sola parola che possa accampare un qualche riscontro storico.
(torna su)26) Misticismo e antisemitismo nel discorso sulla "luce del mondo"
Nel IV vangelo l'antisemitismo è tanto più forte quanto più viene usato come mezzo per mascherare i veri motivi che porteranno il tentativo insurrezionale del Cristo a finire tragicamente. Basta leggersi i vv. 35-50 del cap. 12 per convincersene, quelli dedicati al tema della "luce del mondo".
Sono passi di natura mistica che, anche per questa ragione, si prestano più facilmente ad essere svolti in chiave antisemitica. Essi sono serviti per sostituire, mistificandolo, il discorso politico che inevitabilmente il Cristo dovette pronunciare subito dopo l'ingresso trionfale a Gerusalemme. È difficile dire cosa di quel discorso originario sia rimasto in questi versetti: è però facile individuare gli elementi mistici e antisemitici. Presumibilmente invece sono veri i passi in cui vien detto che non vi era sufficiente consenso (almeno per quanto riguarda le autorità giudaiche) per compiere l'insurrezione, per cui il Cristo fu costretto a nascondersi nel Getsemani: infatti subito dopo vi è il racconto dell'ultima cena, cioè dell'ultima chance che il Cristo si diede per compiere la rivoluzione, ove l'apostolo Giuda avrebbe dovuto giocare un ruolo decisivo, in senso positivo, e che invece lo giocò in senso negativo.
Ora però si faccia attenzione a come viene adulterato il discorso politico di Gesù (che è poi, in realtà, la seconda parte del discorso, in quanto la prima è compresa nei vv. 23-34).
Quando inizia a parlare della "luce", cioè di se stesso e di chi, in quel momento così decisivo, avrebbe potuto diventare suo discepolo, sta in sostanza invitando la popolazione a non sprecare un'occasione favorevole a un'insurrezione armata contro la guarnigione acquartierata nella fortezza Antonia, che sovrastava il Tempio, tenendolo sotto controllo. Tutti sapevano che durante la festività pasquale affluiva nella capitale tantissima gente, per cui sarebbe stato relativamente facile aver ragione degli occupanti Romani (i soldati della X Legione Fretense), che nella fortezza non potevano superare le mille unità.17 Semmai il problema sarebbe venuto dopo: come affrontare l'inevitabile ritorsione dell'imperatore, che avrebbe inviato le sue legioni.
L'insurrezione non poteva certo rimanere circoscritta entro le mura della Città Santa. Peraltro, persino alcuni esponenti del mondo pagano ("Greci") avevano chiesto di parlare con lui, a testimonianza della sua crescente popolarità.
I vv. 35-36 sembrano non avere nulla di mistico, anche se il riferimento all'ideologia qumranica appare evidente. Gesù non fa altro che prospettare uno scontro, che in quel momento sembra essere decisivo, tra "luce" e "tenebre". Poi però vien detto che "si nascose da loro". Cioè i riferimenti alla luce sembrano essere conclusivi di quanto egli ha già detto nella prima parte del discorso. Si può quindi presumere che quel che viene dopo, dal v. 37 al v. 50, sia tutto inventato.
Invece non è così. Anche se in questi ultimi versetti il misticismo è notevolmente aumentato, e vengono persino introdotti elementi di antisemitismo, possono risultare sufficientemente attendibili alcune parti. P.es. il v. 42 non presenta aspetti inverosimili, anche se restano sicuramente controversi. In esso infatti viene detto che "molti, anche tra i capi, credettero in lui; ma, a causa dei farisei, non lo confessavano apertamente, per non essere espulsi dalla sinagoga". Che significato hanno queste parole? Alcuni capi, membri del Sinedrio, avevano più paura dei farisei che non dei sadducei e dei sommi sacerdoti? Avevano paura del partito meno collaborazionista tra quelli tradizionalisti? I politici (parlamentari) progressisti temevano il giudizio del partito farisaico, composto da attivisti sociali e culturali che lottavano a favore dell'identità ebraica in funzione anti-romana? Temevano di perdere consenso e quindi voti?
È strano questo modo di presentare i farisei come un blocco unico, monolitico, decisamente avverso a Gesù, quando proprio dai vangeli e anche dagli Atti degli apostoli sappiamo che alcuni esponenti di questo partito gli erano in qualche modo favorevoli: basta leggersi il dialogo con Nicodemo per capirlo, ma anche fare riferimento alla figura di Gamaliele negli Atti. Addirittura nel vangelo di Luca son proprio i farisei ad avvisare Gesù che Erode lo voleva uccidere. Lo stesso Paolo di Tarso, se avesse potuto vedere in azione il Cristo politico, sarebbe stato un suo fidato e zelante seguace, tant'è che quando cominciò a perseguitare i cristiani, li odiava proprio perché, parlando di un "messia morto e risorto", distoglievano la popolazione dall'obiettivo dell'insurrezione armata.
È quindi da presumere che, nonostante il v. 42 presenti aspetti verosimili, questa stretta identificazione dei farisei col nemico più irriducibile dei cristiani, superiore addirittura, per pericolosità, agli stessi sadducei e sommi sacerdoti, faccia parte di quell'antisemitismo riscontrabile in altri versetti. Ci si riferisce a quelli compresi dal n. 37 al n. 43. Se questi versetti venissero tolti, risulterebbe che il motivo per cui, in quel frangente, molti Giudei non seguirono Gesù resta piuttosto sfumato o poco definito, anche se, tutto sommato, abbastanza comprensibile, in considerazione del fatto che compiere un'insurrezione antiromana comportava rischi e pericoli non trascurabili. D'altra parte non si può neppure credere che il Cristo, nel momento in cui aveva decisivo di entrare pubblicamente nella capitale come una sorta di "liberatore", non avesse fatto un calcolo delle probabilità a lui favorevole. Tale ingresso era stato preparato accuratamente dagli stessi Giudei presenti in occasione del decesso di Lazzaro, in mezzo ai quali non poteva certo mancare una parte del partito farisaico.
Stando invece agli autori di questa pericope, i versetti 37-43 devono indurre il lettore a credere in una prospettiva ermeneutica completamente diversa. Indirettamente essi lasciano capire che l'insurrezione non poté essere fatta perché i Giudei, qua talis, erano considerati inaffidabili. Ovviamente il testo, avendo un'ideologia di tipo religioso, deve dirlo in maniera mistica, da usarsi per avvalorare l'antisemitismo, che infatti inizia subito, sin dal v. 37: "Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, non credevano in lui". Come se il fatto di compiere miracoli fosse un'attestazione sicura della credibilità etica e politica del soggetto che li compie! Al punto da ritenerlo idoneo a compiere l'insurrezione! Come se, al cospetto di significativi miracoli, il popolo ebraico fosse destinato (da dio) a non credere in Gesù! Come se il popolo ebraico avesse bisogno di "miracoli" per credere in qualche ideale politico o valore etico! Come se il Cristo avesse mai compiuto dei "miracoli"! Come se, pur accettando, in via del tutto ipotetica, che effettivamente abbia compiuto qualcosa di straordinario, egli se ne sia servito per dimostrare la propria divinità!
Per quale motivo il redattore ha introdotto, in maniera così maldestra, un'argomentazione così speciosa e assai poco sostenibile? La risposta è molto semplice: dio aveva impedito agli ebrei di "credere", cioè di "vedere" in maniera chiara e distinta. Ma come! Dapprima il Cristo vagheggia che chi lo seguirà, potrà diventare "figlio della luce", e poi il redattore dà per scontato, avvalendosi anche di una citazione del profeta Isaia, che non potevano assolutamente diventarlo, poiché dio li voleva punire con la pena della cecità, rendendoli duri di cuore, interiormente non disponibili a credere nelle parole del Cristo. Il popolo ebraico (e quello giudaico in particolare) era destinato a "non vedere" ciò che "guardava", e quindi a restare nelle "tenebre".
La motivazione di ciò la conosciamo da tempo, in quanto tutto il Nuovo Testamento ne è intriso: dio voleva fare in modo che il messaggio religioso del Cristo si universalizzasse il più possibile, mettendo tutti i popoli della Terra su uno stesso piano, cioè facendo perdere a quello di Israele il primato storico che aveva, dovuto al patto veterotestamentario.
Una tale ricostruzione dei fatti è – come ben si può vedere – non solo mistica ma anche antisemitica.
(torna su)27) Antecedenti dell'ultima cena
Gv 12,20-50
Non si può comprendere il significato dell'ultima cena né il motivo del tradimento di Giuda se non si precisano i momenti salienti che l'hanno preceduta.
Nel vangelo di Giovanni infatti il capitolo 13 non è solo strettamente connesso, sul piano cronologico, al racconto dell'ingresso messianico, ma è anche consequenziale, in modo tattico, all'atteggiamento che assunsero i leader dei partiti politici in occasione del suddetto ingresso.
Su tale atteggiamento i redattori dei vangeli hanno speso molte parole: quelle dei vv. 20-50 del cap. 12 (d'ora in avanti le citazioni dei versetti senza il capitolo fanno riferimento al cap. 12). Vediamo di darne un'interpretazione riassuntiva, rimandando, per i dettagli, a quanto già detto sul testo dell'ingresso messianico.
L'atteggiamento che ebbero i capi politici subito dopo l'ovazione trionfale (che la chiesa ribattezzerà col nome di "Domenica delle Palme"), fu, nel complesso, abbastanza deludente. Se si escludono quelli di origine greca (vv. 20-26), di cui però non sappiamo nulla e che forse sono stati inseriti nel testo con propositi antigiudaici, di tutti gli altri il vangelo di Giovanni dice esplicitamente che "non credevano in lui" (v. 37), o meglio: "non dichiaravano di credere in lui davanti ai farisei, per non essere espulsi dalle loro comunità" (v. 42).
Quindi la situazione politica presentava aspetti di preoccupante ambiguità. L'ingresso, pur essendo stato esaltante, non aveva sciolto il nodo più intricato, che era di ottenere il consenso da parte del partito politico più influente di allora, quello fariseo, che al tempo di Erode il Grande era stato quello più progressista.
Certamente il fatto che gran parte della popolazione fosse intenzionata a seguire il Cristo sulla strada dell'insurrezione armata stava a indicare che i tempi erano maturi per compiere un'operazione del genere. Gli autori dei vangeli, che pur hanno accuratamente evitato di descrivere le molteplici sommosse antiromane di quel periodo (a differenza di Giuseppe Flavio), sono stati costretti a ricordare che prima dell'ultimo ingresso messianico del Cristo nella capitale, il militante Barabba aveva già compiuto, con altri seguaci, un sanguinoso tumulto (Mc 15,7). Peraltro nel 66, cioè circa un trentennio dopo gli eventi della vita e morte del Cristo, allorché il partito zelota decise di occupare Gerusalemme, la guarnigione romana venne immediatamente sopraffatta. Praticamente fino al 70 fu possibile per gli ebrei compiere una serie di sommosse popolari con cui impensierire seriamente la dominazione romana. L'ultima resistenza fu quella di Masada, che si concluse con un suicidio di massa.
L'incertezza sul da farsi non sarebbe tuttavia potuta durare a lungo, proprio perché il Cristo, col suo movimento popolare, si era esposto senza riserve al momento dell'ingresso. Una decisione andava presa, prima che la prendessero i Romani e le forze giudaiche collaborazioniste. Le quali comunque con Caifa l'avevano già presa: "è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione" (Gv 11,50), disse ai farisei, incerti sul da farsi dopo il trionfale ingresso messianico a Gerusalemme.
Inutile precisare che la ricostruzione di questi antecedenti, da parte dei redattori cristiani, è stata condotta sulla base di motivazioni del tutto artificiose. A loro giudizio, infatti, la constatazione dell'incredulità dei capi giudaici appare funzionale all'inveramento della profezia di Isaia, secondo cui la morte di Gesù era prevista nel piano originario di dio (vv. 38-41); quindi, in un certo senso, per i Giudei i tempi non erano ancora maturi, poiché era dio stesso che impediva loro di credere (v. 39).
Qui, a parte le considerazioni che si possono fare circa il modo disinvolto che avevano questi redattori di vedere nel Cristo l'oggetto di riferimento di pensieri formulati secoli prima, appare piuttosto singolare il fatto che mentre nei vv. 27-36 si ha l'impressione che i redattori abbiano voluto rendere ambiguo un discorso che in quel frangente dovette essere piuttosto esplicito, nel senso che in luogo di "Romani" essi preferirono parlare di "demonio o principe di questo mondo" da "buttare fuori" (v. 31); in luogo di "elevazione alla gloria" preferirono equivocare sul termine "elevazione", lasciando credere che il Cristo in realtà si riferisse all'"innalzamento sulla croce" (v. 33) – viceversa, nei vv. 37-50 la falsificazione dei redattori diventa molto palese, come se si fosse presenti a un intervento redazionale successivo.
Infatti, è soprattutto in questa seconda parte della pericope che si dà per scontato che i Giudei "non potevano" credere alle parole del Cristo, esattamente come già il profeta Isaia (il quale ovviamente si riferiva a tutt'altra situazione) aveva previsto (vv. 38-41). Addirittura si ha la presunzione di sostenere che "Isaia disse queste cose perché già conosceva la gloria di Gesù. Era di lui che parlava" (v. 41). Insomma, sembra qui di avere a che fare con un intervento redazionale di tipo "clericale".
Tutto il racconto degli antecedenti si riduce a questa lapidaria tesi: il Cristo dichiarò di non voler compiere la rivoluzione perché non era questa la motivazione che aveva indotto dio-padre a inviarlo sulla terra. La sua missione consisteva semplicemente nell'informare l'umanità che il mondo non doveva più sentirsi "condannato" da dio a vivere una vita senza senso, e che tutte le sofferenze avrebbero trovato il loro riscatto nell'ultimo giorno, quello del "giudizio", che apriva le porte alla "vita eterna".
La chiesa cristiana, soprattutto a partire dalla svolta impressa da Paolo, comincerà a sostenere l'idea che l'ira di dio, causata dal "peccato d'origine", che aveva prodotto la "morte", era stata finalmente placata dall'autoimmolazione del Cristo. Questa era l'unica vera possibile liberazione che gli uomini potevano e dovevano attendersi. La seconda liberazione, quella definitiva, sarebbe avvenuta nell'ultimo giorno, quello del "giudizio" (v. 48). Chi crederà nell'identità d'intenti tra Gesù e dio, tra il padre e il figlio (vv. 44-45), avrà sin d'ora la consapevolezza escatologica che sarà salvato per la "vita eterna" (vv. 46 e 50). Così dicono i vangeli.
Come si può ben notare il Cristo da "politico" è stato qui trasformato in "filosofo", o meglio in "teologo", e ai suoi seguaci altro non viene chiesto che assumere un atteggiamento di serena e distaccata rassegnazione, in attesa della parusia. Una tesi del genere, tanto rigorosa quanto assurda, si basa su una cosa del tutto indimostrabile, e cioè che i Giudei non potevano credere nelle parole del Cristo proprio perché così "voleva dio". Questa tesi prende forse le mosse da una domanda cui non si riuscì a trovare una risposta abbastanza convincente per poter continuare il programma di Gesù esattamente come lui l'aveva impostato: "Perché la sua rivoluzione è fallita?".
Sarà quando gli apostoli vedranno la tomba vuota che avranno l'idea (da cui – come noto – nacque il cristianesimo), di trasformare quella domanda politica in una domanda di tipo religioso: "Se il Cristo era un dio, perché non è riuscito a trionfare sui suoi nemici?", ovvero "Se non vi è riuscito lui, che era dio, come potrà riuscirvi l'uomo?".
L'attesa passiva di una imminente parusia, che non ci fu, farà poi il resto. La versione definitiva della tesi sarà quella della "morte necessaria", perché un dio che avrebbe potuto trionfare sugli uomini e che invece si fa crocifiggere non può che indurre a credere come "necessaria" la propria morte.
Dunque – ecco la conclusione del sillogismo – se la sua morte era necessaria, i Giudei erano in un certo senso "costretti" a non credere. Il fatto che non abbiano creduto non va quindi imputato a loro più di quanto non vada imputato a dio, che voleva il sacrificio del figlio. Sacrificio che, perché non sia reso vano dal rischio di un "divino fatalismo", impone che si debba comunque credere nell'unità d'intenti tra padre e figlio.
Sarebbe infatti mostruoso sostenere che il Cristo doveva morire per adempiere alla volontà del padre. Il sacrificio della croce fu una scelta consensuale, ritenuta la migliore ai fini della salvezza dell'umanità. Così recita la chiesa da duemila anni. I Giudei e, in sostanza, tutte le persone incredule, hanno tempo di ravvedersi sino al giorno del giudizio. Non vengono condannati per aver condannato il Cristo. È la sua parola che li giudicherà nell'ultimo giorno.
I redattori cristiani erano riusciti in sostanza a trasformare la morte del Cristo in una "vittoria religiosa", come occasione di riscatto dal fallimento della rivoluzione. La vittoria è consistita proprio nel fatto che il Cristo aveva accettato volontariamente il sacrificio, pur potendolo rifiutare, sia perché innocente come uomo, sia perché potente come dio. "Che devo fare? – gli fanno dire i redattori. Dire al padre: fammi evitare questa prova? Ma è proprio per quest'ora che sono venuto" (v. 27).
Nell'ambito del processo di falsificazione operato nel vangelo di Giovanni, la lotta per la giustizia e per la liberazione nazionale è stata praticamente sostituita con la testimonianza della verità fino al martirio. Il martirio è stato cioè considerato non come una sconfitta politica, ma come una vittoria filosofica, anzi teologica. La grandezza del Cristo non sta tanto nell'aver accettato la morte con dignità, restando coerente ai propri ideali di giustizia e libertà, ma sta piuttosto nell'aver fatto del sacrificio di sé un modo per dire che la liberazione nazionale non solo non era possibile ma neppure necessaria. Ai fini della salvezza personale, che è sostanzialmente religiosa, la politica è irrilevante. "Noi non combattiamo contro le forze della terra, la carne e il sangue, ma contro le potenze dell'aria" – dirà Paolo in Ef 6,12.
È dunque evidente che un Cristo disarmato, che concentra tutto il valore della sua vita nell'accettare volontariamente una cosa necessaria: il martirio, non solo non sarebbe potuto morire in battaglia, ma non sarebbe potuto morire neppure di vecchiaia. Qui infatti la verità di sé diventa qualcosa di strettamente vincolato all'idea di martirio, il quale ha la potenza – nell'immaginazione dei redattori – di rendere vera una posizione che sul piano umano qualcuno potrebbe anche ritenere discutibile.
L'uomo di fede, per il cristianesimo apostolico, è dunque colui che si lascia uccidere per difendere l'ideale in cui crede (cfr Ap 12,11). Non è l'uomo che difende l'ideale con la forza delle armi: i nemici infatti vanno "amati" (Mt 5,44) e i persecutori "benedetti" (Rm 12,14), ma è l'uomo che difende l'ideale solo con la forza della verità di quell’ideale. È l'uomo che non può non dire la verità, poiché l'unica missione che può e deve compiere è appunto quella di testimoniare la verità, sempre e comunque. Ogni reazione che possa impedirgli di svolgere questa missione, viene considerata come una prova ulteriore della giustezza del suo ideale e del modo in cui la verità viene testimoniata.
L'uomo di fede sa a priori che la testimonianza della verità con molta difficoltà può essere accettata dai potentati economici e politici, per cui egli è costretto a dare per scontato che la liberazione dalle ingiustizie non sia possibile su questa terra, ma solo nei cieli; egli quindi mette in preventivo l'eventualità del martirio, poiché gli uomini non amano ascoltare ciò che smaschera le loro incoerenze. L'uomo di fede fa del martirio il privilegio più grande che possa ottenere, per dimostrare con sicurezza la verità del proprio operato. "Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno" – dirà Paolo (Fil 1,21).
Dunque tutta la pericope degli antecedenti si basa su una tesi assolutamente indimostrabile, e cioè che una posizione sia tanto più vera quanto più è soggetta a persecuzione. Tesi, questa, che in realtà può anche appartenere a una concezione di vita di tipo irrazionalistico, sia essa religiosa, filosofica o politica. Fare della morte il senso della propria vita può anche essere la conseguenza di una rappresentazione disperata della vita stessa. E, in tal senso, può risultare relativamente normale che l'attribuzione di un particolare valore salvifico alla morte possa essere una conseguenza dell'incapacità di attribuire una valore altrettanto grande alla vita. I cristiani, in sostanza, hanno fatto indebitamente di un aspetto particolare della vita del Cristo, e cioè la sua morte, reinterpretata come "resurrezione", il nodo cruciale verso cui far convergere tutte le loro frustrazioni politiche.
Su questo però bisogna precisare che nel Nuovo Testamento vari autori hanno a più riprese ribadito che parte essenziale della dottrina cristiana è anzitutto e soprattutto l'obbedienza alle autorità, se cittadini liberi, o ai padroni, se schiavi (Rm 13,1; Ef 6,5; 1 Tim 6,1; Tit 2,9; 3,1...). Solo se, nonostante questa obbedienza, si viene ugualmente osteggiati nella professione della propria fede, allora la disponibilità al martirio diventa necessaria. Il cristiano non può tacere per timore delle persecuzioni, anche se questo coraggio non può autorizzarlo a provocare artificiosamente (artatamente) situazioni in cui il conflitto diventa inevitabile. Non tutti i compromessi sono uguali, e se vengono salvati i fondamenti della fede, si può anche transigere su aspetti di minore importanza. Se si salvaguarda la purezza dei principi, non è certo disonorevole usare la diplomazia al fine di evitare spargimenti di sangue.
Da ultimo si può dire che il fatto che qui il vangelo di Giovanni prescinda totalmente dai riferimenti all'istituzione dell'eucarestia (in aperto contrasto con l'impostazione sinottica) è indicativo della potenza del suo messaggio. In un certo senso la teoria della morte necessaria e dell'identificazione di verità e martirio va oltre qualunque struttura sociale o sacramentale che le faccia da supporto. Essa presume d'imporsi come teoria universale, a disposizione di chiunque voglia riconoscere nel sacrificio del Cristo il significato ultimo della vita e della storia degli uomini.
(torna su)28) Lavanda dei piedi
Gv 13,1-20
I
Nel racconto giovanneo della cosiddetta "lavanda dei piedi" vi sono aspetti umani mistificati da un aspetto religioso fondamentale: il fatto che Cristo "doveva morire". La tesi della sua "morte necessaria" fa da cornice ai due contenuti umanistici che in qualche maniera si possono individuare nella pericope: l'uguaglianza degli apostoli, cioè la necessità di non creare gerarchie tra loro, come invece accadeva tra i potentati contro cui stavano lottando; lo spirito della democrazia, che avrebbe sempre dovuto caratterizzare i loro rapporti interni, anche nelle situazioni più drammatiche, quali p. es. le defezioni o, peggio, i tradimenti.
Nel corso dell'ultima cena gli apostoli assistettero a una grande lezione di civiltà, il cui significato era squisitamente umano, ammesso e non concesso che l'episodio della lavanda sia un fatto reale e non una costruzione simbolico-redazionale. Forse è questo il motivo per cui nel vangelo di Giovanni – la cui falsificazione, rispetto ai Sinottici, è sicuramente di livello più elevato – si è cercato di circoscrivere i due suddetti grandi valori umani e politici non solo all'interno della tesi della "morte necessaria" che, come tale, è originaria proprio dei Sinottici, ma anche all'interno di una sorta di comandamento filosofico relativo all'amore universale, in virtù del quale i Dodici avrebbero dovuto rinunciare, definitivamente, a qualunque istanza politico-rivoluzionaria.
Il modello di amore universale che si è voluto far passare e che è specifico del quarto vangelo, è quello che caratterizza un Gesù "uomo" che, pur essendo "dio", ha preferito la croce alla gloria, il martirio al potere, rinunciando a creare con la forza un regno di pace e di giustizia sulla terra, che col dialogo, la persuasione, l'intesa non si era potuto creare. Quest'uomo che, secondo i vangeli era un "dio", avrebbe saputo fare della propria morte un'occasione di vita, e della propria tragedia un motivo di fede per tutti gli uomini, per una vita migliore non su questa terra ma nei cieli.18
L'uomo di fede è colui che crede di poter essere un giorno ricompensato per essere stato capace di sopportare degnamente le sofferenze della vita terrena. È colui che, convinto che la morte violenta dell'uomo-dio abbia posto un'ipoteca decisiva sulla possibilità di realizzare una giustizia su questa terra, trasferisce ogni suo desiderio umano d'emancipazione e di liberazione nell'aldilà. È questa una filosofia di vita molto vicina a quella degli stoici, con la differenza che il cristianesimo ha costruito tale rassegnazione mistificando un avvenimento politico-rivoluzionario e quindi mirando a far credere che il suo messaggio serviva in qualche modo per mutare l'esistente.
È singolare, in tal senso, che la storiografia cattolico-borghese insista nel dire che il cristianesimo nulla deve all'antichità. Il fatto che lo stoicismo greco-romano abbia osteggiato il cristianesimo al fine di difendere le tradizioni pagane non significa, di per sé, ch'esso non abbia potuto influenzarlo. Gli ebrei fuggirono con ribrezzo dalle civiltà schiavistiche della Mesopotamia e del Nilo, ma questo non ha impedito loro di ereditare molte concezioni di vita adattandole alle loro esigenze.
In particolare lo stoicismo greco, che con Seneca entrò nella fase romana, influenzò così tanto il cristianesimo che si arrivò persino a immaginare l'esistenza di un carteggio tra lo stesso Seneca e l'apostolo Paolo. Concetti come monoteismo, logos, provvidenza, cosmopolitismo, immortalità dell'anima, vita eterna, regno di dio dentro l'uomo, amore reciproco, uguaglianza degli uomini sono già presenti nelle opere di Seneca, il quale, a differenza di Paolo, non parlò invece mai di giudizio universale, di peccato originale, di coscienza del peccato, di satana ecc.
Per il mondo greco-romano il peccato non era la forma principale dell'incapacità di essere, ma una sorta di limitazione temporanea dovuta a ignoranza o irragionevolezza o inettitudine. Nei propri rapporti con l'assoluto lo stoico greco-romano non si sentiva mai completamente abbandonato nelle mani di un dio onnipotente; anzi, nelle opere di Seneca il giusto viene invitato a sentirsi come dio, a lottare eroicamente per riuscire a conquistare quelle virtù che in dio sono immanenti.
Lo stoicismo greco-romano era una forma di rassegnazione aristocratica, che caratterizzava i ceti più elevati e, più in generale, era il modo di pensare di chi non si preoccupava di tradurre in pratica, a livello sociale o politico, i propri princìpi di vita. Sotto questo aspetto, lo stoicismo è sempre rimasto una filosofia di vita individualistica, sostanzialmente ligia al potere costituito, tant'è che non ha mai negato risolutamente all'imperatore la pretesa di ritenersi pari a un dio, né ha mai avuto l'ardire di porsi come una cultura popolare, anche se ebbe il merito di svincolare del tutto la fede nel monoteismo dalle rappresentazioni simboliche e cultuali.
I.1)
Con la descrizione dell'ultima cena Giovanni (o chi per lui) compie un duplice tentativo:
– trasforma l'esigenza, da Cristo manifestata e dagli apostoli condivisa, di un regno di liberazione (politica e umana) dal dominio romano, in un moralismo ad altissimo livello, introducendo il concetto etico dell'"amore reciproco universale", che può anche portare al proprio martirio;
– subordina a questo moralismo e quindi al concetto di "amore reciproco" l'istituzione stessa dell'eucarestia, che invece nei Sinottici ha un ruolo centrale, ancorché simbolico, all’interno del tema teologico del sacrificio.
Fatto fondamentale di questa cena sarebbe stato – al dire di Giovanni – non l'istituzione dell'eucarestia (con cui praticamente i Sinottici fanno nascere la chiesa), ma la lavanda dei piedi, con cui Cristo ha voluto insegnare fino a che punto può arrivare l'"amore fraterno". Ovviamente qui bisogna precisare che questo gesto – nella pericope giovannea – costituisce soltanto una forma di anticipazione o di prova generale di ciò che il Cristo sarebbe stato capace di fare di lì a poco, con l'accettazione del tradimento e del supplizio della croce.
Non è da escludere che i fatti siano andati come Giovanni li ha descritti. In effetti non sarebbe in contraddizione con l'immagine di un Cristo politico l'idea che questi abbia voluto mostrare ai suoi seguaci che se in tutto quello che facevano fossero venute meno le esigenze dell'etica, essi avrebbero rischiato di compromettere le finalità del loro impegno politico. Perché scandalizzarsi se nel momento più critico del movimento nazareno, il suo leader riconosciuto ha voluto lasciare ai discepoli più stretti e più fidati un'indicazione operativa che avrebbe dovuto essere considerata valida a prescindere dalla realizzazione o meno dell'obiettivo insurrezionale? Va ritenuto forse poco dignitoso per un leader politico insegnare ai propri seguaci la necessità dell'"amore reciproco"?
Il problema semmai è un altro: Giovanni introduce il concetto di "amore reciproco" in chiave moralistica, poiché lo priva di qualsiasi prospettiva politico-rivoluzionaria. Nel suo vangelo (come d'altra parte in quello di Paolo) l'amore in generale (fraterno, reciproco o addirittura universale) è fine a se stesso, poiché influisce solo indirettamente sui processi sociali, esterni alle relazioni "io-tu", "noi-voi". È un amore tra soggetti che già si amano e che si trasforma in rassegnazione-sopportazione-pietà quando l'amore viene vissuto all'interno di rapporti sociali conflittuali, antagonistici.
Gli apostoli avrebbero ricevuto il compito di amarsi in un mondo che li odia, sul modello del Cristo che li ha amati "sino alla fine" (Gv 13,1). Secondo l'ideologia politica del manipolatore di Giovanni ("politica" in quanto una qualunque "filosofia" ha sempre dei risvolti politici), compito dell'apostolo non è quello di lottare nella società per affermare i principi dell'amore (una lotta ovviamente compatibile coi contenuti che professa), ma quello di resistere alle tentazioni del mondo, cioè quello d'impedire che il male del mondo condizioni la sua esperienza d'amore.
Sembrano sfumature, ma alla fine le conseguenze sono molto diverse. È evidente infatti che entrambe le figure di "apostolo", quella proposta dal Cristo e quella proposta dal Giovanni interpolato, si basano sull'esempio della condotta personale, nonché sulla libertà che gli uomini hanno di accettare o rifiutare l'esperienza dell'amore. Ma la figura dell'apostolo, delineata nel IV vangelo è quella di un uomo persuaso che se il mondo ha rifiutato il grande esempio del Cristo, difficilmente potrà accettare quello di un altro leader politico, per cui il pessimismo diventa inevitabile, nella convinzione che l'uomo sia più incline al male che al bene.
Perché diciamo che questo moralismo è di altissimo livello? Appunto perché il modello cui fa riferimento è quello del Cristo che accetta volontariamente di morire. Amore e morte, nel vangelo di Giovanni, procedono sempre di pari passo e si valorizzano a vicenda, ma in ultima istanza è la morte che dà significato all'amore. La convivenza raggiunge l'apice dell'amore nel momento stesso del martirio, proprio perché all'amore è stata negata la prospettiva rivoluzionaria, che è quella del cambiamento dell'esistente. Il vertice dell'amore viene raggiunto nel momento stesso in cui il Cristo sceglie spontaneamente di dare la propria vita per la salvezza dei propri discepoli e di tutti quanti lo vorranno diventare: "Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici" (Gv 15,13).
Gesù cioè, nella teologia esistenziale e spiritualistica di questo Giovanni manomesso, avrebbe accettato di morire per dimostrare fino a che punto era grande il suo amore per gli apostoli e, tramite loro, nei confronti di tutto il mondo. Una tesi questa che sul piano squisitamente etico sarebbe inattaccabile se con essa non si volesse, implicitamente, negare il suo rovescio, cioè quella per cui Gesù, se tutte le condizioni o circostanze, soggettive e oggettive, fossero state favorevoli, avrebbe potuto dimostrare ugualmente il suo grandissimo amore per gli apostoli (e per la sua patria) non in negativo, accettando di morire in croce, ma in positivo, compiendo la rivoluzione contro il dominio straniero e il collaborazionismo interno. Non si può giustificare il fallimento della rivoluzione mostrando che la morte del messia era necessaria ai fini della comprensione della legge dell'amore, poiché in questa maniera si finisce col falsificare lo svolgimento dei fatti.
L'autore del vangelo di Giovanni in sostanza fa questo ragionamento: con l'accettazione del tradimento nel Cenacolo, della cattura nel Getsemani e della croce sul Golgota, Gesù ha voluto fa capire che, in ultima istanza, più importante della liberazione d'Israele è l'amore universale, e che nessuno ha amore più grande di chi sacrifica la propria vita per gli altri. In fondo cosa resta agli uomini se i loro ideali politici falliscono? Resta appunto l'amore. Insomma il redattore del IV vangelo chiede al suo lettore di vivere l'amore, rinunciando a realizzare gli ideali politici in cui crede, soprattutto se questi si scontrano con la logica dell'amore, che è quella del sacrificio, sino alla morte, se necessario.
In tutto questo ragionamento sono due le domande cui forse si sarebbero dovute dare altre risposte:
– davvero Gesù, prima del tradimento, riteneva indispensabile la propria morte al fine di dimostrare quant'era grande il suo amore per gli uomini?
– Si può davvero affermare che se il Cristo avesse politicamente vinto, non avrebbe potuto dimostrare ugualmente, con la stessa forza e intensità, il proprio amore per gli uomini? Per quale motivo il suo vangelo per i poveri si sarebbe dovuto trasformare, a rivoluzione avvenuta, in un vangelo per i ricchi?
Grazie alla morte di Gesù – sembra dire Giovanni – gli apostoli hanno potuto comprendere sino in fondo il vero contenuto del messaggio dell'amore, che, mentre lui era in vita, avevano evidentemente compreso solo in parte. Togliendo all'amore predicato da Cristo qualunque carica e tensione politica, che è la capacità di trasformare, anche con la lotta violenta, se necessario, le istituzioni sociali e pubbliche, Giovanni ha ipostatizzato il concetto di amore all'interno di due coppie di valori metafisici: Padre e Figlio da un lato (nel loro rapporto reciproco e verso il mondo, come da Gv 3,16.35; 10,17...) e Padre e Discepoli dall'altro.19
I.2)
Poiché nel racconto giovanneo relativo all'ultima cena non si fa cenno alcuno (diversamente che nei Sinottici, dove anzi risulta centrale), all'istituzione dell'eucarestia, il lettore non può fare a meno di porsi alcune domande: Giovanni, l'ultimo degli apostoli a scrivere di Gesù, non ha parlato dell'eucarestia perché lo si era già fatto a sufficienza nei Sinottici? oppure egli ne parla usando formule espressive differenti? se sì, il loro contenuto era davvero così particolare da necessitare una trattazione del tutto indipendente da quella sinottica? oppure Giovanni non parla dell'eucarestia perché in realtà Gesù non l'ha mai istituita?
Se mettiamo a confronto il capitolo 13 del suo vangelo con quelli successivi, dal 14 al 17, ci si accorgerà di una sproporzione assolutamente incredibile tra fatti narrati e commenti redazionali: qui è evidente la mano autorevole di una comunità post-giovannea. Praticamente il solo capitolo, tra quelli appena citati, a contenere dei fatti è il 13, che ne riporta tre: la lavanda dei piedi (in cui Gesù discute con Pietro), il dialogo tra Gesù e gli apostoli su un possibile tradimento e sulle sue conseguenze, infine il dialogo tra Gesù e Pietro su un possibile rinnegamento da parte di quest'ultimo.
Da nessuna parte Giovanni parla di "cena pasquale" o di "eucaristia". Peraltro è noto che Giovanni, affrontando l'argomento canonico dell'ultima cena, non usa lo stesso calendario dei Sinottici, per i quali quella cena doveva per forza essere "pasquale", in quanto secondo loro Gesù morì non il 14 ma il 15 Nisan.
Da tempo l'esegesi protestante è giunta alla conclusione che nel vangelo di Giovanni l'istituzione dell'eucarestia non viene riportata perché non rende sufficientemente l'idea del valore salvifico e della portata universale del tema predicato da Cristo nei capitoli successivi al 13, che è quello ove viene descritto il famoso "comandamento dell'amore".
Questa è ovviamente una tesi che andremo a discutere, ma bisogna dire subito che è anche una tesi la cui falsità sta negli stessi presupposti, in quanto l'ideologia filosofico-religiosa dell'amore universale non è stata utilizzata nel vangelo di Giovanni per integrare o addirittura superare i limiti di quella teologico-ecclesiastica dei Sinottici, volta a codificare il sacramento più importante della comunità post-pasquale, ma è stata utilizzata per negare qualunque valore all'istanza politico-rivoluzionaria che animò il movimento nazareno. Sono dunque questi gli aspetti che qui bisogna esaminare.
Hanno ragione quegli esegeti di tendenza meno confessionale a sostenere che in Giovanni non si parla del memoriale del sacrificio di Cristo semplicemente perché la celebrazione di un rito, sacro quanto si voglia, non può mai sostituire l'esigenza dell'amore, personalmente vissuto. L'espressione "fate questo in memoria di me" non può essere simbolizzata in un sacramento, altrimenti se ne conserverebbe la memoria solo a livello rituale-formale. Non è ripetendo, in modo incruento, il sacrificio di Gesù che il cristiano, secondo Giovanni, può veramente credere d'imitare il "verbo incarnato". Se si può amare solo amando, si può imitare il modello solo imitandolo veramente.
Gesù dunque, come persona, non poteva istituire – stando a Giovanni – alcun sacramento: né il battesimo, né l'eucaristia, né alcun altro rito. I sacramenti rappresentano, nel migliore dei casi, una mera rappresentazione scenica del dramma dell'amore e del sacrificio, nel peggiore dei casi una sorta di burocratizzazione della fede. Gesù si considerava un laico, non un sacerdote e, come non avrebbe tollerato l'uso simbolico della fede nel suo vangelo attraverso i sacramenti, così ha sempre rifiutato l'uso di pratiche magiche, superstiziose, esoteriche per diffondere l'idea dell'amore universale.
Giovanni su questo è abbastanza netto. Si può anzi qui aggiungere che là dove nei vangeli si parla di guarigioni, si è in presenza o di eventi umani di tipo psico-somatico, oppure di mistificazioni redazionali che deformano o censurano avvenimenti di tipo politico, molto scomodi all'idea propagandata dalla Chiesa petrina e paolina di un Cristo redentore universale e non liberatore nazionale.
In effetti gli attuali sette sacramenti della Chiesa cattolica e ortodossa possono al massimo essere apprezzati come uno strumento simbolico-evocativo volto a richiamare l'attenzione sull'esigenza dell'amore e del sacrificio di sé, ma essi restano sempre il frutto del fallimento e non della riuscita della rivoluzione. Se nel mondo l'amore fosse concretamente presente, il loro valore sarebbe nullo, e non è certo dalla loro efficacia che si potrà realizzare l'amore. L'amore può essere generato solo da se stesso, può essere garantito solo se c'è e dal fatto stesso di esistere e di riprodursi.
Tutti i sacramenti sono nati come giustificazione al fallimento della realizzazione dell'amore: ancora oggi la Chiesa, nei suoi livelli gerarchici, illude i semplici credenti che per poter imitare il modello dell'amore, per poter rivivere lo stesso rapporto d'amore e di sacrificio vissuto da Gesù, sia appunto sufficiente partecipare a questi riti. Riti che in realtà scompariranno proprio quando l'amore trionferà, non perché essi avranno adempiuto al loro compito, ma, al contrario, perché ci si accorgerà che non da essi si sarà ottenuta quella realizzazione.
Peraltro l'istituzione dell'eucaristia è un'assurdità anche per la seguente ragione cronologica: Gesù non poteva dare per scontata l'intenzione che Giuda aveva di tradirlo. Nei Sinottici Gesù parla e agisce come se il tradimento di Giuda si fosse già attuato ed avesse avuto, per questo, delle precise conseguenze nei suoi confronti. Questo perché l'idea dominante è quella della "morte necessaria del figlio di dio".
Rispetto dunque all'ideologia ecclesiastica dei Sinottici, Giovanni ha pienamente ragione. Tuttavia riguardo all'esigenza di liberazione nazionale, espressa dal Cristo, egli ha completamente torto. Ritenendo infatti che l'amore possa essere vissuto pienamente in qualunque situazione storico-politica, quindi anche in una di oppressione, sfruttamento e ineguaglianza, la posizione giovannea (o meglio pseudo-giovannea), col racconto della lavanda dei piedi, non può escludere in via di principio l'uso dei sacramenti: può soltanto limitarsi a subordinarli alla necessità di vivere l'amore concretamente.
La differenza tra l'eucaristia e la lavanda dei piedi non sta sul piano politico, poiché entrambe vengono interpretate in maniera regressiva, ma semplicemente su quello umano, nel senso che, pur togliendo alla lavanda dei piedi qualsiasi riferimento esplicito a quella che doveva essere una sollevazione popolare in piena regola, Giovanni riesce ugualmente a darle una connotazione etica più significativa di quella religiosa che i Sinottici diedero all'eucarestia. Il livello umano-realistico di un gesto umilissimo supera la forma simbolico-evocativa del sacramento liturgico.
D'altra parte i Sinottici, pur giustificando, come il Giovanni manipolato, il fallimento della rivoluzione politica presentando Gesù in veste di redentore morale, preferiscono racchiudere l'esperienza della redenzione entro il perimetro istituzionale della Chiesa, che si apre al mondo rinunciando alla Palestina indipendente. L'universalismo di Giovanni invece non ha bisogno di un apposito organismo che tuteli il principio dell'amore: l'amore si tutela da sé. Qui si è in presenza di un maggiore spiritualismo, che nella storia della chiesa troverà ampi sviluppi nelle esperienze di tipo monastico.
È sul rapporto tra umano e politico che si giocano le maggiori differenze tra Giovanni e i Sinottici. Là dove la Chiesa (strutturata sul modello delle comunità paoline) si pone come istituzione alternativa al regno davidico, in cui l'accettazione di determinati aspetti dogmatici nonché rituali-devozionali è dirimente per l'identità cristiana, Giovanni fa invece valere le esigenze spiritualistiche dell'amore reciproco, in cui il politico è tutto inglobato in una forma di umanità da viversi in maniera monastico-escatologica, come se la fine dei tempi fosse sempre imminente.
Sono entrambe forme di falsificazione del messaggio evangelico cristico, proprio in quanto, pur non avendo il politico realizzato gli obiettivi che l'umano s'era prefisso (la liberazione della Palestina dai Romani), si ha la pretesa che l'umano possa affermare pienamente se stesso, o comunque restare salvaguardato come tale, in un mondo determinato dall'antagonismo sociale. La politica, nell'ideologia cristiana, si estingue non dopo ma prima ch'essa sopprima le contraddizioni che impediscono all'umano di esprimersi adeguatamente. Conseguenza inevitabile di ciò è che il cristianesimo diventa esso stesso "dominante", finendo sempre col giustificare i poteri costituiti che impediscono all'umano di essere quel che è.
E forse la falsificazione di più difficile individuazione non è quella sinottica bensì quella giovannea. Proprio nel racconto della lavanda dei piedi, infatti, il significato simbolico originario del gesto servile non doveva essere semplicemente quello di affermare l'amore interpersonale, l'uguaglianza degli apostoli all'interno del collegio, il valore della democrazia in generale, ma anche e soprattutto quello di far capire che senza un appoggio consapevole, organizzato, delle masse popolari l'esigenza di un potere politico per la liberazione del paese si sarebbe facilmente trasformata in un arbitrio. I gesti, le parole acquistano significati assai diversi se mutano i contesti semantici in cui vengono collocati.
Al momento dell'ingresso messianico Gesù avrebbe anche potuto prendere il potere con la forza del dittatore politico-militare, ma con la lavanda dei piedi in sostanza faceva capire che senza una partecipazione democratica delle masse all'edificazione della nuova società (e qui le responsabilità cadono sui leader che allora dirigevano i diversi movimenti politici), la conquista del potere (pacifica o violenta sarebbero state le circostanze a deciderlo) non avrebbe potuto garantire la realizzazione degli obiettivi che il movimento nazareno s'era prefisso, specie di fronte alla inevitabile controffensiva dell'imperialismo romano.
Da questo punto di vista un leader come Gesù non poteva ritenere indispensabile la propria morte – come invece vuole il testo giovanneo – per dimostrare quanto era grande il suo amore nei confronti degli uomini. Se ad un certo punto l'ha ritenuta inevitabile, in quanto non vi era altro da fare, ciò non può essere interpretato nel senso che, dovendo accettare la soluzione più tragica, Gesù voleva porre una seria ipoteca sulla credibilità della scelta rivoluzionaria.
Il significato dell'espressione: "Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri" (v. 14), non stava semplicemente nell'uguaglianza morale e intersoggettiva, quanto piuttosto nell'esigenza di continuare il suo messaggio di liberazione, qualunque cosa gli fosse accaduta, proprio perché più importante di lui era il suo vangelo: un vangelo dell'amore, se vogliamo, ma per la liberazione integrale dell'uomo, da ogni schiavitù morale e materiale.
L'espressione di Gesù: "Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi" (v. 15), andava appunto interpretata in questo senso, ed è probabile che qualcuno, non riportato nei testi canonici della chiesa, abbia anche cercato di farlo (Giacomo Zebedeo, p. es., morì martire nel 44 d.C.).
Nella pericope in oggetto Gesù mostra un relativo ottimismo a proposito della capacità che gli apostoli dovevano avere nel tenere uniti gli aspetti umani a quelli politici. Stando al dialogo tra lui e Pietro, quasi tutti gli apostoli erano pronti per continuare fedelmente il messaggio evangelico nell'imminenza dell'insurrezione armata (che fosse "armata" persino Luca lo dice esplicitamente: "Chi non ha una spada venda il suo mantello e se ne procuri una", 22,36): si trattava soltanto di capire che le questioni umane non potevano mai restare subordinate a quelle politiche, neppure nel caso in cui il leader dei Dodici fosse perito sotto i colpi del nemico.
Pietro però era uno di quelli che voleva un messia politicamente vincente a tutti i costi, sicché, di fronte al gesto umilissimo di lavargli i piedi, si scandalizza e protesta. Il dialogo tra lui e Gesù può forse essere riscritto nei termini seguenti:
– Perché ti abbassi a questi livelli? Non è dignitoso, meno che mai per un leader politico che sta per diventare re d'Israele.
– Sì, mi rendo conto che un gesto del genere può essere frainteso, ma non ti preoccupare: lo capirai strada facendo. L'importante è che tu continui ad aver fiducia in me.
– Tutto ciò è pazzesco. Noi abbiamo avuto fiducia in te come messia, per realizzare la liberazione nazionale. Perché t'abbassi a svolgere le mansioni d'un servo? È inaccettabile!
– Se non accetti questo gesto, temo che dovrò chiederti di andartene, perché ho bisogno di sapere, in questo momento cruciale per la storia del nostro movimento e per i destini del paese, su chi posso contare con relativa sicurezza.
– Se non ti fidi di me, lavami pure tutto!
– Mi fido di te, ti chiedo solo d'accettare quest'ultima prova, e come la chiedo a te, la chiedo agli altri, senza eccezioni.
– E quale sarebbe il significato di questa cosa?
– Lavandovi i piedi ho voluto farvi capire che non voglio realizzare la liberazione per rivendicare un potere personale. Non sarò disposto a rinunciare all'umanità che ci ha sempre contraddistinto in nome della rivoluzione. Spero che anche tra voi domini questo spirito democratico, perché senza la democrazia e l'uguaglianza tutto quanto fino adesso abbiamo fatto e quanto ancora dovremo fare, non avrebbe alcun senso. Vi dico questo a prescindere da ciò che, nel corso della rivolta, potrà accadere a ognuno di noi.
Come si può notare il dialogo con Pietro è il confronto tra una posizione democratica e una estremistica: Gesù temeva che di fronte al suo rifiuto di gestire la rivoluzione senza un sicuro consenso popolare, senza il quale peraltro sarebbe stata impossibile la resistenza contro Roma, qualcuno pensasse, agendo in maniera arbitraria, di doverlo mettere in una posizione tale per cui egli sarebbe stato costretto ad agire diversamente da come avrebbe voluto.
Il diverbio con Pietro non ha nulla a che vedere con la decisione di Giuda di tradire. Qui infatti non si ha a che fare con un oltranzismo portato alle estreme conseguenze (quelle cui non volle arrivare Pietro), ma al contrario, con una sorta di eccesso di moderatismo, che già si era riscontrato poco tempo prima, nell'episodio di Lazzaro, allorquando l'apostolo Tommaso era stato molto riluttante a esporsi pubblicamente (Gv 11,16).
Tuttavia esiste una differenza sostanziale tra Pietro e Giuda sul piano etico. Entrambi, è vero, tendevano a subordinare gli aspetti umani del messia a quelli politici, ma Pietro li trascurava meno, non li sottovalutava; pur essendo più impulsivo di Giuda, alla fine si rendeva conto dei propri errori e se ne pentiva. In tal senso forse Giuda avrebbe dovuto comprendere meglio che non si può essere seguaci di un movimento politico rivoluzionario senza provare l'esigenza di un rapporto umano con le persone che vi appartengono.
Con questo ovviamente non si vuole affatto sostenere che Giuda non volesse la liberazione del proprio paese dai Romani; tuttavia i suoi legami col giudaismo gli impedivano di assumere posizioni radicali; probabilmente non era disposto a far nulla senza il concorso del fariseismo progressista, il quale però per liberare la Palestina aveva scelto la strada del compromesso, delle piccole rivendicazioni, delle riforme graduali... nell'illusione che un passato glorioso avesse la forza sufficiente per sopravvivere ancora per molto tempo.
I.3)
Perché dunque i Sinottici non riportano la lavanda dei piedi? Si è già cercato di rispondere a questa domanda, ma ora è giunto il momento di tirare le fila del discorso.
Anzitutto l'istituzione dell'eucaristia dà per scontato il tradimento e quindi la morte del Cristo. Infatti, quando Gesù afferma che qualcuno lo avrebbe tradito (Mc 14,18), Giuda aveva già preso accordi coi capi dei sacerdoti (Mc 14,10 s.). La lavanda dei piedi diventa inutile, in quanto non può avere una funzione dissuasiva.
La tesi della "morte necessaria" nei Sinottici viene vista come una sconfitta politica da trasformare in vittoria religiosa ("si è adempiuta la volontà del Padre"): sotto questo aspetto la lavanda dei piedi diventa irrilevante; gli apostoli non hanno bisogno di apprendere una lezione di umanità (o di umiltà) per seguire meglio il Cristo; tutta la loro umanità è racchiusa nella fede nella resurrezione. Ecco perché nei Sinottici si esalta il ruolo della chiesa istituzionale e sacramentale.
Dando per scontato il tradimento, in quanto facente parte dell'economia salvifica divina, i Sinottici cadono in una contraddizione che in Giovanni è presente solo là dove sono intervenute mani redazionali a interpolare il testo con la tesi della "morte necessaria". I Sinottici, infatti, avendo in mente un Cristo impolitico (che rinuncia al messianismo nazionalista sin dall'inizio), sono costretti ad affermare l'idea di un tradimento riprovevole solo sul piano morale, soggettivo, mentre sul piano oggettivo (quello teologico) lo considerano legittimo, in quanto previsto, inevitabile.
In Giovanni sino all'ultimo Cristo spera che tutti gli apostoli restino uniti e concordi sul da farsi nell'imminenza dell'insurrezione armata. La lavanda dei piedi viene usata a scopo simbolico-pedagogico, al fine di dimostrare che umano e politico devono restare sempre uniti. Il messia ha bisogno di sapere se i Dodici si fidano ancora di lui, anche se non comprendono esattamente tutte le sue scelte politiche.
In Giovanni il tradimento ha effetti catastrofici, anche se il Cristo, nel modo in cui l'accetta (e la lavanda dei piedi, in tal senso, è un'anticipazione della sua umanità), mostra d'essere rimasto sempre coerente col proprio messaggio umano e politico di liberazione. La croce, pur nella propria negatività, è un'esperienza di vittoria, in quanto accettata con dignità.
In Giovanni la realtà della chiesa istituzionale e sacramentale viene superata dal concetto di "amore universale", bene espresso con la lezione di umiltà e di democrazia della lavanda dei piedi, il quale concetto però viene usato, nel suo vangelo, in alternativa anche all'istanza politico-rivoluzionaria.
II
Ora però vediamo il racconto dell'ultima cena, così come descritto nel vangelo attribuito a Giovanni, sotto un'altra prospettiva.
Ribadiamo anzitutto il fatto che la descrizione redazionale è stata condotta su un registro completamente mistico, in virtù del quale si è potuto evitare di dire che in quel frangente si doveva soltanto prendere la decisione su come proseguire la strada già scelta dell'insurrezione, nonostante le opposizioni o quanto meno le incertezze riscontrate tra i Giudei, subito dopo l'ingresso trionfale nella capitale. Se si fosse deciso di rinunciarvi, i pericoli non sarebbero stati di meno, poiché si trattava comunque di sottrarsi a una cattura, e bisognava farlo di notte.
Gesù non può non aver pensato che, giunti a quel punto, sarebbe stato molto rischioso avere dei ripensamenti: diventava quasi più difficile tirarsi indietro che andare avanti. Una volta fatto l'ingresso pubblico, seppur in groppa a un asino, in segno di pace, rinunciare alla coerenza avrebbe significato perdere di credibilità, deludere le aspettative degli ebrei progressisti, disposti a compiere qualunque sacrificio pur di vedere la patria liberata dagli invasori e dai collaborazionisti. Non si può giocare alla rivoluzione, anche perché quando le cose vanno male la ritorsione è sempre spietata.
Il momento fatidico dell'insurrezione doveva per forza avvenire di notte, quando il nemico è meno preparato e può essere colto di sorpresa. Stando a tutti i vangeli, il principale protagonista fu Giuda. Egli doveva essere di Gerusalemme, probabilmente aveva militato nel partito dei farisei. Aveva una missione da compiere, e dal tempo che ci avrebbe messo, gli apostoli potevano capire se l'insurrezione era da farsi oppure no, oppure era da farsi in un modo e non in un altro. Infatti l'ordine che Gesù gli diede era perentorio, anche se i redattori si sono preoccupati di non renderlo chiaro: "Quello che devi fare, fallo presto". In pratica avrebbe dovuto riferire agli apostoli se potevano contare su alcuni possibili alleati, disposti a impugnare le armi, oppure se dovevano limitarsi soltanto alle forze che avevano messo in preventivo (a Betania) e che consideravano sicure. Una cosa del genere andava chiarita quanto prima, poiché quella era una notte cruciale.
Giuda però, forse raggirato da qualcuno, che gli fece false promesse, tradì il mandato ricevuto e volle fare di testa sua. Probabilmente si era convinto che i tempi non fossero ancora maturi o che non doveva essere Gesù a dirigere l'iniziativa, ma qualcuno dei capi politici di Gerusalemme, oppure ch'erano sbagliate le modalità operative degli apostoli: non è infatti da escludere ch'egli ritenesse la tattica di Gesù troppo democratica per poter essere davvero efficace. Si può comunque presumere ch'egli non si aspettasse il tragico epilogo della croce, altrimenti non si sarebbe suicidato (sempre che non siano stati gli stessi apostoli a farlo fuori).
Ora cerchiamo di capire quale messaggio hanno voluto trasmettere i redattori col racconto in oggetto. Prima di farlo però ci piace sottolineare come in esso non vi sia alcun cenno al sacramento dell'eucaristia, per cui si può tranquillamente affermare che tale memoriale è un'invenzione della comunità post-pasquale, influenzata dalle idee mistiche di san Paolo. Quel sacramento ha un'evidente riferimento alle pratiche monastiche della comunità di Qûmran, ed è troppo religioso per poter essere attribuito a Cristo. La cosa strana è che, sebbene Giovanni Zebedeo provenisse originariamente proprio da quegli ambienti, qui sembra prevalere una certa dissonanza rispetto alla versione marciana, che rispecchia più fedelmente la teologia petro-paolina. In questo racconto il tema dominante è un altro: quello dell'umiltà, della fratellanza, dell'uguaglianza che deve esserci tra i discepoli; cosa che nel vangelo di Luca è stata sufficientemente recepita, con inaspettati riferimenti alle modalità (di servizio e non di dominio) con cui si deve vivere la politica.
Si faccia ora attenzione al tipo di manipolazione redazionale. Anzitutto gli autori vogliono far passare Gesù per uno che sa già di dover morire, in quanto è andato a Gerusalemme proprio con tale proposito. Lo sa perché deve rispettare le consegne ricevute dal dio-padre.20 Lui deve morire affinché il primato storico-politico-nazionalistico dei Giudei si trasformi in un'occasione di conversione religiosa per l'umanità intera. Questa l'assurda tesi dei redattori cristiani. Gli ebrei devono perdere politicamente affinché i cristiani possano vincere spiritualmente. In tal senso il cristianesimo non è che un ebraismo depurato da tutti quegli aspetti che più lo caratterizzano come politica religiosa nazionalistica; e ciò è potuto avvenire grazie all'innesto di elementi tratti dal mondo pagano (p.es. dalla filosofia orfica, gnostica ecc.).
Il racconto dell'ultima cena è quindi il racconto di un addio, in relazione a un'esperienza già vissuta e che non si ripeterà (almeno non esattamente a come era stata vissuta), anche se il Cristo qui spera che lo sia il più possibile secondo i canoni etico-religiosi che offre in questo vangelo. In tal senso è anche il racconto di una nuova speranza, completamente diversa da quella che aveva caratterizzato il movimento nazareno fino a quel momento: una speranza appunto socio-religiosa, non politico-rivoluzionaria. In questo racconto quindi vi è qualcosa di patetico, di struggente, di melodrammatico, nulla di politico, a meno che non lo si voglia vedere come un manifesto a favore dell'anti-politica.
Poiché il Cristo viene fatto passare come un dio, egli non poteva non sapere chi l'avrebbe tradito. Si noti, a proposito di questo, l'effetto che si ottiene su un lettore sprovveduto. Se il Cristo è dio (e lui sapeva di esserlo), il fatto di non aver voluto compiere un'insurrezione politica, quando avrebbe potuto facilmente condurla in maniera vittoriosa, va considerato come una prova eloquente che la politica va sostituita con l'anti-politica. In questo racconto infatti non vi è più, all'ordine del giorno, il tema della liberazione nazionale, della giustizia sociale, della lotta contro la corruzione della casta sacerdotale, collusa col nemico e tenacemente legata ai propri privilegi economici e politici. Il tema è quello della rinuncia al potere da parte del leader di un movimento che, virtualmente, avrebbe potuto fare la rivoluzione.
La lavanda dei piedi (un gesto che di regola faceva il servo di una casa signorile) qui viene messa per indicare l'estrema umiltà del messia, che, non senza difficoltà, viene accettata dagli apostoli, qui rappresentati (polemicamente) da Pietro. Il quale arriva a dire che se Gesù non si fida ancora di loro, in quanto li vede troppo ancorati alle esigenze terrene di una liberazione politico-nazionale, allora che li lavi completamente, non solo nei piedi. Al che Gesù risponde con una frase che, all'apparenza, sembra avere poco senso. Infatti dice che non ha bisogno di "lavare integralmente" gli apostoli, in quanto hanno già capito cosa lui pensa in merito alla politica rivoluzionaria. Devono solo capirlo in maniera definitiva, proprio nel momento più fatidico della loro storia personale e collegiale.
Tutto ciò però non riesce ad accettarlo uno come Giuda. "Voi siete netti, ma non tutti": che significato hanno queste parole? Probabilmente uno solo: gli autori della pericope vogliono mostrare che gli apostoli, rappresentati da Pietro, erano disposti ad accettare l'anti-politica del Cristo (anche se Pietro non può non manifestare la propria riottosità a credervi); l'unico che non ha intenzione di accettarla è Giuda, che qui viene fatto passare per un ebreo ancora troppo "giudeo" per poter essere un buon "cristiano".
La lavanda dei piedi doveva servire come esempio di anti-politica o di pre-politica, da viversi nell'ambito di una comunità monastica, ove regna l'uguaglianza sociale, la comunione dei beni e la reciproca fiducia. Se qui Pietro fa la figura di un uomo impulsivo, interessato più alla politica che all'etica, è perché nel IV vangelo vi è una certa rivalità degli autori nei suoi confronti, che è poi il contrasto tra cristiani di origine giudaica e cristiani di origine galilaica. Pietro rappresenta una sorta di via di mezzo tra il tardo-giudaismo di Giuda e l'avventurismo politico dei Galilei.
Questa forte antipatia nei confronti di Pietro (il quale, come noto, aveva sposato la tesi paolina relativa alla figliolanza divina del Cristo) la si nota anche nei vv. 36-38, là dove lo si fa passare per un traditore quasi alla stregua di Giuda. Pietro infatti con la sua interpretazione della tomba vuota come "resurrezione", aveva rinunciato subito a qualunque tentativo insurrezionale. In questo vangelo non può evidentemente emergere la motivazione di fondo dell'antipatia di Giovanni nei confronti di Pietro, e tuttavia di essa qualche traccia è rimasta in varie parti.
II.1)
L'annuncio del tradimento, nella seconda parte della pericope (vv. 18-35), rientra ancora di più nell'impostazione mistica di tutto il racconto. Questa seconda parte non è che una ripresa dell'argomentazione della prima, svolta più analiticamente, ma con effetti, in un certo senso, sconvolgenti.
Un ulteriore elemento mistico è introdotto là dove si dice che il tradimento di Giuda era già stato previsto dalle Scritture. In tal modo viene corroborata la tesi precedente, relativa alla volontà sacrificale del dio-padre. Naturalmente le Scritture (anticotestamentarie) vengono interpretate nella maniera più arbitraria possibile, estrapolandone quei passi che possono servire per confermare delle tesi precostituite. Il Cristo può permettersi di anticipare il tradimento di Giuda proprio per dimostrare ch'egli era "figlio di dio" o di "natura divina", come una sorta di extraterrestre.
Ora, a prescindere da tale misticismo, che qui raggiunge livelli piuttosto elevati, non è comunque da escludere che nel momento dell'ultima cena, vedendo che Giuda tardava a tornare, gli apostoli, e non solo Gesù, avessero subodorato che qualcosa era andato storto, per cui sarebbe stato meglio nascondersi nell'orto degli ulivi.
Difficile qui capire il rapporto tra Gesù e Giovanni (che gli posa il capo sul petto per sapere il nome del traditore) in merito al tradimento di Giuda. Non è da escludere che Giovanni sia stato il primo a intuire che Giuda stava tradendo la causa rivoluzionaria, conoscendo bene anche lui gli ambienti della città. Anzi ci si può chiedere il motivo per cui Gesù non abbia incaricato Giovanni, discepolo prediletto, a compiere un incarico così delicato e decisivo. Evidentemente la scelta era caduta su Giuda a motivo della sua esperienza pregressa, che non era certo stata negli ambienti essenici, come quella di Giovanni, discepolo del Battista. Anche da questo si può inferire che Giuda provenisse da circoli farisaici progressisti.
Qui però la tesi che i redattori vogliono sostenere è semplicemente mostruosa. Stando infatti alla dinamica degli eventi, da loro prefigurata, Giovanni avrebbe saputo in anticipo da Gesù che Giuda sarebbe stato il traditore e, ciononostante, egli avrebbe deciso di non dire nulla agli altri, nemmeno a Pietro, con cui era in aperta confidenza. Motivo di tale stranezza? Giovanni avrebbe capito, prima degli altri, che la morte di Gesù andava considerata come "necessaria" alla realizzazione del comandamento dell'amore reciproco, espresso al v. 34. In pratica Gesù, con quell'ordine tassativo: "Quello che fai, fallo presto" (v. 27), si riferiva esplicitamente all'intenzione che Giuda aveva maturato di tradirlo. Giuda quindi sarebbe stato una sorta di esecutore involontario, stabilito da dio, nei confronti di un Cristo votato al martirio; e mentre Pietro, sulla base di motivazioni squisitamente politiche, avrebbe fatto di tutto per impedirlo, Giovanni invece, con le sue motivazioni teologiche, ne fu complice: ecco perché risulta essere il più grande degli apostoli, l'unico ad aver capito in anticipo le vere intenzioni del Cristo.
Se tale ricostruzione dei fatti è vera, bisogna dire che negli autori di tale vangelo vi è una perversione mentale di non poco conto, la cui gravità non viene certo attenuata dall'obiettivo finale con cui il Gesù mistico avrebbe giustificato la necessità del tradimento di Giuda e quindi della propria morte, che qui tanto assomiglia a un suicidio, e cioè l'amore fraterno, da viversi tra gli apostoli e tra tutti i discepoli successivi. Qui è evidente che gli autori di questo vangelo (o almeno di questo racconto, poiché si deve per forza pensare a una composizione plurima) non possono essere stati discepoli di Giovanni, anche se in essi è rimasta traccia del dissidio che tra Giovanni e Pietro maturò l'indomani della scoperta della tomba vuota. Se questi autori sono appartenuti a una comunità edificata da Giovanni, di sicuro, quando scrivono un testo del genere, ne avevano tradito l'ideale originario. Non era certo questo il modo di far apparire Giovanni migliore di Pietro.
(torna su)29) Il tradimento di Giuda
Gv 13,21-30 - Mc 14,18-21
Il primo evangelista a scrivere, Marco, non ha dubbi nel sostenere che se il Cristo "doveva morire" (ovviamente di morte violenta), perché così era "scritto nei cieli", egli non poteva non essere tradito da qualcuno dei suoi più stretti discepoli. "Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito!" (Mc 14,21). Matteo e Luca dicono la stessa cosa, e nessuno si rende conto che se questa scomparsa dipendeva dalla volontà divina, la colpa di Giuda andava di molto ridimensionata; la sua azione anzi veniva a configurarsi come provvidenziale nell'economia salvifica del padre eterno, che tutto predispone con largo margine di anticipo sulle possibili scelte degli uomini. Questa in fondo è anche la tesi del vangelo di Giuda, uno degli ultimi apocrifi ritrovati.
Giovanni invece, come al solito, è più sottile: è vero che nella parte posticcia, aggiunta successivamente da un altro redattore, ribadisce la tesi sinottica (di origine petrina) della "morte necessaria", ma in quella più autentica fa capire, più realisticamente e anche più semplicemente, che Gesù temeva che qualcuno dei Dodici avrebbe potuto far fallire la causa rivoluzionaria nel suo momento più critico.
I quattro evangelisti, che ragionano ex-post, cioè col senno del poi, assumono una posizione, nei confronti del tradimento di Giuda, che si può sintetizzare nelle seguenti. Gesù fece:
– un'affermazione esplicita relativa al fatto che qualcuno degli apostoli l'avrebbe tradito (Mc, Mt, Lc e Gv);
– un'affermazione esplicita sul fatto che il traditore sarebbe stato Giuda (Mt);
– una confessione riservata a Giovanni sul nome preciso del traditore (Gv).
Tuttavia solo i Sinottici sostengono che la decisione di tradire venne presa da Giuda prima dell'ultima cena. Così scrive Marco: "Giuda Iscariota andò dai capi dei sacerdoti per aiutarli ad arrestare Gesù. Essi furono molto contenti della sua proposta e promisero di dargli dei soldi. Allora Giuda si mise a cercare un'occasione per farlo arrestare" (14,10 ss.). Luca aggiunge che voleva farlo catturare "lontano dalla folla" (22,6). Matteo (26,14 ss.) sostiene che il tradimento avvenne soltanto per motivi economici: Giuda era disposto a tradire dietro congruo compenso (le famose trenta monete d'argento). Quanto a Giovanni, egli si limita a dire che i capi dei sacerdoti e i farisei, dopo l'episodio di Lazzaro, avevano dato ordine di arrestarlo (11,49 ss.): non viene citata alcuna ricompensa, anche perché solo nel corso dell'ultima cena Giuda decise di tradirlo (13,2.27).
Già al momento della cosiddetta "moltiplicazione dei pani" Giuda – stando alla versione giovannea (6,70) – non aveva capito il rifiuto di Gesù di diventare "re" d'Israele, sul modello dei grandi predecessori, Davide e Salomone, e si era scandalizzato nel vedere che Gesù voleva scardinare le tradizioni politico-religiose del giudaismo classico. Se questa versione è vera, allora probabilmente egli non era rimasto molto entusiasta neppure dell'ingresso trionfale del messia a Gerusalemme, avvenuto qualche giorno prima dell'ultima cena, avente lo scopo di preparare l'insurrezione armata.
Ora poi, con la lavanda dei piedi, il suo imbarazzo doveva essere stato non meno forte di quello di Pietro, che ebbe l'ardire di manifestarlo esplicitamente. A dir il vero l'azione in sé era abbastanza consueta nella Palestina d'allora. All'ospite che viaggiava per le strade polverose si offriva l'acqua per lavarsi i piedi. Chi aveva dei servi li utilizzava in quell'occasione. Raramente però i discepoli lo facevano in modo spontaneo come segno di riverenza verso il loro maestro. Che fosse poi quest'ultimo a farlo nei loro confronti, era del tutto inconcepibile.
Dunque ammesso e non concesso che tale rito simbolico (non del battesimo, ma dell'umiltà) sia effettivamente accaduto, è fuor di dubbio che durante l'ultima cena non si deve aver parlato soltanto dei preparativi per l'imminente rivolta popolare, ma anche dei rischi cui si sarebbe andati incontro nell'eventualità di un insuccesso. In quel particolare frangente tutti dovevano essere ben consapevoli che in gioco era la vita.
La coesione tra loro doveva essere massima, assoluto il rispetto delle regole. Il significato del racconto della lavanda dei piedi stava nel fatto che gli apostoli avrebbero dovuto fidarsi del loro leader, che non aveva scelto la soluzione dell'insurrezione armata per spirito d'avventura o per ottenere un potere personale, ma unicamente per il bene del paese.
Per realizzare tale obiettivo egli era disposto anche al sacrificio della vita e chiedeva che lo stesso spirito di abnegazione animasse anche gli altri leader. Di fronte però al fatto ch'egli mostrasse con l'esempio servile della lavanda dei piedi tale proposito, Pietro, abituato a ragionare più in termini politici che umani, rimase un po' risentito e protestò. Egli infatti voleva compiere la rivoluzione ad ogni costo e gli pareva quanto meno fuori luogo una preoccupazione di tipo "democratico" nel momento in cui si doveva tirar fuori la spada per abbattere il nemico.
Nel racconto di Giovanni Pietro ostenta una certa permalosità, come se in realtà avesse detto: "Se non ti fidi di me, allora dimmi chiaramente che mi escludi dall'impresa". Gesù infatti non stava mettendo in discussione il coraggio politico degli apostoli, ma la capacità di affrontare in maniera democratica degli eventi che sarebbero anche potuti sfuggire di mano.
Da questo punto di vista che vi sia stato il gesto effettivo della lavanda dei piedi o una semplice chiacchierata sull'esigenza di rispettare le regole e di amarsi reciprocamente, non fa molta differenza. Se il Cristo, ad un certo punto, si risolse a ricorrere all'espediente servile, forse lo fece perché aveva a che fare con discepoli che non si rendevano sufficientemente conto dell'importanza della democrazia nei momenti rivoluzionari.
Se tutto fosse filato liscio, la vittoria sarebbe stata certa, ma non sarebbe stata scontata la gestione legale, umanitaria della vittoria. Si dovevano evitare assolutamente gli eccessi contro la guarnigione romana, le ritorsioni contro i collaborazionisti ebrei, le vendette private, gli eccidi di massa nel timore di una controrivoluzione interna, in una parola la violenza gratuita.
Anche perché il vero problema non era tanto quello di come vincere nella capitale, quanto piuttosto di come resistere alla inevitabile controffensiva imperiale. La questione cruciale da affrontare sarebbe stata quella di come convincere la maggioranza della popolazione a organizzare una resistenza armata contro lo strapotere delle legioni romane, le più forti del mondo.
La gente comune infatti, per potersi muovere rischiando la vita, non ha soltanto bisogno di trovarsi in condizioni particolarmente difficili, ma anche di credere nella possibilità di una sconfitta del nemico. E questo atteggiamento va saputo gestire: il popolo non è carne da macello, non lo si può obbligare al sacrificio. Il popolo va persuaso in maniera democratica, lasciandogli la possibilità di scelta.
Chi pensa che un leader non si debba abbassare come un servo, al punto da lavare i piedi ai suoi discepoli, ha capito poco della democrazia e rischia di far fallire gli obiettivi della rivoluzione. Questa cosa la si evince anche da quanto il Cristo dice nel racconto di Lc 22,24 ss., che pur non riporta la lavanda dei piedi: "Secondo voi chi è più importante: chi siede a tavola o chi sta a servire? Quello che siede a tavola, non vi pare? Eppure io sto in mezzo a voi come un servo".
Poiché gli evangelisti sostengono la tesi della "morte necessaria" del messia, è venuto loro spontaneo far dire al Cristo, con perentorietà, che il tradimento di uno degli apostoli non era affatto una eventualità remota, bensì una cosa inevitabile, soteriologicamente prevista, al punto che sin dall'inizio del racconto sull'ultima cena si fa capire al lettore ch'egli sapesse con sicurezza chi lo stava tradendo.
Il tono apodittico, usato per aumentare la tensione e la solennità degli ultimi avvenimenti, sta p. es. in parole o espressioni del genere: "Io vi assicuro" (Mc 14,18; Mt 26,20; Gv 13,21); "È stato stabilito per lui" (Lc 22,22); "Il Figlio dell'uomo sta per morire, così come è scritto nella Bibbia" (Mc 14,21; Mt 26,24); "Devono realizzarsi queste parole della Bibbia: Colui che mangia il mio pane si è ribellato contro di me (Sal 41,10). Ve lo dico ora, prima che accada; così, quando accadrà, voi crederete che Io sono" (Gv 13,18 s.).
In realtà se avesse detto parole del genere, avrebbe subito creato un clima di terrore, di panico generale, di sospetti e diffidenze tali da rischiare di paralizzare la capacità decisionale di tutto il movimento, che in quel frangente così particolarmente delicato per i destini del paese, doveva assolutamente restare immutata.
Al massimo dunque egli può aver manifestato preoccupazioni di carattere generale, può aver ventilato delle ipotesi cautelative, al fine di scongiurare ogni pericolo, ogni imprevisto, nei limiti del possibile ovviamente. È da escludere a priori ch'egli abbia sostenuto delle certezze relative al tradimento, meno che mai può aver formulato il nome del traditore, né apertamente a tutti, né velatamente al discepolo prediletto.
Nel quarto vangelo Pietro, addirittura, vuol farsi dire da Giovanni, dopo che questi aveva ottenuto la confidenza da parte di Gesù, il nome del traditore, per poterlo fermare in tempo, coi metodi che possiamo immaginare. Anche ammettendo questo ruolo "poliziesco" che Pietro avrebbe voluto avere nell'ultima cena, è davvero impensabile credere che, sapendo con certezza il nome del traditore, lo stesso Cristo non avrebbe fatto nulla per scongiurare la possibile débâcle dell'insurrezione.
È invece possibile che Pietro abbia chiesto a Giovanni di farsi dire dal Cristo se aveva dei sospetti concreti, degli indizi precisi, ma va escluso categoricamente che Giovanni abbia ottenuto la confidenza sull'identità del traditore. Tutto quanto viene scritto nel suo vangelo in merito a quella confidenza personale, va considerato come un semplice espediente letterario, la cui finalità era quella di dimostrare o che Giovanni non aveva mai avuto alcuna stima di Giuda, oppure che Giovanni era superiore a Pietro. Ma a tragedia avvenuta egli si sarà chiesto mille volte come fosse stato possibile che nessuno degli apostoli si rendesse conto chi tra loro avrebbe tradito e che cosa si sarebbe potuto fare per evitare quella sciagura.
Il fatto è che nei vangeli tutto deve apparire esplicito: la necessità del tradimento e addirittura il nome del traditore. Scopo di questo è sostenere la tesi della inevitabilità della morte del messia, la quale, a sua volta, è subordinata alla tesi della equiparazione del messia a dio. Se rifiutassimo di considerare mistificante questa spiegazione dei fatti post-eventum, si finirebbe col dover fare valutazioni molto imbarazzanti sul ruolo di taluni discepoli, in particolare proprio su quello di Giovanni.
Supponendo infatti ch'egli avesse ottenuto la confidenza da parte di Gesù, ascoltata nel mentre gli teneva il capo appoggiato sul petto, per quale motivo non avrebbe fatto nulla per impedire che il tradimento si realizzasse? Perché non dire niente a Pietro? Quali considerazioni di opportunità può aver fatto per permettere a Giuda di agire indisturbato? Temeva forse che se Giuda fosse stato emarginato o addirittura giustiziato, la congrega dei Dodici si sarebbe spaccata a metà, mandando a picco l'idea della rivoluzione?
Alcuni esegeti sono persino arrivati a sostenere che mentre per tutti gli altri apostoli la tesi della "morte necessaria" fu acquisita soltanto dopo la scoperta della tomba vuota, in Giovanni invece essa era chiara sin dall'inizio. Se così fosse, noi dovremmo affermare che proprio il discepolo prediletto sarebbe stato, in ultima istanza, uno dei principali responsabili della morte di Gesù!
Questo per dire che le esegesi di tipo confessionale generalmente non valgono nulla. Il fatto stesso che considerino quella riunione politica una sorta di cena mistica o rituale, nell'imminenza della Pasqua ebraica, le squalifica in partenza. In quel momento non si istituì alcun sacramento eucaristico, ma la tattica della presa del potere, per realizzare la strategia dell'insurrezione nazionale. È impensabile sostenere che in quella notte così decisiva, Gesù o Giovanni, pur conoscendo bene l'identità del traditore e ciò che di lì a pochissimo stava per compiere, avevano deciso di non fare assolutamente nulla per fermarlo.
Intanto va detto che Giovanni, scrivendo che solo a lui Gesù fece una personale confidenza, smentisce per così dire i Sinottici, là dove sostengono che la certezza assoluta del tradimento e l'identità precisa del traditore erano cosa nota a tutti gli apostoli, al punto che Giuda è in un certo senso costretto a svolgere il suo vergognoso ruolo. Tuttavia se confidenza ci fu, è da scartare a priori l'idea che Gesù volesse perorare una qualche causa fatalistica o irrazionalistica, del tipo "l'eroe deve morire" o "la verità sta nel martirio". Al massimo può aver chiesto al discepolo più fidato di vigilare sugli elementi più instabili, senza però creare una mini-rete spionistica, che avrebbe finito col danneggiare gli interessi della squadra.
Tutta la ricostruzione della vicenda, fatta dagli evangelisti, risulta completamente falsata dall'idea mistica che Gesù fosse una sorta di extraterrestre, dotato di poteri assolutamente straordinari, in grado di prevedere in anticipo qualunque tipo di scenario e, nello stesso tempo, capace di salvaguardare la libertà di scelta di ognuno. Cosa che, se anche per ipotesi fosse stata vera, non sarebbe mai potuta apparire esplicitamente, proprio per evitare che gli apostoli nutrissero l'impressione di stare recitando una parte il cui copione era già scritto altrove. La chiesa non riesce a rendersi conto che quanto più si presenta Gesù come un dio, tanto più si toglie all'uomo ciò che lo distingue dall'animale, e cioè il libero arbitrio.
Sarebbe infatti paradossale pensare sia la seguente cosa che il suo contrario, sulla base della convinzione che Gesù fosse il figlio di dio: e cioè da un lato che il tradimento avrebbe potuto essere vanificato dal Cristo in qualunque momento (in tal senso Giuda avrebbe tradito soltanto per metterlo alla prova, per spingerlo a trionfare sui propri nemici a tutti i costi, mentre Giovanni per lo stesso motivo avrebbe taciuto); dall'altro invece che il tradimento rientrava nell'economia salvifica di dio, per cui andava accettato come una necessità inderogabile (in tal senso Giuda, senza sapere quello che faceva, avrebbe tradito per vedere se Gesù rifiutava il destino del "calice", mentre Giovanni avrebbe taciuto, sapendolo bene). In entrambi i casi Giuda, a resurrezione avvenuta, sarebbe stato facilmente perdonato e a Giovanni sarebbe stato riconosciuto il privilegio di considerarsi il "discepolo prediletto".
Tuttavia, piuttosto che cadere in interpretazioni del tutto fantasiose, gli esegeti farebbero meglio a immaginarsi una situazione molto più realistica, in cui da un lato si doveva decidere qualcosa che poteva mettere a repentaglio la vita di tutti, dall'altro si doveva in qualche modo evitare che la possibilità di un fallimento dell'insurrezione potesse dipendere non da cause di forza maggiore, assolutamente imprevedibili, ma da fattori soggettivi, come appunto la defezione di qualcuno o un tradimento all'ultimo minuto.
Se dunque Gesù o Giovanni sospettarono qualcosa o qualcuno, ciò non poteva tradursi in un motivo sufficiente per bloccare del tutto il tentativo insurrezionale. La macchina era già stata messa in moto durante l'ingresso messianico, anzi, ancor prima, durante l'episodio di Lazzaro, che i Sinottici tacciono perché evidentemente appariva troppo favorevole a una visione politico-rivoluzionaria del Cristo. Ora la gente si aspettava qualcosa di risolutivo, anche perché, chi era andato incontro a Gesù e ai suoi discepoli coi ramoscelli d'ulivo chiamandolo "salvatore della patria", aveva sicuramente rischiato qualcosa. In quell'occasione le guardie del Tempio e la guarnigione romana, nella adiacente fortezza Antonia, evitarono d'intervenire proprio perché la folla era troppo numerosa. Noi non sappiamo chi avesse organizzato quell'evento spettacolare, in grado di mettere le autorità nel panico, ma non è da escludere che tra i registi vi fossero i seguaci di Lazzaro (Gv 12,17 s.).
Insomma il possibile tradimento di uno non poteva vanificare le speranze di molti. Se, pur sapendo su chi era meglio nutrire i maggiori sospetti, si decise di proseguire comunque la missione, evitando di assumere atteggiamenti autoritari (quelli che invece avrebbe voluto prendere Pietro), il motivo probabilmente era che si pensava che il tradimento sarebbe rimasto una possibilità teorica, destinata a rientrare da sola, a insurrezione avvenuta con successo, oppure che, nella peggiore delle ipotesi, esso non avrebbe avuto un effetto devastante sulla riuscita dell'impresa. I tempi cioè erano talmente maturi per una generale insurrezione anti-romana da rendere impensabile un'inversione di rotta. Sarebbe stata la forza degli eventi a ridimensionare la gravità del gesto o dell'intenzione di Giuda. Ormai non era più in gioco il solo destino dei Dodici o del movimento nazareno, ma dell'intera nazione. Ormai il tradimento più grande non poteva più essere quello di un apostolo, ma quello di un intero popolo nei confronti di se stesso.
Giovanni quindi, se effettivamente seppe o intuì qualcosa di preoccupante e non fece nulla per evitarla, non fu dettato da basse motivazioni opportunistiche relative alla tutela dell'unità della compagine politica, né – come alcuni hanno detto – perché non ebbe il tempo materiale per avvisare Pietro, ma, escludendo ch'egli pensasse che il messia fosse un dio troppo grande per non superare la prova di un tradimento così umano, semplicemente agì sulla base di tre ragioni: la prima è che non si può dare del traditore a qualcuno che ancora non ha tradito, la seconda è che nessuno, usando la forza, può impedire a qualcuno di tradire, la terza è che nessuno può togliersi volontariamente la speranza di credere che, nonostante la possibilità del tradimento, non verrà pregiudicata la riuscita di un progetto rivoluzionario.
Ma la domanda più difficile, che ancora non abbiamo posto, è un'altra. Nel racconto di Giovanni appare chiaro che dal momento in cui Gesù, con grande familiarità, porse un boccone di pane inzuppato a Giuda, al momento in cui questi decise di tradirlo, non passò molto tempo. Noi siamo propensi a credere non solo che alla domanda di Giovanni di sapere il nome del possibile traditore, Gesù non diede alcuna risposta, né esplicita né implicita, ma anche che lo stesso Giovanni, a tragedia finita, abbia cercato di associare, con un nesso causale che in quel momento non poteva esserci, la dichiarazione relativa al tradimento col gesto del boccone.
Cioè la sequenza degli eventi narrata da Giovanni: dichiarazione sul tradimento, boccone offerto a Giuda, decisione di tradire e, da ultimo, richiesta di compiere una missione ("Quello che devi fare, fallo presto"), non può aver avuto questa successione cronologica, altrimenti si dovrebbe dare per scontata una cosa inammissibile, e cioè che Gesù "voleva" essere tradito.
Infatti la domanda più difficile cui dobbiamo rispondere è questa: cosa doveva fare Giuda di tanto urgente? Davvero l'esigenza di Gesù era quella di sapere se Giuda avesse o no intenzione di tradirlo? O si vuole sostenere che gli chiese addirittura di farlo, come sostengono i credenti, che sostituiscono l'idea politica di "rivoluzione" con quella religiosa di "morte necessaria"?
Dopo aver esplicitamente ammesso ch'esisteva la possibilità, all'interno del Collegio, di una grave defezione, Gesù aveva di fronte a sé due alternative: o rinunciare del tutto all'impresa insurrezionale, uscendo dalla città in quella stessa notte; oppure chiedere agli apostoli di stare uniti e di controllarsi a vicenda, senza per questo dover creare tensioni insopportabili, in cui il solo sospetto avrebbe rischiato di procurare più danni dello stesso tradimento. Se sceglieva la seconda soluzione, non gli restava che affrontare la decisione finale, e solo in tal caso diventa legittimo chiedersi: aveva senso rischiare di affidare a Giuda l'incarico più delicato per la riuscita dell'insurrezione, quando i principali sospetti ricadevano proprio su di lui?
Sì, aveva senso. Giuda era stato incaricato da Gesù di compiere qualcosa che solo lui poteva compiere, probabilmente perché essendo nativo della Giudea aveva agganci o referenze nella capitale più che non molti altri apostoli, originari com'erano della Galilea (Pietro, non dimentichiamolo, verrà scoperto proprio a causa della sua parlata). Probabilmente non venne scelto nessuno degli ex-seguaci del Battista, in quanto già si sapeva che gli esseni avrebbero o non avrebbero partecipato all’insurrezione. Venne forse scelto Giuda perché questi, negli anni passati, aveva frequentato ambienti farisaici progressisti o forse zeloti della Giudea, e si attendeva da costoro una definitiva presa di posizione. Difficile dire se dal rifiuto di tale adesione sarebbe dipeso il destino dell’insurrezione del movimento nazareno o se questa si sarebbe comunque fatta.
In ogni caso non si trattava tanto di mettere alla prova il presunto traditore, quanto piuttosto di affidargli un incarico della massima responsabilità per la riuscita definitiva della strategia rivoluzionaria. Il fatto che Giovanni dica che, al sentire quella frase: "Quello che devi fare, fallo presto" (Gv 13,27), "nessuno dei commensali capì; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: – Compra quello che ci occorre per la festa; oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri" (13,28 s.), questo fatto non può indurre a credere che gli apostoli fossero seguaci di un messia folle, intenzionato a farsi tradire per fare della propria morte un culto di tipo religioso.
È paradossale che nel momento decisivo dell'insurrezione armata gli apostoli non abbiano capito il significato della missione che Giuda doveva compiere, o che abbiano addirittura ipotizzato che proprio nel momento in cui finalmente si poteva assicurare un futuro ai poveri, Giuda dovesse far loro la beneficenza! O che nel momento in cui si decideva l'insurrezione popolare, Giuda dovesse preoccuparsi di acquistare le vivande per il giorno dopo! È difficile pensare che Giovanni, così sempre attento ai particolari, possa aver scritto simili assurdità.
Peraltro, che bisogno aveva di presentare le cose in modo tale da dover ribadire una tesi già espressa ad abundantiam nei Sinottici? Qui deve essere intervenuta pesantemente la mano di qualche revisore. Infatti da come le cose vengono presentate, sembra che Gesù non solo non abbia fatto nulla per evitare il tradimento, ma anzi abbia fatto di tutto per provocarlo. Infatti, se il solo Giuda non fosse stato incaricato di qualcosa di particolare, che soltanto lui quindi poteva compiere, difficilmente questi avrebbe potuto trovare un'occasione più favorevole. Ma se il Cristo voleva farsi prendere, perché nascondersi coi suoi discepoli nel Getsemani e non restare invece nel cenacolo? Non decise forse di nascondersi nel Getsemani per dare a Giuda una seconda possibilità di non tradirlo sino in fondo?
L'insurrezione non poteva certo essere compiuta da dodici militanti: la guarnigione romana comprendeva circa 600 militari, cui andavano aggiunte le guardie del Tempio e i vari collaborazionisti ebrei: come minimo c'erano un migliaio di persone ben armate da affrontare. Non si poteva rischiare l'avventura, anzi, bisognava essere sufficientemente sicuri che l'insurrezione avrebbe avuto successo. Tuttavia il Cristo aveva bisogno di una conferma, poiché non tutto era stato ancora deciso, o comunque non tutto poteva essere deciso da loro.
Qui non era tanto in gioco la necessità di sapere su quali discepoli Gesù poteva contare con sicurezza e su quali invece era meglio nutrire dei dubbi; qui ormai il problema era diventato quello di come organizzare gli ultimi dettagli di una sommossa annunciata. Gesù non poteva aver incaricato Giuda di compiere una missione particolare al solo scopo di verificare se era un discepolo affidabile: non c'era tempo per una cosa del genere, anche perché tutti loro, trovandosi all'interno della città, nell'eventualità di un tradimento, non avrebbero avuto scampo.
Gesù doveva necessariamente fidarsi di Giuda, il quale doveva contattare gli alleati (i farisei progressisti, gli zeloti...) e, a un segnale convenuto, far scoppiare la rivolta armata popolare quella notte stessa. Dal tempo che avrebbe impiegato, Gesù poteva capire se la rivoluzione era stata tradita oppure no, ovvero se era il caso di tentarla lo stesso, seguendo un percorso diverso, o se era meglio posticiparla di qualche tempo, anche se quello della Pasqua (che durava sette giorni) era sicuramente il migliore, a motivo dell'enorme affluenza di massa nella capitale.
Questo sul piano politico. Sul piano umano la questione è molto più complessa. La sequenza degli eventi dell'ultima cena, di cui si parlava prima, ha qualcosa di altamente drammatico: Gesù che porge a Giuda un boccone di pane intinto nel sugo (cosa che in quel momento non fa neppure col discepolo prediletto) e nello stesso tempo gli chiede di compiere la missione decisiva per la riuscita dell'insurrezione. Qui è come se si toccassero in un punto incandescente le esigenze dell'umano e quelle del politico. Non è facile trovare in altre parti dei vangeli una situazione emotiva così carica di pathos.
Per un militante come Giuda, abituato forse a considerare il politico più importante dell'umano, i due gesti della lavanda dei piedi (che anche Pietro, in un primo momento, aveva rifiutato) e del boccone di pane inzuppato rischiavano di provocargli una lacerazione interiore. A quel punto o lui capiva che l'umano non poteva restare subordinato al politico, ovvero che nel politico del Cristo c'era un umano non meno significativo, oppure tradiva. Per dargli la possibilità di decidere liberamente e consapevolmente, il Cristo gli affida, riconoscendogli la fiducia che meritava, il compito più importante di tutta la sua vita.
Se Giuda avesse avuto delle riserve sostanziali sulla strategia generale del progetto politico, non avrebbe potuto o dovuto trovarsi lì in quel momento, né gli sarebbe stata affidata una missione così delicata. Ma il gesto del boccone voleva appunto significare che, anche nell'eventualità ci fossero state differenze sostanziali tra le sue idee e quelle del messia, non era quello il momento di farle pesare e il gesto di grande confidenza e di fiducia che il Cristo gli aveva manifestato, doveva appunto indurlo ad agire secondo quanto gli veniva chiesto. A meno che dei redattori burloni non si siano divertiti, con quel gesto, a far apparire il traditore in una luce incredibilmente spregevole.
Tutto ciò lo si comprende leggendo tra le righe del vangelo di Giovanni. Nei Sinottici è prevalsa la leggenda dei cosiddetti "trenta denari". A dire il vero solo Matteo parla esplicitamente di questa somma (26,15); Marco (14,11) e Luca (22,5 s.) sostengono che i sommi sacerdoti e i capi delle guardie si accordarono per dargli del denaro come ricompensa (non se ne specifica l'importo), denaro che poi Giuda accettò.
I trenta denari d'argento erano il prezzo che la legge mosaica fissava per la vita di uno schiavo ucciso (Es 21,32): è dunque impossibile non vedervi un'analogia; peraltro la fine che questo denaro ha fatto (gettato nel Tempio dallo stesso Giuda pentito), di cui parla il solo Matteo (27,3 ss.), è del tutto simile a quella descritta in Zc 11,13.
Ma a parte questo, ciò che davvero non si riesce ad immaginare è come Gesù potesse tenere, nel proprio entourage, un uomo così venale, e come abbia potuto affidare nel momento decisivo dell'insurrezione un incarico così delicato a un discepolo i cui ideali politici erano pesantemente condizionati dagli interessi economici.
Già il pensiero che Giuda fosse entrato nel movimento nazareno coll'intenzione di arricchirsi, pare assurdo, ma se anche così fosse stato, resta del tutto inspiegabile la decisione di chiedere come ricompensa, per la cattura del ricercato più pericoloso di quel momento, una cifra equivalente al salario mensile di un operaio medio.
Qui vi è sicuramente una leggenda da sfatare. Qualche esegeta, rendendosi conto dell'incongruenza, ha sostenuto l'idea che Giuda avesse chiesto del denaro semplicemente per rendere più credibile il tradimento. Tuttavia qui non si ha a che fare con un semplice traditore per denaro: che bisogno aveva infatti di accompagnare di persona la scorta armata per catturare Gesù e tutti i discepoli? Non sarebbe stato sufficiente indicare il luogo del nascondiglio? Siamo davvero sicuri che Giuda non volesse sostituirsi al Cristo nella guida del movimento nazareno, dando a questo una fisionomia diciamo più "moderata"?
La dinamica della cattura, avvenuta praticamente senza spargimento di sangue, lascia pensare che le intenzioni dei militari fossero semplicemente quelle di catturare Gesù, e il fatto che questi le accetti, permettendo ai suoi discepoli di fuggire, sembra confermarlo. Giuda non può aver tradito senza sapere che all'interno dei Dodici qualcuno avrebbe preso le difese di Gesù e qualcun altro avrebbe invece condiviso la sua iniziativa. E lo scopo del suo tradimento più che esser quello di rinunciare all'idea di una liberazione nazionale, al massimo poteva essere quello di rinunciare all'idea di compiere in quel momento un'insurrezione armata. Altrimenti non si comprende perché sia rimasto tra i Dodici sino all’ultimo momento: era forse – come qualcuno ha detto – un infiltrato di Caifa?
La questione del denaro viene poi contraddetta dal fatto che, dopo aver constatato come il tradimento avesse comportato non solo il desiderato fallimento dell'insurrezione armata ma anche l'inattesa crocifissione del messia, egli prese la decisione d'impiccarsi. Se Giuda avesse tradito convinto che Gesù ne sarebbe uscito sì sconfitto ma non giustiziato (e forse l'episodio del bacio voleva essere una rassicurazione in tal senso), Giuda probabilmente non avrebbe avuto rimorsi, o forse non li avrebbe avuti così grandi o comunque non così in fretta. A meno che non si voglia sostenere la tesi – come alcuni hanno fatto – che il suicidio di Giuda sia stato in realtà un omicidio mascherato. In tal caso dovremmo ribaltare tutte le interpretazioni.
Giovanni, pur associandosi alla tesi sinottica secondo cui Giuda manifestava un certo interesse per il denaro (si ricordi l'episodio di Betania in cui egli contesta lo spreco del profumo profuso dalla sorella di Lazzaro sui piedi di Gesù), non riporta affatto il suicidio di Giuda, anzi, in tutto il racconto dell'ultima cena descrive l'atteggiamento di Pietro, impulsivo e contraddittorio, come più pericoloso per la riuscita dell'insurrezione, rispetto a quello di tutti gli altri apostoli.
Non è quindi da escludere che l'accusa giovannea relativa al fatto che Giuda fosse un ladro (12,6) sia in realtà il frutto di una manipolazione successiva, influenzata dalla tesi sinottica. Non dimentichiamo che in Matteo, su cui pesano le maggiori responsabilità della caricatura "economicistica" di Giuda, il nome del traditore viene svelato pubblicamente da Gesù (26,25).
Sia come sia resta da chiedersi il motivo per cui Giuda tradì e il motivo per cui si pentì d'averlo fatto. Tradì forse perché temeva l'insuccesso dell'impresa e lo fece nella convinzione che ai nazareni sarebbe stata risparmiata la vita, essendogli stato così promesso? Cioè tradì come politico e si uccise come uomo? Giuda era un estremista o un moderato? Nel racconto di Giovanni la parte dell'estremista sembra caratterizzare più Pietro che Giuda. Tant'è che quando Giuda contestò lo spreco del profumo a Betania, è probabile che non stesse affatto pensando al prezzo del profumo, quanto piuttosto al fatto che quella unzione regale fosse troppo prematura per l'esito della rivoluzione.
Qualcuno ha sostenuto che Giuda tradì l'uomo-Gesù, il democratico, perché così gli sembrava di valorizzare meglio il messia politico, quello rivoluzionario. Cioè egli tradì nella convinzione che mettendolo alle strette, di fronte all'eventualità di una sconfitta sicura, Gesù avrebbe rinunciato alle tentazioni "buoniste" (come in occasione dei "pani moltiplicati") e sarebbe passato decisamente all'attacco.
In realtà questo atteggiamento, diciamo "provocatorio", apparteneva più a Pietro che a Giuda, che invece rappresentava l'ala moderata dei Dodici, quella che cercava un compromesso col fariseismo progressista. Ma perché – ci si può chiedere – accettare un incarico decisivo ai fini della riuscita dell'insurrezione quando si nutrono dei dubbi sul suo esito? Perché non dichiarare apertamente il proprio dissenso? Perché far pagare ad altri le proprie divergenze? E soprattutto, perché, dopo aver rivelato al nemico l'intenzione di compiere la rivolta armata, decidere di rivelargli il luogo segreto del nascondiglio, accompagnando addirittura la coorte per catturare tutti gli apostoli? Giuda voleva forse sostituirsi al Cristo o dobbiamo credere alle versioni apocrife che lo vedono, essendo egli il figlio del fratello di Caifa, come un infiltrato antirivoluzionario sin dall'inizio?
Quel che è certo è che proprio la dinamica del tradimento esclude categoricamente la tesi della "morte necessaria". Infatti, quando Gesù si rese conto, dal ritardo di Giuda (la coorte romana andava preparata), che incombeva sugli apostoli un gravissimo pericolo, aveva deciso di andarsene dal cenacolo, non volendo che alcuno fosse catturato. Probabilmente disse ad alcuni discepoli, prima di recarsi all'Orto degli Ulivi, che sarebbe stato meglio disperdersi o che non lo seguissero, onde evitare il peggio per tutti.
Fra i più impulsivi di nuovo Pietro, che subito esclama: "perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te" (Gv 13,37). E qui, come tutti ben sanno, Gesù rispose con quella frase ad effetto, relativa al canto del gallo successivo al triplice rinnegamento dell'apostolo. Una frase che venne messa dai Sinottici con un chiaro intento apologetico, quello di giustificare la divina preveggenza del Cristo. Una soluzione mistica, questa, sicuramente efficace nella sua semplicità, ma molto meno profonda di quella che vede il tradimento di Giuda come il compimento del disegno divino sul sacrificio del nuovo agnello pasquale, per il riscatto degli uomini dalla maledizione del peccato originale. Giuda resta sì colpevole, ma solo sul piano morale, non su quello politico.
Nel vangelo di Giovanni si raggiunge poi l'apice del misticismo, sostenendo che proprio in virtù del tradimento subìto, Gesù ha potuto dimostrare fino a che punto era grande il suo amore per gli esseri umani. Giustificando il tradimento di Giuda, Giovanni ha giustificato il fallimento della rivoluzione, e con lui la chiesa intera ha giustificato il proprio tradimento.
Le varianti aggiunte al testo originario di Giovanni hanno sortito il loro effetto: l'ideologia dell'amore universale ha potuto sostituire l'esigenza della liberazione nazionale, e l'idea della "morte necessaria" ha potuto sostituire quella della "rivoluzione possibile". Di fronte a queste mistificazioni persino il tradimento di Giuda diventa ben poca cosa.
(torna su)30) Addendum
Si può parlare di estremismo politico nel tradimento di Giuda?
La figura di Giuda è tra le più interessanti nei vangeli, poiché il suo tradimento sta ad indicare che pur credendo nei medesimi ideali di giustizia degli altri compagni di lotta, un militante può compiere, spinto da motivazioni soggettive, cose che vanno in direzione opposta rispetto alla desiderata realizzazione di quegli obiettivi.
La storia di Giuda c'insegna tre cose fondamentali: 1. la giustezza di un ideale non garantisce della sua corretta applicazione; 2. l'incoerenza fra teoria e prassi è un frutto della libera volontà dell'uomo e non può essere impedita oltre un certo limite; 3. tale incoerenza porta a falsificare lo stesso ideale in cui inizialmente si credeva.
Giuda dunque non può aver tradito per denaro ma per motivi politici: probabilmente come Tommaso riteneva che l'insurrezione sarebbe fallita, non avendo il movimento di Gesù tra i Giudei il consenso sufficiente. Fu un errore, poiché il consenso l'aveva avuto proprio dopo la morte di Lazzaro, il cui movimento per i Giudei costituiva una grande speranza.
Il Giuda di Zullino (Rizzoli 1988)
Pietro Zullino è un outsider di professione, uno che ama i personaggi – come lui stesso li definisce – "maledetti" o "perdenti" della storia: già ha cercato di rivalutare Catilina e i sette re di Roma. Quali ne siano stati i risultati è presto detto. Con la tecnica del ballon d'essai, Zullino ha realizzato discreti scoop editoriali a sfondo scandalistico; in effetti, per quanto affermi il contrario, la storia proprio non gli interessa. Avvenimenti reali o completamente inventati per lui sono la stessa cosa: ciò che più gli preme è colpire il lettore con novità più o meno eclatanti e, naturalmente, vendere il più possibile.
Questa volta Zullino, nei panni d'un novello Sherlock Holmes, ha cercato d'imitare il suo collega Vittorio Messori che con le sue Ipotesi su Gesù (SEI 1976) aveva senza dubbio ottenuto un grande successo. Solo che una differenza purtroppo c'è: Zullino non ha né l'onestà intellettuale né la serietà professionale di Messori. È solo un giornalista rampante in cerca di fortuna. Messori però ha abboccato e s'è messo a fare, sulla rivista "Jesus", una diligente e canonica lezioncina, a puntate, circa la personalità, l'ideologia e la morte di Giuda, incluse le interpretazioni che ne sono state date (ovviamente restando nei limiti del confessionismo cattolico-romano). Sotto questo aspetto è difficile dire se sia preferibile un intellettuale di estrazione cattolica che si sforza di modernizzare il Cristo della chiesa romana, oppure quegli intellettuali laici travestiti da preti, lanciati dalla Rusconi in analoghe imprese (come ad es. O. Gurgo, che ha faticato su Pilato, nel 1987).
Dal canto suo, Zullino non è certo quell'eretico di cui si vanta, benché sulle prime appaia meno allineato di Messori. Si può forse considerare critica, seria, trasgressiva un'opera che dà per scontate le apparizioni di Gesù risorto, la sua ascensione, il primato di Pietro e altre favole del genere? Peraltro, già prima di lui non pochi esegeti hanno cercato di riconsiderare la figura di Giuda, liberandola dal marchio infamante del traditore. Di ammiratori dell'Iscariota si ha notizia sin dal II sec. d.C.: i cainiti (seguaci di Caino) ritenevano, ingenuamente o cinicamente, che il tradimento facesse parte di un provvidenziale "piano di dio", per cui la colpevolezza dell'apostolo andava di molto ridimensionata. Una tesi, questa, che nel corso dei secoli ha affascinato una sequela di poeti e scrittori (fra i contemporanei si possono citare i nomi di J. L. Borges, Finzioni; G. Berto, La passione secondo noi stessi; M. Brelich, L'opera del tradimento; F. Ulivi, Trenta denari, ecc.), i quali, più o meno laicamente, hanno intravisto nella sibillina frase di Cristo pronunciata nell'ultima cena: "Quello che devi fare, fallo presto", un vero e proprio invito alla diserzione.
Zullino dunque non ha fatto altro che accodarsi dietro le fila di questi maestri del trasformismo, per i quali – consapevoli dell'epoca in cui viviamo – i traditori diventano "uomini di coscienza", i ravveduti "uomini imbelli", i venali "uomini realisti" che conoscono le difficoltà della vita, e così via. Oggi la psicanalisi più dégagé vede addirittura in Giuda una figura simbolica, mitologica, creata da una comunità cristiana pentita d'aver rotto i suoi rapporti col giudaismo. Per tale comunità il traditore sarebbe stato non Giuda ma lo stesso Gesù!
Insomma, l'esempio dell'Iscariota, figlio di Simone, oggi è diventato un pretesto per compiacersi dell'idea secondo cui un uomo non può essere ritenuto responsabile delle sue azioni quando tutto lo induce a muoversi in una determinata direzione. Anzi, c'è di più. Giuda – si sostiene – non è una vittima delle circostanze (come ad esempio il Pilato dei vangeli) ma un eroe suo malgrado. Grazie, infatti, al tradimento (della cui portata egli certo non poteva essere consapevole) è nato il più grande mito della storia: il figlio di dio che s'immola per salvare l'umanità dai suoi peccati. Gloria a Giuda dunque, che ha avuto il coraggio di fare quello che gli altri apostoli non seppero o non vollero fare!
Stando dunque a Zullino, Giuda si aggregò alla comunità di Gesù quando questi, all'inizio della sua carriera messianica, frequentava gli ambienti del Battista. Gesù gli affidò la gestione della cassa comune. Essendo nativo della Giudea, l'apostolo non riuscì a vedere di buon occhio la cacciata dei mercanti dal Tempio di Gerusalemme, né accettò, in seguito, la predicazione rivolta ai pagani. Il gruppo minoritario dei Dodici (Giuda, Tommaso, Taddeo, Giacomo il minore e Simone cananeo) fu – a parere di Zullino – responsabile della secessione di Cafarnao, in occasione dei "pani moltiplicati", perché non si voleva un messia avversario del Tempio, né amico dei pubblicani (fra i quali Matteo e, più tardi, Zaccheo) o degli erodiani (come Chuza, funzionario di Erode). Proprio a causa di queste amicizie, Giuda, in qualità di cassiere, si rendeva conto di amministrare soldi di dubbia provenienza. Sommati a questi vi sono – secondo Zullino – molti altri fattori che a un certo punto indussero l'Iscariota a compiere in extremis il gesto disperato: vedendo Gesù circuito da erodiani e pubblicani, egli tradì perché si sentiva tradito.
Una ricostruzione – come si può facilmente notare – piuttosto fantasiosa, che ricalca, in buona parte, quella del teologo E. Stauffer, il quale vedeva in Giuda un figlio fedele della sinagoga. Ma la principale tesi di Zullino è un'altra. Egli sostiene che Giuda non si pentì – come risulta dalla versione di Matteo – restituendo i 30 sicli d'argento e impiccandosi a un albero, ma, al contrario, fu ucciso per vendetta o per precauzione, mentre si stava godendo il frutto della sua spiata, cioè l'acquisto di un podere nei pressi di Gerusalemme.
I mandanti di questo delitto possono essere stati – al dire di Zullino – sia il nemico n. 1 di Gesù, il sommo sacerdote Caifa, sia Pilato, ma anche i pubblicani e persino gli stessi apostoli, fra i quali i sospetti maggiori cadono su Giovanni e Tommaso. Nella versione degli Atti di Luca (1,15-19) risulta – secondo Zullino – che Giuda venne assassinato nel campo di Hakeldamà, alla periferia della capitale ebraica: il suo ventre fu trovato squarciato e nessuno si meravigliò di questa morte. Il racconto di Matteo venne in seguito elaborato per rendere meno imbarazzante la testimonianza di Pietro. (Dopo queste, molte altre sciocchezze vengono dette nel libro suddetto).
Ora, se c'è una cosa che, a questo punto, uno storico non dovrebbe assolutamente fare è proprio quella di dimostrare il contrario delle tesi di Zullino. Infatti, su quali basi si potrebbe farlo? Esistono forse, riguardo a tutta questa faccenda, fonti storiche attendibili? Messori ostenta coraggio nel rimproverare a Zullino e a certi esegeti "scomodi" – come A. Loisy, E. Renan, ecc. – che le loro interpretazioni rientrano nel "romanzo", ma la sua, che vanta una fedeltà pressoché letterale al Nuovo Testamento, può forse essere considerata storica?
In realtà, con le poche fonti di cui disponiamo, se vogliamo fare "quattro chiacchiere", tralasciando la discussione sulla loro autenticità, non possiamo che opporre romanzo a romanzo. Zullino, ad esempio, è convintissimo che la versione di Pietro offerta negli Atti di Luca sia più affidabile di quella matteana. Ma siamo veramente sicuri che Pietro voglia riferirsi all'omicidio di Giuda? Secondo alcuni esegeti tedeschi, poco conosciuti in Italia, proprio i versetti cui Zullino si appella (18-20 del c. 1), altro non sono che un'aggiunta posticcia allo stesso testo di Luca, usata per avvalorare l'idea che Giuda era un essere abietto e spregevole, destinato a una fine vergognosa. Idea che, ai tempi di Matteo (che ha scritto il vangelo prima degli Atti), non era ancora stata espressa in maniera così cruda. La decisione di restituire i soldi del contratto e quella d'impiccarsi facevano appunto pensare a un Giuda fondamentalmente onesto. E questo senza tener conto che anche la versione di Matteo (che dei quattro evangelisti è il più leggendario) non è molto tenera con l'Iscariota. Matteo infatti è responsabile della volgarissima accusa secondo cui Giuda avrebbe tradito per denaro.
Viceversa, nel racconto di Marco, che è più antico di Matteo, si parla di soldi solo nel senso che le autorità religiose avrebbero dato una ricompensa a Giuda, se questi fosse riuscito a consegnare loro Gesù. Come Marco possa sapere questo è difficile dirlo, ma di nient'altro si parla. Dal canto suo, Giovanni, che pur scrivendo per ultimo mostra a volte di conoscere le cose meglio degli altri, non accenna minimamente a particolari ricompense né a cifre prestabilite dallo stesso Giuda.
È vero, spesso gli esegeti si soffermano sull'episodio dell'unzione di Betania, allorché Giuda si scandalizzò nel vedere lo spreco che Maria, sorella di Lazzaro, fece cospargendo il capo e i piedi di Gesù di un profumo molto costoso. In quell'occasione egli avrebbe detto che sarebbe stato meglio venderlo e distribuire il ricavato ai poveri. Al che Giovanni obietta che Giuda disse questo non perché amasse i poveri, ma perché era un ladro e dalla cassa di tanto in tanto sgraffignava qualcosa. Oggi però anche sull'autenticità di questo versetto giovanneo si hanno molti dubbi. Sarebbe stato davvero poco intelligente rimproverare un apostolo che, almeno apparentemente o comunque senza cattiva fede, muoveva una giusta protesta.
È dunque probabile che pure in questo caso, come in tantissimi altri, si debba vedere la mano di qualche manipolatore del vangelo di Giovanni che, sulla scia della tesi di Matteo, abbia voluto evidenziare un Giuda non solo venale ma anche ipocrita. Gesù infatti gli risponderà che Maria aveva riservato a lui quel profumo, per il giorno della sua morte (secondo l'usanza ebraica), e che pertanto non poteva essere rimproverata se aveva voluto usarlo prima: ai poveri non era stato tolto niente.
Di tutto ciò Giuda non poteva certamente essere a conoscenza. Se di una cosa l'apostolo così attento alle questioni sociali poteva essere rimproverato, era semmai la scarsa attenzione prestata al rapporto umanissimo fra Gesù e Maria. Quest'ultima infatti aveva deciso d'usare in anticipo quel prezioso nardo per ringraziarlo d'averle riportato in "vita" (simbolicamente parlando, s'intende) il fratello Lazzaro. Che poi in questo gesto l'esegesi cattolica abbia creduto di vedere, erroneamente, una consapevolezza profetica, da parte di Maria, dell'imminente morte di Gesù, questo è un altro discorso. E qui non è neppure il caso di parlare del fatto che quella di Lazzaro non fu affatto una resurrezione ma al massimo una guarigione, se non addirittura una metafora della ripresa del movimento di liberazione della Palestina, di cui lo stesso Lazzaro era stato attivo fautore. Sicché l'unzione di Maria fu in realtà un'anticipazione della vittoria imminente del Cristo a Gerusalemme, cui Giuda rispose avanzando delle riserve sui tempi.
Il vangelo di Marco, che solo di recente, dopo quasi duemila anni di oblio, si è cominciato a considerare come il più significativo dei Sinottici, lascia completamente in ombra il movente del tradimento. Ma se diamo ragione all'opinione di S. Brandon (Gesù e gli zeloti, Rizzoli 1983), secondo cui tale vangelo tende a conciliare l'ideologia cristiana col potere politico dell'impero romano, si può ragionevolmente credere che il suddetto movente sia stato più "elevato" o meno "ignobile" di quel che in genere si creda.
Presentando infatti un Cristo spoliticizzato al massimo, Marco non poteva che censurare un personaggio scomodo come Giuda. Il suo merito naturalmente non sta in questo, ma nell'aver evitato di fornire un'immagine fortemente deformata dell'apostolo. Che questi comunque non sia stato quel "mostro di cattiveria" dipinto solitamente dalla chiesa, da un pezzo molti lo credono: persino un ingenuo come G. Ricciotti s'accorse, a suo tempo, che il gesto di riconsegnare il denaro ai preti mal si addiceva al cliché del Giuda avaro o esoso.
D'altra parte, lo stesso Matteo lascia intendere che la somma corrisposta e restituita non aveva altro scopo che quello di confermare una profezia di Geremia (che poi, invece, era di Zaccaria). Per non parlare del fatto che i 30 sicli d'argento sono identici al prezzo fissato dalla legge mosaica per la vita di uno schiavo ucciso (Gesù infatti nei vangeli appare come uno schiavo: o perché trattato così dai Romani, o perché lui stesso, pur essendo dio, scelse di vivere così).
In realtà, sin dal 1828 l'ipotesi più interessante con la quale si è cercato di spiegare il motivo del tradimento e, di conseguenza, l'omertà e le falsificazioni dei vangeli (che sono testi sì politici, ma sostanzialmente conservatori), è sempre stata quella dell'estremismo politico che caratterizzava l'apostolo della Giudea. Allora il primo a sostenerla fu H. E. G. Paulus, con la sua famosa Vita di Gesù; oggi il già citato Brandon, E . Schweizer e altri ancora. D. Rops sostiene sì il motivo politico, ma nel senso che Giuda tradì perché Gesù non voleva dare alcun adito alle ambizioni temporali (col che, in ultima istanza, si finisce col condividere l'interpretazione evangelica).
Giuda insomma – questa la miglior tesi fino a oggi proposta – trovatosi profondamente deluso dall'immobilismo di Gesù, ne avrebbe provocato l'arresto per costringerlo a prendere il potere con un colpo di mano, o comunque per sollecitare la folla di Gerusalemme a un'insurrezione antiromana nel momento cruciale della Pasqua. Giuda dunque sarebbe stato un estremista vicino alle posizioni zelote. La stessa denominazione di "Iscariota" non indica – come vogliono alcuni – la città di provenienza, bensì la trascrizione semitica di sicarius, termine col quale i Romani designavano gli zeloti o comunque l'ala più radicale di questo partito. Peraltro anche l'apostolo Simone cananeo era uno zelota21 e l'appellativo di "barjona" riferito a Pietro in Mt 16,17 può benissimo significare "ribelle" o "fuorilegge" (vedi le tesi di F. Schulthess, riprese da O. Cullmann).
Che Giuda fosse un estremista e non un conservatore – come crede Zullino – lo si capisce proprio dal racconto giovanneo dei pani moltiplicati, che è il più politicizzato dei quattro. Giuda cominciò a pensare di tradire Gesù nel momento stesso in cui lo vide rifiutare il trono d'Israele di fronte a cinquemila persone che glielo offrivano (non dimentichiamo che la guarnigione romana stanziata a Gerusalemme era composta soltanto di 600 soldati). Diversamente da come vuole Zullino, Giuda, forse più degli altri apostoli, sperava che Gesù approfittasse della popolarità acquisita per muovere subito contro il potere di Roma e dei suoi alleati (sadducei, anziani, sommi sacerdoti, erodiani, ecc.).
A Cafarnao invece Gesù declinò l'invito della folla perché s'era reso conto ch'essa voleva la sua elezione monarchica, non in quanto lo riteneva superiore a Mosè, e quindi capace di rinnovare profondamente i valori e la prassi esistenti, ma solo in quanto lo riteneva capace di ripristinare le vecchie consuetudini ebraiche, ridando lustro a un'antica e gloriosa tradizione, quella dei tempi di Davide e Salomone.
Praticamente la stessa cosa si ripeté a Gerusalemme in occasione dell'ingresso messianico. Anche Giuda ha la stessa fretta di veder realizzato il regno e non riesce ad accettare il realismo e le scelte tattiche del messia. Nel racconto giovanneo dell'ultima cena Gesù, temendo seriamente che qualcuno, con decisioni impulsive, lo potesse costringere a fare cose che non avrebbe voluto fare, verifica la fiducia degli apostoli nella scelta dei suoi tempi e nella sua strategia... lavando loro i piedi! Fu un gesto simbolico, ma di grande effetto. Tentato dal rifiutarlo, Pietro non riusciva a sopportare che l'imminente re d'Israele si abbassasse a quel livello. Ma il candidato al trono voleva soltanto far capire che non avrebbe preso il potere senza una vasta e cosciente partecipazione popolare: il suo messianismo o veniva accettato in tutta la sua umana democraticità, oppure era meglio rinunciare all'impresa, poiché le conseguenze, al cospetto dell'impero schiavista più forte del mondo, sarebbero state pesanti per tutti.
Durante il trionfo dell'ingresso messianico, a chi pretendeva di vedere nel messia un superman capace d'imporsi con la forza della sua autorità, il Cristo aveva risposto d'essere soltanto un "figlio dell'uomo" che per poter vincere l'oppressore romano aveva prima bisogno d'essere "innalzato", cioè eletto, appoggiato democraticamente dalle masse popolari.
Giuda però questa volta non si lascia sorprendere: per lui le masse erano soltanto un gregge da guidare, una forza da usare a propria discrezione. Ecco perché rifiuta, pur senza manifestarlo, la lavanda dei piedi. La sua alternativa ormai è un'altra: "O reagisci alla mia provocazione prendendo a tutti i costi il potere, oppure ne esci sconfitto, ma allora non eri tu il messia che attendevamo". Probabilmente Giuda era anche convinto che, comunque fossero andate le cose, nessuno avrebbe potuto rimproverarlo d'aver tradito. Viceversa Gesù, non intenzionato a imporre un regime di terrore psicologico all'interno del collegio apostolico in un momento così delicato, cercava di dissuadere chiunque dal non prendere iniziative personali.
In particolare con l'Iscariota il Cristo usa molto tatto e diplomazia: lo vuole vicino a sé durante la cena, gli offre con gesto di grande familiarità un boccone di cibo e lo incarica di una missione molto importante, sconosciuta – dice Giovanni – agli altri apostoli. La famosa frase di Gesù: "Quello che devi fare, fallo presto", va appunto intesa in questo senso, che Gesù voleva sapere, prima di decidere il piano d'azione insurrezionale, qual era l'ultima parola dei possibili alleati (in primo luogo i farisei, ma anche gli zeloti, i battisti, gli esseni...), cioè su quali forze poteva effettivamente contare.
Cosa poi sia successo mentre Gesù e gli altri apostoli attendevano la risposta e mentre cercavano di sottrarsi alla cattura ritirandosi nel rifugio del Getsemani, è facile immaginarlo, anche se impossibile dimostrarlo. Ottenuta una risposta negativa o insoddisfacente, Giuda avrà deciso a quel punto di agire come la sua coscienza gli comandava.22
Quando si osservano atteggiamenti di questo tipo è difficile individuare il meccanismo che li fa scattare. Indubbiamente la tendenza a credere che nelle situazioni di conflitto esasperato sia più facile conseguire determinati obiettivi di giustizia e di libertà, può diventare una forte sollecitazione interna. Normalmente, però, una convinzione del genere porta o a sopravvalutare le proprie forze o a sottovalutare quelle dell'avversario. Sia come sia, la logica fatalistica e insieme volontaristica del "tanto peggio tanto meglio" resta assolutamente inaccettabile.
Il desiderio di creare situazioni-limite, altamente esplosive, senza tener conto delle reali forze in campo, riflette non solo una grande sfiducia nelle potenzialità delle masse, ma anche una concezione individualista dell'esistenza, che facilmente sbocca verso soluzioni terroristiche o comunque velleitarie. Peraltro, proprio a queste soluzioni si deve – stando alla cronistoria di Giuseppe Flavio – la trasformazione della Palestina in un cumulo di pietre fumanti.
(torna su)31) L’arresto di Gesù
Gv 18,1-18 - Mc 14,43-54 (fonti)
Durante l'ultima cena Gesù aveva incaricato Giuda di svolgere una mansione decisiva in tempi brevi ("Quello che devi fare, fallo presto", Gv 13,27), di cui possiamo soltanto vagamente immaginarci la natura, essendo quella cena l'ultima prima dell'insurrezione armata, che forse doveva avvenire in quella stessa notte.
Il fatto che Gesù avesse incaricato Giuda, in un momento così delicato, e non un qualunque altro apostolo che fino a quel momento era stato sicuramente molto più protagonista di lui, ci fa pensare che quell'incarico poteva svolgerlo solo lui, o che comunque lui fosse in quel momento la persona più indicata (probabilmente a motivo delle sue origini giudaiche, cioè non galilaiche, oppure a motivo delle sue conoscenze o del suo passato politico in Giudea).
Sappiamo che alcuni apostoli provenivano dall'ambiente battista, altri dal quello zelota: Giuda forse proveniva dal fariseismo progressista (quello di Nicodemo, Giuseppe di Arimatea...). Se è così, allora è possibile ipotizzare che Giuda dovesse avvisare i farisei e i gruppi politici che avevano organizzato l'ingresso trionfale del messia nella capitale, che l'insurrezione era imminente, per cui dovevano tenersi pronti a intervenire in maniera costruttiva, cercando di renderla meno cruenta possibile.
Dal momento che Giuda tardava a tornare, Gesù e gli apostoli rimasti cominciarono a preoccuparsi: forse non pensarono subito a un tradimento, ma a un incidente, a una qualche fatalità che aveva impedito a Giuda di tornare indietro. Fatto sta che ad un certo punto decisero di abbandonare il cenacolo e di rifugiarsi al di fuori delle mura, in un bosco sopra un monte: il Getsemani, detto Orto degli Ulivi.
Poiché non possiamo credere che Gesù avesse scelto di affidare l'incarico a Giuda proprio perché lo sospettava di tradimento, né perché volesse metterlo alla prova in un momento così cruciale per la riuscita della rivoluzione, dobbiamo anzi pensare il contrario, e cioè che Gesù desse per scontato che Giuda avrebbe eseguito il compito senza discutere.
Durante l'ultima cena Gesù s'era raccomandato di stare uniti, di rispettare alla lettera le disposizioni comuni, di non prendere iniziative personali: Giuda in quel momento era stato incaricato di eseguire un compito decisivo ai fini della riuscita della rivoluzione. Se qualcosa andò storto, non fu perché lui aveva da tempo preventivato di tradire (come in genere i vangeli vogliono farci credere), ma proprio perché lo fece a insaputa di tutti. Partì dal cenacolo con un'intenzione e vi ritornò con tutt'altra intenzione.
Dobbiamo anzi dare per scontato che Giuda non sospettasse affatto che Gesù stava subodorando un tradimento, per cui, in prima battuta, mentre guidava le guardie per catturarlo, si sarà recato al cenacolo, convinto di trovarli ancora tutti lì. Soltanto quando vide che non c'era nessuno, pensò che si fossero rintanati nel solito nascondiglio: il Getsemani, dove la cattura, a motivo anche del buio, sarebbe stata sicuramente più difficoltosa.
Probabilmente fino al cenacolo si pensò che le guardie del Tempio potessero essere sufficienti, ma sicuramente per entrare nel Getsemani si aveva bisogno di un ulteriore rinforzo militare, che venne offerto da Pilato.
Perché Giuda tradì? Se voleva la Palestina libera e non credeva nella rivoluzione, perché non era uscito prima dal movimento nazareno? Ha forse fatto il doppio gioco sin dall'inizio? Era forse un infiltrato di Caifa o dei farisei? Com'è possibile che ad un uomo così poco affidabile il Cristo avesse dato in quella notte una missione così delicata da compiere? Se invece militava nei nazareni convinto di poter liberare il suo paese, perché decise di tradire? Se a questa domanda dessimo questa risposta: Giuda era un moderato che tradì in buona fede, convinto di fare gli interessi del suo paese, saremmo molto lontani dalla verità? Oppure dobbiamo pensare che Giuda tradì perché, vedendo l’indisponibilità dei farisei progressisti, temeva che il Cristo avrebbe rinunciato all’insurrezione, come già aveva fatto al tempo dei cosiddetti "pani moltiplicati"? E quindi pensava che le folle di Gerusalemme, vedendo l’ennesimo leader catturato dai Romani, si sarebbero ribellate in massa, a dispetto dei loro partiti opportunisti e contro le loro istituzioni colluse col nemico?
Quando Gesù entrò trionfante a Gerusalemme, in groppa a un asino, in segno di umiltà ma facendo chiaramente capire che i tempi erano maturi per l'insurrezione, i farisei erano molto indecisi sul da farsi: da un lato avrebbero voluto fermarlo, dall'altro si chiedevano se non fosse il caso di appoggiarlo. È contro quest'ultimi che si scaglia Caifa, chiedendo che il messia venga catturato prima che i Romani reagiscano con violenza.
Dopo la vicenda di Lazzaro di Betania (in cui la sua "resurrezione" va letta come metafora della ripresa della battaglia rivoluzionaria) il Cristo avrebbe voluto entrare subito a Gerusalemme, ma vi fu impedito da una riunione del Sinedrio, in cui si decise ufficialmente la sua morte, o comunque che bisognava assolutamente arrestarlo e consegnarlo ai Romani: era la prima volta che i farisei accettavano una risoluzione del genere. Per questo motivo gli apostoli con lui resteranno nella clandestinità presso Efraim (Gv 11,54) almeno sino all'imminenza della Pasqua.
A Betania doveva essere successo qualcosa di politicamente molto significativo, poiché Giovanni scrive che, al vedere Gesù uscire dalla clandestinità coll'intenzione di entrare nella capitale, "molti credevano in lui" (11,45) e i partiti politici di Gerusalemme s'erano divisi sull'atteggiamento da tenere.
I farisei progressisti erano dell'avviso che bisognasse appoggiare l'iniziativa dell'insurrezione, anche se temevano le conseguenze da parte non tanto della guarnigione romana stanziata nella capitale, che in fondo era ben poca cosa, quanto piuttosto delle legioni imperiali che sicuramente sarebbero intervenute col peso di tutta la loro forza. Essi volevano la liberazione della Palestina, ma temevano di prendere decisioni risolute in senso rivoluzionario, preferivano temporeggiare, nella speranza di poter logorare il potere romano con la politica dei "piccoli passi", che però fino a quel momento non aveva dato alcun frutto tangibile.
Fu Caifa che, nel corso della riunione parlamentare, fece una proposta che lasciò tutti spiazzati. Disse che se avessero lasciato fare i nazareni, Israele sarebbe stata perduta, poiché essi non fruivano di appoggi popolari e istituzionali sufficienti; se invece avessero arrestato il Cristo, Roma li avrebbe considerati più affidabili a livello istituzionale e avrebbe aumentato le loro libertà di manovra. Caifa insomma quando affermò, rivolto ai farisei, quella frase che appariva come una sentenza di morte: "Voi non capite! Non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione" (Gv 11,50), aveva dato sfoggio di tutta la sua abilità di consumato politico, abituato a guardare la realtà dalle finestre del suo palazzo.
E magari qualche cinico, tra i sinedriti, avrà pensato che se la responsabilità dell'esecuzione del messia fosse ricaduta interamente sui Romani, si sarebbe anche potuto ottenere una ribellione in massa della popolazione, stanca di vedere infranta ogni speranza di liberazione. E solo a quel punto le istituzioni giudaiche avrebbero dovuto guidare la rivolta antiromana.
Il quarto vangelo poi qui si diverte a equivocare sul significato delle parole. Il fatto che si volesse "Gesù morto per la nazione e anche per unire i figli di Dio dispersi" (Gv 11,51 s.) cosa stava a significare concretamente? Forse ch'era meglio collaborare con Pilato nel sacrificare un leader ebraico, evitando così la ritorsione dell'occupante e salvare il paese? Oppure che – come vuole l'interpretazione cristiana – grazie alla morte del Cristo s'è potuto porre fine al primato etico-politico della nazione d'Israele, aprendo le porte alla salvezza spirituale di tutto il genere umano? Davvero di fronte allo scandalo di una nuova esecuzione capitale da parte dei Romani l'intera popolazione d'Israele (e non solo quindi quella Giudea) sarebbe insorta in massa? Il Cristo andava quindi "sacrificato" per il bene della nazione oppressa e degli ebrei della diaspora?
È assodato che la stragrande maggioranza dei gruppi, movimenti e partiti politici dell'intero paese volesse la liberazione nazionale, ma sui metodi da usare per realizzare questo obiettivo non ci si trovava mai d'accordo. È molto probabile, in quel momento, che, vedendo la decisione dell'ala conservatrice del Sinedrio di catturare Gesù per consegnarlo ai Romani, l'ala progressista dei farisei fosse ancora intenzionata ad appoggiare una qualche iniziativa rivoluzionaria, seppur senza impegnarsi in prima fila.
Giuda era forse stato incaricato di chiedere definitivamente ai farisei progressisti da che parte stessero, e dalla risposta che poteva ottenere, Gesù avrebbe deciso la relativa tattica: non è da escludere ch'egli si sarebbe accontentato di una dichiarata neutralità da parte dei farisei. Doveva soltanto saperlo presto, anche perché, in caso contrario, non gli restava che nascondersi nel Getsemani o addirittura fuggire dalla città santa.
È probabile, a questo punto, che lo stesso Giuda si sia o sia stato convinto a comportarsi come non avrebbe voluto, cioè è probabile che gli siano state fatte delle promesse, delle assicurazioni, traendolo in inganno. Giuda fu traditore suo malgrado, tradì per debolezza, superficialità, errato senso del dovere, protagonismo fuori luogo... di certo non tradì per denaro.
*
Qui tuttavia, mettendo a confronto la versione del quarto vangelo con quella dei Sinottici, vien spontaneo chiedersi il motivo per cui Giovanni abbia avvertito il bisogno di riscrivere la cattura di Gesù quando l'episodio era già stato abbondantemente trattato prima. Perché ripetere cose già dette quando risultavano assodate almeno quattro cose:
– che Giuda fosse il traditore;
– che fosse lui la guida del manipolo nel Getsemani;
– che Gesù non oppose resistenza al suo arresto;
– che qualcuno tra i discepoli reagì cercando di uccidere un servo del sommo sacerdote.
Rispetto a queste cose, condivise dai Sinottici, che cosa si poteva dire di più o di diverso? In realtà vi sono alcune differenze sostanziali tra Giovanni e gli altri vangeli che l'hanno preceduto. E ora bisogna vederle estesamente.
Il trasferimento dal cenacolo al Getsemani avvenne per motivi di sicurezza. Anche Luca sa che "di notte il Cristo – dopo aver insegnato di giorno presso il tempio – usciva dalla città di Gerusalemme e se ne stava all'aperto, sul monte degli Ulivi" (21,37). Ogni tanto Luca sorprende per certe informazioni cripto-politiche che rilascia autonomamente, come quando ad es. dice che Gesù raccomandò ai discepoli di vendere il mantello per procurarsi una spada (22,36), e tuttavia qui egli non s'accorge che il trasferimento dal cenacolo al Getsemani era avvenuto proprio per motivi di sicurezza.
I Sinottici, in effetti, su questo trasferimento forzato sono piuttosto reticenti, in quanto non possono far vedere che il Cristo "non voleva" morire. La loro tesi è che al Getsemani, accompagnato dai discepoli, Gesù andò non tanto per nascondersi quanto per "pregare" dio di aiutarlo ad affrontare con coraggio l'ultima prova della sua vita, e questo mentre tutti, inclusi i tre prediletti, dormivano della grossa, o perché stanchi, o perché l'ora era tarda, in ogni caso del tutto ignari del pericolo incombente. Giovanni invece capovolge la situazione e dice che tutti erano ben svegli e preoccupati.
Gesù si era deciso per il trasferimento dal cenacolo al Getsemani solo dopo aver visto che Giuda tardava a compiere l'incarico che gli era stato affidato. Invece di scegliere la soluzione della fuga precipitosa in ordine sparso, preferì la soluzione più rischiosa, ma che offriva maggiori chances nel caso si fosse stati costretti a patteggiare qualcosa. Cioè se il Cristo si fosse nascosto da solo nel Getsemani e avesse lasciato gli Undici nel cenacolo, liberi di fare quello che volevano, probabilmente avrebbero catturato tutti. Viceversa, stando tutti uniti, egli poté usare se stesso come merce di scambio per la liberazione dei discepoli.
Quindi è da escludere ch'egli abbia detto loro che dove andava lui loro non avrebbero potuto seguirlo (Gv 13,31-38). Al massimo possono aver discusso su che cosa fare nell'eventualità che avessero catturato Giuda o che questi avesse tradito. Forse possono aver pensato a una fuga in ordine sparso, poi, vedendo Pietro che insisteva nel volersi nascondere col Cristo nel Getsemani, in quanto temeva che se l'avessero lasciato solo sicuramente l'avrebbero catturato, tutti gli altri si saranno adeguati. È poi probabile la spacconata di Pietro quando dice che se anche avesse dovuto morire non l'avrebbe mai tradito, ma è del tutto inverosimile la profezia del Cristo relativa alla coincidenza di terzo rinnegamento e canto del gallo.
Peraltro qui gli esegeti hanno sempre pensato che nell'ultima cena fossero presenti soltanto i dodici apostoli, ma, trattandosi di una riunione clandestina, è impensabile immaginare che non vi fossero altre persone a garantire un certo servizio d'ordine: la richiesta di vendere il mantello per comprare una spada non può essere stata fatta agli apostoli, che dal periodo della clandestinità giravano sempre armati.
Se al Getsemani vi fosse stato uno scontro cruento tra ebrei, le conseguenze sarebbero state imprevedibili. Il fatto stesso che le guardie guidate da Giuda chiedano soltanto di catturare Gesù è indicativo. Giovanni dice esplicitamente che "quando si avvicinò la Pasqua, molti dalle campagne salirono a Gerusalemme per purificarsi prima della festa. Là cercavano Gesù..." (11,55 s.). Non lo cercavano tanto per salutarlo o incoraggiarlo, quanto per mettersi a sua disposizione. Solo un irresponsabile infatti avrebbe potuto fare un'insurrezione nella capitale presidiata dai Romani, senza avere un sicuro riscontro popolare.
Giovanni fa capire due cose: che Gesù non voleva essere catturato e che veniva data a Giuda una seconda possibilità per non tradire, quella di non rivelare il nascondiglio segreto. Giuda avrebbe potuto portare le guardie al cenacolo, costatare che non vi era più nessuno, sostenere che non conosceva nessun altro posto ove avrebbero potuto nascondersi e tutti se ne sarebbero tornati a casa. L'unico a rimetterci della figuraccia sarebbe stato lui, che peraltro non avrebbe potuto trovare parole adeguate per giustificarsi di fronte al collegio apostolico.
Nei Sinottici appare esattamente il contrario, e cioè che Gesù aveva scelto quel luogo proprio perché Giuda lo conosceva bene, per cui poteva tradirlo in tutta tranquillità, come se tra i due vi fosse stata una preliminare intesa, un accordo "in nome di dio".
Tra la polizia giunta per arrestarli non c'era solo quella giudaica ma anche quella romana. Questa precisazione di Giovanni è stata oggetto di moltissime controversie, in quanto fa chiaramente capire come sin dall'inizio il movimento nazareno risultasse inviso alle autorità di Roma. Pilato doveva necessariamente sapere che Gesù era un leader che stava preparando un'insurrezione armata.
Nessuno dei Sinottici dice questa cosa: Marco parla di "molti uomini armati di spade e bastoni mandati dai capi dei sacerdoti, dai maestri della legge e dalle altre autorità" (14,43). Matteo e Luca, che in questo copiano da Marco, dicono la stessa cosa. Chi siano le "altre autorità" non è dato sapere: certamente dai Sinottici, costantemente preoccupati a dimostrare l'affidabilità politica dei cristiani al cospetto di Roma, non si potrà mai scoprire ch'erano quelle romane.
Giovanni non parla solo di "coorte romana" ma anche di guardie messe a disposizione dai farisei (18,3): quindi è da escludere che i farisei progressisti non sapessero di questa iniziativa.27 Il termine tecnico usato da Giovanni per indicare i Romani è stato preso dal linguaggio militare di quel tempo: la cohors era un decimo della legione, quindi circa 600 uomini. Un numero che agli esegeti è parso subito eccessivo per un'operazione del genere. Va detto però che a volte il termine in questione veniva usato per indicare anche solo un terzo della coorte, per cui in tal caso può essersi trattato di un manipolo di 200 soldati. Sarebbe stato d'altra parte insensato lasciare totalmente sguarnita la fortezza Antonia, ove appunto era acquartierata una coorte di circa 600 militari.
La presenza massiccia di queste forze militari giudaico-romane, guidate da un tribuno (Gv 18,12), fu probabilmente richiesta dalle stesse autorità giudaiche, che non volevano rischiare, essendo molto favorevole l'occasione insperata del tradimento di Giuda, che il messia riuscisse a fuggire, né che a causa del suo arresto scoppiasse un tumulto popolare in città. Con una scorta così numerosa e ben armata sarebbe stato difficile ai nazareni organizzare in fretta una controffensiva.
Non fu Giuda a indicare con un bacio Gesù alle guardie, affinché lo individuassero con sicurezza nel buio e lo catturassero, ma fu lo stesso Gesù che si fece riconoscere e arrestare. Sono versioni molto differenti dei fatti. In quella sinottica si ha l'impressione che Cristo sia stato colto di sorpresa e che senza quel bacio forse non sarebbero stati in grado di catturarlo: il che contraddice l'intera impostazione sinottica che nella cattura di Gesù vede qualcosa di inevitabile, utile alla tesi della "morte necessaria" del messia. Tale contraddizione ha fatto pensare che il bacio in realtà fosse stato inserito non tanto secondo la motivazione che ne dà Giuda, cioè come gesto di riconoscimento certo dell'identità della persona da arrestare, quanto allo scopo di mostrare il traditore nella veste più abietta e spregevole possibile. È impensabile infatti che le autorità non sapessero chi fosse Gesù, dopo anni di predicazione pubblica, anche nella capitale. Il gesto del bacio è stato descritto sulla scorta di precedenti veterotestamentari più o meno analoghi (Gen 27,26 ss.; 2Sam 15,5; 20,9; Prov 7,13; 27,6 ecc.), a meno che qui non si voglia sostenere che le prime guardie incontrate dal Cristo fossero esclusivamente quelle romane, che forse lo conoscevano più di fama che di persona.
Resta comunque singolare, in tal senso, che gli stessi Sinottici facciano dire al Cristo una frase, al momento della cattura, in netto contrasto col significato del bacio di Giuda: "Siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come se fossi un delinquente! Tutti i giorni ero in mezzo a voi, insegnavo nel Tempio, e non mi avete mai arrestato" (Mc 14,48 s.). Una frase, questa, storicamente priva di senso, in quanto da tempo – stando a Giovanni – Gesù viveva nella clandestinità, e che è stata messa soltanto per indurre a credere ch'egli non era un messia politico, per cui alla sua cattura furono totalmente estranei i Romani.
I Sinottici inoltre si sono sentiti in dovere di giustificare l'anomala presenza di tutta quella polizia armata di "spade e bastoni": per non far vedere che gli apostoli erano armati, sono stati costretti a far dire a Gesù ch'era un pacifista assoluto, contrario persino alla legittima difesa, facilmente catturabile in qualunque momento. Poi quando non potranno tacere che Pietro aveva una spada con cui cercò di ammazzare una di quelle guardie, presenteranno la cosa mostrando tutta l'ingenua impulsività dell'apostolo, che non sapeva quel che stava facendo e che in fondo girava armato all'insaputa del messia o addirittura contro la sua volontà. In realtà il nome di Pietro non viene neppure fatto: i Sinottici si limitano a dire "uno di loro", avendo troppo scrupolo nel presentare uno dei futuri capi della chiesa cristiana armato di tutto punto.
Al gesto inconsulto di Pietro i Sinottici cercheranno di rimediare con giustificazioni al limite del ridicolo, quando non patetiche come quella di Luca, che induce il Cristo a riattaccare l'orecchio alla testa del servo Malco. Matteo addirittura farà dire a Gesù che se volesse potrebbe chiamare "dodici migliaia di angeli" (26,53) con cui sterminare tutti!
L'importante insomma per i Sinottici è far apparire il Cristo un pacifista ad oltranza, assolutamente contrario ad ogni forma di violenza: "Tutti quelli che usano la spada moriranno colpiti dalla spada" (Mt 26,52), profetizza al bellicista Pietro.
Da notare, en passant, che solo Giovanni cita il nome di Malco (17,10). Ciò ha dell'incredibile: Giovanni conosceva di persona uno dei servi principali del sommo sacerdote (che poi si scoprirà non trattarsi di Caifa ma di suo suocero Anna o Anania, che in quella carica l'aveva preceduto e che evidentemente aveva conservato il titolo onorifico).
La spontanea consegna del messia fu in realtà l'esito di una trattativa, accettata dalle guardie: Gesù si offriva volontariamente, a condizione che lasciassero liberi gli apostoli, altrimenti questi si sarebbero difesi. In tal modo non vi sarebbero stati morti o feriti e l'arresto sarebbe potuto avvenire in tutta tranquillità, senza rischio di svegliare l'intera città.
Il fatto che fossero andati con armi e bastoni lasciava capire che ritenessero il movimento nazareno non solo politicamente ma anche militarmente pericoloso. Lo stesso Giuda doveva averli avvisati che non avrebbero avuto a che fare con gente che si sarebbe lasciata prendere senza difendersi. Infatti se si fosse stati convinti che il movimento era disarmato, non si sarebbe andati con spade e bastoni: era sufficiente andare in massa.
Nella versione di Giovanni le guardie, una volta giunte all'interno dell'oliveto, stentano a credere, di primo acchito, che Gesù parli per primo, rischiando così di lasciarsi facilmente individuare e catturare. Temono una trappola. Gesù ha bisogno di porre due volte la stessa domanda: "Chi cercate?". Doveva essersi in qualche modo accorto della enorme sproporzione delle forze in campo, a differenza di Pietro, che invece volle intervenire colpendo di spada una delle guardie. Sicché Gesù, vista la situazione disperata, pensò subito a intavolare una trattativa: "Sono io! Se cercate me, lasciate che gli altri se ne vadano" (Gv 18,8).
S'egli non avesse fermato in tempo Pietro, in quel bosco si sarebbe compiuta una strage. Gli apostoli erano del tutto impreparati ad affrontare quell'emergenza: i Sinottici addirittura, per dimostrare che il trasferimento nel Getsemani non aveva alcun carattere politico-militare ma soltanto religioso, in quanto vi fanno "pregare" il messia, affermano unanimi che i discepoli stavano tutti dormendo. L'aspetto comico di questa versione è che poi sono proprio i Sinottici a descrivere con dovizia di particolari tutto quello che di "mistico" fece Gesù in quel frangente, come se tutti fossero lì a osservarlo.
Il fatto che dormissero ha indotto i Sinottici a sostenere la versione che i discepoli non si aspettavano assolutamente che il tradimento si sarebbe verificato in quel modo, in quel momento, in quel luogo, sicché, al momento del risveglio, paiono come terrorizzati e sono indotti ad abbandonarlo e a fuggire. Pietro, nei Sinottici, appare sì impulsivo, ma come un eroe disperato, che non sa esattamente cosa fare.
In Giovanni la situazione è del tutto capovolta: invece di tacere, Gesù si fa avanti; invece di aspettare che vengano scoperti, si fa scoprire; vuol dominare il più possibile gli avvenimenti prima che questi prevalgano da soli; vuole scongiurare inutili e irresponsabili estremismi. È lui che si fa catturare, non per adempiere alla volontà di dio, ma per evitare una sicura sconfitta, forse nella speranza che s'illudessero, catturando soltanto il leader di un movimento, di aver distrutto tutto il movimento.
Giovanni conclude dicendo che due apostoli tornarono indietro per vedere dove conducevano Gesù: erano Pietro e Giovanni (18,15). Nei Sinottici invece fuggono tutti, ad eccezione di un giovanetto (forse lo stesso Marco), che provò a seguirli, ma invano: dovette anche lui fuggire, dopo aver lasciato il lenzuolo con cui era vestito nelle mani degli inseguitori (Mc 14,51 s.). La figura di questo giovanetto pare essere più metaforica che realistica, in quanto la cattura di Gesù è avvenuta nel Getsemani, cioè in un luogo che per gli apostoli andava considerato come un rifugio segreto, dove assai difficilmente avrebbero portato, in quel momento così pericoloso, un ragazzino imberbe. Si pensa che l'immagine sia una sorta di "firma di autenticità" dello stesso redattore Marco.
Ma la cosa più stupefacente che a questo punto dice Giovanni è che i due apostoli poterono entrare nel palazzo del sommo sacerdote Anna e ascoltare il primo processo davanti alle autorità giudaiche, proprio perché Giovanni era conosciuto dallo stesso Anna. Dunque – ci si può chiedere – se Giovanni aveva aderenze del genere a Gerusalemme, perché incaricare Giuda di compiere quella missione così delicata? Forse perché la missione era rivolta proprio a quei farisei progressisti che non avrebbero visto di buon occhio un ambasciatore come Giovanni, i cui trascorsi, ai tempi del discepolato presso il Battista, avevano riguardato anche gli ambienti di Anna? Quando il Cristo cacciò i mercanti dal Tempio Giovanni era un seguace del Battista e decise di lasciare quest'ultimo proprio in seguito a quella energica "purificazione", cui il Battista non volle partecipare. Anche il fariseo Nicodemo era sul punto di farsi seguace del Cristo, ma all'ultimo momento declinò l'offerta. Può darsi che in quell'occasione fu proprio Giuda a staccarsi dal fariseismo progressista.
(torna su)32) L'udienza da Anania
Gv 18,19-27 - Mc 14,53-65
Nel racconto dell'arresto di Gesù, nel Getsemani, Giovanni ci aveva lasciato stupefatti quando scrisse d'aver riconosciuto perfettamente il servo del sommo sacerdote, che, scansandosi in tempo, per evitare che Pietro gli spaccasse la testa in due con la spada, aveva soltanto ottenuto, per sua fortuna, il taglio dell'orecchio. Un gesto impulsivo e scriteriato, quello dell'apostolo, che Gesù stigmatizzò con un ordine di tipo militare, intimandogli di riporre subito la spada nel fodero, onde evitare il rischio di una vera e propria strage.
Ebbene quel servo, che stando in prima fila, doveva essere importante, si chiamava Malco, e siccome Giovanni aggiunge ch'era alle dipendenze del sommo sacerdote, al lettore viene naturale pensare che quest'ultimo fosse Caifa, che si trovò a detenere quella suprema carica dal 18 al 36 d.C. Invece ora scopriamo che si trattava di suo suocero Anna o Anania (Anano ben Seth), che l'aveva preceduto nella stessa carica dal 6 al 15 d.C.
Anania, storicamente, risultò più importante di Caifa: non solo perché – come fa capire Giovanni – al tempo di Gesù aveva mantenuto il titolo onorifico, pur senza esercitare un potere reale, ma anche e soprattutto perché egli riuscirà a far avere la più alta carica sacerdotale a ben cinque figli e appunto al genero Caifa. La sua dinastia finirà con l'ultimo suo figlio, avente il suo stesso nome, che farà uccidere Giacomo, fratello di Gesù e che verrà eliminato nel 67 dagli zeloti, nel corso della grande guerra giudaica.
Anania, nominato da Quirino, legato romano di Siria, era stato deposto dal procuratore Valerio Grato, che in tutto nominò e depose non meno di quattro sommi sacerdoti. Valerio Grato – come noto – era stato il predecessore di Pilato. Caifa invece, insieme a Pilato, verrà deposto da Vitellio, altro legato di Siria, dopo aver tenuto l'ambita carica sacerdotale (che non era solo religiosa ma anche civile) per ben diciotto anni, grazie alla strategia che aveva adottato di versare a Pilato una somma annuale, evitandone così la rotazione, su cui i procuratori romani speculavano alquanto, essendo una loro prerogativa quella di assegnare la carica istituzionale del supremo sacerdozio al migliore offerente.
Queste informazioni storiche sono importanti, perché non è affatto vero – come invece ama credere la storiografia confessionale – che Giovanni integri i Sinottici là dove questi appaiono lacunosi. Al contrario il suo vangelo si pone come obiettivo quello di rettificarli, di contestarli in aspetti essenziali della vita di Gesù, riscrivendo, a volte completamente, la versione dei fatti. Semmai dovremmo chiederci in quali punti di queste precisazioni vi è la mano di Giovanni e non quella dei suoi falsificatori. Ma, a prescindere da questo, possiamo comunque considerarci fortunati che ci sia giunto un testo così difforme dai Sinottici e che non sia finito bruciato da qualche parte o manipolato al punto tale da farlo diventare un apocrifo.
Gli stessi studiosi di origine ebraica dovrebbero esaminarlo con cura, poiché questo vangelo (almeno nella sua parte meno manipolata) è molto meno antisemita dei Sinottici, proprio perché non attribuisce ai soli Giudei la responsabilità dell'esecuzione del messia, ma anche ai Romani, che non giocano affatto in questo vangelo un ruolo subordinato, da comparsa, da meri esecutori di una volontà politico-religiosa ad essi estranea. Anzi, se vogliamo essere precisi, il vero regista di tutta l'operazione politica, giuridica e militare compiuta ai danni di Gesù non è stato affatto Caifa, che pur seppe convincere i farisei ch'era meglio per i destini della nazione eliminare "un uomo solo" (Gv 11,50), ma piuttosto Pilato, che seppe gestire magistralmente il processo-farsa, facendo credere a tutto il popolo che pur di soddisfare la sua volontà era anche disposto a liberare Barabba28.
Nel racconto della cattura di Gesù, Giovanni aveva volutamente citato il nome di Malco proprio per anticipare una cosa che avrebbe detto al momento dell'interrogatorio davanti ad Anania, e cioè il fatto ch'egli conosceva Malco perché l'aveva già incontrato presso gli ambienti del sommo sacerdote Anania (Gv 17,15). Che Giovanni fosse noto in questi ambienti (non necessariamente dal sommo sacerdote in persona) verrà confermato anche nel momento in cui egli s'accorgerà (dalla finestra del primo piano, in cui si svolgeva l'interrogatorio) che un parente di Malco, nel giardino sottostante del palazzo, dirà, con acceso fervore, d'aver visto Pietro proprio nel Getsemani.
Giovanni riuscì a entrare subito nel suddetto palazzo e subito riuscì anche a convincere la portinaia a far entrare Pietro nel giardino antistante, ove questi poté scaldarsi attorno al fuoco delle guardie di Anania. La relativa disinvoltura con cui egli si muoveva all'interno del palazzo di Anania, le cui principali guardie in quel momento stavano interrogando un presunto messia, appena arrestato, ritenuto particolarmente pericoloso, al quale si stava chiedendo di rivelare proprio i nomi dei discepoli più stretti, ha sconcertato non poco gli esegeti di tutte le confessioni. Infatti, è addirittura probabile, benché nel quarto vangelo non venga espressamente detto, che Pietro poté evitare d'essere arrestato nel giardino del palazzo, solo grazie all'intervento di Giovanni.
Noi non sapremo mai che rapporti potevano esserci tra Giovanni e gli ambienti conservatori di Anania. L'unica cosa che si può pensare è che Giovanni, prima di aderire al movimento nazareno, era stato un seguace del Battista, il quale era figlio del sacerdote Zaccaria e di Elisabetta, quest'ultima di stirpe sacerdotale, parente di Maria, madre di Gesù, la quale aveva come sorella la madre degli stessi fratelli Giacomo e Giovanni (Gv 19,25), chiamata Salome (e forse anche la famiglia di Giuseppe era imparentata con quella di Zaccaria): tutti quindi erano di origine giudaica, la famiglia Zebedeo e quella di Gesù, che presero a risiedere in Galilea soltanto dopo l'epurazione del Tempio, ovviamente per motivi di sicurezza, essendo finita, quell'iniziativa senza precedenti, in un nulla di fatto.
È probabile dunque che ci fossero stati, prima della militanza del giovane Giovanni nei battisti (o esseni), dei rapporti con gli ambienti ecclesiastici di Anania, eventualmente nella speranza di poter mutare qualcosa di significativo di quegli stessi ambienti corrotti, speranza poi venuta meno proprio a motivo del fatto che Giovanni, considerando quegli ambienti irriformabili ab intra, si risolse di diventare seguace del Battista, che spingeva per una riforma ad extra.
In ogni caso appare molto banale la motivazione che danno alcuni esegeti circa il fatto che Giovanni conoscesse quegli ambienti semplicemente perché, essendo un pescatore, li riforniva di pesce. Semmai potremmo dire che il fatto che Giovanni fosse "noto" in quegli ambienti non deve farci pensare che fosse anche "amico" o "seguace" di Anania e del suo entourage, altrimenti non riusciremmo a spiegarci (essendo forte l'inimicizia post-pasquale tra Pietro e Giovanni) il motivo per cui i Sinottici non ne abbiano approfittato per metterlo in cattiva luce, facendolo passare per una sorta di doppiogiochista.
Le stranezze tuttavia non finiscono qui. Noi non dobbiamo dimenticare che il vangelo di Giovanni poté essere accettato nel canone solo a condizione che vi fossero incluse determinate manipolazioni redazionali a favore delle tre principali tesi petro-paoline che fondarono il cristianesimo, trasformando il "Gesù storico" in un "Cristo teologico": la "morte necessaria", la "resurrezione" e la "parusia gloriosa e imminente". Se tale premessa è chiara non ci si stupirà di vedere come questa udienza presso il sommo sacerdote Anania sia del tutto assente nei Sinottici, ove invece viene dato particolare risalto a quella davanti a Caifa, che viene considerata pubblica e perfettamente regolare: "là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi" (Mc 14,53).
Nel vangelo di Marco è detto espressamente che solo Pietro prese a seguire Gesù e che solo lui poté assistere all'interrogatorio da parte di Caifa. Se si mettono a confronto i due interrogatori, la differenza è notevole: in quello riportato da Giovanni il Cristo appare come un politico avente una propria ideologia e dei propri seguaci; in quello riportato dai Sinottici appare come un religioso, che pretende di dichiararsi "figlio di dio".
Anania considera Gesù un sovversivo che agiva nella clandestinità, e Gesù si difende dicendo che, per quanto gli era possibile, egli aveva sempre agito in pubblico e ne erano testimoni i tanti seguaci che aveva, anche nella stessa Gerusalemme.
Caifa invece considera Gesù un impostore che si fregia del titolo di messia, senza una previa autorizzazione religiosa, un eretico, uno che minaccia l'autorità della classe sacerdotale, avendone espulso i mercanti ch'essa autorizzava per i traffici davanti al Tempio. Tuttavia il Sinedrio, incerto sul da farsi a causa di testimonianze opposte sulla natura politica del messia, si decide a condannarlo soltanto davanti a un'esplicita affermazione del Cristo: "Sono io il Messia, il figlio di Dio" (Mc 14,61), che viene interpretata come una bestemmia, cioè come una professione inequivocabile di ateismo, in quanto lui, ch'era uomo, si faceva uguale a dio.
Così, mentre nel quarto vangelo Gesù viene condannato come messia rivoluzionario, che minaccia i poteri collaborazionisti costituiti, in Marco invece viene condannato per ateismo, in grado di minacciare gli stessi poteri, ma per motivi culturali o religiosi o, se si preferisce, di politica–religiosa, non di politica in generale, cioè non in relazione all'indipendenza nazionale del paese, alla democrazia come forma di governo.
Il Cristo di Marco non dice mai nulla contro Roma, anzi invita espressamente a pagare i tributi a Cesare (Mc 12,17), e alla classe sacerdotale chiede soltanto (si fa per dire) d'essere riconosciuto come "figlio di dio" (che poi, in realtà, questa sarà la richiesta che Pietro, in At 4,8 ss., rivolgerà direttamente al potere giudaico, al fine di realizzare un compromesso in cui si barattava, in cambio di un riconoscimento dell'idea di resurrezione, da parte delle autorità religiose, la rinuncia, da parte cristiana, a rivendicare l'esigenza dell'insurrezione armata). Insomma i Giudei, stando a Marco, avrebbero condannato Cristo per non aver accettato ch'egli fosse "messia" in quanto "figlio di dio".
Una tesi, questa – come si può facilmente notare – del tutto assurda, poiché, se veramente le cose fossero andate così, noi dovremmo sostenere che i Giudei ebbero tutto il diritto di comportarsi in quella maniera, non potendo essi sapere in anticipo che il messia sarebbe "risorto"; e comunque resterebbe poco comprensibile la consegna di un "messia mistico" nelle mani di un procuratore romano, che in teoria non avrebbe saputo che farsene di accuse di tipo religioso, esattamente come Gallione nei confronti di Paolo (At 18,15). In precedenza, quando in gioco era la non meno odiata predicazione del Battista, non si pensò neanche lontanamente di catturarlo per consegnarlo all'autorità romana. E non lo si farà neppure quando, vari anni dopo la morte del Cristo, si deciderà di eliminare personaggi scomodi come Stefano, Giacomo Zebedeo, Giacomo fratello di Gesù ecc.: tutti "omicidi di stato" che, se non venissero spiegati con motivazioni di ordine politico, difficilmente potrebbero esserlo con quella psicologica offerta da Marco (15,10) per giustificare l'esecuzione del messia: l'invidia.
L'accusa di tipo religioso era peraltro insostenibile anche per altre due ragioni: la prima è che Gesù non aveva mai detto d'essere "figlio di dio", secondo l'accezione "cristiana". Neppure Pietro usò mai questo concetto prima di Paolo. Ci vorrà il concilio di Nicea del 325 per poter stabilire ufficialmente che il "dio-figlio" andava considerato "consustanziale" al "dio-padre". E se un concetto del genere non poteva essere interpretato in maniera "esclusivista", come farà Paolo, allora poteva essere attribuito, in forma "traslata", a chiunque avesse dimostrato particolare dignità e carisma. Se davanti a Caifa il Cristo avesse fatto dipendere la propria "messianicità" dalla propria "divinità" o avesse fatto il contrario, i Giudei avrebbero avuto tutte le ragioni nel temere un folle esaltato, capace di plagiare le masse. Infatti, chi avesse sostenuto di poter avere con Jahvè un rapporto di figliolanza esclusiva, facendo passare i propri connazionali come semplici esseri umani, sarebbe stato accusato di "ateismo" in quanto "folle". Il concetto di "figlio di dio" non solo non è mai stato usato dal Cristo contro il potere giudaico, ma neppure questo avrebbe mai potuto usarlo contro di lui. Semmai l'accusa di ateismo poteva essere riferita al fatto ch'egli non rispettava il sabato, le regole dietetiche, il primato del Tempio, non praticava alcuna forma di culto, non apparteneva ad alcun partito religioso dominante, non frequentava le sinagoghe e così via.
La seconda ragione è che Gesù aveva manifestato il proprio ateismo dicendo non che si sentiva "come dio", ma che tutti gli uomini si dovevano sentire come "dèi" (Gv 10,34). L'epurazione del Tempio doveva appunto far capire che il popolo non aveva più bisogno di dipendere da una casta sacerdotale, meno che mai da quella corrotta dei sadducei e dei sommi sacerdoti. Sotto questo aspetto non era neppure vero ch'egli volesse "distruggere materialmente" il Tempio (Mc 14,58), ma soltanto che voleva sottrarre al clero la sua gestione affaristica: cosa che capì anche Nicodemo (ovvero l'ala progressista del fariseismo), per quanto non volesse ammetterlo pubblicamente (Gv 3,1 ss.). Se uno proprio voleva essere "credente" gli si doveva dare il diritto di esserlo ovunque, senza obbligarlo a versare decime ai sacerdoti e a compiere sacrifici presso il Tempio. I Samaritani furono entusiasti di questa proposta.
Qui si può aggiungere che se anche Caifa gli avesse fatto una domanda esclusivamente politica: "Sei tu il messia?", senza riferimenti di tipo religioso, la risposta non avrebbe certo potuto essere affermativa, proprio perché un qualunque messia che avesse voluto apparire democratico avrebbe dovuto lasciare alle folle il compito di rispondere a quella domanda. Cioè Gesù avrebbe dovuto rispondere la stessa cosa detta davanti ad Anania: "Perché interroghi me?" (Gv 18,21).
Marco insomma dà una versione dei fatti del tutto apologetica delle tesi petrine. Decidere poi di far picchiare Gesù davanti a tutto il Sinedrio, aggiungendo persino la provocazione d'indovinare chi in quel momento l'aveva percosso dopo averlo bendato, facendo così credere ai suoi lettori romani che gli accusatori Giudei sapevano esattamente che Gesù si riteneva un "dio", è stata una scelta antisemita assolutamente indegna per un intellettuale come lui. Che possibilità di pentimento avrebbe potuto esserci da parte di chi, sapendo esattamente che Gesù si considerava "dio" e trovando una conferma di questo nella tomba vuota e nell'idea petrina di resurrezione, aveva consapevolmente deciso di farlo fuori lo stesso?
Luca negli Atti (3,17 ss.) non arrivò mai a tanto, anzi fece dire a Pietro parole di speranza: "io so che voi avete agito per ignoranza, così come i vostri capi; Dio però ha adempiuto così ciò che aveva annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto. Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù". Pietro legava l'idea di immediata e trionfale parusia alla condizione del generale pentimento. Marco invece, che constata la mancata parusia, può sentirsi più libero nel proprio antisemitismo.
L'udienza davanti al sommo sacerdote Caifa è attestata anche da Giovanni, ma perché non riportarne neppure una parola? L'aveva fatto Pietro attraverso Marco, pur non avendo alcuna conoscenza di ambienti altolocati giudaici, attraverso i quali poter avere informazioni riservate: a maggior ragione avrebbe dovuto farlo Giovanni, che quelle conoscenze le aveva. Qui le ipotesi possono essere almeno due: o a Giovanni sarà parso che quanto detto dai Sinottici fosse bastevole, sufficientemente attendibile per comprendere la dinamica degli eventi, oppure avrà considerato superfluo ripetere cose già dette prima, parlando dell'interrogatorio davanti ad Anania. L'esegesi confessionale sostiene che, avendo Giovanni dei lettori di origine pagana, costoro non potevano essere interessati più di tanto a questioni di natura "strettamente giudaica". In realtà se davvero vi fossero state questioni meramente "giudaiche" è assai dubbio che le autorità religiose si sarebbero risolte a consegnare immediatamente il detenuto nelle mani di Pilato.
Il fatto che Giovanni dica che quando Gesù uscì dalla residenza di Caifa il gallo cantò, deve farci pensare che anche presso di lui l'udienza sia durata molto poco e che forse non abbia avuto un contenuto diverso da quello della precedente, ammesso e non concesso che Giovanni avesse informazioni sufficienti per descriverla. In quel momento ai capi dei sacerdoti bastava sapere che il messia fosse stato davvero catturato, che non ci fossero dubbi sulla sua identità e che si potesse consegnarlo immediatamente a Pilato, onde evitare che i nazareni lo liberassero prima dell'esecuzione.
Noi possiamo facilmente ipotizzare che tra Anania e Caifa non doveva esserci molta differenza nell'atteggiamento ostile nei confronti del movimento nazareno (lo portarono prima ad Anania soltanto in segno di rispetto e Anania lo inviò a Caifa così come gliel'avevano consegnato). Nondimeno sarebbe stato poco intelligente, da parte di Giovanni, non riportare alcunché di un'udienza il cui principale attore era lo stesso di tutto il giudaismo ufficiale di quel tempo, il primo responsabile – come viene detto nel suo vangelo (11,49 s.) – della decisione di condannare a morte il messia; lo sarebbe stato anche nel caso in cui gli argomenti o le modalità processuali fossero stati analoghi a quelli dell'udienza già avvenuta in casa di Anania.
Qui si ha la netta impressione – anche leggendo il resoconto sinottico del processo giudaico – che i redattori cristiani non avessero in realtà alcuna possibilità di sapere come andarono effettivamente le cose in casa di Caifa. E dobbiamo parlare proprio di "casa", esattamente come per Anania, e non di Sinedrio, coi suoi 71 parlamentari, poiché, essendo di notte, non vi era alcuna possibilità di convocarlo in maniera regolare nell'atrio quadrato del Tempio detto Beth Din, né lo si sarebbe voluto, temendo le solite spaccature tra farisei e sadducei (Gv 12,42). Le udienze, in un certo senso, furono private e con la precipua finalità non di processare il Cristo ma di consegnarlo a Pilato.
L'onere di giustiziare un sedizioso politico dovevano assumerselo i Romani, e di fronte a questa necessità l'atteggiamento del potere giudaico, istituzionale (sadduceo) e sociale (fariseo), poteva anche porsi in maniera duplice, nel senso che se il popolo l'avesse condivisa si confermava la posizione rassegnata dei collaborazionisti sadducei, mentre se l'avesse impedita, sgominando la guarnigione romana, quella parte di farisei che aveva appoggiato Gesù poteva anche impegnarsi seriamente in un progetto rivoluzionario. Quante volte, come precondizione del loro appoggio, i farisei avevano chiesto a Gesù di dar loro un "segno" (Mc 8,11; Gv 2,18; 6,30), cioè una garanzia di successo dell'insurrezione?
Non dobbiamo peraltro trascurare che il tradimento di Giuda fu cosa del tutto inaspettata per le autorità giudaiche, le quali, anzi, dopo l'ingresso trionfale di Gesù nella capitale giudaica, non potevano non avvertire vicina la loro fine politica, che già era stata seriamente minacciata in occasione della cacciata dei mercanti dal Tempio. Non avrebbe avuto alcun senso comportarsi in maniera legittima, rispettando tutti i crismi della legalità, nei confronti di un personaggio del genere.
Le autorità non avevano alcuna intenzione di scendere a trattative col movimento nazareno, sapendo bene che il tempo per porre delle condizioni a loro favore era scaduto. L'unica possibilità di salvezza che avevano era soltanto quella di dimettersi. Ecco perché andarono a chiamare immediatamente rinforzi sul versante del nemico romano: fu Pilato in persona che inviò l'intera coorte a catturare Gesù.
Quanto al merito dell'udienza davanti ad Anania, va ribadito – se ce ne fosse ancora bisogno – ch'essa non può configurarsi come un dibattito processuale vero e proprio, non solo perché il luogo era privato e la durata fu irrisoria, ma anche perché il detenuto andava considerato "politico" e non "comune", e sarebbe stato indelicato, da parte di Anania, scavalcare le prerogative di Caifa, allora in carica. Quell'udienza quindi si configura soltanto come un incontro del tutto informale, privo di qualsivoglia aspetto giuridico, anche perché si sapeva benissimo che qui non si aveva a che fare semplicemente con un individuo che, a titolo personale, violava alcune interpretazioni ufficiali della legge, ma con un leader politico pericoloso, avente molto seguito popolare, che si prefiggeva di liberare la Palestina non solo dai Romani ma anche dai loro collaborazionisti. Sarebbe stato assurdo pensare di poterlo condannare a morte solo perché violava il sabato o perché negava qualunque legittimità a una casta sacerdotale la cui corruzione era ben nota.
Peraltro quando interroga Gesù, Anania sembra quasi fingere di non conoscere il movimento nazareno e il suo leader: chiede delucidazioni sulla sua dottrina e sui suoi seguaci, trattandoli come terroristi o estremisti che agiscono nella clandestinità, capaci abilmente di sottrarsi a tutti i mandati di cattura. Sembra quasi che voglia recitare la parte dell'inquisitore che rispetta le regole formali di un dibattimento regolare: in realtà sta cercando soltanto un appiglio utile a esplicitare la motivazione con cui consegnare il sovversivo a Pilato.
Gesù però non ci sta a essere considerato come leader di una setta segreta e rivendica il carattere pubblico e democratico del suo movimento: se le autorità vogliono sapere qualcosa dei suoi seguaci non hanno che da interrogarli. Le domande, in sostanza, gli paiono fuori luogo, anzi tendenziose. Solo che la risposta che lui dà, laconica ma obiettiva, appare offensiva, irrispettosa, alla guardia principale del sommo sacerdote, che decide, per questa ragione, di colpirlo in faccia. Evidentemente davanti a una figura istituzionale come Anania, il cui potere era indiscusso, si era abituati a vedere atteggiamenti più reverenziali e dimessi. Gesù invece manifesta di sentirsi alla pari, per cui il militare, colpendolo, è come se avvertisse il dovere precipuo di tutelare l'onore e il rispetto dovuto all'autorità.
Senza trascendere, senza lasciarsi impressionare, ma con dignità, Gesù risponde anche a lui, facendogli capire che svolgere una funzione di protezione non significa dover essere "servili", per cui lo invita a ragionare con la sua testa, dimostrando, nel merito, il torto della risposta data al sommo sacerdote. Vedendo questo, Anania capisce che Gesù non gli risponderà com'egli avrebbe voluto, per cui lo manda da Caifa, ben "legato" (Gv 18,24).
(torna su)33) Il rinnegamento di Pietro (Mc 14)
[A]
[28] Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea".
[29] Allora Pietro gli disse: "Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò".
[30] Gesù gli disse: "In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte".
[31] Ma egli, con grande insistenza, diceva: "Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò". Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.
[53] Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi.
[54] Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco.
[66] Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote
[67] e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: "Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù".
[68] Ma egli negò: "Non so e non capisco quello che vuoi dire". Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò.
[69] E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: "Costui è di quelli".
[70] Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: "Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo".
[71] Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo che voi dite".
[72] Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: "Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte". E scoppiò in pianto.
*
È singolare che nel "proprio vangelo" Pietro abbia voluto ricordare un episodio così spiacevole per lui. Non è però per questo che lo diamo per assodato, ma semplicemente perché ne parla anche il vangelo di Giovanni. Evidentemente a quel tempo doveva essere di dominio pubblico che Pietro "lo spaccone", di fronte all'eventualità di un proprio arresto, avesse preferito rinnegare il suo leader.
Tuttavia mentre nel IV vangelo è solo Giovanni che s'accorge di questa defaillance dell'amico e compagno di lotta (come noto i vv. 13,36 ss., quelli in cui si parla di previsione del rinnegamento, vanno considerati spuri), qui invece Pietro sfrutta quell'episodio per fare l'ennesima apologia della propria concezione fatalistica della politica. Nel senso che qui egli vuol far capire d'aver negato di conoscere Gesù esattamente come lui aveva previsto, sicché andava considerata giusta la tesi della divinità del Cristo.
Il pianto di pentimento di Pietro è in relazione non tanto o non anzitutto al fatto d'averlo tradito, quanto piuttosto al fatto di non aver compreso sino in fondo il senso effettivo della morte espiatrice del "figlio di dio". È un pianto che può essere utilizzato per rinnegare Cristo anche dopo morto.
Infatti qui Pietro sembra opporsi al fatto che Gesù preannunci che dopo la sua resurrezione li avrebbe aspettati in Galilea. Il procedimento redazionale può apparire contorto, ma alla fine la logica è molto semplice: Pietro nel vangelo ha bisogno di apparire come militante politico, di contro alle intenzioni religiose del suo messia, per poter dimostrare al movimento nazareno, quando il Cristo sarà morto, che la decisione di optare per la scelta religiosa (con le tesi della "morte necessaria", della "resurrezione" e della "parusia imminente") era stata dettata proprio da un'errata interpretazione della volontà del Cristo, la quale era apparsa in tutta la sua chiarezza soltanto al momento della scoperta della tomba vuota.
D'altra parte Pietro aveva anche una propria dignità personale, e se qui ha deciso di accettare di apparire come l'unico pavido dei Dodici, a suo favore risultavano due fatti: il primo era che anche gli altri apostoli dicevano che non l'avrebbero mai rinnegato (Mc 14,31), il secondo ch'egli era stato l'unico a seguire da lontano la banda che aveva catturato Gesù (Mc 14,54).
Peccato però che anche in questo caso egli menta, poiché in realtà a seguire Gesù erano stati in due: lui e Giovanni e che solo grazie a quest'ultimo egli poté entrare nel cortile del sommo sacerdote Anania.
Il motivo per cui Pietro sia stato costretto a non far apparire Giovanni in questa circostanza è spiegato dalla differente versione che entrambi danno del processo davanti al sommo sacerdote: in quella di Marco Gesù viene condannato perché si dichiara "figlio di dio", cioè per motivi religiosi non politici, o comunque per motivi di "politica religiosa" non di "politica rivoluzionaria". Il Sinedrio – secondo Marco – consegnerà Gesù a Pilato soltanto per "invidia" (15,10). Non dimentichiamo che questo vangelo attribuirà proprio al centurione romano, ai piedi della croce, la prima affermazione consapevole della divinità del Cristo (15,39). È il più grande favore che Pietro potesse fare ai carnefici del Cristo, anche perché in questa maniera tutte le responsabilità di quella esecuzione ricadevano sui Giudei.
Giovanni fa chiaramente capire, nel suo racconto, che Pietro negò di conoscere Gesù, in quanto dava per scontato che, se si fosse tradito, Giovanni non avrebbe potuto aiutarlo. Tuttavia in quel momento critico uno avrebbe anche potuto avere buoni motivi per non lasciarsi banalmente catturare. Non c'era bisogno di scomodare la "profezia divina" del Cristo sul suo triplice rinnegamento, per giustificare una prudenza o, se si preferisce, una pochezza in fondo così umana.
[B]
Gv 18,15-27 - Mc 14,53-72
Come si può facilmente notare, Giovanni dà una versione differente sia dell'udienza davanti al sommo sacerdote (che per lui non è Caifa ma Anna o Anania), che del rinnegamento di Pietro. In Mc 14,30 Gesù previde, con una precisione a dir poco impressionante, che Pietro avrebbe negato di conoscerlo per ben tre volte prima che il gallo avesse cantato due volte. E le cose in Marco risultano inconfutabili, in quanto unico loro testimone fu Pietro, che si era messo a seguire in solitudine, senza farsi notare, la turba che aveva catturato Gesù. Nulla di ciò nel quarto vangelo.
Leggendo il solo Marco (la cui fonte è lo stesso Pietro) non si capisce, di primo acchito, il motivo per cui, se le cose sono andate esattamente come descritte, il protagonista abbia accettato di apparire in una luce per lui così poco dignitosa, sebbene la decisione di seguirli alla lontana, essendo esclusiva di lui, faccia pensare a una qualche forma di coraggio. Fortuna però che abbiamo anche la versione di Giovanni, che – come noto – legge Marco, mentre il contrario non è vero.
In effetti, proprio il racconto marciano, ancora una volta, viene ad avvalorare la tesi petrina della "morte necessaria", in quanto solo un Cristo divino avrebbe potuto prevedere, nel dettaglio, un rinnegamento così esplicito e articolato. Cioè, pur negando la sequela al Cristo per ben tre volte, Pietro ha potuto confermare, con l'associazione arbitraria del suo gesto alla casualità del canto mattutino del gallo, fatto passare come segno di conferma della profezia del Cristo, che quest'ultimo era "dio", per cui la morte era "necessaria".29 In tal modo Pietro ha avuto tutto l'interesse ad annullarsi come uomo per autoesaltarsi come prosecutore legittimo di quello che nel proto-vangelo è stato fatto passare come "messaggio redentivo" di Gesù (contro la pretesa giovannea alla successione per la ripresa della strategia politico-rivoluzionaria), un messaggio che da "politico" era diventato "teologico". Rebus sic stantibus la conseguenza diventa paradossale: il rinnegamento di Pietro, di fronte al fatto "divino" che il Cristo "doveva morire", non appare neanche tanto grave dal punto di vista "umano".
L'interpretazione del fatto, data dal quarto vangelo, risulta specularmente opposta. Il confronto delle versioni di questi episodi (l'udienza e il rinnegamento) induce a fare riflessioni critiche nei confronti di Pietro, che non è soltanto – come sappiamo – la fonte principale di Marco, ma anche, come ideologia vincente, alla base delle manipolazioni compiute ai danni dell'ultimo vangelo, la prima delle quali, in questo specifico e drammatico contesto, è stata quella di eliminare un testimone scomodo come Giovanni, il cui nome non appare mai (in Marco neppure come persona): una volta eliminato Giovanni dal racconto sull'udienza processuale giudaica, Marco ha avuto buon gioco nel costruire un resoconto quasi del tutto fantasioso sul rinnegamento di Pietro.
Qui non si deve pensare solo a una sorta di irriconoscenza da parte di un leader, Pietro, che non ha voluto ammettere il suo debito di gratitudine nei confronti di un proprio compagno di lotta, il quale, facendolo entrare nel cortile di casa Anania, gli aveva in un certo senso offerto l'opportunità di stare molto vicino alle primissime e informali fasi processuali a carico di Gesù. Le questioni che dividono, anche in queste pericopi, i due protagonisti sono di natura non tanto umana, quanto ideologica e politica.
Nel quarto vangelo Giovanni era potuto entrare nel cortile di casa di Anania perché conosciuto dagli ambienti del sommo sacerdote, e poté far entrare anche Pietro, ch'era rimasto fuori, contattando la portinaia, che appena lo vide subodorò ch'egli fosse, al pari di Giovanni, un seguace del messia, e lui qui, per la prima volta, negò di esserlo. Da notare che solo nella versione marciana Pietro viene riconosciuto dalle guardie anche per la sua parlata galilaica (Mc 14,70), mentre in Giovanni ciò risulta del tutto irrilevante.30
Nel racconto giovanneo, diversamente da quello marciano, la portinaia non dà affatto l'impressione di voler denunciare Pietro, proprio perché conosceva Giovanni e forse simpatizzava per la causa del Cristo. Con la domanda posta a Pietro essa probabilmente si aspettava una risposta affermativa, altrimenti non sarebbe riuscita a spiegarsi il motivo per cui, di notte, Giovanni avesse portato con sé un compagno al seguito del messia in stato d'arresto: la domanda in un certo senso era retorica, una sorta di banale curiosità, cui lo stesso Giovanni, in quel momento, non dovette dare particolare peso. Al massimo si può pensare, visto che la donna era al servizio di un nemico dei nazareni, che la domanda avesse un tono un po' beffardo, di benevola derisione, senza avere però un fine che potesse minacciare l'incolumità di Pietro, altrimenti dovremmo considerare Giovanni uno scriteriato, un imperdonabile ingenuo.
Nel vangelo di Marco la donna non ha affatto un comportamento discreto o semplicemente curioso, ma alquanto minaccioso, anzi accusatorio. Infatti lei si dirige verso di lui, intento a scaldarsi presso un fuoco, e, dopo averlo guardato bene in faccia, gli dice, con molta sicurezza, d'averlo riconosciuto come un seguace del Cristo. Pietro nega ed esce dal cortile, poi però il brano prosegue con una incongruenza. Infatti la donna, vedutolo uscire, cominciò di nuovo a dire a quelli ch'erano lì presenti che Pietro andava catturato. Quindi evidentemente non era uscito del tutto da quella abitazione, che per lui si stava facendo molto pericolosa. Lui continua a negare, finché sono gli stessi soldati che lo riconoscono a motivo della sua parlata galilaica. Eppure, nonostante tutti questi plateali mascheramenti, nessuno lo cattura, sicché egli può uscire in maniera relativamente tranquilla da quella "maledetta" abitazione, andandosene a piangere fuori a causa del proprio comportamento.
Nel vangelo giovanneo le cose non vengono descritte in maniera così inverosimile, essendo tutto più sfumato e realistico, anche se appare molto strano che Pietro non si sia reso conto che una risposta negativa circa il proprio discepolato, invece di rassicurare la portinaia l'avrebbe insospettita. Evidentemente egli non aveva capito bene quali fossero i rapporti tra lei e Giovanni.
Di sicuro nel proto-vangelo di Marco si è cercato di mischiare le carte in tavola per giustificare in qualche modo il rinnegamento di Pietro. In questo vangelo infatti Pietro si trova da solo a seguire a Gesù e riesce a entrare, non si sa come, nel cortile della casa del sommo sacerdote, il cui nome non viene detto ma si deve dare per scontato sia Caifa, poiché la versione marciana dell'udienza si riferisce a lui, un'udienza – ci preme qui ribadirlo – che in Marco appare pubblica e del tutto regolare (benché di notte!), proprio perché si vuol far ricadere esclusivamente sui Giudei l'intenzione di eliminare Gesù. Pietro si è servito dell'idea di apparire come unico testimone nel cortile del sommo sacerdote Caifa per dare una versione (teologica) del tutto fantasiosa del processo e per dimostrare che Gesù, prevedendo il rinnegamento, era effettivamente il "figlio di dio".
In altre parole, egli accettò di apparire in una veste così poco dignitosa per un apostolo prestigioso come lui, perché, sapendo bene che, insieme a lui, vi era stato anche Giovanni, che avrebbe potuto smentirlo, ha preferito accentuare la drammaticità del lato umano del suo carattere, pur di far passare come vera l'interpretazione ch'egli aveva dato della tomba vuota. Pietro fa passare Gesù per un preveggente, in grado di anticipare il triplice rinnegamento, e così toglie alla sua predicazione qualunque connotazione politica (soprattutto rimuove da questa predicazione i suoi addentellati eversivi).
A dir il vero anche in Gv 13,36 ss. si parla della medesima predizione, ma in termini così mistici da risultare del tutto inattendibile, anche perché Gesù pronuncia una frase che Pietro non avrebbe potuto capire in alcun modo: "Dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi". Il che, nelle intenzioni mistificanti dei manipolatori di questo vangelo, voleva dire: "Adesso non puoi condividere i miei ideali perché sei mosso da esigenze politiche, ma, dopo che sarò morto e risorto, capirai che i miei obiettivi erano solo religiosi". Inoltre nel racconto del rinnegamento non si fa alcun cenno a questa predizione, cosa che invece risulta di capitale importanza nei Sinottici per dimostrare la divinità del Cristo.
In entrambe le pericopi, di Marco e di Giovanni (quelle di Matteo e Luca dipendono in toto da quella marciana), Pietro dà l'impressione, al cospetto della portinaia, di rispondere in maniera affrettata e prevenuta a una domanda che gli era sembrata eccessiva, pericolosa, come se già nel percorso che lo separava dal Gesù tradotto nel palazzo del potere giudaico (o forse sarebbe meglio dire nell'abitazione privata di Caifa) avesse pensato di reagire così nel caso in cui gli avessero chiesto di identificarsi.
Un atteggiamento del genere, alla luce delle versioni a nostra disposizione, si può spiegare solo in due modi: in Marco si vuol far vedere che il rischio d'essere catturato era reale, in quanto la portinaia (definita "serva" dall'evangelista) accusa esplicitamente Pietro d'essere un nazareno (lo "fissa" addirittura con lo sguardo davanti alle guardie), per cui il rinnegamento andava considerato umanamente comprensibile, anche se religiosamente non giustificabile, poiché qui l'apostolo aveva addirittura negato di riconoscere Gesù come "dio" (il che però, dopo aver constatata la tomba vuota, interpretata arbitrariamente come "resurrezione", gli servirà poi per dimostrare che effettivamente Gesù era "dio"); in Giovanni invece Pietro non vuole essere da meno del suo compagno di lotta e chiede di entrare anche lui nel cortile, cioè chiede di poter beneficiare dello stesso privilegio di Giovanni, conosciuto dagli ambienti del sommo sacerdote Anania.
L'idea di far assistere Pietro "nel cortile del sommo sacerdote" (Gv 18,15) non doveva essere partita da Giovanni, il quale si era già reso conto che l'aver cercato di uccidere Malco sul Getsemani poneva l'apostolo in una situazione molto rischiosa. Sarà stata probabilmente l'insistenza di Pietro a convincerlo a contattare la portinaia. Ed è impossibile pensare che Giovanni, potendolo far entrare, non avesse detto o fatto capire a Pietro che poteva stare tranquillo, nel momento in cui la portinaia l'avesse visto di persona. Quindi perché negare d'essere un nazareno? Qui si ha l'impressione che Pietro non mostri alcuna fiducia nei confronti del suo compagno di lotta o comunque nei confronti delle sue amicizie, in questo caso la portinaia e sicuramente altri che l'avranno visto entrare o gli avranno dato il permesso di farlo. Per quale motivo Pietro ha pensato che, in caso di problemi, Giovanni non avrebbe fatto di tutto per farlo "uscire" da quel cortile?
Il rinnegamento – come si può notare – fu la conseguenza di un atteggiamento impulsivo, lo stesso con cui Pietro si era eccessivamente esposto sul Monte degli Ulivi mentre tentava di sottrarre Gesù alla cattura. Nei confronti della portinaia egli non aveva alcun vero motivo politico e, se vogliamo neppure umano, per mentire. Un motivo semmai avrebbe potuto esserci quando le guardie di Anania, vedendolo intento a riscaldarsi attorno al fuoco (in aprile, di notte, a Gerusalemme, a 800 metri sul livello del mare, fa freddo), e non riconoscendolo come uno di loro, gli avevano chiesto qualcosa circa la sua presenza in quel luogo e a quell'ora (e dall'accento della sua parlata s’erano accorte che proveniva dalla Galilea), e soprattutto quando era stato smascherato in maniera decisa da parte del parente di Malco, che sosteneva d'averlo visto proprio sul Getsemani, mentre Pietro con la spada sguainata cercava di difendere Gesù dall'arresto. Circostanze, come si può notare, molto concrete e che fanno capire bene quanto fosse stato sciocco Pietro a pretendere di entrare in quel cortile: non a caso esse, nel vangelo di Marco, risultano del tutto assenti, in quanto si evita sia di citare il nome di Malco che di fare riferimento al suo parente. Il fatto che lo faccia Giovanni è una conferma ch'egli doveva conoscere, almeno in parte, gli ambienti legati al sommo sacerdote Anania.
La cosa strana, nel resoconto giovanneo, è che nonostante l'esplicito riconoscimento da parte del parente di Malco, non sembra affatto che vi sia stato un qualche tentativo di denunciare o di catturare immediatamente anche Pietro: tutto sembra limitarsi a una sorta di atteggiamento di biasimo e riprovazione a motivo delle sue ripetute negazioni. Vien da chiedersi, a questo punto, se le guardie non abbiano pensato a un qualche particolare permesso che giustificasse la sua presenza in quel luogo e in quel momento, ché, in caso contrario, sarebbe parsa assai poco comprensibile la sua presenza, per nulla accorta, attorno al loro stesso fuoco. Se infatti avessero voluto prenderlo, dopo la testimonianza inoppugnabile del parente di Malco, non si sarebbero certo fermati davanti alle sue imprecazioni e ai suoi spergiuri. Forse non fecero nulla o perché Giovanni, in qualche modo, riuscì a toglierlo da quell'impiccio, oppure perché la parola d'ordine in quel momento era un'altra: "Conviene che uno solo muoia per tutto il popolo" (Gv 18,14), e i militari spesso non fanno più di quanto venga loro comandato. In fondo sul Getsemani la turba armata aveva accettato molto tranquillamente la proposta di Gesù di lasciare andare i suoi discepoli in cambio di una sua immediata e volontaria consegna.
Noi comunque non sapremo mai se Pietro negò con così tanta insistenza d'essere un nazareno semplicemente perché era un vile che voleva restare vivo a tutti i costi (in tal caso potrebbe anche essere umanamente scusabile), o perché non avrebbe mai accettato di morire in maniera così banale, scoperto dalle guardie attorno a un fuoco (sul Getsemani, in fondo, aveva dato prova di voler difendere a tutti i costi il messia). Certo non si può pensare che lui abbia scelto il rinnegamento nella convinzione che, nel caso in cui l'avessero preso, il movimento nazareno si sarebbe inevitabilmente sbandato. Pietro era forse così egocentrico da ritenersi insostituibile? Noi in realtà peccheremmo di superficialità se non pensassimo che il rinnegamento (che qualunque membro del movimento nazareno avrebbe giustificato) poteva servire anche per lanciare la controffensiva insurrezionale in un secondo momento. Non si può rimproverare a Pietro di non essere stato sufficientemente coraggioso quando, in quel frangente, il coraggio sarebbe potuto apparire una forma di inutile autoimmolazione. È irrazionalistico cercare il martirio a tutti i costi.
Il suo torto semmai sta nel fatto che, quando si vuole dimostrare d'essere audaci e risoluti (sul Getsemani, tirando fuori la spada di fronte a un nemico troppo forte da vincere, e ora seguendo Gesù fin dentro il pericoloso cortile del sommo sacerdote), si deve poi prevedere che possono esserci conseguenze spiacevoli per la propria e per l'altrui sicurezza. Non solo, ma, di fronte a tali conseguenze, le reazioni che si assumono possono apparire giustificate solo ai propri occhi, non a quelli degli altri, che si aspettano sempre una maggiore coerenza. Anche perché nessuno poteva certo dare a Pietro la sicurezza matematica che, entrando nel giardino di Anania, non sarebbe stato riconosciuto da alcuna guardia. Proprio il suo tentativo di voler uccidere Malco avrebbe dovuto metterlo sull'avviso. La fretta stessa con cui aveva risposto alla portinaia stava ad indicare ch'egli aveva messo in conto la possibilità d'essere scoperto.
Dopo l'ultimo rinnegamento Giovanni scrive che "un gallo cantò" (18,27), ma il legame tra rinnegamento e canto fu assolutamente casuale, messo più che altro per chiarire la scansione cronologica degli eventi, ovvero la durata minima delle udienze giudaiche presso i due sommi sacerdoti. In tal senso l'espressione del Cristo, riportata nel suo vangelo: "non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte" (13,38), va considerata del tutto spuria, utilizzata da qualche redattore proprio per avvalorare la versione marciana sull'episodio del rinnegamento.
Ma se il nesso è casuale, la pericope giovannea diventa significativa, poiché raggiunge due obiettivi: negare valore politico alla tesi petrina della "morte necessaria", negare valore soprannaturale al Cristo, che nei Sinottici viene presentato in maniera "divina" (in Lc 22,61 addirittura Gesù, nel momento preciso dell'ultimo rinnegamento, si volta verso Pietro con sguardo di commiserazione). Il Cristo in realtà non ha mai fatto nulla che potesse far sorgere il sospetto ch'egli avesse una natura più che umana, e tutto quanto di miracoloso gli viene attribuito va considerato una falsificazione.
*
Ma su questo racconto bisogna spendere altre parole, poiché contiene aspetti abbastanza sconcertanti. Qui infatti si ha a che fare con due versioni nettamente contrapposte di un medesimo evento. La contrapposizione sta proprio nel fatto che nella prima versione il redattore Marco, che scrive quasi sotto dettatura di Pietro e che risente non poco dell'influenza di Paolo (almeno nelle parti più strettamente teologiche e che probabilmente sono state aggiunte in una successiva redazione), ha omesso del tutto la presenza di Giovanni; nella seconda, scritta dallo stesso Giovanni e poi manomessa da qualcuno che dipende dalla teologia petro-paolina, si parla di due testimoni oculari. In entrambe il protagonista principale è Pietro.
La versione giovannea è stata manipolata non solo là dove si è omesso il nome dell'apostolo, ma anche dove viene detto (per due volte!) che l'anonimo compagno di Pietro poté entrare nel cortile e assistere all'interrogatorio di Gesù da parte di Anania perché era conosciuto negli ambienti di quest'ultimo. Cioè era conosciuto dai nemici più irriducibili del suo maestro! E che tali fossero lo si evince dallo stesso quarto vangelo, ove viene detto che Caifa aveva convinto i sinedriti ad arrestare Gesù prima che i Romani reagissero peggiorando le condizioni dell'oppressione nazionale. Infatti, secondo il sommo sacerdote, se avessero consegnato Gesù a Pilato, questi, in cambio dell'insperato favore, avrebbe avuto un occhio di riguardo per la Giudea. Quanto al primo interrogatorio, Anania interpella Gesù come se questi fosse un pericoloso terrorista che, nella propria clandestinità, stava fomentando il popolo non solo contro i Romani, ma anche contro la stessa classe sacerdotale. Al che Gesù sembra meravigliarsi alquanto che non si conosca la sua attività, avendo egli scelto di agire pubblicamente, almeno finché gli era possibile non compromettere l'incolumità dei suoi seguaci.
Si può quindi arguire o che Giovanni non fosse un seguace prestigioso del Cristo, o che Anania non fosse così convinto, come Caifa, a eliminare chi stava per compiere un'insurrezione antiromana, visto che dimostra di non conoscerlo in maniera adeguata, oppure che Giovanni avesse frequentato gli ambienti di Anania prima di diventare un discepolo del Cristo, sicché poteva ancora servirsi di alcune conoscenze. In quest'ultimo caso si deve dare per scontato ch'egli fosse un giudeo di Gerusalemme, come, d'altra parte, dimostrano molti brani del suo vangelo.
Ovviamente non si può scartare a priori l'ipotesi che la presenza dello stesso apostolo Giovanni vada vista in questo racconto come una forma d'interpolazione da parte di qualche redattore a lui ideologicamente vicino. Tuttavia su questo i dubbi sono molto forti, nel senso che è più naturale pensare che questo episodio sia già stato raccontato nel vangelo originario di Giovanni. Cioè la comunità cristiana doveva necessariamente sapere che il testo era stato scritto proprio da lui, testimone oculare del triplice rinnegamento di Pietro, e che la sua versione dei fatti (da cui non si poteva prescindere, a motivo del ruolo molto importante ch'egli aveva avuto quando Gesù era in vita) era piuttosto diversa da quella registrata dall'evangelista Marco, discepolo di un altro testimone oculare.
Quindi si può tranquillamente presumere che nel vangelo di Giovanni la manipolazione redazionale non sia intervenuta soltanto là dove si è censurato il nome dell'autore del racconto, ma anche là dove si è deciso di calunniare la figura dell'apostolo. Ora, siccome la censura sulla sua identità è una costante in tutto il suo vangelo (a meno che non si voglia pensare che l'apostolo si era volontariamente autocensurato per poter essere meglio accettato nella comunità petro-paolina), qui ci limiteremo ad analizzare il motivo per cui lo si è voluto mettere in cattiva luce.
Non ci vuole un particolare acume psicologico per capire che i manipolatori del quarto vangelo, sapendo bene che la posizione politica di Giovanni era antitetica a quella di Pietro, avevano tutto l'interesse a far credere che l'apostolo non aveva mai rotto i ponti col giudaismo ufficiale e che, per questa ragione, era finito col fare, in un certo senso, il doppio gioco, per cui andava addebitata anche a lui la morte del Cristo.
È un racconto davvero strano, questo. Se si basa su un ricordo personale di Giovanni, non si capisce perché sia stato da lui inserito nel suo vangelo, in quanto dal dialogo tra Gesù e Anania non emerge alcunché di veramente significativo (meno che mai poi se lo si confronta col dialogo, del tutto inventato, tra Gesù e Caifa riportato nel vangelo marciano), né si comprende perché il suo nome sia stato tolto dai manipolatori del suo vangelo, visto ch'era nel loro interesse far apparire piuttosto sospetta la sua presenza in quel frangente. Sotto questo aspetto è molto probabile che i manipolatori abbiano voluto estendere la semplice conoscenza della portinaia da parte di Giovanni (che gli garantì di entrare furtivamente nel cortile e di conservare una certa riservatezza) a una vera e propria affiliazione dell'apostolo agli ambienti di quel sommo sacerdote. Se questa cosa fosse davvero stata scritta da Giovanni, avrebbe dovuto quanto meno essere spiegata, così come egli aveva già chiarito, all'inizio del suo vangelo, che prima di abbracciare la causa del Cristo era stato discepolo del Battista.
È poco realistica l'ipotesi di chi pensa che Giovanni abbia scelto di apparire come un doppiogiochista per avere la possibilità che il proprio vangelo venisse approvato dalla tradizione petro-paolina, a lui ostile, la quale così avrebbe considerato il rinnegamento di Pietro maggiormente comprensibile. Anche perché il fatto ch'egli fosse conosciuto in quegli ambienti non sembra aver comportato la fruizione di un privilegio particolare. Appare evidente infatti che la casa di Anania era una semplice abitazione privata con tanto di giardino. Le guardie lì presenti erano quelle ebraiche che avevano catturato Gesù nel Getsemani: se vi erano anche quelle romane, come risulta nel quarto vangelo, al momento dell'arresto di Gesù, esse stavano attendendo al di fuori di quella abitazione, o forse non erano neppure presenti, visto che il leader nazareno era saldamente nelle mani delle guardie giudaiche e che i suoi discepoli erano tutti fuggiti. Se Giovanni poté assistere all'interrogatorio di Gesù, questo deve per forza essere avvenuto al di fuori della casa di Anania, alla presenza di molteplici persone, e deve essere stato molto breve. Gesù era legato e al suo fianco aveva una guardia, la stessa che lo schiaffeggiò quando quegli disse di voler essere considerato un uomo pubblico e non un terrorista.
Se l'interrogatorio è avvenuto dentro la casa, solo la portinaia può averlo riferito a Giovanni. La cosa strana è che Pietro sembra trovarsi in un punto d'osservazione diverso da quello di Giovanni, intento a riscaldarsi con altri soldati presso un fuoco: il che non esclude che anch'egli avesse potuto ascoltare il dialogo tra Gesù e Anania. Quel che di sicuro sappiamo è che Giovanni, pur essendo conosciuto negli ambienti di Anania, non è in grado di dire la minima parola relativamente al dialogo tra Gesù e Caifa. Viceversa nel vangelo di Marco sembra essere Pietro ad avere la possibilità di accedere alla casa di Caifa e di assistere, alla presenza dell'intero Sinedrio (sic!), con una inspiegabile sicurezza, a un dialogo molto teatrale e drammatico, molto più importante del precedente.
Soltanto dopo aver assistito a questo dialogo, Pietro comincia a essere sospettato d'essere un seguace di Gesù. Infatti nel vangelo di Marco si voleva mostrare che la massima responsabilità della morte di Gesù doveva ricadere sui sommi sacerdoti e su tutti i membri del Sinedrio. La presenza del solo Pietro nel cortile della casa di Caifa stava appunto a testimoniare che la sua versione dei fatti doveva apparire inconfutabile. I Romani non c'entravano nulla: se fosse dipeso interamente da loro, non l'avrebbero giustiziato. I capi giudaici lo consegnarono a Pilato semplicemente perché del Cristo non accettavano la sua divinità, la sua figliolanza divina e lo condannarono perché si faceva come Dio e quindi appariva come un ateo. La condanna era quindi per motivi religiosi e la politica c'entrava solo indirettamente, e comunque non riguardava lo Stato romano. Gesù viene consegnato ai Romani perché con la sua predicazione minacciava l'establishment religioso della Giudea e di tutta la Palestina. Questa è l'interpretazione falsata dei fatti data dal proto-vangelo marciano.
A priori non si può negare che prima ancora di diventare un seguace del Battista, Giovanni avesse frequentato gli ambienti teologico-politici di Anania. Si può anzi presumere ch'egli fosse consapevole di non poter nascondere a nessuno il suo background giovanile e che quindi abbia scelto qui di parlarne in maniera del tutto distaccata, senza preoccuparsi delle conseguenze di ciò che stava dicendo. Ma se questa ipotesi è attendibile, se davvero egli ha accettato, in maniera così disinvolta, che una terribile ombra di sospetto infangasse la sua personalità, si può anche presumere ch'egli in realtà volesse parlare d'altro, di qualcosa di molto più grave. E qui la domanda non può essere che la seguente: il racconto di Giovanni voleva forse far vedere di quale pasta era fatto l'apostolo che, dopo la morte di Gesù, aveva convinto il movimento nazareno a rinunciare all'insurrezione armata? Siamo forse in presenza di un racconto contro la spavalderia, la meschineria e la falsa concezione della politica che aveva Pietro, ovvero la cattiva interpretazione che aveva dato della morte del Cristo? Doveva forse servire per dimostrare che Pietro in realtà non era affatto quell'uomo coraggioso che voleva far credere?
È vero, anche nel vangelo marciano si parla di un triplice rinnegamento di Pietro, ma Giovanni, che è un politico di razza, vuol far vedere altro. Egli ha intenzione di dirci non tanto che Pietro era un uomo dalla personalità contraddittoria, quanto piuttosto che non era capace di interpretare i fatti per quello che effettivamente erano.
Anche nel quarto vangelo egli nega di conoscere Gesù per tre volte: alla portinaia, a un soldato e a un parente di Malco, la guardia che Pietro avrebbe voluto uccidere spaccandole la testa con la spada, alla quale però, scansandosi quella in tempo, avuto soltanto reciso l'orecchio. In quel momento Pietro non si era reso conto dell'enorme disparità delle forze in campo e aveva rischiato di far ammazzare tutti i discepoli a causa della sua impulsività. E così di nuovo, nel giardino di Anania nega di essere un seguace del Cristo proprio perché pensava che, senza di lui, il movimento nazareno si sarebbe sbandato (benché nel contesto semantico del racconto il rinnegamento sembra essere dovuto al fatto che Pietro, se fosse stato arrestato, non avrebbe potuto contare sull'aiuto di uno che frequentava gli ambienti del nemico).
Non è da escludere che il racconto sia servito per dimostrare che i rapporti tra i due, ad un certo punto, si ruppero in maniera irreparabile, e non tanto perché Giovanni fosse un traditore (come invece i manipolatori vogliono far credere), quanto perché Pietro era un pusillanime, il vero traditore del suo maestro. Se questo è vero, allora è stato del tutto naturale che sia stato omesso il nome di Giovanni: i manipolatori non volevano far sapere che il testimone dell'opportunismo di Pietro era stato proprio quell'apostolo che, dopo la morte del Cristo, era diventato suo nemico, in quanto non aveva accettato l'idea della resurrezione usata come rinuncia alla lotta di liberazione nazionale.
[C]
Gv 13,33-38 - Mc 14,26-31
Stando al vangelo attribuito a Giovanni (13,36 ss.), non si capisce, a differenza che in quello di Marco (14,26 ss.), che Gesù, mentre profetizzava a Pietro che l'avrebbe rinnegato tre volte, si trovava con gli apostoli nel Getsemani.23 Tale contesto, se si vuole, è abbastanza logico, in quanto, pur essendo quella previsione del tutto fantasiosa, il sospetto di essere traditi aveva già indotto la comitiva ad andarsene dal luogo del pasto in comune e a rifugiarsi nel luogo segreto, utilizzato altre volte. In quell'orto degli ulivi può apparire del tutto naturale che Gesù abbia messo gli apostoli sull'avviso di una loro possibile cattura, o quanto meno di un duro scontro armato con esito fatale per loro, in quanto sicuramente, se vi era stato un tradimento tale per cui era stato rivelato il loro luogo segreto, sarebbero venuti a cercarli in massa e ben armati. È stato di fronte a queste parole che Pietro deve aver detto che non sarebbe mai fuggito, anche a costo di affrontare il nemico col rischio di morire.
Nel vangelo di Marco la descrizione di Cristo, in quel frangente, è – come spesso succede quando si vogliono mistificare religiosamente le cose – quella di un dio in grado di prevedere esattamente gli eventi futuri. In altre parole, lui sarebbe stato catturato e loro, disperati, sarebbero fuggiti, ma tutti si sarebbero ritrovati in Galilea dopo la sua resurrezione. Si noti che al v. 28 si parla proprio di "resurrezione", dando per scontato che il loro leader sarebbe stato ucciso o giustiziato. Non si tratta di una semplice rassicurazione che chiunque può fare, nei momenti più difficili, per scongiurare il peggio o allentare la tensione. Non a caso il vangelo di Marco si chiuderà con le parole che l'angelo dirà alle donne sbigottite davanti al sepolcro vuoto: "Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro ch'egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto" (16,7).
La descrizione marciana dei fatti appare piuttosto bizzarra, persino illogica dal punto di vista teologico. Infatti l'evangelista fa dire a Pietro che non si sarebbe "scandalizzato" della cattura di Gesù, e non sarebbe quindi fuggito. Il che però potrebbe anche essere interpretato nel senso che l'apostolo sapeva bene che il Cristo sarebbe risorto!24
In realtà si riesce a intuire ugualmente che Pietro intendeva dire che avrebbe difeso il Cristo rischiando di persona. E tutti gli altri dicono la stessa cosa, dimostrando così di non aver capito le parole di Gesù relative alla resurrezione o addirittura di non averle accettate.
La cosa strana, nel vangelo di Marco, è che il rinnegamento di Pietro viene previsto da Gesù esattamente come il tradimento di Giuda.25 Ora, chiunque si rende facilmente conto che quando le cose sono preannunciate e si verificano puntualmente, la responsabilità di chi le compie, nel bene o nel male, è notevolmente ridotta. Qui l'evangelista, pur di mistificare quel particolare momento politico, in cui tutto era in gioco, è stato costretto a concedere alla teologia uno spazio enorme, con cui alla fine può giustificare tutto e tutti: il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro e la crocifissione del Cristo (o meglio, la sua autoimmolazione). Nessuno ha davvero una "colpa" o un "merito" di ciò che è accaduto, in quanto tutto era debitamente previsto dalla insondabile prescienza divina (quella di cui parlerà espressamente Pietro in At 2,23).26 Dunque Gesù non si era rifugiato, coi suoi discepoli, nel Getsemani per sottrarsi alla cattura, ma soltanto per fare in modo che loro si salvassero (d'altra parte di fronte al supremo sacrificio di un dio, per il bene dell'umanità, a cosa sarebbe servito quello di pochi uomini?).
*
La versione di Luca contiene degli aspetti ancora più sconcertanti. Ovviamente anche lui deve mettere, come cappello introduttivo, la sua dose di misticismo, sicché fa dire a Gesù, rivolto a Pietro: "Quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli" (22,32). Il che voleva dire che quando egli avrà capito la necessità della morte in croce, dovrà poi spiegarla agli apostoli, usando il concetto di "resurrezione".
A parte questo, resta assai poco spiegabile, in Luca, il motivo per cui, in quel contesto, Gesù abbia detto ai suoi discepoli più stretti (o ai discepoli in generale) di vendere il mantello e di comprare una spada (v. 36). Stando all'impostazione teologica del racconto in oggetto e, in fondo, di tutto il suo vangelo, in quel momento le spade avrebbero dovuto semmai deporle, non barattarle coi loro mantelli. Se il Cristo "doveva" essere catturato, a che pro difenderlo?
Il bello è che tutti gli apostoli, in quel momento, non avevano affatto bisogno di vendere i loro mantelli, in quanto – secondo Luca – erano già tutti armati. Infatti presentano a Gesù due spade, come se stessero obbedendo a un ordine militare. Al che lui risponde, perentorio: "Basta!" (v. 38). E non dimentichiamo che Pietro cercò di uccidere Malco, il servo del sommo sacerdote (Lc 22,50; Gv 18,10).
Questo modo di presentare le cose è davvero strano. Luca dà l'impressione di essere a conoscenza di un lato militaresco nell'ambito dei Dodici, che negli altri vangeli è stato accuratamente rimosso. Stando alla sua versione, gli apostoli sarebbero stati disposti a morire per Gesù, senza rendersi conto che se Giuda avesse rivelato il nascondiglio segreto, sarebbe giunta una massa di uomini armati di tutto punto, nei cui confronti non vi sarebbe stata alcuna possibilità di vincere. Non saper valutare le forze in campo e volersi difendere a tutti i costi, senza accettare l'idea della resa, significa essere degli irresponsabili. Cosa che Gesù comprese perfettamente quando al momento della trattativa per la sua cattura, chiese di lasciare andare i suoi discepoli, consegnandosi spontaneamente: in questo modo nessuno ci avrebbe rimesso la vita.
*
Ora però vediamo la versione di Giovanni. Anche la piccola pericope in cui Gesù preannuncia a Pietro il rinnegamento, vi sono mistificazioni a non finire, anche se condotte a un livello superiore. Si faccia attenzione ai sottintesi.
– Simone gli domandò: "Dove vai?". Cioè: "Perché vuoi rinunciare all'insurrezione armata?". Oppure: "Perché vuoi farti ammazzare come un agnello sacrificale? Che senso ha essere venuti qui a Gerusalemme?". Ovviamente queste parole vanno collegate al v. 33: "Per poco sono ancora con voi. Dove vado io, voi non potete venire", che hanno un chiaro riferimento redazionale alla morte e resurrezione.
– Gesù rispose: "Dove vado io, non puoi seguirmi per ora; ma mi seguirai più tardi". Il che significa, in altre parole: "Il motivo per cui voglio sacrificarmi ora non puoi capirlo, ma lo capirai dopo che sarò risorto".
– Pietro gli disse: "Perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!". Cioè: "Se hai deciso di sacrificarti, consegnandoti al nemico, lo farò anch'io". In sostanza gli autori hanno trasformato il Cristo da politico a religioso, e Pietro, che viene presentato come un politico, non può capirlo. È infatti da escludere che qui si voglia presentarlo come uno che aveva capito il motivo religioso dell'autoimmolazione del Cristo e che chiedeva d'imitare il suo maestro.
– Gesù gli rispose: "In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte". Cioè non è questione di viltà, ma proprio del fatto che Pietro, se sapesse sino in fondo il motivo per cui Cristo si lascia giustiziare, non accetterebbe tanto facilmente di seguirlo. Quindi il motivo del rinnegamento è abbastanza evidente: l'avrebbe fatto in quanto "politico", non essendo ancora pronto ad accettare, sino in fondo, la motivazione "religiosa" sottesa al martirio.
Tuttavia c'è qualcosa che non quadra. Pietro qui viene sminuito da una comunità post-pasquale, che ha già accettato la tesi fondamentale dello stesso Pietro, secondo cui la tomba vuota andava interpretata come "resurrezione". Ma allora perché sminuirlo? Perché tacciarlo di pavidità? Qui la risposta non è semplice, ma si fa fatica a trovarne un'altra: il torto di Pietro starebbe nel fatto che volle gestire l'idea di "resurrezione" in maniera regressiva, rinunciando a qualunque lotta armata. Pietro aveva detto che, se Cristo era risorto, bisognava attendere passivamente il suo ritorno, che sicuramente sarebbe stato trionfale.
Qui la critica che i redattori fanno a Pietro non è tanto quella di non aver capito in tempo la natura divina del Cristo, quanto piuttosto quella di aver rinnegato i suoi ideali politici, in quanto avrebbe potuto tranquillamente proseguire il progetto insurrezionale del Cristo, pur non escludendo l'idea di una misteriosa scomparsa del corpo di Gesù dalla tomba. Cioè avrebbe dovuto proseguire ciò che insieme si era deciso e non inventarsi qualcosa di nuovo, che avrebbe mandato tutto all'aria. Questa, infatti, era la posizione di Giovanni, che aveva rifiutato – come risulta dall'Apocalisse – di fare della scoperta della tomba vuota un motivo per rinunciare all'insurrezione. Di qui peraltro la sua improvvisa scomparsa dai racconti degli Atti degli apostoli.
(torna su)34) Caifa, tra verità e falsità
Se la verità potesse essere desunta in modo evidente, come credevano i filosofi greci, per i quali A era A e B era B, cioè se si potesse dedurre il vero da tutto ciò che non è falso, l'umanità avrebbe fatto enormi progressi in pochissimo tempo. E non avremmo p. es. avuto dei nazisti dire ai sopravvissuti dei lager che, se anche fossero tornati a casa, nessuno avrebbe creduto alle loro testimonianze. Ma poi per fortuna venne Hegel il quale capì che la verità poteva stare nella falsità e questa in quella, anche se non sempre riuscì ad applicare questa brillante intuizione a se stesso e allo Stato politico ch'egli voleva rappresentare.
La verità dunque può stare nella falsità, poiché a volte si dicono cose vere senza volerlo. E la falsità può stare nella verità, specie quando, per ingannare meglio, si dicono soltanto alcune cose vere. Prendiamo ad es. questa frase famosa detta dal sommo sacerdote Caifa nel vangelo di Giovanni, quando i capi giudaici presero la decisione di eliminare il Cristo:
"[48] Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione". [49] Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: "Voi non capite nulla [50] e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera". [51] Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione [52] e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. [53] Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. (Gv 11,48-53).
In questi sei versetti ci sono varie persone che parlano: Caifa (Giuseppe bar Caiafa), del partito sadduceo, alcuni parlamentari del Sinedrio e l'evangelista, e una che tace: Gesù. E c'è anche una quinta persona, seminascosta, quella che manipola il vangelo di Giovanni e che fa dire all'evangelista cose diverse da quelle che ha scritto. Non sarà facile trovare la verità tra persone che mentono e altre che o non possono parlare o vengono travisate.
Si noti, en passant, l'illogicità del v. 49 rispetto al v. 48: alcuni sinedriti sono preoccupati della popolarità di Gesù e pensano che se non intervengono con la forza, lo faranno i Romani, che ne approfitteranno per distruggere l'intera nazione. Dopodiché interviene Caifa che invece di condividere questa preoccupazione, la contesta dicendo che chi l'ha manifestata "non capisce niente", ma poi la fa sua tirando da essa le inevitabili conseguenze: Gesù va fatto fuori per il bene della nazione.
Sembra che manchino le parole di chi si era opposto alla preoccupazione di quei sinedriti timorosi e che magari avrà detto il contrario, e cioè che bisognava approfittare proprio della popolarità del Cristo per togliere di mezzo i Romani. In ogni caso le parole di Caifa indicano che la decisione di eliminare il Cristo venne presa non da tutto il Sinedrio ma dalla sua parte maggioritaria. Perché sia stata tolta la versione della minoranza non è dato sapere, ma è da presumere che se si fosse insistito troppo su questa diatriba si sarebbe scoperto che il Cristo non era affatto quella figura mistica che ci presenta il quarto vangelo manipolato, bensì un politico pronto all'insurrezione armata (e magari un politico che, nell'ambito del Sinedrio, fruiva di certi appoggi da parte di qualche gruppo politico, p. es. i farisei progressisti).
Ora però soprassediamo su queste incongruenze ed omissioni e andiamo avanti, proprio perché nei vangeli non bisogna soffermarsi tanto sulle contraddizioni quanto piuttosto sulle mistificazioni e falsificazioni.
Quello che voleva dire Caifa l'abbiamo capito: essendo un collaborazionista dei Romani, un conservatore delle tradizioni ebraiche, uno che non vedeva di buon occhio l'operato del Cristo, in quanto non lo riconosceva come messia liberatore d'Israele, giudicandolo piuttosto un avventuriero, un irresponsabile, incapace di rendersi conto che Israele non avrebbe potuto farcela contro il potere di Roma, almeno non in quel momento, non alle condizioni che lui aveva posto, non senza l'appoggio della casta sacerdotale; essendo dunque un collaborazionista, Caifa aveva maturato l'idea d'impedire con la forza che il movimento nazareno potesse compiere la rivoluzione e, secondo lui, il modo più efficace per poterlo fare era quello di catturarne il suo principale leader, consegnandolo ai Romani e cercando, con tale gesto, di ottenere da loro nuovi favori, maggiori libertà. Non dobbiamo pensare a Caifa come a uno statista che non volesse la liberazione d'Israele, uno che preferiva accettare una soluzione di compromesso per mera convenienza personale o di casta; semplicemente egli non voleva l'insurrezione in quel momento o nel modo in cui i nazareni l'avevano pensata. Non dimentichiamo che Gesù aveva già cercato di destabilizzare l'autorità dei sommi sacerdoti e dei sadducei cacciando i mercanti dal Tempio.
L'evangelista non può aver detto più di questo, e tutto ciò al massimo può essergli stato riferito da qualcuno del Sinedrio. Se ha scritto altre cose, allo stato attuale delle fonti non possiamo saperlo.
Ora invece dobbiamo cercare di capire che cosa ha voluto dire il manipolatore di questo vangelo nei versetti 51 e 52. Questa figura è non meno importante di quella dell'evangelista, poiché rappresenta il portavoce ufficiale della ricostruzione interpretativa, assolutamente mistica, che fecero i cristiani (o comunque i seguaci del cristianesimo petro-paolino) riguardo alle circostanze che portarono il Cristo alla croce.
Al v. 51 viene detta una cosa molto curiosa: "Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione". E al v. 52 si rincara la dose dicendone un'altra ancora più strabiliante, come solo un ebreo convertito al cristianesimo avrebbe potuto fare: "e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi". Due versetti aggiunti impunemente a tutto il resto.
In sostanza quale messaggio subdolo voleva trasmettere il manipolatore? Per poter capire l'inganno bisogna ora creare una tabella divisa in tre colonne, una per ogni persona in gioco: l'evangelista Giovanni, il suo manipolatore e Caifa.
|
Evangelista
Posizione
politica |
Caifa
Posizione
politica |
Manipolatore Posizione religiosa |
|
Cristo aveva intenzione di compiere un'insurrezione contro i Romani per liberare Israele e avrebbe dato la propria vita pur di farcela. |
Per salvare Israele dalla distruzione dei Romani bisogna eliminare Cristo. |
Cristo morì per il bene di tutto il popolo di Israele, perché in questa maniera gli ebrei poterono unirsi ai pagani nel suo nome. |
|
Giovanni avrebbe voluto dire una cosa vera ma il manipolatore glielo impedisce, anche se non può farlo completamente. |
Caifa disse una cosa falsa che il manipolatore fa passare per vera, ma non secondo le intenzioni originarie di Caifa. |
Il manipolatore vuol negare che Cristo fosse un politico, quindi la sua morte non è servita per salvare politicamente Israele dai Romani (anche perché i Romani l'hanno distrutta ugualmente), ma per salvarla dall'ira divina, riconciliando gli ebrei con dio, beninteso quelli che hanno creduto nella figliolanza divina del Cristo, rinunciando al primato della legge mosaica e del Tempio di Gerusalemme. E insieme agli ebrei, divenuti cristiani, hanno potuto riconciliarsi con dio anche i pagani, inclusi gli stessi Romani, che quindi non vanno più combattuti politicamente e militarmente. |
|
Cristo non voleva morire, anche se non si sarebbe tirato indietro nell'eventualità che ciò fosse stato necessario. |
Cristo doveva morire per salvare militarmente Israele dalla inevitabile ritorsione romana conseguente al tentativo insurrezionale dei nazareni. |
Cristo doveva morire perché solo con la sua morte gli ebrei avrebbero capito che la liberazione umana non può essere politica ma solo religiosa. La vera liberazione è quella dal peccato e dalla morte e quindi quella che si vivrà nell'altra vita. |
|
Cristo voleva una liberazione nazionale, per mostrare a tutte le nazioni oppresse da Roma che esisteva la possibilità concreta di liberarsi da questo dominio. |
Cristo voleva una liberazione nazionale in tempi e soprattutto in modi sbagliati, in quanto negava valore alle tradizioni religiose e rifiutava un'intesa con la casta sacerdotale. |
Cristo non voleva una liberazione nazionale ma universale, non la voleva politica ma spirituale. |
Come si può notare il comportamento del manipolatore è stato diverso a seconda di chi aveva di fronte a sé: nei confronti dell'evangelista s'è limitato a censurare; nei confronti invece di Caifa ha riportato una frase estrapolandola dal suo contesto e reinterpretandola in maniera diversa. In tal modo ha potuto dire che la frase era vera, ma ha dovuto per forza sostenere che lo era all'insaputa dello stesso Caifa. Anzi, in un certo senso, ha voluto addirittura sostenere che Caifa fu, indirettamente, senza volerlo, uno strumento nelle mani di dio, il quale riuscì, attraverso un persecutore, a realizzare un obiettivo superiore, che il persecutore non poteva neppure immaginare. Ma su questa interpretazione veramente incredibile bisogna spendere ulteriori parole, perché bisogna cercare di capire a chi era rivolta.
È impensabile infatti che il manipolatore si stia rivolgendo a degli ebrei lettori di questo vangelo. Un ebreo infatti non avrebbe mai potuto accettare che un "messia morto" era meglio di un "messia liberatore". Avrebbe potuto dirlo solo se fosse stato convinto che il liberatore Gesù altro non era che un falso messia, capace di mettere a repentaglio il destino di Israele.
Sia come sia, nessun ebreo sarebbe stato disposto ad ammettere che nella morte di un vero messia vi potesse essere qualcosa di "religiosamente necessario". La necessità mistica con cui s'è voluta giustificare la crocifissione del messia è stata inventata dai cristiani ed è un'aberrazione, che però è potuta passare per una grande verità religiosa proprio perché i Giudei, con tutta la loro politica nazionalistica, il loro settarismo ideologico, l'incapacità di creare una vera democrazia sociale interna, avevano soltanto portato il loro paese alla catastrofe.
Ma il punto non è solo questo. La mistificazione che il manipolatore opera ai danni di Caifa è in realtà rivolta contro Giovanni. Infatti se Caifa avesse detto una frase che non poteva essere strumentalizzata in senso mistico, molto probabilmente i redattori l’avrebbero omessa. Noi non abbiamo il testo originario del vangelo di Giovanni.
Secondo il manipolatore, seguace ovviamente del paolinismo, Caifa non poteva prevedere le conseguenze concrete (in senso storico-religioso) delle sue affermazioni politiche. Il ragionamento è davvero curioso e merita d'essere dettagliato. In sostanza il manipolatore (che in questo caso è forse solo un interpolatore), sostiene che siccome Caifa era sommo sacerdote, egli affermò, proprio in quanto "autorità religiosa", una cosa giusta, anche se, essendo "ebreo", non poteva sapere che la sua affermazione era in realtà una profezia semi-cristiana (cioè cristiana a metà, poiché la croce non servì solo agli ebrei ma anche ai pagani).
Questo tipo di lettura cristiana delle parole dello statista ebreo Caifa è del tutto ideologica, decontestualizzata e post-eventum: non solo non serve a capire storicamente Caifa, ma favorisce addirittura un'interpretazione giustificatoria del suo operato, tanto che, posta la questione in questi termini, non è da escludere che un Caifa pentito abbia potuto appartenere a qualche comunità cristiana, esattamente come Paolo di Tarso.
Qui, come si può notare, si vuole aggiungere mistificazione a mistificazione: infatti Caifa non era solo un "religioso" ma anche un "politico", ma siccome il manipolatore, che è un "credente", non potrebbe mai sostenere che le parole dette da un "politico" avrebbero potuto avere conseguenze positive sul piano "religioso", vuol far capire al suo lettore che quell'uomo in realtà non aveva nulla di "politico" e nulla, di conseguenza, l'aveva Cristo.
Il fatto che da un evento se ne possa determinare un altro dal contenuto opposto, ci è già stato insegnato dalle leggi della dialettica, ma questo non significa che dal falso possa venire fuori il vero come per magia. Supponiamo infatti che la tesi del manipolatore sia giusta, e cioè che in virtù della morte del Cristo l'ebraismo, mescolandosi col paganesimo, si è universalizzato diventando cristiano.
Una parte di vero, questa tesi, in effetti l'ha, ma sarebbe falsissimo sostenere che l'universalizzazione del messaggio di Cristo avrebbe potuto manifestarsi solo in chiave religiosa e non in chiave politica. La liberazione voleva essere "nazionale" non "nazionalistica", cioè voleva restare aperta al dialogo con tutti, senza pregiudiziali ed esclusivismi di sorta. Gv 12,20 lascia capire che anche alcuni gruppi di Greci volevano intavolare trattative col Cristo per un'azione comune e non fu loro impedito.
Il manipolatore sostiene una tesi in cui ancora oggi credono milioni di persone, e cioè che il Cristo doveva morire per togliere al giudaismo ogni istanza politico-nazionalistica e per promuoverne un'altra di tipo universalistico-religioso. Come si può facilmente notare, non c'è alcuna differenza tra la politica opportunista di Caifa e quella di questo manipolatore cristiano. Anzi, probabilmente tra le due rassegnazioni quella di Caifa era minore.
(torna su)35) Il processo davanti a Pilato
Gv 18,28-40; 19,1-16 - Mc 15,1-20
I
Alcune autorità sinedrite (non "tutte", come vuole invece Mc 15,1, qui intenzionato a far vedere, con l'antisemitismo che lo caratterizza, l'unanimità degli intenti), quelle appunto che di notte s'erano riunite in casa Anania e poi in casa Caifa, subito dopo l'insperata cattura di Gesù, e che l'avevano sottoposto a un informale e sbrigativo interrogatorio, giunsero nel pretorio (o tribunale) per consegnare il prigioniero al procuratore (o prefetto) Ponzio Pilato31, il quale risiedeva di regola a Cesarea Marittima (capitale politico-militare della Giudea dal 13 a.C.), ma, durante le grandi feste religiose, era obbligato a trasferirsi a Gerusalemme (distante circa 60 miglia), che diveniva facile occasione, a motivo del forte afflusso di fedeli, di azioni dimostrative dei rivoltosi contro Roma e i poteri giudaici collaborazionisti. Poiché sul Getsemani – secondo Giovanni – v'era una parte significativa o addirittura l'intera coorte di 600 unità (stanziata nella fortezza Antonia della capitale), armata di tutto punto, in quanto le era stato detto di prepararsi a uno scontro notturno coi nazareni, è da escludere che Pilato non avesse autorizzato il tribuno a servirsene.
Qui Giovanni evidenzia la sua sottile ironia, affermando che le autorità giudaiche "non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua" (18,28): uno scrupolo per la purezza esteriore (si era alla vigilia del sabato pasquale) chiaramente in contrasto col modo vergognoso con cui si era catturato e interrogato e consegnato il messia al peggior nemico di Israele.
Sicché Pilato, che di mattina molto presto già li attendeva, fu costretto a uscire dal pretorio, ch'era annesso alla fortezza Antonia. Sin dalle prime battute si ha la netta sensazione che fra lui e le autorità ci fosse stato un accordo preliminare, secondo cui il prigioniero, nel caso fosse stato catturato vivo, sarebbe stato consegnato a Pilato. Il motivo di questo è in fondo molto semplice: le autorità sinedrite avvertivano che di fronte a un leader come Gesù, a guida d'un movimento troppo popolare per loro, non avrebbero potuto avere sufficienti poteri per condannarlo a morte.
Vari esegeti hanno sostenuto che il Sinedrio, a causa dell'occupazione romana, non aveva alcuna possibilità di emettere sentenze capitali: in realtà, quand'erano in gioco questioni religiose (e noi sappiamo che nella Palestina d'allora la religione era un tutt'uno con la politica), poteva farlo molto tranquillamente, e lo dimostrerà alcuni decenni dopo la morte di Gesù, in occasioni descritte anche nel Nuovo Testamento, come la lapidazione di Stefano, o l'assassinio di stato di Giacomo Zebedeo o dell'altro Giacomo, fratello di Gesù. Anzi, nei confronti dello stesso Gesù, più volte s'era già cercato di linciarlo mediante lapidazione (Gv 8,59; 10,31.39). Anche Marco, in relazione alla trasgressione del sabato, ne parla (3,6).
Di fronte a reati giudicati gravissimi, a tutti evidenti, riguardanti taluni aspetti fondamentali del Tempio o della Legge mosaica o del nome di Jahvè, il Sinedrio poteva emettere sentenze di morte senza autorizzazione da parte dell'occupante romano. Semmai era l'imputato che si rivolgeva a Roma per sottrarsi a questi verdetti, come appunto farà Paolo di Tarso, ma doveva avere la cittadinanza romana. Procuratori e prefetti di Roma emettevano sentenze capitali (condannando alla croce) a carico di quei rivoltosi ebrei che destabilizzavano il loro potere, e lo facevano ovviamente senza chiedere alcun permesso alle autorità giudaiche. Nel caso di Gesù, pur avendo egli motivi sufficienti per essere condannato a morte sul piano religioso, il potere popolare di cui egli disponeva faceva diventare insufficienti quegli stessi motivi: ci voleva una sentenza politica emessa da un potere più forte di quello giudaico.
Tale premessa dovrebbe aiutare a leggere meglio Gv 18,29-31, ove le domande e le risposte sembrano essere molto convenzionali, quasi di rito. Pilato, temendo che la popolarità di Gesù gli possa ritorcersi contro, sembra voglia dimostrare di non aver alcuna parte in questo improvviso arresto. La sua prima domanda appare di un'ingenuità sconcertante, al punto da far pensare che chi l'avesse detta non fosse un governatore politico ma un semplice giudice popolare: "Che accusa portate contro quest'uomo?". Gli risposero, tradendo la loro complicità: "Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato". "Malfattore" è un termine giuridico, non esattamente politico. Pilato finge d'interpretarlo così e infatti risponde: "Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!". Nel senso che se Gesù fosse davvero stato un "malfattore" in senso politico, un brigante, un sedizioso, un rivoltoso, ci avrebbe già pensato lui, non avrebbe aspettato che glielo consegnassero le autorità sinedrite, anche perché queste erano sì collaborazioniste ma non così autolesioniste da consegnare fisicamente e pubblicamente i rivoltosi nelle mani del peggior nemico di Israele. Pilato dunque sa bene che di fronte al reato politico di Gesù le autorità saranno costrette a rispondere: "A noi non è concesso mettere a morte nessuno".
Di questo scambio di battute l'evangelista Giovanni dev'essere stato testimone o in qualche modo informato, e non può certo aver pensato di metterle nel suo vangelo per spiegare di quale morte "doveva morire" Gesù, cioè in croce e non lapidato: il v. 32 va chiaramente considerato un'aggiunta a favore del misticismo.
Indubbiamente da questi preliminari di procedura processuale Pilato esce "pulito", cioè alla stregua di un giudice imparziale, che s'è trovato improvvisamente a dover giudicare un caso per lui inaspettato. I quattro vangeli canonici in questo sono unanimi: Pilato andava salvaguardato dal punto di vista politico e riprovato dal punto di vista giuridico, in quanto s'era lasciato raggirare dall'astuto potere giudaico. Quindi delle due l'una: o queste battute iniziali vanno considerate del tutto inventate da un redattore che ha voluto politicamente scagionare il governatore (è strano però che Marco, sempre attento a tutelare i romani, non ne parli), oppure Pilato sta recitando la parte del politico ingenuo, che non s'era reso conto della vera pericolosità del messia Gesù, ovvero del giudice equidistante, disposto a vagliarne la causa, non senza una certa curiosità personale (vedi p. es. lo scambio di opinioni filosofiche sul concetto di "verità").
La recita del copione, da parte di entrambe le parti accusatrici, serve a Pilato per scaricare sui sacerdoti la causa prima della condanna a morte del messia, e serve ai sacerdoti per far capire al popolo che la strategia del messia Gesù era contraria agli interessi del paese. L'importante è dare l'impressione che il messia, alla fin fine, s'è condannato da sé. Presi separatamente, entrambi i poteri oppressivi si rendono conto di non aver sufficiente autorità, né politica né morale per convincere le masse a condannare Gesù, però pensano che, se si accordano, forse riusciranno nel loro intento, anche perché in caso contrario, il loro reciproco destino è segnato: l'insurrezione dei nazareni non voleva essere solo contro Roma ma anche contro i sacerdoti del Tempio. Le questioni giuridiche qui non hanno alcun peso: questo è un processo politico a tutti gli effetti, in cui i poteri costituiti hanno bisogno di far vedere che la sentenza verrà emessa direttamente dal popolo, proprio al fine di evitare incidenti di sorta, che durante la Pasqua hanno un altissimo coefficiente di possibilità. Se Gesù non avesse avuto quella grande popolarità, non sarebbero stati costretti a inscenare un processo-farsa.
"Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse..." (Gv 18,33). Qui il racconto dovrebbe interrompersi, poiché Giovanni non può essere stato testimone del dialogo privato tra Gesù e Pilato (è peraltro incredibile che Pilato, non conoscendo la natura dell'accusa, abbia subito interpretato la parola "malfattore" come "re dei Giudei"). Anche Mc 15,2 va considerato inventato, tanto più che con la sua ambigua risposta, alla domanda s'egli era il messia d'Israele: "Tu lo dici", Gesù avrebbe anche potuto intendere due cose opposte: "Sì, lo sono", "Lo dici tu, non io". Ma Marco va considerato inventato soprattutto là dove dice che Gesù venne consegnato dai sacerdoti a Pilato a causa dell'"invidia" (15,10): un'accusa non politica ma morale, anzi psicologica, che peraltro nel suo resoconto non viene in alcun modo motivata.
Anche i manipolatori del vangelo di Giovanni sono intervenuti per dimostrare sia che Gesù era un sant'uomo ingiustamente accusato e condannato, sia che Pilato era sufficientemente avveduto per capire che le accuse mosse contro Gesù erano del tutto false. Quindi i vv. dal 32 al 38a sono tutti interpolati. La motivazione è la solita: giustificare almeno in parte l'operato di Pilato, il quale, essendo umanamente debole e vile e politicamente opportunista, avrebbe lasciato crocifiggere Gesù per fare un favore ai sacerdoti e alla folla, evitando così a se stesso di avere problemi di ordine pubblico. Se avesse potuto giudicarlo senza condizionamenti di sorta, l'avrebbe sicuramente liberato.
In tal senso il Gesù impolitico che parla davanti a Pilato è lo stesso della comunità cristiana post-pasquale, con la variante, rispetto alla versione sinottica, che qui si evidenziano aspetti di natura filosofica, derivanti da ambienti gnostici, quegli ambienti che trasformeranno la politica rivoluzionaria del Cristo in una sorta di filosofia-religiosa: "Il mio regno non è di questo mondo", "Io sono re [ma] per rendere testimonianza alla verità". È sintomatico, in tal senso, che alla domanda scettica di Pilato: "Che cos'è la verità", Gesù non dia alcuna risposta. Ad essa infatti non si può dare una risposta di tipo filosofico, poiché di fronte a una risposta di tal genere avrebbe sempre avuto la meglio il relativismo di Pilato, non essendosi mai posta la filosofia il compito di mutare i rapporti sociali esistenti, meno che mai quelli di natura oppressiva. Sono queste le ragioni che portano a escludere categoricamente che Pilato fosse interessato a confrontarsi sul piano umano, etico o filosofico col Cristo. Per lui il problema era soltanto quello di come eliminare un pericoloso sovversivo senza scatenare le ire popolari.
Nondimeno resta significativa la frase che viene fatta dire a Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei" (Gv 18,36). I redattori sembrano così voler attestare e, in forza dell'ideologia petro-paolina, giustificare la passività e la rassegnazione con cui i nazareni accolsero il verdetto di morte. Detto altrimenti, non potendo scrivere ch'essi furono colti in contropiede e che la loro sconfitta militare dipese anche dall'immaturità politica che il movimento espresse nel corso del processo, i redattori han preferito puntualizzare espressamente che l'obiettivo del messia non era quello di creare un nuovo regno terreno: col che però non si sono resi conto che, sulla base di una motivazione così mistica, non solo Pilato non l'avrebbe mai giustiziato, ma neppure i sinedriti gliel'avrebbero consegnato, sia perché un profeta meramente religioso non avrebbe avuto un gran seguito popolare, sia perché, senza tale seguito, se avessero dovuto giustiziarlo per motivi religiosi, i Giudei l'avrebbero fatto con tutti i crismi della legalità.
Pilato insomma doveva recitare la sua parte, per cui quando uscì, fingendo d'aver ascoltato la versione di Gesù, propose alla folla di lasciare in libertà per la Pasqua un prigioniero politico: "Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?" (Gv 18,39). Una mossa astuta, poiché, nel caso in cui avessero chiesto Gesù, lui, consegnandolo, avrebbe dimostrato di non averne alcuna paura, e avrebbe avuto ragione, sapendo bene che ormai il tentativo insurrezionale, da farsi di notte e all'improvviso, andava considerato fallito. Eventualmente il Cristo sarebbe stato sorvegliato a distanza o trattenuto nelle carceri fino alla conclusione della festa.
Forse fu proprio quella l'occasione in cui egli ripristinò una vecchia usanza ebraica, oppure un'usanza in voga prima del suo arrivo. Difficile pensare che non avesse avuto rassicurazione, da parte delle autorità giudaiche, che si sarebbe fatto di tutto per scongiurare l'eventualità di liberarlo. Infatti "i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba", scrive Mc 15,11 (da notare che Giovanni qui non distingue tra "folla" e "capi giudaici"). Pilato non aveva proposto questa alternativa, ma ora non può più tirarsi indietro: uno dei due lo deve liberare. Certo qui è difficile capire se a Pilato i sommi sacerdoti saranno parsi eccessivamente anti-romani con la loro richiesta di liberare uno che di sicuro aveva commesso un assassinio politico ai danni della presenza romana sul territorio, oppure se questa richiesta rientrava in un piano che doveva servire ai sacerdoti per far capire alle folle che, non per il fatto di chiedere la morte di Cristo, si doveva pensare ch'esse stessero dalla parte di Roma. Contro la prima ipotesi interpretativa pesa il fatto che Pilato era sin dall'inizio a conoscenza della cattura di Gesù sul Getsemani, che per lui in quel momento costituiva assolutamente il pericolo più grande. Contro la seconda sta il fatto che alla fine del processo, pur di veder morto il Cristo, le medesime autorità faranno esplicita sottomissione a Roma.
Sempre secondo Marco "Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio" (15,7). Quale sia il tumulto non è dato sapere: qui è evidente che Marco minimizza l'importanza di questo leader politico, di cui non si sa neppure il vero nome, in quanto "Barabba" vuol dire semplicemente "figlio del padre", come "Bar Kokhba" – il leader che guidò l'ultima rivolta antiromana – voleva dire "figlio della stella". Luca dice che la sommossa era "scoppiata a Gerusalemme" (23,19) e Matteo che il "prigioniero era famoso" (27,16). È probabile si trattasse di uno zelota e che gli altri due che verranno giustiziati insieme a Gesù fossero suoi compagni.
Ovviamente i Sinottici sono costretti a presentare Barabba come un terrorista meritevole di morte. Giovanni invece si astiene dal fare commenti e si limita a confermare ch'era un leader politico (18,40). Non è da escludere – vista l'insistenza con cui i capi giudaici ne chiesero la liberazione – che dietro la sua azione estremista vi fossero proprio le autorità del Tempio, interessate a creare uno stato di tensione in cui la vigilanza romana fosse particolarmente accentuata, a discapito del movimento nazareno. Barabba non aveva in mente un'insurrezione armata ma produrre solo un'azione dimostrativa.
Ora è evidente che se i sacerdoti chiedono di amnistiare Barabba e Pilato decide di farlo, per loro doveva essere meno pericoloso di Gesù e, sulla base di questa convinzione, il loro problema era semplicemente quello di convincere del contrario la folla, la quale, evidentemente, finì col cadere nella trappola, poiché, in quella situazione di grave oppressione straniera, essa tendeva a privilegiare un'immagine del messia liberatore più autoritaria che democratica (è un peccato, in questo senso, che i vangeli, puntando sulla spoliticizzazione del Cristo, non facciano particolare differenza tra queste due concezioni messianiche). Va detto peraltro che se davvero Pilato avesse avuto intenzione di liberare Gesù – come sostengono i vangeli – non avrebbe mai accettato di metterlo in alternativa con un "prigioniero famoso", poiché la scelta sarebbe stata scontata. Gesù in realtà viene considerato da Pilato come un politico di professione, il cui ascendente sulle masse è infinitamente più grande di quello di Barabba, abituato ad agire secondo criteri terroristici o estremistici e che, una volta liberato, sarebbe stato facilmente ripreso.
I Sinottici e i falsificatori di Giovanni si sentivano in dovere di giustificare l'operato di Pilato non solo perché dopo il 70 il cristianesimo petro-paolino aveva deciso di limitare il proprio impegno politico al solo non riconoscimento della dimensione divina dell'imperatore, ma anche perché se si fosse rischiato di far apparire la morte di Gesù come il frutto di una condanna per motivi politici, si sarebbe irrimediabilmente compromessa l'immagine che di lui si diede, a partire dalla svolta petrina, di un soggetto eminentemente religioso, il cui "regno" appunto non era di questo "mondo", il cui odio nei suoi confronti era "senza ragione" (Gv 15,25).
Gesù dunque – secondo i vangeli – non avendo come obiettivo finale la liberazione della Palestina dai romani, non fallì affatto la sua missione: semplicemente tutto il popolo, inclusi i suoi discepoli, non ne capirono la portata, l'entità, se non dopo la constatazione della tomba vuota, di fronte alla quale però s'inventarono le cose più bizzarre. In tale maniera i vangeli non solo mistificano il suo messaggio ma riescono anche a giustificare la pochezza degli apostoli durante il processo e il loro tradimento dopo l'esecuzione. A questa apologetica versione dei fatti i Sinottici aggiungeranno la tesi antisemita secondo cui, non avendo i Giudei accettato di pentirsi dopo l'esecuzione, dio, attraverso i romani, distrusse giustamente la loro nazione.
Sotto questo aspetto i falsificatori di Giovanni agiscono con più distacco, essendo influenzati da idee di tipo stoico. Il loro Gesù esce vittorioso, nel confronto con Pilato, proprio per aver accettato consapevolmente e volontariamente il destino della croce. Infatti una liberazione politica dall'oppressore romano non avrebbe potuto comportare un'effettiva soluzione del problema di come liberare l'uomo dalla sua tendenza al male. Tale soluzione – sembra voler far capire il vangelo giovanneo manipolato – è possibile solo al di fuori della storia e del tempo, in una dimensione eterna e ultraterrena. Cristo è morto per insegnare il limite estremo dell'amore e, nel contempo, la grande libertà che gli uomini hanno di non credere nella verità del suo vangelo.
II
Pilato, intanto, vinta la prima mossa di offrire teoricamente la libertà al messia, ne approfitta per tentarne una seconda: fustigarlo al punto da renderlo irriconoscibile. La concessione della libertà a Barabba doveva per forza avere un prezzo da pagare ai danni di Gesù. Se Pilato non s'era deciso subito a condannare a morte Gesù, era stato proprio perché temeva la folla (anche se nei vangeli non viene descritta la resistenza da parte dei nazareni), quella folla che, influenzata dai capi giudaici, gli aveva sì chiesto di liberare Barabba, ma non per questo la si doveva considerare disponibile a far giustiziare Gesù.
Pilato deve continuare a recitare la commedia di chi non trova nel messia alcuna "colpa", ovvero la parte di chi, pur trovando in lui tutte le colpe di questo mondo, non può espressamente dirlo per timore che le folle gli si rivoltino contro, e il fatto che avessero scelto Barabba era un indizio in questa direzione. In fondo l'aver assicurato alle folle che il messia per lui non era così pericoloso come si voleva far credere, era come chiedere alle stesse folle di poter avere carta bianca sul destino da riservargli. Ecco perché decise di rischiare la carta della flagellazione, che qui doveva servire per screditare un pericoloso nemico. Cosa che generalmente non veniva fatta prima dell'esecuzione capitale, essendo essa una sorta di punizione minore, un avviso che la volta successiva sarebbe finita peggio.
Gli scherni dei soldati iniziano solo a questo punto, dopo le pesantissime cento frustate, che risparmiarono soltanto la regione cardiaca, per impedire che il detenuto morisse sul posto. Il mantello di porpora rossa viene usato come se Gesù fosse stato un imperatore, la corona di spine come se fosse stato un vincitore, la canna era lo scettro, gli inchini e i saluti sono i finti omaggi tributati a un potente. Un militare non ama essere comandato, perché sa che se disobbedisce pagherà di persona (e quella volta spesso il fio coincideva con la morte); il militare è costretto ad obbedire, spesso per compiere cose che da civile non avrebbe mai fatto; i militari romani amavano poco stare in Palestina, perché la ritenevano una regione molto rischiosa: per loro dev'essere stato uno spasso poter infierire su uno che aveva pretese di comando a livello nazionale, su uno, peraltro, che se fosse riuscito, la notte precedente, a compiere l'insurrezione armata, avrebbe messo tutti loro in una situazione di grave pericolo.
Da notare che Marco non ha capito, a differenza di Giovanni, che la flagellazione permise a Pilato di mostrare alla folla un messia non più in grado di esercitare il proprio ruolo, nei confronti del quale potevano star bene sia la liberazione che la crocifissione. In Marco tutto sembra essere destinato ad andare in un'unica direzione: la stessa flagellazione, che è conseguente alla decisione di farlo crocifiggere, risulta assolutamente banale, anzi incomprensibile, poiché viene fatta subito prima della crocifissione.
Finita la fustigazione e soddisfatti i soldati d'aver sbeffeggiato e torturato Gesù in varie maniere, Pilato esce di nuovo dal pretorio, mostrando alla folla una parodia del messia, con in testa la corona di spine e sulle spalle il mantello di porpora. E lui stesso lo schernisce definendolo con malcelato disprezzo: "Ecco l'uomo". Come può essere definito "re di Israele" uno conciato in quella maniera? Vedendolo trattato così sarebbe stato difficile per la folla chiederne la liberazione. Pur rendendosi conto che doveva apparire un po' illogico ostentare da un lato la propria umanità, dicendo che in lui non aveva trovato alcuna colpa, e dall'altro essersi risolto a ridurlo a brandelli, Pilato, giocando d'astuzia, pensò che quello era il momento buono per comminare la sentenza definitiva. Infatti, al vederlo in quello stato penoso, le autorità giudaiche e le loro guardie si sentirono incoraggiate a proporre l'esecuzione capitale.
La croce era il supplizio degli schiavi ribelli: il sistema più crudele e vergognoso di esecuzione capitale. I romani l'avevano appresa dai cartaginesi e l'avevano vietata per i loro concittadini. Gli stessi ebrei appendevano al palo soltanto uomini già morti. Pilato, prima di acconsentire a un evento così tragico, ha bisogno di saggiare ancora l'umore della folla, per cui dice: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa". Dà l'autorizzazione a compiere una cosa che gli ebrei non potevano fare. Cioè, pur mostrando d'essere convinto della non pericolosità di Gesù come messia, non si sarebbe opposto alla sua condanna a morte. Voleva soltanto che la decisione finale venisse presa dai capi giudaici.
Quando invece si rese conto che si voleva attribuire unicamente a lui il compito di prendere questa decisione, cercò di ottenere dai capi giudaici la massima contropartita possibile. E questo fu il suo secondo capolavoro: non soltanto riuscì a convincere la folla a far giustiziare il detenuto più pericoloso per gli interessi di Roma, ma anche a far ammettere pubblicamente ai capi giudaici che il loro vero sovrano era Cesare.
L'aspetto religioso di questa seconda parte del processo va considerato spurio, poiché Pilato non avrebbe potuto capirlo. Quando i Giudei affermarono che Gesù doveva morire perché s'era fatto "figlio di dio" (Gv 19,7), Pilato al massimo poteva aver intuito che la morte di Gesù era per i sacerdoti del Tempio un affare di stato, ma non poteva certo aver tratto da quelle parole delle conseguenze di tipo mistico. Anche gli imperatori avevano iniziato a pretendere d'essere considerati delle divinità, ma per Pilato l'accusa di sedizione era già più che sufficiente per condannare a morte il messia. Non avrebbe davvero avuto senso che di fronte a un'accusa di tipo religioso, egli si spaventasse ancor più di quella di tipo politico che era stata sostenuta fino a quel momento. Qui i redattori han soltanto voluto far credere che Pilato, di fronte all'accusa religiosa, sarebbe stato ancor più disposto a liberarlo, in quanto lui stesso si riteneva una persona "credente".
III
Rebus sic stantibus, i redattori hanno avuto buon gioco nel far recitare a Gesù una parte ambigua, tra il politico e il religioso, in cui il significato delle sue espressioni potesse apparire ambivalente, soggette a interpretazioni del tutto opposte. Come leggere infatti una frase del genere: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande" (Gv 19,11)? Cosa si deve intendere con la parola "alto"? Dio? il quale dunque avrebbe più colpe di Pilato? Caifa? che politicamente non aveva certo più potere di Pilato? Il sistema imperialistico romano? Cioè Gesù voleva forse far capire a Pilato che non poteva minimamente dipendere da lui se liberarlo o no, in quanto per il potere ch'egli rappresentava, strutturalmente oppressivo, qualunque liberatore nazionale non poteva che essere giustiziato? Non era forse stato Tiberio, il massimo superiore di Pilato, a peggiorare la severità della "Lex Julia maiestatis" per i possibili crimini o reati contro gli imperatori? Dunque Gesù voleva forse dire a Pilato che se anche soggettivamente avesse voluto liberarlo, oggettivamente non avrebbe potuto farlo? E che quindi chi l'aveva consegnato nelle sue mani, avendo effettivamente due possibilità per agire: una rivoluzionaria, l'altra collaborazionista, era più colpevole di lui? E che insomma egli non aveva alcuna intenzione di fare il martire per una "ragione di stato" e che se l'avessero liberato sarebbe stato politicamente soddisfatto?
Se era questo che voleva dire, ci si può stare: l'importante è evitare interpretazioni mistiche che attribuiscano alla "prescienza divina" o alla categoria della "necessità storica" la sua morte. Pilato non era un'autorità politica che "veniva da dio", in senso metafisico (come invece in Rm 13,1), e che, proprio per questa ragione, gli si doveva un naturale rispetto, e neppure era uno strumento religioso che andava interpretato col senno del poi, in una prospettiva soteriologica, nell'ambito dell'economia salvifica del dio-padre.
Ragionando e concessis, al massimo potremmo essere disposti ad ammettere che l'accusa di volersi fare "figlio di dio" (che andava interpretata, per i Giudei, non in senso "teistico" ma "ateistico"), venne formulata dai sacerdoti per far regredire, in senso integralistico, la coscienza di quei Giudei credenti che, pur condividendo il Gesù politico, non ne apprezzavano il lato antireligioso, quello contrario al Tempio, alla casta sacerdotale, quello indifferente al culto, alle sinagoghe ecc. Di sicuro quell'accusa religiosa non venne fatta presente a Pilato allo scopo di impensierirlo – come invece appare nel quarto vangelo, dove addirittura si evidenzia un lato "superstizioso" della sua personalità –, facendogli p. es. credere che il Cristo aveva ambizioni di tipo "imperiale", rivendicando per sé una caratteristica "divina", in maniera analoga a quanto avevano iniziato a fare gli imperatori. Una problematica del genere era troppo prematura per quei tempi, nonostante Pilato sapesse bene quanto fosse difficile far accettare agli ebrei qualunque segno distintivo dell'imperatore entro la loro capitale.
Al massimo si possono accettare quei versetti in cui, di fronte alle false intenzioni di Pilato di volerlo liberare, i capi giudaici gridarono: "Se liberi costui non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare" (Gv 19,12). Una testimonianza di fedeltà di questo genere, che pur era stata data dietro una velata minaccia ricattatoria, poteva esimere Pilato dal dover continuare a recitare la parte del giudice imparziale (molto comoda, peraltro, a dei redattori interessati a presentare un Gesù assolutamente pacifista e non-violento). Egli era riuscito a far dire ufficialmente ai capi giudaici delle cose che in qualsiasi altra situazione sarebbe stato impensabile ottenere: per lui era diventato impossibile, di fronte a tanta fedeltà, non soddisfare le richieste della folla. Anche perché non poteva rischiare, comportandosi diversamente, di veder minacciato il titolo che aveva di "amico di Cesare".
Tuttavia, prima di decidersi, Pilato si mise a sedere su uno scranno del tribunale, nel Litostroto – dice Giovanni –, semplicemente per voler mostrare il suo travaglio di giudice, a motivo della difficile sentenza che doveva emettere. Si sarà probabilmente consultato coi suoi collaboratori più fidati. Si decise solo verso mezzogiorno (e non alle nove, come vuole Marco), dopo un'intera mattinata, a testimonianza che la resistenza del movimento nazareno non fu affatto insussistente, come invece appare nei vangeli.
Essendo i giochi ormai fatti, l'ultima domanda fu abbastanza retorica: "Metterò in croce il vostro re?". Era questo anche un modo per gabbarsi delle sofferenze dei Giudei, i quali, se veramente avessero creduto di poter avere nel Cristo un loro rappresentante autorevole, non si sarebbero lasciati dire queste cose dal tiranno Pilato. La pantomima invece si concluse per lui nel migliore dei modi: "Non abbiamo altro re che Cesare", gli risposero solennemente i sommi sacerdoti (è la prima volta che Giovanni li distingue dal generico "Giudei"), e proprio questo il prefetto voleva sentirsi dire. Mai prima d'ora era riuscito ad ottenere una così alta manifestazione di obbedienza da parte delle autorità del Tempio, e in questo non è possibile non riconoscergli una certa abilità di governo, anche perché non avrebbe potuto restare un decennio in un territorio così politicamente ostico come la Giudea.
Pur di vedere Gesù morto i sacerdoti del Tempio furono persino disposti a prestare pubblica sottomissione a Cesare. Sembra quasi impossibile un servilismo del genere. Per loro qualsiasi rimostranza del popolo avrebbe dovuto essere considerata meno pericolosa dello sviluppo dell'azione messianica del Cristo. Per Pilato, qui grande burattinaio, questo era il massimo che potesse ottenere. Se è vera la tesi secondo cui egli fu indotto dalle circostanze a eliminare Gesù, allora bisogna precisare che tali circostanze furono le più favorevoli al suo potere e a quello di chi lo comandava (Seiano e Tiberio). E purtroppo fu la folla che, convinta di esercitare un proprio diritto democratico, non s'accorse che la morte di Gesù sarebbe stato un evento molto più grave per i destini del paese di quel che a prima vista non sembrasse.
Trent'anni dopo infatti l'estremismo zelota, che pur eliminerà l'ultimo sommo sacerdote, a testimonianza che per fare l'insurrezione antiromana la classe sacerdotale non avrebbe potuto dare alcun contributo, sarà del tutto incapace di unificare il paese in una resistenza davvero popolare.
IV
Questa esecuzione capitale è stata il frutto di un tacito compromesso politico tra il potere civile-religioso giudaico e quello politico-militare romano. È dubbio considerare quest'ultimo come una sorta di braccio secolare dell'altro: solo apparentemente il potere politico ha voluto scaricare su quello religioso la motivazione della condanna, e quello religioso su quello politico la responsabilità di eseguirla. In realtà il tentativo insurrezionale del Cristo non era rivolto solo contro Caifa (quale principale esponente politico collaborazionista di Roma), ma anche e soprattutto contro Pilato (quale principale esponente politico dell'oppressione nazionale romana), sicché Pilato si sarebbe sentito in dovere d'intervenire anche senza il concorso dei capi giudaici.
Resta vero però che una cosa sarebbe stata cercare di eliminare i tanti nazareni in uno scontro armato, in cui rischiare che la folla galilaica e giudaica si mettesse decisamente dalla parte degli insorti, rivendicando, in caso di vittoria, non solo la liberazione della Palestina ma anche un netto ridimensionamento delle prerogative della casta sacerdotale; ben altra cosa invece sarebbe stata se, invece di attaccare militarmente tale movimento, ci si fosse limitati a giustiziarne il principale leader, servendosi, attraverso un'abile regia, dello stesso consenso popolare.
Alla resa dei conti Pilato s'illuse d'aver ottenuto, attraverso la dichiarazione di fedeltà assoluta a Cesare, da parte dei sommi sacerdoti, un attestato di fiducia che in futuro avrebbe dovuto coinvolgere anche le masse palestinesi; Caifa invece s'illuse, ottenendo da Pilato un aiuto decisivo contro il peggior destabilizzatore dei privilegi sacerdotali, di poter far sopravvivere inalterata la sua carica e la casta che rappresentava, in una situazione di compromesso con un invasore ritenuto troppo forte per Israele.
Le questioni propriamente religiose vanno considerate del tutto irrilevanti in tale processo politico, anche se non lo erano per i capi giudaici, a motivo dell'ateismo del Cristo, e di lì a poco non lo saranno neppure per gli imperatori, che inizieranno a perseguitare i cristiani perché non riconoscevano loro alcuna pretesa divina.
(torna su)36) Barabba: ribelle o figura messianica?
Il processo intentato a Gesù fu un processo politico, gestito da Pilato con l'avallo delle autorità collaborazioniste giudaiche, che, pur volendo un'indipendenza da Roma, non erano affatto convinte che sarebbero riuscite ad ottenerla in virtù del movimento nazareno; anzi, temevano che un'insurrezione capeggiata da questo movimento sarebbe stata sicuramente fallimentare e avrebbe scatenato una dura reazione romana, che avrebbe anche potuto portare alla morte la nazione giudaica.
Tuttavia questo movimento e il suo capo erano troppo popolari perché si potesse facilmente avere la meglio su di loro (basta vedere il successo ottenuto una settimana prima della Pasqua, in cui il Cristo entra trionfante a Gerusalemme, pur seduto su un asinello in segno di pace). La cattura di Cristo fu resa possibile solo grazie a un tradimento, e nel Getsemani non vi fu spargimento di sangue soltanto perché il Cristo si consegnò spontaneamente, ottenendo in cambio che la vita degli altri discepoli restasse salva e nessuno venisse catturato (evidentemente nella speranza di poter essere successivamente liberato o nella speranza che i suoi migliori discepoli potessero realizzare ugualmente il progetto di liberazione nazionale).
Al momento del processo Pilato e i capi ebrei collaborazionisti non erano affatto sicuri che sarebbero riusciti a farlo condannare. Temevano la reazione del popolo. Il processo infatti è durato un'intera mattinata, nel corso della quale le autorità hanno cercato di convincere il popolo che sarebbe stato meglio condannarlo alla croce.
Tra i vari tentativi, riportati nei vangeli, per dimostrare la giustezza o la necessità della condanna, due sono molto evidenti: la flagellazione e lo scambio dei prigionieri. Barabba era un politico rivoluzionario come il Cristo, ma apparteneva a un partito, quello zelota (o dei sicari), che praticava il terrorismo e che aveva meno seguito popolare rispetto a quello nazareno. A Pilato e ai capi giudaici Barabba faceva meno paura del Cristo.
Durante il processo si riuscì però a dimostrare che per la causa d'Israele sarebbe stato meglio liberare Barabba piuttosto che il Cristo. Pilato non fece altro che accettare la proposta dei capi giudaici. E il popolo lì presente (cioè la sua maggioranza) credette a questo inganno e contribuì anch'esso, indirettamente, a far condannare il proprio messia.
Noi dunque non sapremo mai perché i vangeli ci abbiano impedito di identificare il terrorista o zelota Barabba, che aveva ammazzato qualche romano sempre nella settimana di Pasqua. Persino gli altri due crocifissi ai lati di Gesù i vangeli li hanno definiti vergognosamente ladroni, briganti, ecc., salvo poi moralisticamente salvarne uno e condannare l'altro (riducendo così la questione politica dell'insurrezione a una questione etico-religiosa di fede nella divinità del Cristo).
Tendenzialmente però sappiamo che i redattori fecero di tutto per impedire una qualunque precisa identificazione di luoghi e persone che avevano avuto col Cristo un rapporto politico. È probabile quindi che la scelta di liberare, al momento del processo, l'estremista Barabba, dipese dal fatto che il popolo era stato persuaso dai sacerdoti ch'egli avrebbe dato maggiore affidabilità antiromana (il popolo voleva l'insurrezione e i sacerdoti, per poterlo ingannare, dovettero tenere conto di questa istanza eversiva).
Naturalmente i sacerdoti sapevano che Gesù sarebbe stato un avversario più pericoloso per Roma, avendo un movimento più consistente e organizzato, ma sapevano anche che, se questo movimento fosse riuscito a cacciare i romani, anche il loro destino sarebbe stato segnato, avendo il Cristo fatto loro capire chiaramente, già con la prima insurrezione contro i mercanti del Tempio (compiuta almeno tre anni prima, secondo Giovanni), che una gestione politica della fede religiosa sarebbe stata inammissibile in un paese che voleva realizzare non solo la liberazione nazionale ma anche la democrazia.
Insomma, poiché i vangeli non solo hanno dovuto spoliticizzare al massimo il Cristo, ma hanno voluto professare anche un aperto antisemitismo, sono stati costretti a dare dei Giudei l'immagine più vergognosa possibile, quali responsabili di un'incredibile scelta, che può essere tipica solo di un popolo che va giudicato "maledetto", che non merita alcuna giustificazione, alcuna comprensione: al Cristo (giusto, figlio di dio, santo...) hanno preferito un assassino come Barabba.
In questo modo i redattori evitano di farci capire che al Cristo politicamente democratico-rivoluzionario i Giudei preferirono un altro leader politicamente estremista-avventuriero, nella convinzione d'aver fatto la scelta politicamente più giusta.
Infatti non è possibile ingannare il popolo se non si riesce a convincerlo che quello che sta per fare è per il proprio bene. Pilato non fu affatto una marionetta nelle mani dei capi-religiosi ma un co-responsabile, poiché è da escludere categoricamente ch'egli non sapesse quanto fosse più pericoloso Gesù rispetto a Barabba. D'altra parte la stessa idea di mettere i due in alternativa, fa capire eloquentemente quanto temesse che, condannando senza mezzi termini il Cristo, il popolo gli si rivoltasse contro immediatamente.
(torna su) - (Sulla figura di Barabba vedi anche questo testo)37) I vangeli e la passione di Gesù
Nei racconti evangelici della "passione di Gesù" c'è una contraddizione così macroscopica che poteva essere sostenuta solo a condizione che i protagonisti dei fatti fossero o scomparsi o ridotti al silenzio. La folla di Gerusalemme, che lottava contro i romani non meno di quella samaritana o galilaica, avrebbe chiesto la condanna del Cristo appunto perché "messia politico". Una folla completamente reazionaria e asservita all'imperialismo romano, e proprio quella ebraica!
Alle origini del cristianesimo un credente poteva accettare una versione del genere solo perché sapeva di non appartenere ad una comunità avente finalità eversive. Il cristianesimo infatti ha scaricato completamente sugli ebrei la causa della condanna di Gesù, scagionando persino una crudele marionetta dell'imperialismo romano come Pilato, che è stato trasformato in una mera vittima delle circostanze (lui che poteva abbastanza tranquillamente esserne il regista).
La cosa più ridicola, inoltre, è che mentre la folla chiede la condanna a morte del messia-Gesù, la stessa folla chiede anche la liberazione di un altro messia politico, Barabba, che i vangeli peraltro descrivono come un terrorista (Lc 23,18) o un ladrone (Gv 18,40). Qual era dunque l'intenzione degli evangelisti? Semplicemente quella di far credere che la folla ebraica di Gerusalemme, qua talis, aveva assunto una posizione assurda, disumana (quando proprio da quella folla erano emersi i primi discepoli di Gesù!).
È evidente che quando i vangeli furono scritti o quando vennero accettati come "canonici", nessuno era più in grado di smentirne il contenuto, neppure nelle sue singole parti. Gli evangelisti infatti sono tutti preoccupati di mascherare che la scelta di liberare Barabba, in luogo del Cristo, fu determinata proprio da un atteggiamento politico estremista, col quale non si riuscì a comprendere che la politicità del Cristo aveva un respiro strategico di molto superiore a quella dei terroristi (zeloti?) capeggiati da Barabba.
Agli evangelisti interessava unicamente mostrare che il Cristo non era un politico e che quindi l'odio nei suoi confronti nasceva da motivazioni del tutto irrazionali, incomprensibili, assai più vicine al fanatismo religioso che non alla lotta politica. Gli ebrei della capitale sarebbero stati una massa di pazzi scatenati, del tutto ignari di quello che facevano: una folla ingenua, manipolata dalle autorità religiose, le quali provavano "invidia" verso un personaggio così popolare come Gesù (Mc 15,10; Mt 27,18).
Il cristianesimo primitivo ha cercato una sorta di giustificazione al fallimento delle proprie aspettative rivoluzionarie; solo che, così facendo, ha creato un forte pregiudizio antisemita, che ancora oggi tarda a morire. Invece di puntare sul fatto che, al momento della "passione", il popolo ebraico si era anzitutto comportato come un "popolo qualunque" (con le sue correnti di "destra", di "centro" e di "sinistra"), si è preferito sottolineare l'ebraicità di questo popolo, dando a questa caratteristica una connotazione decisamente negativa, tanto che in Mt 27,25 si arriva addirittura a far pronunciare al popolo una frase terribile: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli".32
Questo modo di fare la storia è a dir poco fazioso e pregiudizievole. I cristiani non hanno mai voluto fare una vera autocritica, e se l'hanno fatta, essa di certo non appare nei documenti, molto selezionati, del Nuovo Testamento. Essi hanno dissimulato la loro incapacità rivoluzionaria scaricando sugli ebrei una responsabilità che, in quanto "ebrei", non hanno mai avuto, poiché il Cristo è stato crocifisso sia dai romani persecutori, sia dagli ebrei collaborazionisti, sia dai "cristiani" che non hanno fatto nulla di decisivo per salvarlo.
*
Una delle cose più curiose dei Sinottici è l'aver fatta propria, da un lato, la tesi di Pietro secondo cui il Cristo "doveva morire" e, dall'altro, di aver considerato l'ebraico come un "popolo maledetto da dio". Paolo addirittura arriverà a sostenere che dio si servì dell'odio che i Giudei nutrivano nei confronti del Cristo al fine di far perdere loro il primato sui Gentili. Che cos'è questa se non un'astratta metafisica?
Se gli ebrei assassini avessero accettato l'idea di resurrezione, probabilmente non ci sarebbe stato alcun motivo, per i cristiani, di rompere con loro, né di considerare i pagani in maniera paritetica. Che cos'è questo se non un opportunismo politico?
I primi seguaci di Gesù, nell'ambito della comunità post-pasquale, avevano forse dei motivi validi per polemizzare con gli ebrei, se si esclude l'argomento della resurrezione? No, tanto è vero che nel primo concilio apostolico, a Gerusalemme, il dibattito fu impostato esclusivamente sulla questione della circoncisione e di altre usanze ebraiche che, secondo Paolo e altri suoi seguaci, non potevano essere imposte ai pagani neo-convertiti al cristianesimo. Meno che mai dopo l'esecuzione capitale del Cristo.
Sul piano politico gli ebrei divenuti cristiani di Gerusalemme attendevano ancora, esattamente come tutti gli altri ebrei non collaborazionisti con Roma, la restaurazione del regno davidico: la differenza stava soltanto nel fatto che i primi aspettavano l'imminente e gloriosa parusia del Cristo (nella convinzione che fosse davvero risorto). Essi non vedevano di buon occhio la predicazione di Paolo ai pagani perché avevano l'impressione che Paolo perdesse il suo tempo e, soprattutto, ch'egli lo facesse proprio perché non credeva più nella restaurazione del regno d'Israele. In pratica gli ebrei cristiani tenevano nei confronti di Paolo lo stesso atteggiamento ch'egli aveva tenuto nei confronti degli ebrei ellenisti al tempo dell'assassinio di Stefano.
(torna su)38) Crocifissione e morte del Cristo
Gv 19,17-37 - Mc 15,16-41
La crocifissione
Era consuetudine che il condannato portasse il palo trasversale della croce (patibulum) fino al luogo del supplizio, ove l'attendeva il palo verticale (stipes), già conficcato per terra. Questa cosa non viene compresa leggendo i vangeli, anzi in quello di Marco è scritto che non fu neppure Gesù a portare la croce (che poteva pesare anche 50 kg), ma l'agricoltore Simone di Cirene che, pescato casualmente dai soldati di picchetto, fu costretto ad aiutare un condannato già ridotto a brandelli in seguito alla pesante fustigazione e alle altre torture. La Sindone attesta le cadute, lungo il tragitto di 600 metri sino al Golghota, mostrando terriccio nelle ginocchia e al naso. Vi è anche una zona escoriata e contusa tra lo zigomo destro e il naso, provocata da una caduta, la cui violenza ha rotto la cartilagine del naso.
Che Simone gli abbia portato la trave, forse per l'ultimo tratto, è documentato anche dal fatto che i soldati trafissero i polsi di Gesù coi chiodi, mentre in genere il condannato, che non doveva morire subito ma soffrire tra indicibili tormenti, alla trave veniva tenuto legato e solo i piedi venivano trafitti: un chiodo per ogni piede. Invece nel caso di Gesù si fu quasi costretti a scegliere la soluzione dei tre chiodi: una soluzione che porterà Pilato a meravigliarsi della fine repentina del Cristo.
Ma anche prescindendo dal particolare dell'aiuto improvvisato, di cui Marco non spiega la motivazione e che evidentemente per Giovanni non rappresentò alcunché di significativo, le differenze tra i due racconti si notano sin dall'inizio. Infatti in uno Gesù viene "condotto" sul calvario, nell'altro invece sembra che vi giunga da solo, autonomamente e senza aiuti. Generalmente, quando si tratta di scegliere a quale delle due principali versioni evangeliche dare maggiore credibilità, tendiamo a preferire quella giovannea, ma in questo caso ci sorgono dei dubbi, che però finiscono qui, poiché, anche se Giovanni è molto più veloce nel descrivere questa via crucis, i particolari da lui evidenziati risultano largamente più interessanti di quelli di Marco.
Sono interessanti – come spesso succede leggendo il suo vangelo – per motivi politici. Vediamo anzitutto quello dei due condannati che accompagnavano Gesù. In Mc 15,27 (e Mt 27,38) si tratta di due "ladroni" o, secondo Lc 23,32, di due "malfattori", cioè di "criminali comuni": ebbene – ci si può legittimamente chiedere – che ci facevano sulla croce, visto che quello era il supplizio per i sediziosi o gli schiavi ribelli?
Giovanni, evitando di aggettivarli, dà invece per scontato che fossero due prigionieri politici, probabilmente compagni di lotta di quel Barabba che, grazie al baratto voluto da Pilato, riuscì per sua fortuna a scamparla, almeno in quel momento.33 Ciò naturalmente non significa ch'essi non dovessero avere delle ragioni per insultare il messia in croce, associandosi al coro insolente e provocatorio della folla e dei capi, come sostengono Marco e Matteo (Luca preferisce distinguere gli atteggiamenti dei due "malfattori", ma risulta un po' patetico). Tuttavia noi non possiamo dare per scontata questa acredine, anche perché non è sicuro che ai piedi della croce vi fosse davvero tanta gente disposta a offendere il Cristo; e poi, in definitiva, se vogliamo anche ammettere che i due fossero dei "criminali comuni", non si capisce perché dovessero avercela a morte con un condannato per motivi politici: generalmente anzi tra i destinati alla pena capitale non vi è odio ma solidarietà.
Il corteo al seguito di Gesù
Secondo Giovanni il corteo che seguì il condannato sul Golghota34 dovette essere composto da poche persone: tra i discepoli presenti cita solo quattro donne. Secondo Marco invece ve ne erano parecchie: dai semplici passanti ai sommi sacerdoti, tutti intenti a deridere Gesù, e nella sua versione risulta stranamente assente la madre di lui, che, data l'importanza, non può ritenersi inclusa semplicemente nelle "molte altre" provenienti dalla Galilea. D'altra parte Marco aveva già espresso un giudizio negativo nei confronti di Maria (3,31 ss.).
L'iscrizione della croce
Diversamente che in Marco, dove risulta imprecisa l'iscrizione del titolo della colpa, che manca del riferimento al nome del condannato, Giovanni sostiene ch'essa fu fatta apporre da Pilato sulla croce di Gesù in tre lingue (l'ebraico o l'aramaico, ch'era la parlata palestinese, il latino dell'occupante romano e l'universale greco), a testimonianza forse della particolare popolarità del soggetto in questione.
Peraltro a Marco risulta del tutto estranea la contestazione sul medesimo titulum. Eppure le fonti cui avrebbe potuto attingere erano le stesse di quelle di Giovanni: le donne ai piedi della croce. Il quarto vangelo invece fa notare che i sommi sacerdoti, i sadducei e gli anziani, che poche ore prima, pur di vedere giustiziato Gesù, avevano dichiarato di non avere altro re che Cesare, si erano lamentati con Pilato dicendo che sarebbe stato meglio scrivere non "Il re dei Giudei" ma "Io sono il re dei Giudei" (Gv 19,21). In altre parole, essi volevano recuperare agli occhi del popolo quella credibilità necessaria a dimostrare che stavano ancora dalla parte delle tradizionali speranze dell'oppressa nazione. Il nuovo messia che si doveva attendere, contro i romani, non avrebbe dovuto mettere in discussione le loro prerogative di casta.
Ma Pilato, che forse di fronte a una tale richiesta si sarà reso conto d'aver vinto coi Giudei solo una semplice battaglia, ribadì seccato la giustezza della motivazione della sentenza: "Ciò che ho scritto ho scritto" (Gv 19,22), e l'aveva fatto secondo la Lex Julia che lui stesso doveva rigorosamente rispettare. Il che, in sostanza, era un avviso forte e chiaro per tutti coloro che, chiusa la parentesi di Gesù, avevano nuovamente intenzione di tornare alle ostilità contro Roma: la prossima volta egli non avrebbe accettato di recitare la parte del giudice imparziale e del governatore che fa di tutto per non peggiorare la situazione.
Infatti, dopo questi eventi, Pilato avrà molti altri problemi da affrontare con gli ebrei, di cui parla lo storico Giuseppe Flavio, finché il massacro dei Samaritani sul monte Garizim, nel 36, non lo costringerà a rinunciare all'incarico. La situazione resterà incandescente anche coi suoi successori, per altri trent'anni, fino alla scoppio della grande guerra giudaica nel 66.
Il ruolo dei militari
Giovanni torna a parlare dei militari durante la spartizione delle vesti e della tunica: scrive che erano quattro e tra loro non vi era il "centurione" citato in Marco, il quale – come noto – era preposto al comando di un'unità di almeno otto uomini.
Come di regola i componenti del picchetto d'esecuzione del condannato a morte avevano il diritto di spartirsi i suoi ultimi beni. Questo episodio, in sé del tutto irrilevante, è stato interpolato nel vangelo di Giovanni allo scopo di metterlo in relazione simbolica con il Salmo 22, arbitrariamente scelto al fine di giustificare la tesi petrina della "morte necessaria".
Vi è comunque un'altra differenza tra la versione marciana e quella giovannea: nella prima si giocano a dadi tutte le vesti, nella seconda – in maniera più logica – solo la pregiata tunica senza cuciture, che nell'Antico Testamento era segno di regalità (come la "porpora" di cui parla Mc 15,20); anzi una delle sofferenze morali più grandi del "giusto" o del sovrano "ingiustamente perseguitato" poteva anche essere quella di vedere la propria tunica giocata ai dadi: una sorta di sconfitta politica su tutti i fronti.
Con fare molto apologetico e non senza tracce di antisemitismo, Mc 15,39 sostiene che l'unico militare, in quel momento, a riconoscere Gesù morto come "figlio di dio" sarà proprio il centurione (che qui inevitabilmente ricorda quello di nome Cornelio citato in At 10,1).
La madre di Gesù
Come faccia Giovanni a sapere tutti i particolari di cui parla non può dipendere da quanto viene scritto in fondo alla pericope, e cioè ch'egli era presente in quel luogo. È probabile invece ch'egli si sia servito della testimonianza delle quattro donne citate: la madre di Gesù, sua sorella Salome (ch'era madre dei fratelli Zebedeo), Maria di Cleofa (madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, o Joses) e Maria di Magdala (o Maddalena)35, ricordate anche da Marco, ad esclusione della prima.
L'episodio della consegna reciproca, da parte di Gesù, della propria madre a Giovanni e di questi a quella, va considerato spurio, in quanto l'apostolo non poteva essere ai piedi della croce in quel momento. Tuttavia non è escluso che Gesù abbia detto a Maria di chiedere a Giovanni di poter essere assistita da lui.
A dir il vero dovremmo considerare abbastanza scontato che alla morte di Gesù i suoi fratelli e sorelle o qualcuno dei discepoli si sarebbe dovuto far carico delle necessità di sua madre, la quale, probabilmente o era già vedova o era stata abbandonata da Giuseppe, stando a talune interpretazioni dei racconti dell'infanzia di Gesù riportati da Matteo e Luca.
Pertanto appare strano qui, anche considerando che il vangelo di Giovanni è un testo eminentemente politico, che l'evangelista (o un redattore successivo) si sia voluto soffermare su un aspetto che ha l'aria di presentarsi in maniera privata. Doveva per forza esserci qualcosa di più di un semplice gesto di pietà filiale.
Anzitutto, in effetti, la pericope sembra valere come firma autografa del quarto vangelo: era infatti noto che Maria fosse andata a vivere con l'unico apostolo celibe. In secondo luogo non è da scartare l'idea che con questa richiesta di assistenza Gesù avesse voluto far capire a Giovanni che il compito di proseguire politicamente la sua missione spettava proprio al discepolo che, agli occhi della madre, avrebbe potuto meglio sostituirlo sul piano umano, e, all'opposto, che se Giovanni aveva saputo essergli vicino umanamente ora doveva esserlo, in maniera coerente, anche sul piano politico. Quindi non si trattava soltanto di un semplice affidamento filiale, protettivo, ma anche del riconoscimento di una legittima successione politica, che però non avvenne ufficialmente, essendo prevalsa l'ideologia petrina della "morte necessaria" del messia. Di qui forse l'assenza di Maria nell'elenco delle donne riportato da Marco.
Resta comunque singolare che nessuno dei Sinottici, neppure i due che l'hanno maggiormente esaltata nei racconti mitologici della natività, riporti il fatto che ai piedi della croce vi era anche la madre di Gesù, come vuole la testimonianza di Gv 19,25 ss.36
Il vino mirrato
In Mc 15,23 si vogliono offrire a Gesù un vino mirrato o drogato, inebriante, prima della crocifissione, per lenire il dolore, ma lui lo rifiuta, e di nuovo glielo danno, questa volta acetato, prima di morire, per dissetarlo, ma lui non fa in tempo a prenderlo. Si ha l'impressione che la bevanda acidula (posca), di cui facevano uso i soldati romani per dissetarsi, venga offerta come ulteriore offesa a un Cristo già molto sofferente, quasi gli si volesse prolungare l'agonia in attesa che "Elia" venisse a liberarlo.
Secondo Giovanni invece Gesù, che non pronunciò la frase veterotestamentaria: "Elì, Elì, perché mi hai abbandonato?", disse semplicemente di "aver sete" e fu esaudito. Con la flagellazione, l'incoronazione di spine e l'inchiodamento egli doveva aver perso un fiume di sangue: di qui l'arsura e la sua precoce morte.
Tuttavia in Gv 19,28 il redattore ha voluto vedere nella semplice richiesta di bere un riferimento esplicito a un passo dell'Antico Testamento, "per adempiere la Scrittura", e per poter dire, subito dopo aver preso l'aceto, "Tutto è compiuto". Questo modo di vedere le cose è semplicemente immaginifico, anche se può essere realistico che Gesù non sia morto urlando di disperazione.
Le frasi ingiuriose
Marco è molto severo nei confronti dei Giudei, che paiono tutti contro Gesù, dai capi al popolo, ivi inclusi i due "ladroni": le frasi che usano sono particolarmente ingiuriose e offensive, sino all'ultimo suo respiro.
Luca invece si limita a dire che solo i capi lo schernivano, mentre il popolo stava a guardare. In altre parole cerca di farlo morire con dignità e serenità interiore, ma usando tutta una serie di artifici letterari che rendono il racconto alquanto inverosimile (dei due "malfattori" crocifissi solo uno lo insultava; l'altro riceve la promessa del paradiso direttamente da Gesù, il quale chiede al padre dei cieli di perdonare gli uomini perché non sanno quello che fanno; subito dopo la sua morte, la folla torna a casa piangendo, ecc.).
Giovanni probabilmente evita di parlare dei Giudei presenti poiché, in quella situazione, qualunque comportamento non avrebbe potuto aggiungere o togliere nulla alla loro colpevolezza. Perduta l'occasione di manifestare un pieno appoggio all'iniziativa rivoluzionaria del Cristo, tutto il resto non era altro che una fatale e tragica conseguenza, da accettarsi con compostezza. Ciò che in quel momento più contava era vedere se il Cristo moriva con dignità o rancore, disperato o sereno.
Il colpo di lancia
Giovanni ha messo il particolare della trafittura al costato, non riportato nei Sinottici ma confermato dalla Sindone, non per trovare, ovviamente, un'assonanza con le Scritture (i vv. 36-37 vanno considerati un'interpolazione, come il 34b), ma per dimostrare una cosa molto più importante, e cioè che Gesù morì effettivamente sulla croce non perché gli evangelisti lo scrissero, ma perché lo attesta la potenza romana.
Egli morì prima degli altri due probabilmente a causa dello spargimento di sangue procurato dalla pesante flagellazione, dalla coronazione di spine, dall'uso dei chiodi in luogo delle corde, dai molti maltrattamenti subìti, oltre ovviamente alle difficoltà respiratorie dovute a quella posizione. Se i soldati avessero avuto dubbi sul suo decesso, sicuramente gli avrebbero spezzato le ginocchia (crurifragium) come agli altri due, per affrettarne la sepoltura nell'imminenza del sabato pasquale. Il colpo di lancia dritto al cuore (per il quale non s'è potuta trovare una citazione analoga nel Vecchio Testamento!) era la sicurezza matematica di cui avevano bisogno prima di autorizzare la sepoltura, come i gladiatori nell'arena, quando dovevano finire, con la spada, i loro rivali.
La Sindone attesta che il sangue della ferita del torace è sgorgato da una persona già cadavere: la parte seriosa bianca è separata da quella rossa (Gv 19,34).
L'ora della morte
Dice Mc 15,25: "Erano le nove del mattino quando lo crocifissero", cioè era "l’ora terza". Ma l’ora terza include il tempo dalle nove a mezzogiorno. Tradurre "nove del mattino", come fa la Bibbia di Gerusalemme, è un assurdo, poiché contraddice sia la versione di Gv 19,14, che pone la crocifissione "verso mezzogiorno", dopo un lungo e tortuoso processo pubblico, in cui non si dava affatto per scontata la morte di Gesù37 (e Giovanni, in questi dettagli, è sempre più preciso di Marco); sia la stessa affermazione di Mc 15,44, secondo cui Pilato, al momento in cui Giuseppe d'Arimatea gli chiese il cadavere di Gesù, "si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo". Va tuttavia detto che prima si anticipa la crocifissione del Cristo e più facilmente le si toglie la sua motivazione politica.
Gesù morì nel primo pomeriggio (secondo Mc 15,34 alle tre, e questo coincide con la versione di Giovanni). Dal momento in cui Giuseppe chiese la salma al momento in cui la ottenne, passarono sicuramente un paio d’ore. Peraltro Giuseppe si decise a chiederla solo dopo che i Giudei avevano mostrato l'intenzione di far seppellire i cadaveri in una fossa comune, essendo per loro "indecoroso" tenerli appesi nella festività della Pasqua.
Considerando poi che Giuseppe dovette cercare la tomba (sempre che non fosse già sua, come dice il solo Matteo) e acquistare il lenzuolo per avvolgere il cadavere, si spiega il motivo per cui tutti gli evangelisti dicono che al momento della sepoltura ormai era "sera", cioè in pratica "sabato", stando al modo ebraico di contare le ore.
Sepoltura di Gesù: ricostruzione ipotetica
Gv 19,38: Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
Mc 15,44: Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.
Mc 15,46: Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Gv 19,41: Infatti, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto.
Mc 15,46: Poi Giuseppe fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro.
Mc 15,47: Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Joses stavano ad osservare dove veniva deposto.
Gv 19,42: Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei [vigilia della Pasqua], poiché quel sepolcro era vicino.
La dichiarazione dei discepoli di Giovanni
In Gv 19,35 risulta molto strano che, nel descrivere questa morte, i suoi discepoli abbiano avvertito la necessità di precisare che "chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate". Sono stati davvero i suoi discepoli a farlo o suoi manipolatori?
Istintivamente vien da pensare che la precisazione venne fatta perché, essendo in quel momento la versione di Marco la più accreditata, si voleva far credere ch'era attendibile anche quella dell'apostolo prediletto.
Tuttavia, se si guardano le manipolazioni subite dal quarto vangelo, vien da pensare in realtà il contrario, ossia che tutto ciò che è stato scritto in questo vangelo è vero non tanto perché lo testimonia Giovanni, quanto perché è stato confermato dalla chiesa ufficiale, che ne ha revisionato il contenuto. Infatti, a leggere il quarto vangelo uno può avere l'impressione che tra questo e i Sinottici le incoerenze o incongruenze prevalgano nettamente sugli aspetti comuni. Invece i redattori qui sembrano voler affermare che gli aspetti difformi del quarto vangelo non contraddicono, nella sostanza, le tesi teologiche dominanti nei Sinottici.
(torna su)39) Il significato della morte: riepilogo generale
Ciò che Cristo disse sulla croce è importante solo relativamente, in quanto quel che voleva far sapere ai propri discepoli era già stato detto nel corso di vari anni. Se accettiamo l'espressione riportata da Giovanni: "Tutto è compiuto", dobbiamo appunto intenderla nel senso che Gesù ebbe la consapevolezza che più di così, nel rispetto della democrazia, egli non avrebbe potuto fare: ora stava ai discepoli proseguire la sua missione, cercando di conciliare il più possibile gli aspetti umani e politici.
Nell'ultima settimana di lotta, a Gerusalemme, volendo restare fedele sino alla fine all'ideale che s'era prefisso: liberare la Palestina dagli oppressori interni ed esterni, egli aveva dovuto affrontare due problemi fondamentali, dalla cui soluzione sarebbe dipeso il successo dell'impresa. E le risposte che si diede furono le seguenti: non si può fare alcuna insurrezione nazionale popolare confidando soltanto nell'appoggio dei propri seguaci; si può accettare anche il proprio sacrificio quando questo serve per non mettere a rischio l'incolumità dei propri discepoli. La prima cosa l'aveva capita prima del tradimento, la seconda dopo. Quanto al tradimento, era evidente che non si poteva evitarlo imponendo a un movimento democratico un regime di sospetto e di terrore.
Quindi se la sua strategia era fallita, per l'immaturità delle masse e l'ostilità dei capi politici, il suo ideale restava integro, a disposizione di quanti avessero voluto continuare la missione salvaguardando le regole della democrazia, quelle stesse regole che, quando vengono rispettate e accettate con coerenza, possono anche portare sul patibolo.
Detto questo, sarebbe ora del tutto fuorviante pensare che il consummatum est si sia compiuto definitivamente sulla croce. Sul Golghota in realtà si era soltanto concluso per il messia l'esercizio della propria opportunità politica e umana, che non poteva non prevedere l'accettazione consapevole di una soluzione negativa della strategia rivoluzionaria. Ciò però non avrebbe dovuto pregiudicare minimamente, agli occhi dei discepoli più fidati, il compito di proseguire in maniera positiva la missione rivoluzionaria: si trattava soltanto di convincersi che esistevano tutte le possibilità per superare le conseguenze del tradimento di Giuda.
Purtroppo gli eventi non andarono come previsto. Infatti, invece di proporre alle masse una speranza politica di liberazione, gli apostoli, con Pietro in testa, si limitarono a sostenere l'idea di un fatto biologico e del tutto personale del messia: quello che determinò la tomba vuota. Col che essi si renderanno responsabili di tutte le mistificazioni, i tradimenti, le astratte e mitologiche congetture che si opereranno su di lui da allora ad oggi.
In particolare nei racconti di crocifissione e morte del messia Gesù, Marco e Giovanni, pur dando un'interpretazione diversa di questi eventi, nella sostanza restano entro i limiti del misticismo, con la differenza che l'uno lo scelse, l'altro vi fu costretto dalle manipolazioni.
Il Cristo marciano è disperato e chiede aiuto al padre dei cieli, avendo a che fare con un nemico implacabile tra la sua stessa gente, ma sa anche che questo nemico è uno strumento di cui dio-padre si serve per compiere la propria volontà, che è quella di togliere a Israele il primato storico di "nazione eletta", rendendo gli ebrei uguali ai gentili, e tutti, nel nome di Cristo, desiderosi d'essere salvati solo nell'aldilà.
Il Cristo marciano è quindi un martire che accetta di sacrificarsi per un fine superiore di bene. La croce è servita per inaugurare la morte di Israele, che non è più capace di vero bene, di cui è simbolo il velo squarciato del Tempio: la rottura è tragica, al punto che il nuovo credente diventa il centurione romano.
Marco si spinge verso una posizione estrema, antisemita, sostenendo che, a causa delle proprie colpe, la Palestina va distrutta, in quanto l'addebito della crocifissione ricade esclusivamente sulle spalle dei "perfidi Giudei", "popolo deicida" per eccellenza. Viene superato persino l'atteggiamento conciliante che Pietro, che pur è fonte di questo vangelo, tenne negli Atti, allorché sembrava essere disposto a un compromesso con le autorità sinedrite, ridimensionando la morte di Gesù in un misterioso progetto divino, rimasto nascosto al popolo ebraico e che andava oltre la semplice liberazione dai romani.
Anche nella versione giovannea manipolata è presente l'idea di "morte necessaria", ma non come obbligo da subire. Il suo Cristo non muore invocando l'aiuto di dio-padre, sentendosi abbandonato da tutti, ma con assoluta dignità e padronanza della scena. Croce e gloria coincidono: Cristo vi è salito per dare testimonianza di sé, per dimostrare che quello è il modo migliore di amare l'intera umanità.
Nessuno dei due evangelisti attribuisce allo stesso movimento nazareno una parte della responsabilità di questa morte. Non vi è alcuna autocritica, come non ve n'è in alcuna parte del Nuovo Testamento.
(torna su)40) Appendici
In che senso il vangelo di Marco può essere definito "vangelo di Pietro"?
Conversione dei primi apostoli (Mc 1)
[16] Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
[17] Gesù disse loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini".
[18] E subito, lasciate le reti, lo seguirono.
[19] Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti.
[20] Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
*
Nel suo vangelo (1,35-51) Giovanni spiega che la conversione di Pietro non avvenne come viene raccontata da Marco, cioè mentre pescavano sul lago di Galilea, ma avvenne attraverso Andrea (detto dalla chiesa il "protoclito", "primo chiamato"), ch'era discepolo del Battista: fu lui che, lasciato il movimento del Precursore e avendo deciso di abbracciare la causa del Cristo, convinse il fratello Simone a fare lo stesso. E questi, in quel momento, doveva trovarsi a Gerusalemme, poiché Andrea poté incontrarlo subito e, insieme agli altri primi discepoli di Gesù, è molto probabile che abbia assistito o addirittura partecipato alla cacciata dei mercanti dal Tempio, anche se questo episodio, nel vangelo di Marco, ha una collocazione del tutto sbagliata, funzionale a uno schema redazionale di tipo catechetico, non storico. Tra i seguaci del Battista vi era anche Giovanni Zebedeo, che probabilmente convinse il fratello Giacomo a seguire Gesù.
Come risulta dall'elenco marciano dei Dodici, Giovanni conferma che il nome di Pietro (Cefa = pietra) fu dato a Simone dallo stesso Gesù, ma questo nome di battaglia gli venne dato in Giudea, nell'imminenza della rottura col movimento del Battista, che Marco non ha mai voluto mettere in risalto nel suo vangelo, prevalentemente ambientato in Galilea, in polemica con gli ambienti giudaici. Il motivo per cui gli abbia cambiato subito il nome proprio con un altro fittizio probabilmente va legato al fatto che dopo l'epurazione del Tempio, ch'era stata una mezza rivoluzione, anche la sicurezza personale di Pietro, seguace di Gesù, rischiava d'essere minacciata, come d'altra parte quella dei Zebedeo. Nel vangelo di Giovanni non sembra affatto che il soprannome gli venga dato per indicare un lato della sua personalità, per quanto Gesù mostri di conoscerlo personalmente o di fama, dicendogli ch'era "figlio di Giovanni" (1,42): forse Pietro era o era stato un seguace del partito zelota, molto popolare in Galilea.
Il motivo per cui Andrea, Giovanni e Pietro presero a seguirlo, ritenendolo il futuro "messia", è poco chiaro, in quanto Gesù non aveva ancora fatto nulla di politicamente rilevante, almeno stando ai vangeli. Probabilmente avevano capito, osservando la posizione titubante del Battista, che era meglio seguire lui, che in quel momento aveva intenzione di compiere un gesto clamoroso nella capitale, non condiviso politicamente dall'apostolo degli Esseni.
Giovanni sembra voglia lasciar credere che originariamente Gesù era della Giudea (infatti quando i primi ex-discepoli del Battista gli chiedono dove abitasse, egli indica un'abitazione della Giudea) e che solo dopo la cacciata dei mercanti si convinse ad andare a vivere in Galilea, in quanto con quella iniziativa rivoluzionaria, che non aveva ottenuto l'effetto sperato, egli non sarebbe potuto restare in Giudea senza rischiare una ritorsione da parte dell'aristocrazia sacerdotale. Ed infatti portò con sé in Galilea anche la madre, i fratelli e le sorelle, che evidentemente abitavano in Giudea. Di Giuseppe invece (il padre) non si saprà più nulla.
Che Gesù fosse giudeo è confermato dalla prima persona ch'essi incontrano mentre tornavano verso la Galilea: la samaritana al pozzo di Giacobbe, che s'accorge della sua provenienza dalla parlata. Probabilmente se l'acqua da bere le fosse stata chiesta da un galileo non si sarebbe meravigliata della richiesta, perché tra Samaritani e Galilei si sopportavano meglio che non tra Samaritani e Giudei.
Nel vangelo di Marco invece si vuol far passare Gesù per un galileo, essendo fortissima la rivalità tra questo gruppo etnico e quello giudaico (cfr Mc 14,28; 16,7; 15,41), confermata dal fatto che, nel momento cruciale dell'insurrezione a Gerusalemme, saranno i Giudei a tradire, consegnando il messia ai romani. Persino nel racconto marciano di resurrezione, l'angelo seduto sul sarcofago dice alle donne di non stare a piangere, in quanto il Cristo avrebbe preceduto i discepoli in Galilea.
Stranamente nel vangelo di Giovanni Gesù mostra di conoscere bene Filippo, ch'era di Betsaida38 (la città nativa di Andrea e Pietro, non necessariamente anche quella dei fratelli Zebedeo) e soprattutto di apprezzare molto la moralità di Natanaele (o Bartolomeo), ch'era galileo, al quale viene detto che Gesù era figlio di Giuseppe di Nazareth; Natanaele, al sentire questo, mostra d'aver una pessima considerazione di quella località. Ma è probabile che le conversioni di Filippo e Natanaele siano avvenute dopo il trasferimento di Gesù in Galilea e comunque nel vangelo di Giovanni vi sono in questo racconto pesanti interpolazioni, in quanto il Cristo appare già come una divinità.
Le interpolazioni possono essere state fatte perché in un altro punto del suo vangelo (6,41 s.) Giovanni dice che i Giudei conoscevano bene il padre di Gesù: "Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre".
Giovanni dunque è probabile che non abbia mai potuto dire esplicitamente che Gesù era originario della Giudea, perché ciò avrebbe fatto dispiacere a Pietro, ch'era fiero d'essere galileo e che fece soprattutto pesare la propria origine dopo la morte del Cristo. Non a caso il vangelo di Giovanni è stato manipolato anche su un altro punto, laddove si è inventato il miracolo di Cana in Galilea (fatto passare come il primo prodigio), al fine di dimostrare che i Galilei erano superiori ai Giudei, le cui giare di pietra per la loro purificazione erano simbolicamente "vuote" (2,6).
Ma la censura più significativa relativa all'origine giudaica di Gesù sta nel fatto che la purificazione del Tempio è stata messa da Marco nell'imminenza dell'ultima Pasqua, togliendo ad essa tutto il significato che aveva di rottura politica col movimento battista, senza poi considerare che nel suo vangelo essa appare di natura esclusivamente "etico-religiosa", mentre in quello di Giovanni ha aspetti di natura politica e antireligiosa. D'altra parte Marco, nel suo vangelo, fa iniziare la predicazione di Gesù dopo che Giovanni era stato arrestato (1,14), proprio per far credere ai suoi lettori che la religiosità di matrice "galilaica" del Cristo rappresentava una sorta di compimento della religiosità di matrice "giudaica" di Giovanni, ultimo profeta veterotestamentario.
Tuttavia non è da escludere che dopo la stesura del vangelo di Marco, cioè dopo la catastrofe del 70, il partito nazareno divenuto "cristiano", sotto l'egida petro-paolina, abbia accettato di stipulare una sorta d'intesa coi battisti, in virtù della quale i cristiani accettavano il rito del battesimo e l'idea che il Battista avesse anticipato con la sua attività la venuta del Cristo, mentre i battisti ovviamente dovevano accettare che Gesù fosse stato non solo il messia tanto atteso ma anche il "figlio di dio" morto e risorto: cosa che nel vangelo di Giovanni appare chiarissima là dove il Battista gli riconosce addirittura un'identità divina (come noto una parte dei battisti rifiutò tale compromesso).
Nel vangelo (qui interpolato) di Marco (1,9) il Precursore viene così tanto rivalutato che si stabilisce di fargli fare una cosa del tutto assente nel vangelo di Giovanni: quella di battezzare il Cristo. Il movimento battista viene recuperato religiosamente dalla nuova chiesa creata da Pietro e da Paolo proprio perché viene negato come movimento politico, e soprattutto perché vengono negate le motivazioni politiche che avevano portato i primi discepoli di Gesù a staccarsi dal Battista. Da notare che tra questi ex-discepoli del Precursore non vi era stato Pietro, che militava probabilmente tra gli zeloti e che, per questo, non poteva nutrire una grande considerazione per il Battista, ancora troppo legato agli ambienti giudaici e poco propenso a togliere al Tempio il suo primato istituzionale.
E viene anzi da pensare che lo stesso Giovanni Zebedeo non fosse affatto della Galilea, ma anche lui della Giudea, al seguito del Battista e conosciuto dal sommo sacerdote Anania, il quale probabilmente aveva previsto per lui una carriera sacerdotale (Gv 18,15).
La scena marciana della conversione dei pescatori della Galilea si riferisce probabilmente più ai fratelli Pietro e Andrea che non ai fratelli Zebedeo. In ogni caso, essa, per come viene descritta, è abbastanza mitologica, stereotipata. Come minimo presuppone che i protagonisti si conoscessero da tempo ed essa forse vuol semplicemente indicare il momento di ripresa dell'attività politica dopo aver lasciato passare dei mesi dal giorno della purificazione del Tempio, che avvenne nel corso della prima "Pasqua politica" narrata da Giovanni.
Guarigione della suocera di Pietro (Mc 1)
[29] E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni.
[30] La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.
[31] Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli.
*
Questa pericope è stata messa per far vedere che Pietro non credeva più nell'esigenza farisaica di rispettare il sabato e si poneva in maniera polemica nei confronti della sinagoga di Cafarnao, ove la presenza scribo-farisaica era dominante: infatti chiede a Gesù di guarire sua suocera proprio in questo giorno e quella si mette a servirli a tavola, violando la regola del riposo assoluto.
La cosa strana è che Pietro gli chiede di guarirla con la sicurezza di chi sapeva che l'avrebbe potuto fare e che l'avrebbe fatto violando la proibizione del giorno festivo. Bisogna quindi dare per scontata l'esistenza di una situazione pregressa (in ambito giudaico, come ben risulta nel quarto vangelo) che qui viene taciuta, anche perché nel vangelo di Marco questa guarigione è la prima.
Ritiro di Gesù nel deserto (Mc 1)
[35] Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava.
[36] Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce
[37] e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano!".
[38] Egli disse loro: "Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!".
[39] E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
*
Sia qui che nella pericope precedente della guarigione della suocera di Pietro appare evidente l'atteggiamento strumentale che l'apostolo aveva nei confronti del Cristo, che vi si sottrae chiedendo di andare a predicare per tutta la Galilea. Il vangelo di Marco, a differenza di quello di Giovanni, fa delle guarigioni un elemento imprescindibile della predicazione di Gesù, una vera e propria dimostrazione di "divino-umanità", anche se esplicitamente non viene mai detto che le faceva in quanto "figlio di dio". Esse tuttavia appaiono così straordinarie che quando si scoprirà la tomba vuota e si accetterà la tesi petrina della resurrezione, sarà giocoforza attribuirle a una capacità che non poteva essere semplicemente "umana". È noto tuttavia che le guarigioni o furono delle mistificazioni per coprire eventi di tipo politico, oppure vanno considerate come manifestazioni di capacità terapiche che di "divino" non hanno nulla.
Il Cristo può aver compiuto guarigioni indipendentemente dalla missione politica che s'era prefisso (p. es. può averle fatte per ricambiare l'ospitalità che gli avevano riservato i Galilei dopo lo smacco della prima insurrezione). Sarebbe assurdo pensare ch'esse venivano gestite proprio per ottenere più facilmente un consenso o addirittura una sequela al suo movimento. Al massimo è possibile credere che le guarigioni venissero utilizzate come pretesto per far credere che più importante della guarigione personale era la liberazione nazionale.
I Dodici (Mc 3)
[16] Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;
[17] poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono...
*
L'elenco dei Dodici, messo in maniera simbolica per richiamare le tribù d'Israele, reca sempre come primo nome quello di Pietro. Ora, anche a prescindere dal fatto che questo "collegio" – come viene chiamato dalla chiesa – non aveva alcuna caratteristica "monarchica" (come invece ha sempre sostenuto la chiesa romana), resta il fatto che nel vangelo di Giovanni il discepolo prediletto di Gesù, quello che avrebbe dovuto succedergli dopo la sua morte, non è Pietro ma lo stesso Giovanni, cioè colui che evitò di dire che la morte del Cristo era stata "necessaria", in quanto prevista dai profeti, e che quindi non poteva accettare che "tomba vuota" volesse necessariamente dire "resurrezione", e tanto meno che, in virtù di questa ipotesi interpretativa, si dovesse attendere passivamente una "imminente e trionfale parusia" del Cristo. Per l'apostolo Giovanni il corpo di Gesù era soltanto "scomparso" e nessuno l'aveva più rivisto.
Il vangelo di Marco, poi preso a modello da Matteo e Luca, non solo ha inventato la tesi della "resurrezione", ma, in conseguenza di ciò, ha fatto passare Pietro per il "campione della fede", distorcendo l'attribuzione di valore e di responsabilità che il Cristo aveva stabilito per i suoi discepoli più stretti e fidati. Da notare però che Luca, che spesso non si rende conto di dire cose non proprio in linea con la mistificazione voluta inizialmente da Pietro, negli Atti degli apostoli (1,13) mette, nel suo elenco dei Dodici, Giovanni subito dopo Pietro, quando in realtà Giovanni non ha alcun ruolo negli Atti.
La figlia di Giairo (Mc 5)
[35] Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: "Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?".
[36] Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: "Non temere, continua solo ad aver fede!".
[37] E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
*
Pietro, Giacomo e Giovanni assistono alla presunta resurrezione della figlia dell'archisinagogo Giairo. È curiosa l'assenza di Andrea, che fu il primo discepolo del Cristo (protoclito). Andrea scomparirà subito anche dagli Atti degli apostoli, esattamente come Giovanni.
A volte si ha persino l'impressione che nel vangelo di Marco il Giacomo messo per secondo, quando si cita questa triade di apostoli, non sia affatto il fratello di Giovanni, ma il fratello di Gesù, quello che sostituì Pietro dopo che questi fu fatto evadere dalle prigioni di Gerusalemme ed espatriare dalla Palestina.
Giovanni qui sembra essere stato messo soltanto perché non si poteva evitarlo, avendo egli giocato un ruolo di primo piano quando il Cristo era vivo. Resta infatti molto strano che Marco abbia avuto bisogno di precisare che il Giovanni in questione fosse "fratello di Giacomo". Non c'erano altri "Giovanni" tra i Dodici (e Marco l'aveva già detto nell'elenco che i due discepoli erano fratelli): qui la precisazione lascia quasi pensare che il "Giacomo" in questione fosse davvero il fratello di Gesù. Ma se è così, perché non dirlo, visto che proprio da questo vangelo (3,31; 6,3) si è potuto sapere che Gesù aveva vari fratelli e sorelle?
Probabilmente il motivo sta nel fatto che il successore di Pietro non ebbe in alcuna simpatia Paolo, che diceva di voler divulgare all'estero le idee petrine sulla "morte necessaria" del Cristo e sulla sua "resurrezione", facendo di queste idee un motivo per considerare i pagani sullo stesso piano degli ebrei. Il vangelo di Marco infatti si rivolge ai romani, i quali certo non potevano vedere di buon occhio che tra i discepoli più stretti del messia ve ne fossero alcuni che, anche dopo la sua morte, continuavano a sperare in una liberazione d'Israele da Roma. Tra questi discepoli vanno annoverati, molto probabilmente, non solo Giacomo fratello di Gesù, ma anche Andrea e gli stessi fratelli Zebedeo, chiamati da Gesù "Boanerghes" (figli del tuono).
Identità di Gesù (Mc 8)
[27] Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: "Chi dice la gente che io sia?".
[28] Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti".
[29] Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo".
[30] E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
[31] E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare.
[32] Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo.
[33] Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: "Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini".
*
Pietro lo riconosce come messia, cioè come leader politico-nazionale e Gesù risponde col "segreto messianico", cioè col divieto di divulgare questa verità. Perché?
Gesù sostiene che non possono infondere false aspettative nelle masse, poiché egli dovrà morire come previsto dai profeti, per poi risorgere. Pietro lo critica privatamente, per aver detto cose del tutto impolitiche, ma Gesù lo minaccia di espellerlo dalla comunità. Che senso ha tutto ciò?
Il significato di questi dialoghi è molto semplice: Pietro, dopo la morte del Cristo, si rifiutò di proseguire il suo messaggio rivoluzionario, cioè l'idea di un'insurrezione armata nazionale, e cominciò a predicare l'idea di "morte necessaria", ma siccome il movimento messo in piedi dal Cristo aveva una chiara finalità politica eversiva, fu costretto ad aggiungere a quella tesi l'idea della "resurrezione", associandola a quella della "parusia imminente e trionfale", ch'erano tesi sì fataliste ma sempre basate sulla liberazione nazionale da Roma.
Nel vangelo di Marco Pietro in pratica cerca di mostrare come la concezione della "morte necessaria" e della "resurrezione" non proveniva dalla sua mente ma da quella del Cristo, il quale, ogniqualvolta i discepoli, lui per primo, gli chiedevano di comportarsi come "messia", egli minacciava di scomunicarli. I tre preannunci di morte, fatti risalire da Marco direttamente a Gesù, sono chiaramente finalizzati a giustificare l'ideologia petrina.
Ma è anche facile immaginare cosa può aver detto Gesù in quel frangente, e cioè che la rivoluzione non doveva basarsi sull'azione di un singolo duce ma sulla volontà popolare. In tal senso essi non avrebbero dovuto illudere le masse sulle capacità carismatiche dei propri leader, proprio perché erano le masse stesse che avrebbero dovuto organizzarsi per liberarsi dei romani. L'aspettativa di un messia liberatore è sempre un segno di immaturità politica.
La trasfigurazione (Mc 9)
[2] Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro
[3] e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
[4] E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù.
[5] Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!".
[6] Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.
[9] Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti.
[10] Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
[11] E lo interrogarono: "Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?".
[12] Egli rispose loro: "Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato.
[13] Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui".
*
Questo racconto vuol semplicemente mostrare come Gesù venisse concepito dagli apostoli alla stregua di un novello Mosè, con in più delle capacità sovrumane, di cui però egli non si sarebbe potuto avvalere per liberare Israele, in quanto il suo destino era quello di essere ucciso e di risorgere, onde mostrare non solo a Israele ma a tutto il mondo ch'egli era figlio di dio.
Pietro, che propone le tre tende, mostra d'avere una concezione politica del messia che da questi viene contraddetta. Come si può notare, si tratta di un rovesciamento redazionale della realtà. Pietro non solo non riusciva a capire il lato democratico della concezione politica del Cristo (in quanto si aspettava un messia dittatore), ma, dopo la crocifissione, non riuscirà neppure a capire il lato rivoluzionario di tale concezione, in quanto trasformerà il "suo messia" in un essere dalle capacità divine (o, meglio, "semi-divine", poiché dobbiamo lasciare a Paolo il tentativo della massima spiritualizzazione del Cristo).
Il giovane ricco (Mc 10)
[23] Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: "Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!".
[24] I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: "Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio!
[25] È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio".
[26] Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: "E chi mai si può salvare?".
[27] Ma Gesù, guardandoli, disse: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio".
[28] Pietro allora gli disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito".
[29] Gesù gli rispose: "In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo,
[30] che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.
[31] E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi".
*
In questa pericope Pietro risponde a quanti avevano aderito al movimento nazareno per poter avere un riscatto sociale (di emancipazione economica), oltre che politico (di liberazione nazionale).
Ed è costretto a fare soltanto delle promesse rivolte a un futuro imprecisato, poiché nel presente di reale vi sono soltanto le persecuzioni. Pietro in sostanza lascia capire che la rivoluzione non poté essere fatta anche perché non fu mai appoggiata dai ceti benestanti. Con ciò egli tradisce la sfiducia che aveva nei confronti della capacità rivoluzionaria dei ceti marginali.
Poi Marco farà dire a Gesù che anche i ricchi si salveranno, ma solo perché lo vorrà dio. In questa pericope in sostanza vi è il passaggio dalla liberazione politica alla salvezza religiosa. Pietro vuol far vedere che aveva creduto nella prima, ma che poi le circostanze lo indussero a credere nella seconda.
Il fico seccato (Mc 11)
[20] La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici.
[21] Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: "Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è seccato".
[22] Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio!
[23] In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
[24] Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.
[25] Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati".
*
Il fico seccato è un simbolo della fine d'Israele, che qui viene anticipata subito dopo la purificazione del Tempio. Marco, e con lui Pietro, dà per scontato il rifiuto da parte dei Giudei di considerare Gesù il liberatore nazionale. Il che, sul piano storico-politico, rende del tutto inspiegabile la decisione di andare proprio a Gerusalemme per far scoppiare l'insurrezione armata.
Ma la stranezza è nello stesso atteggiamento del Cristo, che fa seccare una pianta che non aveva potuto sfamarlo solo perché non era quella la stagione per fare frutti. Come si può facilmente notare, il brano è stato completamente inventato: solo che qui Pietro vuole entrare in scena lo stesso, mostrando tutto il suo disprezzo per i Giudei. E fa fare al Cristo una parte assurda: quella di condannare il proprio popolo per non aver capito ch'egli, avendo capacità divine (p. es., nella fattispecie, seccando all'istante un fico), doveva per forza essere il messia atteso.
Ma c'è di peggio. Il Cristo che condanna il proprio popolo per averlo ucciso, lo ricondanna a non avere più alcuna aspettativa politica nei confronti di altri liberatori nazionali, in quanto, d'ora in poi, chiunque voglia qualcosa per la propria realizzazione personale non deve fare altro che chiederla nella preghiera.
In questo modo Pietro giustifica la propria trasformazione del Gesù storico nel Cristo della fede.
Le mura del Tempio (Mc 13)
[1] Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: "Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!".
[2] Gesù gli rispose: "Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta".
[3] Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte:
[4] "Dicci, quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?".
*
Qui la cosa strana è che quando si parla di "parusia" il nome di Andrea è associato a quello di Giovanni. È l'ultima volta che nel vangelo di Marco compare il suo nome, che, come noto, non poteva essere quello originario. Secondo la tradizione pare che Andrea, dopo la fine del movimento nazareno, avesse ripreso a battezzare nella Scizia minore (Ucraina meridionale col basso Danubio e la Bulgaria), che avesse compiuto viaggi missionari lungo il Mar Nero e sul Volga, e che fosse morto martire a Patrasso, in Grecia, nel 60, appeso a gambe divaricate ad una croce a forma di X, la cosiddetta "croce di Sant'Andrea". Costantinopoli, la rivale di Roma per tutto il Medioevo, lo riconoscerà come proprio patrono. Da tempo viene riconosciuto come patrono anche da Scozia, Russia, Prussia, Romania, Grecia, Amalfi e Luqa (Malta), risultando di gran lunga più popolare di Pietro.
Sul Getsemani (Mc 14)
[32] Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego".
[33] Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia.
[37] Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola?
[38] Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole".
[39] Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole.
[40] Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.
[41] Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori.
[42] Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino".
*
Perché Marco scrive, a differenza di Giovanni, che sul Getsemani tutti gli apostoli, anche quelli più vicini a Gesù, dormivano profondamente?
Anche qui il motivo è molto semplice: se è vera la tesi della "morte necessaria", nessuno avrebbe potuto impedirne la realizzazione se non Gesù stesso, che era dio. Dunque avendola accettata, la versione petrina della tomba vuota diventava quella giusta.
Pietro può dormire sonni tranquilli proprio perché il suo Cristo è un martire volontario della fede, è un uomo-dio che pensa di affermare la verità del proprio vangelo accettando consapevolmente di morire in croce. Se fossero stati svegli per difenderlo avrebbero rischiato di contrastare un piano divino molto più grande di loro. Infatti qui Gesù li rimprovera soltanto di non avere sufficiente fede nel destino che sta per compiersi. Se fossero stati svegli con lui avrebbero capito la sua necessità di morire e avrebbero evitato di tirare fuori la spada per difenderlo (come appunto farà Pietro, il cui nome qui Marco evita di pronunciare, per non farlo apparire come un violento che andava in giro armato o come un estremista zelota al seguito di Gesù).
La resurrezione (Mc 16)
[7] Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto".
[8] Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.
*
La resurrezione è la conclusione illusoria del vangelo di Marco, ove si conferma che la Galilea veniva contrapposta da Pietro alla Giudea. La conclusione si dipana secondo un ragionamento molto semplice ed efficace: le Scritture dovevano essere interpretate in maniera mistificata, facendo risaltare l'idea di "morte necessaria"; la sindone non aveva alcun valore per la tesi della resurrezione; questa tesi non fu elaborata dalle donne che di fronte al sepolcro vuoto fuggirono terrorizzate, ma da Pietro, che capì che quel sepolcro vuoto era l'inizio di una svolta verso il misticismo. Dopo la croce, né Gesù né gli apostoli avrebbero avuto più nulla da compiere di politico in Giudea, per cui potevano tranquillamente tornarsene in Galilea, dove avrebbero potuto iniziare una nuova storia caratterizzata, questa volta, da elementi unicamente religiosi.
(torna su)41) La nascita del monachesimo cristiano
nei "Discorsi di addio" del IV vangelo
Gv 14-17
I quattro lunghi capitoli del vangelo di Giovanni (14-17) vengono accomunati dalla chiesa sotto il titolo di "Discorsi d'addio" (del Cristo). In essi, soprattutto nel primo, poiché gli altri sono soltanto una ripresa degli stessi argomenti sotto angolazioni differenti, è racchiusa l'essenza principale della falsificazione del quarto vangelo, la quale può tranquillamente essere considerata – dato il livello particolarmente profondo del loro contenuto – come la più sofisticata di tutto il Nuovo Testamento.
Qui si può premettere che mentre la falsificazione del messaggio di Gesù, operata nel vangelo di Marco, riflette chiaramente quella di Pietro e di Paolo, cioè, rispettivamente, di una tradizione galilaica e di una ebreo-ellenistica, viceversa, quella di Giovanni riflette una tradizione giudaica che ha tradito questo stesso apostolo, nel senso che per mistificare adeguatamente la versione giudaica originaria del quarto vangelo è stata necessaria una falsificazione interna allo stesso giudaismo, divenuto "cristiano" in forza dell'egemonia petro-paolina39.
Possiamo anche sostenere che mentre i Sinottici hanno dato vita alla chiesa cristiana come organizzazione socio-religiosa avente uno scopo missionario di predicazione del vangelo petro-paolino in tutto il mondo, il quarto vangelo invece (specie nella parte falsificata) trova la migliore realizzazione di sé nelle comunità di tipo monastico, proprio perché all'alta consapevolezza storico-politica dell'apostolo Giovanni si poteva soltanto opporre, al fine di censurarla, una forte esperienza mistica, avente un elevato contenuto teologico.
Infatti, mentre nei Sinottici la preoccupazione principale resta quella di dimostrare la fine del primato di Israele (o semplicemente della Giudea rispetto alla Galilea, stando alla versione marciana della posizione petrina), e quindi l'uguaglianza degli ebrei coi pagani, in virtù della necessità di rivolgersi al mondo intero predicando la figliolanza divina di un Cristo morto e risorto; nel quarto vangelo invece vi è da un lato un respiro più astratto e universale, e dall'altro una preoccupazione di vivere la nuova religione in un contesto limitato: la comunità cristiana, che inevitabilmente viene a coincidere con una comunità monastica, dove l'amore reciproco diventa regola di qualunque rapporto e attività.
I
Il primo discorso è ritenuto il più importante perché qui si parla esplicitamente e diffusamente di "spirito santo" (14,26), o forse, più semplicemente, di "paraclito" ("consolatore"), in quanto il termine "spirito santo" può essere considerato un'aggiunta ulteriore, più caratterizzata in senso teologico, a un testo (quello appunto dei "Discorsi d'addio") che non si può neppure considerare interpolato, essendo del tutto inventato. Lo stesso temine "spirito santo" lo si ritrova in riferimento alla consapevolezza (anche qui del tutto inventata) che il Battista aveva della "divinità" del Cristo (Gv 1,33).
È dubbio persino che Giovanni abbia mai usato una parola come "spirito" ("pneuma"), e comunque se l'ha fatto non può averle attribuito qualcosa di così eminentemente teologico come ha fatto il suo falsificatore. Quando, dopo l'epurazione del Tempio, Gesù parla con Nicodemo e con la samaritana usando la parola "spirito", al massimo può averlo fatto in polemica col culto centralizzato nell'istituzione del Tempio, senza alcun riferimento a battesimi rigeneratori (Gv 3,5). "Adorare dio in spirito e verità" (Gv 4,23) è espressione improbabile in un Cristo ateo, a meno che non la si voglia intendere nel senso che per il programma politico del movimento nazareno sarebbe stato sufficiente assicurare a tutti la libertà di coscienza o di pensiero, e quindi inevitabilmente di religione.
È vero che il termine "pneuma" è d'origine greca, ma è anche vero che in ebraico esisteva già il termine "ruah", di genere femminile, che si usava per indicare il "soffio vitale" di dio o appunto il suo "spirito", la sua "sapienza". Quindi il Cristo avrebbe potuto tranquillamente usarlo nei dialoghi con Nicodemo e la samaritana, anche se ovviamente non per avvalorare una nuova forma di culto religioso, alternativo a quello dominante.
In lingua italiana, come in latino, lo "spirito santo" è di genere maschile (in greco invece è neutro), anche se sul piano semantico la chiesa romana ha sempre inteso qualcosa di vago e indefinito, né maschile in senso proprio, né, tanto meno, femminile.
Sin dai primi Padri della chiesa latina lo spirito è sì "persona", ma solo in senso astratto, teorico; in realtà esso rappresenta una funzione particolare nell'ambito del rapporto duale (istituzionale) tra dio-padre e dio-figlio: una funzione di cui sono gestori a pari titolo sia il padre che il figlio (secondo i dettami dell'eresia filioquista).
Essendo una religione fortemente patriarcale, autoritaria e maschilista, il cattolicesimo-romano non è mai riuscito a vedere nello spirito il lato "femminile" della divinità. Al massimo – ma questa peculiarità è stata più che altro tipica dei movimenti ereticali anticattolici – si concepiva lo spirito come simbolo della libertà religiosa, di pensiero, di ricerca, di manifestazione della fede nelle sue varie esperienze.
Solo di recente la chiesa romana, recuperando tradizioni del mondo ortodosso (slavo o bizantino), è arrivata ad accettare l'idea che lo spirito sia una specie di "sorella" del figlio di dio, una sapienza (sophia) che promana dalla divinità, avente tutte le caratteristiche tipiche della divinità (immortalità, atemporalità, aspazialità ecc.), confermando così la tesi di un dio in tre persone consustanziali.
Nonostante questo la chiesa romana non è mai arrivata a ricredersi sulla propria eresia filioquista, secondo cui lo spirito non procederebbe originariamente (ab aeterno) dal solo dio-padre, ma anche dal figlio (processio ab utroque), sicché entrambi, padre e figlio, lo gestirebbero in maniera identica, come oggetto interscambiabile. Cosa che gli ortodossi sono disposti ad ammettere al massimo sul terreno dell'economia salvifica, ma non su quello ontoteologico.
D'altra parte per potersi ricredere la chiesa romana dovrebbe accettare la superiorità del concilio sul papato, ovvero la rinuncia a credere che lo spirito possa essere meglio rappresentato dalla monarchia del pontefice che non dalla democrazia del concilio.
Per gli ortodossi lo spirito avrebbe un'autonomia che non dipende né dal figlio né dalla relazione tra questi e il padre, ma unicamente da quest'ultimo. I teologi bizantini dicevano che figlio e spirito andavano considerati come le "mani" del padre.
A quanto pare gli ebrei, usando al femminile la parola "ruah", avevano capito ben prima di chiunque altro che nella creazione vi era stato un fondamentale contributo di tipo femminile. Anche la parola "pneuma" è molto antica, specie nella filosofia idealistica del mondo greco. Lo spirito è un simbolo della verità, che è libera di "soffiare" dove vuole, cioè di "posarsi" su chiunque. Negli Atti degli apostoli si descrivono come esperienze tipicamente "pneumatiche" la glossolalia e la pentecoste, proprio al fine di sublimare la rinuncia all'insurrezione armata antiromana. Tali esperienze vengono anche vantate come forma di autenticità interiore, esistenziale, da parte di comunità religiose settarie, che si pongono in contestazione nei confronti di autorità, istituzioni, tradizioni, dogmi consolidati.
II
Ma la parola "paraclito" da dove proviene? Prima di rispondere a questa domanda, cerchiamo di capire perché i quattro capitoli sono stati collocati subito dopo i due annunci, da parte di Cristo, del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, che, come già detto altrove, vanno considerati entrambi falsi.
Al massimo infatti Gesù può aver paventato il rischio di un tradimento o di una defezione all'ultimo momento, quello più critico per l'imminente insurrezione armata; può cioè aver chiesto con insistenza di restare uniti e Pietro può anche aver fatto lo spavaldo dicendo che nel caso ci fosse stato un tradimento non sarebbe certo partito da lui, anzi lui avrebbe saputo come reagire, come impedirlo. Durante l'ultima cena arrivò infatti a chiedere a Giovanni, sapendo ch'era il preferito da Gesù, di farsi dire se questi aveva dei sospetti particolari su qualcuno. Ovviamente non poté ricevere alcuna risposta. Tutto qui. Gesù può aver obiettato a Pietro che in quel frangente nessuno poteva avere sicurezze assolute su niente: il rischio era quello di giocarsi la vita. Non può certo avergli predetto con matematica certezza il suo rinnegamento prima del canto del gallo, cioè allo spuntare dell'alba.
Dunque, ricapitoliamo. Con l'annuncio del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, Gesù – secondo i vangeli – dava per scontato che l'insurrezione sarebbe fallita e che la sua cattura e crocifissione sarebbero state inevitabili. Su questo punto il quarto vangelo, ma i Sinottici sono all'unisono, vuole essere molto chiaro: Gesù non poteva non morire, la morte era necessaria in quanto appunto inevitabile. E lo era in quanto facente parte dell'economia salvifica di dio, della soteriologia concordata tra il padre e il figlio. La differenza è che mentre nei Sinottici c'è risentimento nei confronti dei Giudei, nel quarto vangelo invece si ha piena convinzione che i Giudei siano stati soltanto lo strumento di un progetto deciso altrove, di cui il Cristo aveva piena consapevolezza da sempre.
La morte di Gesù non è stata il frutto di una semplice autoimmolazione: qui non siamo in presenza di un suicidio da parte di chi è convinto che non vi siano alternative, come forma disperata di protesta. Gesù non ha scelto il martirio per passare alla storia come leader coraggioso: sarebbe stato troppo poco. Lui era dio in quanto figlio unigenito di un padre eterno. La sua morte era stata appunto pattuita col padre, faceva parte di un progetto divino originario, nell'ambito della "prescienza divina", come dice Pietro negli Atti (2,23); un progetto che gli uomini, in quel momento, non avrebbero potuto capire, essendosi mossi al seguito di Gesù per un obiettivo politico-rivoluzionario: liberare la Palestina dai romani.
Non potevano assolutamente immaginare che nella mente del Cristo vi era qualcosa di infinitamente più grande, la cui strategia generale poteva essere nota soltanto a lui, almeno finché lui avrebbe vissuto sulla terra. Non potevano sapere che lui era dio e che all'origine della creazione vi era sempre lui. Non potevano sapere che la sua morte era inevitabile perché la loro vita sulla terra è impossibile e che solo attraverso la resurrezione avrebbero capito che la loro vera vita è possibile solo nell'aldilà.
L'idealismo oggettivo, assoluto, sta proprio in questo, nel cercare di mostrare che una propria intenzione non è soggettiva ma conforme a necessità superiori, le quali dettano legge alla storia: qui la necessità si chiama "dio", in particolare "dio-padre". Gesù si è immolato per adempiere alla volontà del padre e l'ha fatto nella convinzione che quella fosse la cosa migliore, la cosa più giusta da fare.
Per riconciliarsi con l'umanità schiava del peccato d'origine, per rendere uguale, di fronte a lui e al figlio, tutta l'umanità, facendo perdere a Israele il rapporto privilegiato avuto sino a quel momento, e che non poteva più essere conservato perché i Giudei avevano smesso di mostrarsi migliori di altri popoli, dio-padre aveva bisogno del sacrificio del figlio, perché in nome del figlio era avvenuta tutta la creazione, di cui Israele aveva rappresentato per duemila anni l'avanguardia cosciente, la punta avanzata della consapevolezza storica, etica e politica dell'umanità. Il dio-figlio, in un certo senso, pagava il prezzo di un proprio desiderio e questa volta lo pagava per il bene non solo d'Israele ma anche e soprattutto dell'intera umanità, affinché tutti gli uomini, vedendo il suo sacrificio, si convertissero alla nuova fede, tornassero ad adorare il vero dio ed essere veri uomini.
Nel Genesi Javhè si pente d'aver creato l'umanità e vorrebbe distruggerla perché troppo corrotta e iniqua, ma evita di farlo perché Noè gli sembrò giusto e con lui stipulò una nuova alleanza. Anche Abramo chiese a Jahvè di non distruggere Sodoma se avesse trovato anche una sola persona giusta, e dio promise che solo per quest'unica persona non l'avrebbe distrutta.
Qui, nel quarto vangelo, è la stessa cosa. Gli uomini sono orrendamente colpevoli e dio-padre sta per pentirsi d'aver esaudito la richiesta del figlio di creare l'umanità; riesce a placarsi soltanto di fronte al sacrificio di quest'ultimo, che muore innocente per salvare gli uomini dai loro peccati. Cioè il padre si rende conto che l'amore che il figlio nutre per l'umanità è immenso, essendo egli disposto a qualunque sacrificio.
Non si tratta di "buonismo ad oltranza", poiché comunque alla fine dei tempi vi sarà un "giudizio universale", ma di amore infinito per i giusti. Il sacrificio è necessario per dimostrare a dio-padre che l'umanità, a motivo di pochi "eletti" (in questo caso gli stessi apostoli, meno Giuda), merita di sopravvivere alla patriarcale ira divina. La volontà del figlio impedisce a quella del padre di fare piazza pulita della storia umana. Dal canto suo il padre ha voluto mettere alla prova il figlio per vedere fin dove sarebbe stato capace di amare gli uomini intenzionati a ucciderlo.
In questa enorme falsificazione religiosa di derivazione stoica e orfica, in cui – come si può facilmente notare – il peso dell'ideologia petro-paolina è considerevole, ci si deve chiedere quale sia il ruolo del "paraclito", cioè il motivo per cui sia stata introdotta una nuova figura mitologica proprio dopo aver annunciato l'idea di "morte necessaria". È qui che nasce la seconda falsificazione, ancora più sublime della precedente, perché ancora più spiritualizzata.
III
Tutto il capitolo 14 è un invito a considerare la terra come un nulla rispetto a quanto attende l'umanità alla fine dei tempi. Cristo non sarebbe venuto per far tornare l'umanità com'era "al principio", ma per annunciare la fine dei tempi, ovvero il fatto che la reintegrazione nell'originaria innocenza sarà possibile solo nei cieli.
Gli uomini (in questo caso i discepoli o, più in generale, gli "eletti") devono soltanto avere pazienza. Non c'è possibilità di salvezza, di liberazione sulla terra, essendo l'umanità troppo corrotta. La storia non viene decisa dagli uomini ma solo da dio-padre che è nei cieli, che si serve del male per mettere misteriosamente alla prova il bene. La storia degli uomini è soltanto una pallida copia della storia che nei cieli avviene tra forze del bene e forze del male, di cui gli uomini sono mero oggetto di contesa, senza poter svolgere un ruolo da protagonisti. In Gv 6,64 verrà espressamente scritto che "Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito".
Per accettare questa teologia della storia bisogna credere in Gesù, unico mediatore tra dio e gli uomini. Non c'è altra prova dell'esistenza di dio che la parola di Cristo, cui dunque si può credere solo per fede. Non ci sarà cioè alcuna prova che oltre alla storia esiste una metastoria, che oltre alla terra vi sono i cieli, che oltre all'umano vi è il sovrumano. Chi non vuol credere a quanto il Cristo ha detto, vi creda almeno per quello che ha fatto, dice il testo un po' sconsolatamente. Qui Tommaso e Filippo, e più avanti Giuda Taddeo, vengono fatti passare per degli increduli, anche se alla fine del vangelo si dirà che Tommaso arrivò a credere nella tesi petrina della resurrezione.
E per dimostrare che con la fede si può comunque vivere dignitosamente, Gesù assicura agli apostoli che se essi davvero mostreranno di averla, potranno fare cose anche maggiori delle sue e, in ogni caso, se non le sapranno fare, potranno sempre chiedere aiuto a lui e otterranno ciò che desiderano, a condizione ovviamente che la richiesta sia giusta, conforme a verità.
Ed è infatti a questo punto che entra in scena la figura mitologica del Paraclito. Poiché il Cristo è destinato a non esserci, ad andarsene nei cieli, poiché la giustizia, la libertà, l'uguaglianza sono impossibili sulla terra, poiché nelle sconfitte politiche ci si deve universalizzare, assumendo una visione più astratta delle cose, poiché dunque la fede degli uomini può essere debole e vacillante, ecco che Gesù promette a tutti i credenti di dare un aiuto sostanziale, inatteso: il Consolatore, che svolge anche funzioni di Avvocato.
Qui si realizza la mistificazione più significativa di tutto il Nuovo Testamento. Il Paraclito infatti deve aiutare psicologicamente gli uomini a vivere rassegnati, ma senza far perdere loro la dignità umana, quindi deve difenderli di fronte a chi li accuserà di farneticare, di millantare assurdi crediti spirituali.
Gesù dice che pregherà il padre perché conceda loro questa forma di assistenza psicologica e giuridica, che è anche fonte di cultura, in quanto preposta all'insegnamento e alla memorizzazione dell'appreso. Lo spirito "procede dal padre" come soffio vitale, come appagamento interiore, come illuminazione della mente: è la natura femminile della divinità, quella che aiuta l'uomo a riconciliarsi con la propria debolezza, quella che lo fa rinunciare a prevaricare, a ribellarsi, a rivendicare diritti, a usare la forza, quella che lo deve persino dissuadere dal difendersi, se e quando ciò implica l'uso della seppur minima violenza. Infatti non c'è nulla a questo mondo che meriti d'essere difeso se non la fede nel Cristo figlio di dio: è questa la principale confessione che deve fare il cristiano.
È quella debolezza che la chiesa romana, nei suoi livelli istituzionali, s'è sempre rifiutata di riconoscere e che ancora oggi si ritrova nella chiesa ortodossa – la vera confessione da superare dall'umanesimo laico e dal socialismo democratico –, la quale, per questa ragione, è meno visibile della chiesa romana, essendo lontana dal potere politico, disposta ad accettare il regime di separazione dagli Stati.
Questo Paraclito è lo "spirito di verità", cioè la menzogna più sofisticata ai danni del messaggio originario del Cristo. È lo spirito che secondo i cristiani deve aiutare a capire che la storia non è umana, se non indirettamente, incidentalmente, se non come riflesso opaco di una ben altra storia ultraterrena, in cui potenze celesti di varia natura si oppongono ai disegni divini sin da quando è stata creata l'umanità, per invidia del genere umano, ideato, nonostante i limiti della corporalità, a "immagine e somiglianza" di dio.
L'invenzione di uno spirito procedente dal solo padre, che, attraverso la mediazione del figlio, può essere concesso agli uomini, doveva servire per illudere quest'ultimi che, con la morte del Cristo e la rinuncia a compiere qualunque liberazione politica sulla terra, non sarebbe cambiato nulla, proprio perché tutto veniva rimandato all'aldilà. Gli uomini sono soltanto strumenti di azioni la cui volontà è più grande della loro capacità di resistenza: sono marionette nelle mani di dio, predestinati a compiere cose di cui non hanno piena consapevolezza, come quando viene scritto che "Satana entrò in Giuda" (Gv 13,27).
Se Cristo avesse detto che lo spirito procedeva solo da lui, si poteva in un certo senso evitare di credere in dio. Ma è difficile credere in un uomo che dice d'essere dio: potrebbe essere anche un esaltato. Meglio credere – dicono i cristiani – in un uomo che, pur dicendo d'essere dio, non nega dio come realtà a lui esterna, da cui dipende; anzi, per dimostrare che questa realtà gli è superiore, afferma che dio-padre ha il potere di inviare un dio-spirito che risulta essere indipendente dalla stessa volontà del dio-figlio, il quale al massimo può intercedere a favore degli uomini40.
Il Cristo è stato sottoposto a una prova, quella del "Principe di questo mondo", Satana, onde verificare quanto fosse grande il suo amore per il padre e per gli uomini. E quella prova l'ha superata e la supererà sempre, senza ombra di dubbio, come già aveva dimostrato nel deserto, di fronte alle principali tentazioni materialistiche dell'uomo: il ventre, il potere economico e il potere politico (Mt 4,1 ss.).
La differenza tra lui e Giobbe è che lui sa già tutto prima (a esclusione del giorno della parusia, che solo il padre conosce), anche se non lo fa vedere esplicitamente, per cui la resistenza al male è in nome della certezza del bene e di una vittoria eterna e definitiva, sulla cui verità non occorrono domande esistenziali di chiarimento, di comprensione. Giobbe ha bisogno di porsi mille domande e rischia persino l'ateismo, poi, per fortuna, dio gli restituisce con gli interessi tutto quanto aveva permesso che il demonio gli togliesse.
Gesù assicura gli apostoli che sul Golgota supererà la prova, proprio accettando la morte ingiusta e violenta, che per loro sarà occasione di grande riscatto, in quanto lui risorgerà, sicché gli uomini capiranno che la liberazione più importante non è tanto quella della Palestina dai romani, quanto quella della paura del nulla, dell'angoscia del male ritenuto invincibile. La morte avrà il potere catartico di confermare l'amore tra padre e figlio e tra figlio e uomini (qui rappresentati dai discepoli).
IV
Nei cosiddetti "Discorsi di addio" del Cristo vi è la storia della chiesa primitiva post-pasquale nella sua veste monastica. Qui infatti vengono date delle regole di vita, o meglio, viene detto che tutte le regole di vita debbono sintetizzarsi in una sola: l'amore reciproco secondo il modello del Cristo che ha dato la propria vita per i propri discepoli.
La differenza tra quanto fece lui e quanto dovranno fare loro sta nel fatto che manca la politica: lui s'era sacrificato per un fine politico, liberare la Palestina dall'oppressione romana; loro invece non possono farlo, anche se devono sacrificarsi lo stesso. Lui s'era immolato per un ideale superiore (che loro in quel momento interpretavano in chiave politica); loro invece devono continuare a sacrificarsi in nome di un ideale che sanno già di non poter realizzare, nell'attesa che si attui non per merito loro ma solo per merito suo. La morte in croce ha dimostrato che gli uomini non sono strutturalmente capaci di bene: non resta dunque che attendere la fine dei tempi.
La vita diventa come un teatro in cui ognuno recita la parte che gli è stata assegnata dal regista, che è dio. Se il male viene compiuto nel bene, era per predestinazione; se il contrario, era per grazia. Da parte umana, la volontà negativa o la fede positiva giocano un ruolo che può essere considerato sufficiente solo quel tanto che basta per distinguere l'uomo dall'animale, l'uomo dalla marionetta.
Il "piano divino" diventa misterioso e immutabile, sicché gli uomini rinunciano a comprendere il motivo per cui su questa terra è impossibile tornare a essere naturali come nella preistoria. Non a caso vien fatto dire al Cristo in altro contesto: "nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre" (Gv 6,65). Dio viene utilizzato ogniqualvolta si vuole giustificare l'incapacità umana di liberarsi delle contraddizioni che impediscono d'essere se stessi.
Cristo promette il recupero integrale della propria umanità solo nell'aldilà: l'espressione "vado a prepararvi un posto" indica proprio che la terra non conta più nulla, in quanto il peccato originale ha prodotto conseguenze irreparabili e, in tal senso, l'idea di resurrezione serve soltanto a infondere la speranza di una liberazione ultraterrena.
Compito principale di questi discepoli è soltanto quello di amarsi, non è neppure quello di andare a predicare in tutto il mondo il vangelo di Gesù morto e risorto, proprio perché la storia è già stata decisa nei cieli, e i "salvati" saranno soltanto i "predestinati", gli "eletti".
Infatti Giuda Taddeo sembra contestare il fatto che la comunità debba vivere chiusa in se stessa in nome dell'amore fraterno. Ma Gesù gli risponde che l'amore è più importante delle parole: l'amore può essere suscitato solo dall'amore stesso, non dalle parole. Chi sa amare metterà in pratica le parole del vangelo come inevitabile conseguenza. Non c'è più una "legge" da conoscere, se non appunto quella dell'amore.
Un discorso, questo, opposto a quello dell'ideologia paolina, che, pur prevedendo il primato dell'amore sulla speranza e sulla fede, faceva della predicazione ai pagani il perno dell'identità cristiana. Qui invece si ha l'impressione che l'amore venga presentato come esigenza spirituale primordiale, anteriore persino alla stessa incarnazione del Cristo, la quale non avrebbe neppure bisogno d'essere rappresentata da una specifica istituzione.
Gesù sta dicendo a Giuda Taddeo che gli uomini devono soltanto imparare ad amarsi, per il loro stesso bene; sarebbe un controsenso rappresentare l'amore attraverso un'istituzione specifica quale può essere la chiesa; se gli uomini hanno bisogno di un aiuto, è sufficiente che possiedano il Consolatore, che è spirito di verità, di memoria, di pace, di istruzione e formazione, e che viene inviato da dio-padre. A conferma di questa posizione Gesù sostiene che nei cieli esistono "molte dimore", il che sta appunto a significare l'esigenza di imparare una maggiore tolleranza e rispetto nei confronti di chi non è "cristiano".
Ponendo in primo piano le esigenze interiori dell'amore e non quelle esteriori della parola, è evidente per questa comunità monastica che una battaglia di tipo ideologico risulta irrilevante. Questa comunità chiede soltanto di poter esistere in un ambiente ostile (il "mondo"), non si pone il problema di come mutare questo ambiente. Essa non va a diffondere tra i pagani l'immagine di sé come modello di vita, proprio in quanto non ritiene di poter essere un modello migliore in misura o in rapporto al consenso sociale che può ottenere. La comunità monastica, in virtù dell'amore reciproco, si ritiene del tutto autosufficiente: essa sperimenta l'amore universale nell'amore tra gli appartenenti a una comunità chiusa. Chi vive l'amore autentico, automaticamente mette in pratica l'insegnamento del Cristo, per cui non avrà particolare difficoltà a riconoscere il diverso da sé.
V
In questi "Discorsi d'addio" vi sono molte mistificazioni, ma le principali sono forse le tre seguenti.
1. S'è voluto far credere che l'universalismo del messaggio di Gesù avrebbe potuto realizzarsi solo a condizione di superare il nazionalismo giudaico, ovvero solo a condizione di rinunciare alla liberazione politico-nazionale dall'oppressione straniera, come se il cristianesimo non avrebbe potuto nascere che dalla sconfitta dell'ebraismo, come se un ebraismo vittorioso sui romani avrebbe inevitabilmente confermato i propri atteggiamenti di superiorità etica e politica nei confronti del mondo pagano, come se una vittoria sui romani sarebbe stata impossibile senza superare le chiusure del tardo-giudaismo.
2. Introducendo il concetto di "Paraclito", s'è ipostatizzata in maniera teologica un'affermazione umanissima rivolta alla libertà di coscienza, che Cristo può aver pronunciato nei suoi dialoghi con Nicodemo e coi Samaritani l'indomani dell'epurazione del Tempio, allorché introduce concetti come "spirito e verità" che in sé non avevano alcun contenuto religioso, essendo soltanto una forma di garanzia culturale per assicurare il pluralismo degli atteggiamenti nei confronti della questione religiosa.
3. S'è voluto far credere che l'accettazione volontaria della morte violenta, secondo i dettami della "prescienza divina", va considerata come una forma di vittoria non di sconfitta, proprio in quanto il Cristo ha dimostrato quanto fosse giusta la sua intenzione di ritenere definitivamente superato il primato storico-politico degli ebrei sui pagani.
Ora, prima di dire come sarebbero potute andare le cose senza questi infingimenti, vogliamo qui spendere alcune parole sul concetto di "morte necessaria", poiché non si può accettare l'idea che il Cristo abbia volutamente posto i Giudei nella condizione di eliminarlo fisicamente al fine di far ricadere soltanto sulle loro spalle tutte le motivazioni di questa esecuzione.
La morte volontaria può essere considerata una forma di "vittoria" esclusivamente nel senso che il Cristo ha deciso di non sottrarvisi soltanto dopo aver fatto tutto quanto era umanamente possibile per evitarla. Cioè anche se sul piano politico essa resta una sconfitta, può comunque risultare una vittoria in considerazione del fatto che la sua accettazione è avvenuta nel rispetto dell'etica umana, non avendo il Cristo cercato di evitarla usando forme e modi contrari alla dignità personale. La croce è stata accettata in maniera realistica, misurando le forze in campo immediatamente dopo il tradimento di Giuda, e sempre nella speranza che, ottenendo l'incolumità dei propri seguaci in cambio della propria consegna volontaria, essi avrebbero saputo reagire per liberarlo o comunque avrebbero saputo proseguire fedelmente e con determinazione l'obiettivo strategico che insieme si erano prefissi: liberare la Palestina dai romani e dai collaborazionisti ebrei. Tutto quanto esula da questa semplice considerazione va ritenuto un'illazione vera e propria.
Spesso gli esegeti si chiedono che cosa sarebbe cambiato se gli evangelisti avessero raccontato i fatti senza infarciture mitologiche. Qui anzitutto bisogna ribadire che i fatti oggetto della loro narrazione erano stati, nella realtà, di tipo umano e politico e nient'affatto religioso. Se li avessero raccontati in maniera veridica, avrebbero dovuto esordire come minimo con un'autocritica, quella di non aver saputo impedire la crocifissione del loro leader e di non aver saputo proseguire la sua missione rivoluzionaria per i destini di Israele. Probabilmente se fossero stati onesti nel raccontare i fatti, avrebbero non solo deciso di proseguire tale missione, ma avrebbero anche evitato di aggiungere ulteriori tradimenti a quelli di Giuda.
VI
Il resto degli altri Discorsi è – come si diceva – una precisazione di quanto già detto nel primo. La definizione di amore che si dà in 15,13 è molto chiara: "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici". Il modello supremo da imitare è quindi il martirio del Cristo. Qui non si dice semplicemente: "Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te", o, come al giovane ricco: "se vuoi essere perfetto vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi", ma addirittura, con tutta l'enfasi possibile: "se vuoi essere perfetto nell'amore, sacrificati per il tuo prossimo sino alla morte".
L'amore più grande viene misurato sulla base dell'accettazione del martirio di sé. Il modello è talmente superlativo che Gesù arriva persino a dire, per togliere ogni dubbio sulla possibilità di realizzarlo autonomamente: "senza di me non potere far nulla" (15,5). Nel primo Discorso si prometteva l'invio del Consolatore per non disperarsi di non aver potuto realizzare i propri ideali politici di liberazione. Ora invece si fa presente che, oltre a questa assistenza psicologica, si può pensare di raggiungere la vetta più elevata dell'amore autoimmolandosi per i propri compagni, cioè sacrificandosi totalmente per loro, sino appunto all'accettazione della morte violenta.
Il punto più alto del raggiungimento dell'ideale cristiano, in questo mondo terreno, coincide con la croce, con l'affermazione della possibilità di vivere una vita interamente umana sulla terra soltanto morendo. Nessun cristiano deve pensare di poter fare qualcosa di più grande del Cristo, ovvero se a qualcuno venisse in mente di tentare una qualche liberazione dalle contraddizioni antagonistiche che lacerano la vita degli individui, perderebbe il suo tempo, poiché nessun discepolo può essere più grande del proprio maestro (15,20).
D'altra parte non mancheranno le occasioni per dimostrare la propria rettitudine, la propria grandezza morale. Il "mondo" infatti odia i cristiani e li perseguiterà senza sosta, proprio come è stato fatto nei confronti del Cristo. Qui si anticipano addirittura le persecuzioni cui saranno oggetto i cristiani da parte delle istituzioni pagane, anche se nella fattispecie ci si riferisce soltanto a quelle da parte dei Giudei: "vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà, crederà di rendere un culto a Dio" (16,2).
Per la chiesa primitiva la storia, in un certo senso, era già conclusa. Si trattava soltanto di attendere la parusia e il giudizio universale. Cristo aveva già superato brillantemente tutti gli esami, tutte le prove volute da dio-padre. "Nel mondo voi avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio: io ho vinto il mondo" (16,33).
(torna su)42) I due dogmi su Maria
I dogmi cattolico-romani intorno alla persona di Maria: Immacolata concezione del 1854 (cioè nata senza peccato originale) e Assunzione del 1950 (cioè ascesa in cielo dopo la morte, in anima e corpo), che contraddicono, il primo, la teoria paolina della trasmissione del peccato adamitico a tutta l'umanità, e il secondo, la convinzione della chiesa primitiva secondo cui Maria era morta e sepolta (morta a Efeso? sepolta nei pressi del Getsemani?), sono stati il tentativo di recuperare sul piano della devozione più fideistica quanto la chiesa romana aveva perso – a partire dal processo dell'unificazione nazionale italiana – sul terreno politico e istituzionale.
Sono stati cioè il tentativo da parte della curia romana di riavvicinarsi alle masse cattoliche facendo leva sulla loro disponibilità a non mettere in discussione le decisioni religiose, indirettamente politiche, del papato (la formulazione dei due dogmi infatti non ha beneficiato di alcun previo consenso ecclesiale): quelle masse cattoliche che nell'Ottocento s'erano lasciate influenzare dalle idee del liberalismo e nel Novecento da quelle del socialismo.
Tuttavia, la curia vaticana, con la sua abitudine a imporre dogmi e decreti, non ha fatto altro che instillare l'indifferenza nel laicato cattolico (specie quello intellettuale), il quale, ancora oggi, è disposto formalmente ad accettare tutto a condizione che non lo si costringa a farlo veramente. Ecco perché in questi due dogmi sono molto pochi i cattolici a credere ciecamente.
Abbiamo parlato di chiesa "cattolico-romana" perché quella ortodossa non considera l'assunzione un dogma, non avendo questa teoria alcun riferimento biblico; inoltre, pur credendo nella verginità perpetua di Maria (parthenos), essa rifiuta la dottrina dell'esenzione dal peccato d'origine, poiché se questa fosse vera porrebbe la "grazia" al di sopra di qualunque opera di fede.
Nonostante ciò il Catechismo Universale Vaticano sostiene che nei concetti orientali di Theotokos (madre di Dio) e di Panaghia (tutta santa) sia implicita l'idea dell'immacolata concezione (cfr n. 493). Cosa di per sé assurda, in quanto l'ortodossia è contraria persino all'idea, tipicamente cattolica, della trasmissione biologico-ereditaria del peccato d'origine.
Anche quando gli iconografi bizantini dipingevano la "dormizione", cioè il momento della morte di Maria, la sua anima "infante" nelle braccia del Cristo non stava a significare alcuna "assunzione", ma solo che il Cristo nato, come uomo, da lei, era anche il "dio" da cui la stessa Maria era nata.
Naturalmente la formulazione di questi due assurdi dogmi, che negano tutto il valore specifico del messaggio di Cristo, sono stati la logica conclusione di riflessioni teoriche elaborate nei secoli precedenti, rimaste ferme a livello di semplici opinioni. In particolare – afferma Uta R.-Heinemann – "fintanto che si tenne per certa, con Agostino, la trasmissione del peccato originale attraverso l'atto sessuale, non si poteva parlare di un concepimento di Maria [nel senso della sua stessa nascita] senza il peccato originale. Per Agostino, soltanto Gesù venne al mondo senza peccato originale, perché lui solo venne al mondo senza atto sessuale".41 Anche Bernardo di Chiaravalle si oppose all'idea di considerare Maria esente dal peccato d'origine e, con lui, Tommaso d'Aquino, Bonaventura, Alessandro di Hales ecc. Abelardo e Duns Scoto invece l'accettarono.
Nel XV secolo le divergenze circa la dottrina dell'immacolata concezione portarono a conflitti così forti tra francescani (favorevoli) e domenicani (contrari) che papa Sisto IV si vide costretto a vietare alle due parti in causa di applicare la censura di eresia alla parte avversa (1483). Il concilio di Basilea del 1439 arrivò a prescrivere la festa dell'immacolata concezione per tutta la chiesa, ma senza ottenere l'effetto sperato. Per esservisi opposti, alcuni domenicani, a Berna, finirono sul rogo il 31 maggio 1509. Solo nei secoli XVII e XVIII la festa raggiunse un carattere universale.
Come alcuni psicologi hanno notato, nei due suddetti dogmi si può rilevare una sorta di sessuofobia, di chierico maschilismo e di acceso odio nei confronti della donna (e proprio mentre si presume di esaltarla!), il cui modello infatti – Maria – è qui assolutamente inimitabile, essendo la sua virtù frutto di un'arbitraria quanto insondabile grazia divina, e non di una scelta personale. Ciò a prescindere dal fatto che nelle presunte apparizioni della Vergine, che accompagnano sempre, con straordinaria regolarità, i momenti più significativi della storia del culto e del dogma mariano, protagoniste principali delle visioni siano le donne, anch'esse vergini, per lo più adolescenti, quasi sempre povere e ignoranti. A partire dall'anno Mille sono state recensite nel mondo circa 21.000 apparizioni della Vergine, di cui 220 tra il 1928 e il 1971, e fra queste un centinaio nel solo 1940, anno di guerra mondiale.
D'altra parte la mariologia non è stata elaborata da donne, ma da uomini, per giunta celibi, che ritenevano il loro stato celibatario superiore a quello matrimoniale. Nel vangelo di Marco, che è il più antico, risulta chiaro che il Cristo aveva altri "fratelli e sorelle" (3,31 s.; 6,3). Paolo sapeva che uno dei capi della comunità di Gerusalemme, Giacomo, era "fratello di Gesù" (Gal 1,19; 1 Cor 9,5). E nel vangelo di Giovanni, Gesù viene indicato espressamente come "figlio di Giuseppe" (1,45; 6,42). Nello stesso vangelo si dice che i suoi fratelli "non credevano in lui" (7,3 ss.), anche se in At 1,14 essi fanno già parte dei "credenti". Peraltro, nel vangelo di Matteo (1,23), parlando dell'annunciazione, si descrive Maria intenta a leggere la profezia d'Isaia (che si riferiva a Ezechia, 7,4) sulla vergine che doveva partorire l'Emanuele. Ebbene la parola ebraica "almon", tradotta come "vergine" in greco, voleva semplicemente dire "giovane donna in età da marito".
Verso il 150 d.C., tutti questi fratelli e sorelle furono considerati figli di un presunto precedente matrimonio di Giuseppe (vedi l'apocrifo protovangelo di Giacomo). Intorno al 400, siccome anche Giuseppe doveva passare sotto le forche caudine della "verginità perpetua", i fratellastri e le sorellastre di Gesù finirono per assumere il ruolo di "cugini e cugine", figli di altre donne o di altre Marie (Mt 27,56; 28,1; Mc 15,40; Gv 19,25), parenti più o meno prossime di Gesù. Il primo a formulare questa tesi, che ancora oggi fa scuola, fu Girolamo, nel testo Contro Gioviniano. Egli peraltro assunse il pretesto che nel mondo ebraico col termine "fratello" s'intendeva una larga parentela. I vangeli però furono scritti in greco e, se si volevano evitare equivoci, questa lingua aveva a disposizione concetti più precisi.
I nestoriani, al concetto teologico di "madre di Dio" preferirono quello, più umano, di "madre di Cristo". Sulla stessa scia si situarono la sètta araba degli antidicomarianiti, il vescovo Bonoso di Sardica, il laico Elvidio, il monaco Gioviniano di Roma, il presbitero africano Vigilanzio, i quali però incontrarono la forte opposizione, risultata poi vincente, dei vari Efrem, Epifanio, Ambrogio, Agostino, Girolamo, Cirillo di Alessandria, Giovanni Damasceno e altri Padri eminenti, che si avvalsero delle decisioni del concilio di Efeso del 431.
Non solo dunque Maria rimase vergine ante partum, in partu et post partum (in partu per gli ortodossi significa semplicemente "durante la gravidanza"; per i cattolici invece significa anche che l'imene non si ruppe), in quanto essa non ebbe mai alcun rapporto matrimoniale, come è attestato dalle più antiche icone, che la ritraggono con le tre stelle sulla fronte e sulle spalle, ma – aggiungono i cattolici – Maria "immacolata" non fu neppure soggetta alla sofferenza durante il travaglio, avendo concepito senza il piacere della carne. In pratica Gesù sarebbe nato, secondo le leggende popolari, come Platone, Augusto, Alessandro ecc., e Maria non sarebbe che una novella Iside.
Nonostante questa presunta superiorità di Maria rispetto alle altre donne e a tutti gli uomini, Tommaso d'Aquino non si fece scrupolo nell'affermare che se Maria possedeva l'uso della sapienza nella contemplazione, non aveva però il potere d'insegnare. Con ciò Tommaso non aveva certo intenzione di ricordare il fatto, tratto da Mc 3,31 ss., che Maria e i suoi figli consideravano Gesù un "pazzo", ma semplicemente che la catechesi era un privilegio esclusivo del sesso maschile. (Priva di senso comunque resta l'affermazione del già citato Catechismo, secondo cui "Maria, per la grazia di Dio, è rimasta pura da ogni peccato personale durante tutta la sua esistenza", n. 493).
Naturalmente voci di dissenso stanno cominciando ad apparire anche nel mondo cattolico, dove teologi eminenti, che rischiano sempre di perdere l'insegnamento, come Schnackenburg, Pesch e Lohfink, sostengono – a differenza di quanto ha ribadito papa Wojtyla nell'enciclica Redemptoris Mater del 1987 – che il concepimento verginale biologico non è verità di fede biblica e non si può scartare a priori l'ipotesi che Gesù avesse avuto da Maria alcuni fratelli e sorelle (cfr Mt 13,55 s.).
Questi due dogmi, se vogliamo, costituiscono anche una sorta di risposta ideologica all'esigenza che il clero cattolico avverte di giustificare la propria sottomissione al celibato. Il sacerdote cioè sa che non può avere rapporti sessuali con una donna perché la donna per eccellenza, Maria, può essere amata solo senza sessualità, essendo essa "panaghia".
E così, quanto meno il sacerdote ama la donna terrena, tanto più dovrà amare la donna celeste, astratta, frutto della fantasia più arbitraria. Maria diventa colei che chiede al sacerdote di farsi eunuco per il regno dei cieli. I due dogmi sublimano un vero complesso di castrazione. Complesso che può anche portare a pericolose deviazioni verso la pedofilia o comunque a pratiche omosessuali e onanistiche. La "castrazione" può anche essere intesa in senso traslato, come frustrazione sociale, politica e culturale di un popolo oppresso da altri popoli: non a caso ai tempi del nazismo l'idea della razza pura trovò ampi appoggi nei seguaci dell'assoluta verginità di Maria.
In tal senso va considerata relativamente giusta l'idea dello psicologo Jung, espressa nel suo importante studio La risposta a Giobbe, secondo cui il simbolo di questo sapiente ebreo, oppresso da disgrazie immeritate, può trovare in Maria assunta in cielo l'avvocato difensore presso la Trinità.
Noi tuttavia preferiamo credere, come i protestanti, che tutti i dogmi elaborati intorno alla figura di Maria non siano altro che l'espressione, popolarizzata, delle prerogative e dei privilegi che la chiesa romana vuole attribuire a se stessa. Dice però, a tale proposito, Feuerbach: il protestantesimo "avrebbe dovuto essere così coerente e coraggioso da rinunciare, con la Madre, anche al Figlio e al Padre. Soltanto chi non ha genitori sulla terra, ha bisogno di genitori in cielo".42
(torna su)1 La specificazione "di dio" deve essere messa tra parentesi, in quanto il Cristo non ha mai usato l'espressione "regno di dio"; qui si ha chiaramente a che fare con la precisa intenzione redazionale del vangelo marciano di mistificare un evento politico spiritualizzandolo. Se Gesù ha usato l'espressione "regno di dio", al massimo può averlo fatto in maniera convenzionale, cioè usandola come espressione equivalente a "società libera, giusta, a misura d'uomo". In ogni caso egli non ha mai fatto coincidere "regno di dio" con "regno dei cieli", né ha mai pensato di far governare questo regno da una casta sacerdotale. D'altra parte gli stessi partiti rappresentanti dei ceti più oppressi, quando parlavano di "regno di dio" intendevano sempre riferirsi a qualcosa di politico-nazionale - com'era ovvio per la mentalità ebraica - e non a qualcosa di ultraterreno, come invece farà il cristianesimo, ereditando, in questo, la cultura greca orientale. Persino la parola "dio" non può essere stata impiegata da Gesù, in quanto troppo astratta e filosofica. Gli ebrei non pronunciavano mai il nome di dio, ma solo qualche suo aggettivo. La stessa parola "Abbà" è estranea alla cultura ebraica, che non tollera gli antropomorfismi in materia di religione. Peraltro l'unico momento in cui il Cristo l'avrebbe pronunciata, stando al vangelo di Marco 14,36, fu quello dell'agonia nel Getsemani, mentre tutti i discepoli stavano dormendo!
2 L'origine giudaica di Gesù appare anche dal fatto che dopo la sua morte nessun apostolo di origine galilaica fu titolato a sostituirlo. Gli unici che avrebbero potuto farlo erano i fratelli Zebedeo, ma evidentemente la loro esclusione dai leader del cristianesimo giudaico sta a significare che non condividevano l'impostazione strategica (relativa all'imminente parusia trionfale del Cristo risorto) che ne aveva dato Pietro e che verrà ereditata, in forma molto più giudaica che galilaica, da Giacomo il Giusto, almeno finché non s'imporrà la teologia paolina. Anche il successore di Giacomo sarà un altro parente giudaico di Gesù, Simeone (figlio di Cleofa o Cleopa, fratello di Giuseppe), dal 62 al 107, anche lui condannato alla crocifissione. Fu lui che, secondo la tradizione, trasferì la comunità cristiana a Pella di Perea durante la guerra del 66-70.
3 Da notare che in tal senso la cronologia sinottica finisce col cadere in una contraddizione insostenibile. La domanda concitata delle autorità, rivolta a Gesù, è in pratica una richiesta di qualificarsi nella propria identità politica: se fosse stata formulata alla fine dell'attività eversiva del Cristo non avrebbe avuto senso, in quanto si sarebbe già saputa la risposta (la sua stessa popolarità lo avrebbe autorizzato a epurare il Tempio). Essendo invece stata posta all'inizio della sua attività (come nel IV vangelo), la domanda non poteva avere una risposta scontata.
4 La rottura coi farisei avviene sin dalla prima insurrezione di Gesù, ch'egli fece contro i sadducei, in occasione dell'epurazione del Tempio, il cui fallimento dipese anche dall'atteggiamento passivo dei farisei, oltre che dallo scarso appoggio degli esseni. Tuttavia il dialogo con loro continuò, sia in Galilea che in Giudea, anche se la possibilità di un'intesa antiromana si prospetta solo dopo la morte di Lazzaro, che probabilmente era un fariseo come loro. Tale partito non era risolutamente avverso a Gesù, come appunto i sadducei, ma su posizioni interlocutorie: alcuni membri infatti lo frequentano, lo invitano a pranzo, discutono con lui, e non è da escludere che l'apostolo Giuda provenisse dai loro ambienti.
5 Si noti come la parola "segni" (semeia) riprenda la stessa parola riportata in 2,23, che in questo vangelo viene sempre usata in riferimento a dei miracoli portentosi e guarigioni straordinarie che dovevano o presumere la fede, da parte degli interlocutori, o indurla ad averla, e non solo nella "signoria" di Gesù nei confronti delle forze della natura o delle malattie, ma anche addirittura nella sua origine divina, nella sua affiliazione con la persona del Dio-padre (di qui il loro carattere simbolico). Tuttavia a Gerusalemme Gesù non fece alcun "segno" se non quello dell'epurazione del Tempio. Quindi è evidente che il redattore, manipolando il testo originario, ha scollegato l'epurazione del Tempio con l'incontro segreto tra Gesù e Nicodemo e ha lasciato supporre che quest'ultimo si riferisse a una cosa diversa da quella ch'era stata nella realtà. Così facendo però lo ha costretto ad affermare delle parole del tutto arbitrarie, in quanto, se anche il Cristo avesse potuto compiere dei "segni", non per questo avrebbe potuto dimostrare la benevolenza di Dio nei suoi confronti. L'associazione dei miracoli col concetto di "maestro amato da Dio" non era nella mentalità ebraica la regola, bensì l'eccezione, proprio perché non strettamente pertinente, tant'è che in Dt 13,2 ss. è detto chiaramente che chi compie prodigi può anche essere un impostore.
6 P. es. il v. 23, là dove si parla di "adorare Dio in spirito e verità", può essere letto come il tentativo redazionale di trasformare l'idea originaria di Cristo di privatizzare l'atteggiamento personale nei confronti della religione, onde favorire la convergenza delle classi oppresse, nell'idea post-pasquale, di derivazione ellenistica, di una spiritualizzazione della fede di tipo universalistico, in cui la cosiddetta "acqua viva" altro non sarebbe che quella del battesimo cristiano e del dono dello Spirito Santo. Non a caso sarà proprio la Samaria a inaugurare la predicazione del vangelo ai pagani - cfr At 8,5).
7 Non è da escludere che Nazareth sia una località inventata dal cristianesimo primitivo di derivazione galilaica per mostrare la propria rivalità nei confronti di quello giudaico: non a caso nell'ultima pericope autentica del vangelo di Marco è scritto che il Cristo risorto avrebbe rivisto i suoi discepoli in Galilea (16,7).
8 Da notare che l'autore della pericope, inizialmente, non sembra voler includere tra i "discepoli" di Gesù anche i suoi "fratelli" o i parenti più stretti e neppure i servi dello sposo: di nessuno di questi il redattore dice esplicitamente che "credettero in lui"; anzi, a ben guardare, non lo dice neppure di Maria, che nel racconto sembra strappare il prodigio più in quanto "madre" che non in quanto "discepola". Stando a Mc 3,30 ss. e a Gv 7,5, i rapporti tra il Gesù politico e la madre (ivi inclusi i fratelli e le sorelle) spesso erano difficili, benché alcuni fratelli militassero nella cerchia dei Dodici. Forse questo racconto sta a significare che tra Gesù e il suo parentado s'era stabilita una certa riconciliazione, dopo l'evento di pericolosa rottura istituzionale quale fu la cacciata dei mercanti dal Tempio. È probabile che l'esilio in Galilea abbia coinvolto solo una parte del parentado.
9 Si noti come "segni e prodigi [o miracoli]" appaiano come due cose diverse, quando in realtà in questo vangelo coincidono. Il redattore ha voluto mettere la parola "prodigi" perché ha pensato che un lettore di origine pagana non avrebbe potuto capire la parola "segni", più volte utilizzata in questo vangelo in chiave teologico-simbolica. Anche da questo si può comprendere come tutto il racconto sia tardivo, interpolato da una tradizione sinottica.
10 Da notare che l'espressione "Ma io vi dico" non sarebbe mai potuta venire in mente a un ebreo se non fosse stato un ateo. Infatti il nome di Mosè era ed è ancora oggi, per qualunque ebreo, associato al nome di Jahvè, per cui la suddetta espressione non poteva sottrarsi all'accusa di blasfemia.
11 Molti esegeti han ritenuto poco spiegabile il motivo per cui la vera protagonista sia Maria quando è soprattutto con Marta che Gesù dialoga.
12 In Marco invece Giuda tradisce a causa del carattere venale della sua persona, attaccata al denaro.
13 Altri personaggi autorevoli non erano contrari alla predicazione del Cristo: p. es. Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico (Lc 19,1 ss.) e Cuza, funzionario di Erode Antipa (Gv 4,43 ss.).
14 È stato fatto notare che l'origine giudaica di Gesù può essere dedotta anche dal fatto ch'egli prepara l'ingresso messianico mostrando di conoscere personalmente una determinata persona di Gerusalemme che gli metterà a disposizione l'asino da cavalcare.
15 Il cristianesimo è stato una forma di spiritualizzazione dell’ebraismo, una sorta di approfondimento etico sul piano dei valori, ma a scapito dell’esigenza politica di liberazione nazionale e di giustizia sociale. È assurdo pensare che una svolta del genere sia potuta avvenire per progressive determinazioni quantitative. Se fosse dipeso solo da queste, il massimo della spiritualizzazione si sarebbe avuto con la posizione del Battista, cioè restando nell’ambito del migliore giudaismo classico. Invece col Cristo s’era andato oltre, in maniera imprevedibile, ma siccome questa posizione ultragiudaica è stata - secondo la storia che ci è stata tramandata - compiutamente espressa da Paolo di Tarso (tutti gli esegeti su questo sono concordi), bisognerebbe a questo punto porsi la seguente domanda: Paolo è stato superiore a Cristo e quindi a buon diritto dobbiamo considerarlo come il vero fondatore del cristianesimo, oppure, se non ci fosse stato un preventivo tradimento del vangelo di Cristo (operato da Pietro), non ci sarebbe stato neppure un vangelo di Paolo? Detto altrimenti, è possibile supporre che l’approfondimento spiritualistico dell’ebraismo sia stato una conseguenza del fatto che il vangelo di Cristo non era solo profondamente umano ma anche profondamente politico? E che l’aver eliminato la sua politicità ha indotto a trasformare la nuova dimensione etica dell’umanesimo laico in una dimensione squisitamente religiosa?
16 Non pochi esegeti han rilevato come il v. 12,37 ("Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui.") sia in un certo senso contraddittorio col successivo v. 42 ("Anche tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga.").
17 L'insieme delle truppe romane della Giudea era costituito, probabilmente, da cinque "coorti" e da un'"ala", raggiungendo complessivamente la forza di poco più di tremila uomini: una coorte era di stanza permanente a Gerusalemme. Le truppe erano composte anche di soldati ausiliari reclutati di solito fra Samaritani, Siri e Greci, godendo i Giudei dell'antico privilegio di esenzione dal servizio militare.
18 Da notare che nel IV vangelo quando Gesù parla dell’amore, lo fa in un modo molto diverso da quello descritto nel Simposio di Platone. Anzitutto il contesto non è quello gaudente della cena conviviale tra filosofi che amano discutere di qualunque cosa: se una cena c’è, essa è “l’ultima”, in quanto ciò che le fa da sfondo è la tragedia imminente della croce, o comunque l’urgenza e la grande difficoltà di dover organizzare una rivoluzione armata. In secondo luogo non si parla di amore tra un io e un tu, ma tra un io e un molti, nonché di un rapporto di fiducia e di stretta collaborazione tra i discepoli e di un rapporto fattivo-propositivo tra questi e il “mondo”, non senza rischi di tipo personale. In terzo luogo non è un amore dove il sesso ne è parte costitutiva, ma un amore che implica una sequela di tipo politico, una reciproca responsabilità per trasformare il sistema dominante.
19 All’interno del rapporto tra "Padre" e "Discepoli" il quarto vangelo introduce il concetto di "Spirito", quale "sostituto del Figlio". Nel diteismo di "Padre e Figlio" lo Spirito rappresenta una sorta di elemento divino distinto, con personalità autonoma, che porterà, ad un certo punto, il cristianesimo primitivo a qualificarsi come una forma di triteismo. Tale Spirito, secondo questo vangelo, "procede" da una sola origine: il Padre, il quale però, per le esigenze dell’economia salvifica, lo mette a disposizione del Figlio (Spirito e Figlio come "mani di Dio"). Come noto la chiesa romana vorrà negare questa tesi giovannea introducendo nel Credo niceno-costantinopolitano l'eresia filioquista, la quale, facendo dipendere ontologicamente l'identità e la funzione dello Spirito "anche dal Figlio", spezzerà da un lato il regime diarchico tipico del mondo bizantino, in cui sacro e profano o ecclesiastico e laico si ponevano su un piano paritetico, e dall'altro affermerà il regime monarchico esclusivo, in cui il papato ("vicario di Cristo") assumerà un ruolo politico in proprio (integralismo teocratico), salvo la delega a un proprio braccio secolare, confliggendo così con gli interessi dello Stato autonomo, la cui autorità proveniva direttamente da Dio - come allora si diceva - e che, nella sua massima istanza, era legittimamente rappresentato dall'imperatore d'oriente (basileus), cui la chiesa romana vorrà opporre nell'800 la figura di Carlo Magno.
20 Si noti che tale sciocchezza resterebbe tale anche se si supponesse che il Cristo non abbia alcun carattere divino e che l'idea di dio-padre altro non fosse appunto che una sua propria idea.
21 Mc 3,18 non dice che Simone era "zelota" ma solo "cananeo". Lo dice tuttavia Lc 6,15, perché ai suoi tempi la parola "zelota" non aveva più il carattere imbarazzante che aveva ancora in quelli di Marco. Luca infatti fa "armare" i discepoli di Gesù (22,36), Marco no.
22 Chissà perché quando si pensa al tradimento di Giuda viene spontaneo fare un confronto con quello di Trotski nel 1918, allorché, in qualità di capo della delegazione sovietica ai colloqui con i plenipotenziari tedeschi, egli infranse le istruzioni di Lenin, del Cc del partito e del governo sovietico, non sottoscrivendo le condizioni della Germania e rompendo le trattative di pace. Ovviamente i contesti, le motivazioni, le finalità sono del tutto diversi. Ma analoga è la modalità: entrambi decisero arbitrariamente il destino di un progetto di liberazione, violando decisioni collegiali già prese. Come noto, il comportamento di Trotski e dei "comunisti di sinistra" fece il gioco dell'imperialismo tedesco, che così poté passare all'offensiva. Naturalmente il tradimento venne fatto nella convinzione d'essere nel giusto e nella speranza di realizzare precisi scopi; tuttavia i risultati furono esattamente opposti a quelli previsti.
23 Si noti, peraltro, che mentre in 13,36 Pietro chiede a Gesù dove stia andando, in 16,5 Gesù rimprovera i discepoli di non chiedergli dove stia andando. D'altra parte in 14,31 Gesù chiede ai discepoli di andarsene dal Cenacolo, ma poi lo fanno solo in 18,1: il che ha fatto giustamente pensare che tutto il contenuto dei capitoli 15-17 sia redazionale.
24 Nel IV vangelo Gesù usa un linguaggio più sfumato, ancorché non meno mistico: "Dove vado io, voi non potete venire" (13,33).
25 L'altra stranezza sta nel fatto che Marco sembra parlare di "monte degli ulivi" (v. 26) e di "Getsemani" (v. 32) come di due luoghi diversi.
26 Vengono qui in mente taluni miti pagani, in cui i padri chiedono ai figli di sacrificarsi per il bene dell'umanità, di quell'umanità che gli stessi figli hanno voluto e che i padri hanno concesso malvolentieri, sapendo già in anticipo come sarebbe andata a finire.
27 Come spiegare il fatto che, mentre nei Sinottici i farisei non fanno la parte dei traditori, in quanto Gesù viene catturato dalle guardie mandate dai sommi sacerdoti, scribi e anziani, nel IV vangelo invece sono presenti anche loro nel Getsemani? Indubbiamente quando i vangeli furono scritti i nemici più significativi del cristianesimo erano proprio i farisei, che, dopo la distruzione del Tempio, si erano sostituiti ai sadducei, scomparsi come casta sacerdotale. Tuttavia, siccome i vangeli vogliono essere testi religiosi e non politici, e siccome non pochi farisei, seguendo l'esempio di Paolo, erano divenuti cristiani, si può pensare che i Sinottici, piuttosto che presentarli come traditori politici, abbiano preferito limitarsi a dipingerli come fanatici integralisti della fede giudaica. In questa maniera, peraltro, si evitava di far credere che con Paolo il cristianesimo altro non era che un fariseismo ellenizzato. Nel IV vangelo invece i redattori si sentono un po' più liberi di esprimersi, poiché, essendo monaci e non frequentando gli ambienti paolini, non avevano cristiani provenienti da ambienti farisaici.
28 Nel vangelo di Marco vi è la contraddizione secondo cui se davvero Pilato avesse voluto liberare Gesù non l'avrebbe messo in alternativa a un patriota nazionale; tuttavia Marco presenta Barabba come uno spregevole assassino (ancorché "politico" in quanto "ribelle") che non avrebbe meritato d'essere messo in alternativa al Cristo pacifista, e il fatto che il popolo lo scelse è, secondo l’evangelista, che qui non ha scrupoli nel manifestare il proprio antisemitismo, la riprova della bassezza d'animo dei Giudei. Di questa prassi di scambiare un prigioniero per un altro esistono tre testimonianze al di fuori dei vangeli: il costume romano di togliere ai prigionieri le catene e di metterli in libertà in occasione della festa dei lectisternia; il protocollo di un procedimento giudiziario svoltosi dinnanzi a Settimio Vegeto, governatore d’Egitto nell’86 d.C., il quale decise di non esprimere alcuna sentenza lasciando l'imputato al giudizio della folla; il trattato mishnaico Pesachim VIII 6a, che prevede la possibilità di celebrare la Pasqua per un prigioniero che abbia ottenuto la promessa di essere rilasciato. Tuttavia non è da escludere che Pilato avesse adottato questa provvedimento di sua spontanea iniziativa, in considerazione proprio della pericolosità di Gesù.
29 Necessaria in un duplice senso: 1) la liberazione umana e politica nel mondo (e quindi anche in Palestina) è impossibile a causa del peccato originale, che rende gli uomini impotenti; 2) per riscattarsi agli occhi di dio-padre dall'incapacità di compiere il bene, e quindi dal rischio di autodistruggersi o di essere definitivamente abbandonati dallo stesso dio-creatore, occorreva il supremo sacrificio del dio-figlio, prototipo dello stesso genere umano. Questa teologia ovviamente è più paolina che petrina, ma solo perché s'innesta e si sviluppa in quella "teologia della necessità" elaborata da Pietro l'indomani della morte del Cristo (usata anche al fine di dimostrare che i Giudei non erano migliori dei Galilei). Lo stesso vangelo di Marco va considerato espressione di una teologia che è insieme petrina e paolina.
30 Giovanni, a differenza di Pietro, non poteva essere riconosciuto dal suo idioma come proveniente dalla Galilea, poiché era di origine giudaica. È infatti noto che il racconto di Marco (1,16 ss.) sulla chiamata dei primi discepoli, intenti a pescare, va considerato del tutto inventato. Non a caso è nel quarto vangelo che si insiste così tanto sui luoghi giudaici della missione di Gesù.
31 Pilato, della nobile famiglia dei Ponzi, originaria del Sannio o del Piceno, fu il quinto governatore della provincia romana della Giudea dal 26 al 36. Dall'imperatore Tiberio fu convocato a Roma nel 36 (lo stesso anno in cui il sommo sacerdote Caifa venne deposto), per rendere conto di un massacro di certi Samaritani fatto sul monte Garizim: non ritornerà più in Giudea e di lui non si saprà più nulla con sicurezza. Giuseppe Flavio lo descrive come persona intollerante, che non riscuoteva alcuna simpatia da parte dei Giudei. Le leggende su di lui sono infinite: ancora oggi la chiesa copta lo ritiene addirittura un martire.
32 Una frase, questa, che potrebbe essere interpretata anche nel senso che quando si compie un crimine politico nei confronti di una persona autorevole, in grado di fruire di ampi consensi, inevitabilmente le conseguenze non possono essere pagate soltanto dagli autori del crimine, ma anche dai loro discendenti, se effettivamente quella persona rappresentava qualcosa di inestimabile valore. Esattamente come avviene con le violazioni compiute ai danni della natura.
33 Si può tranquillamente ipotizzare che i tre stipes fossero stati messi per eseguire una condanna a morte già sentenziata da Pilato. I tre zeloti in questione dovevano aver ucciso uno o più soldati romani. Solo all'ultimo momento si usò uno dei tre pali per Gesù, al posto di Barabba, il cui nome - come noto - non vuol dire nulla ("figlio del padre"), probabilmente perché in questa maniera i redattori potevano celare l'identità di qualcuno che allora doveva essere molto popolare sul piano politico.
34 Il Golghota ("luogo del cranio"), un rilievo roccioso di pochi metri appena fuori dalle mura di Gerusalemme, era chiamato così per la presenza dei teschi dei condannati non seppelliti. Secondo la leggenda vi sarebbe stato sepolto Adamo, per questo nell'iconografia della morte di Gesù viene posto ai piedi della croce il cranio di Adamo.
35 Si noti che di questa Magdala, posta sulle riva del lago di Galilea, non si sa nulla nel Nuovo Testamento (Flavio Giuseppe la chiama Tarichea, che vuol dire "salatura del pesce"). Appare solo in connessione con la Maddalena, e non è da escludere che ciò sia stato fatto per negare a questa discepola l'origine giudaica e soprattutto la possibilità che venisse identificata con la sorella di Marta e Lazzaro, Maria.
36 Nei confronti di Maria i Sinottici assunsero due atteggiamenti contrapposti: uno di disapprovazione, l’altro di esaltazione leggendaria. La disapprovazione fu il primo atteggiamento, come si può ben costatare in Mc 3,31 e soprattutto in Mc 3,21. L’esaltazione leggendaria appartiene a Matteo e soprattutto a Luca, che ricorda Maria persino in At 1,14, intenta a "pregare" con gli Undici apostoli. L’evangelista più equilibrato resta Giovanni, che sa esaltare il lato umano di Maria (nel racconto delle nozze di Cana), la sua capacità di adeguarsi alla volontà del Cristo (allorché lo segue fino a Cafarnao, per il cambio di residenza, cfr Gv 2,12), nonché la sua capacità di discernere, tra gli apostoli, quello che avrebbe dovuto ereditare la leadership del figlio, cioè lo stesso Giovanni (Gv 19,26 s.). Secondo la tradizione Maria rimase sempre con Giovanni fino alla morte (a Efeso?). Questo ovviamente non significa che Maria non abbia nutrito delle riserve sulla missione di Gesù. Da notare inoltre che in Gv 7,3 ss. i fratelli di Gesù non sono affatto refrattari alla sua politica, come invece appare nei Sinottici, dove vengono considerati alla stregua di ebrei tradizionalisti, conservatori, se non addirittura opportunisti... Giovanni fa capire ch’essi si opponevano alla politica di Gesù in quanto "estremisti" e "avventurieri". Non a caso negli elenchi dei Dodici riportati dai Sinottici non viene mai detto esplicitamente che alcuni di loro erano "fratelli di Gesù". I Sinottici in un certo senso lasciano intendere che i fratelli di Gesù furono dei seguaci della "seconda ora".
37 Si badi: l’imprevedibilità della morte di Gesù non dipese dal fatto che "Pilato cercava di liberarlo" (Gv 19,12), poiché questo non costituisce un "fatto", ma una semplice opinione di stampo apologetico della chiesa primitiva. In realtà Pilato voleva essere sicuro, nel giustiziare un leader politico molto popolare, di avere il consenso necessario da parte di un certo numero di Giudei.
38 A Betsaida, posta a tre chilometri a nord del mare di Galilea, era sepolto Erode Filippo, fratellastro di Erode Antipa e di Erode Archelao. Era stato lui che nel 30 d.C. l'aveva trasformata in polis romana, rinominandola Iulia, in onore della moglie di Augusto.
39 Il principale manipolatore del quarto vangelo è probabilmente quello stesso Giovanni il presbitero autore delle tre lettere, fatte passare dalla chiesa come autografate dall'apostolo Giovanni. Basti pensare che l'espressione affettuosa di "figlioli" o "figlioletti" è presente, oltre che una volta in questo vangelo, ben sette volte nella I lettera di Giovanni.
40 Da notare che la chiesa romana ponendo, per quanto riguarda la processione eterna, originaria, dello spirito, il dio-padre e il dio-figlio esattamente sullo stesso piano, tende a favorire, senza rendersene conto e quindi involontariamente, la formazione dell'ateismo, in quanto fa di dio una mera rappresentazione del Cristo, il quale, a sua volta, diventa una mera rappresentazione del pontefice, che non a caso sostiene d'essere suo "vicario in terra", cioè sua "copia" e quindi, in ultima istanza, "copia di dio". D'altra parte qualunque stretta identificazione di padre e figlio ("chi ha visto me ha visto il padre", ecc.), se svolta in maniera conseguente, può portare all'ateismo. Un figlio che sostiene piena identità col proprio padre e che, per credere in questo padre, chiede di credere semplicemente in se stesso, rende irrilevante la fede nel proprio padre. In tal modo mentre nell'ebraismo (e se vogliano nell'islam) ci si avvicina all'ateismo attraverso la negazione dell'uguaglianza di uomo e dio, nel cristianesimo invece ci si avvicina attraverso l'affermazione dell'uguaglianza di dio-figlio e dio-padre, un'identificazione esclusiva al solo figlio, che se diventa assoluta, come nella chiesa romana, porta inevitabilmente all'ateismo, seppur all'interno della mistificazione religiosa, in quanto nessuna confessione può mai rinunciare alla mediazione sacerdotale tra uomo e dio senza autonegarsi. Per evitare questo la chiesa ortodossa ha ribadito istanze ebraiche di negazione dell'uguaglianza (dio è "tenebra", "totalmente altro", ecc.) e ha puntato maggiormente l'attenzione sul fatto che gli uomini, pur non potendo fruire di alcuna uguaglianza col divino (se non in forme assolutamente mistiche come quelle esicastiche), possono evitare la disperata rassegnazione grazie all'intervento consolatorio del Paraclito. Come si può notare qualunque chiesa tradisce il messaggio originario del Cristo ateo, per il quale esisteva la possibilità d'affermare un'identificazione di uomo e dio da realizzarsi già sulla terra, lottando per la propria liberazione umana e politica. Il limite di tutte le religioni è proprio dovuto al fatto che anche quando presumono di porsi come esperienze di liberazione umana e politica, esse non spingono mai queste esperienze al punto da dover negare la necessità di una mediazione religiosa tra uomo e dio, e questo limite dipende proprio dal fatto che le esperienze religiose non sono mai di autentica liberazione sociale ed economica, non riflettono mai adeguatamente l'uguaglianza esistente nella storia prima della nascita delle civiltà antagonistiche. L'ateismo di cui necessita l'umanità deve essere il riflesso di una condizione di vita che non ha bisogno di dio per motivare le proprie debolezze e contraddizioni.
41 Cfr Eunuchi per il regno dei cieli, ed. Rizzoli, Milano 1990, p. 76.
42 Cfr L'essenza del cristianesimo, ed. Feltrinelli, cap. VII.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube