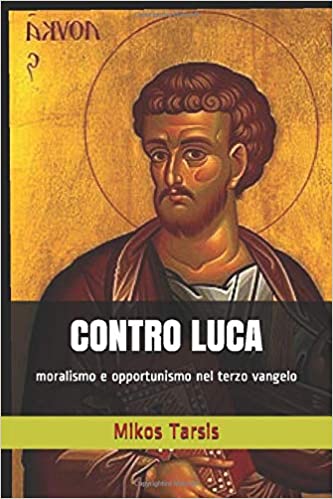
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
CONTRO LUCA
Moralismo e opportunismo nel terzo vangelo
Premessa - 1) Biografia di Luca - 2) Gli inizi della predicazione di Gesù - 3) Il discorso sulla Montagna - 3.1) Dopo il discorso - 4) L'impotenza di Gesù e i limiti di Luca - 5) Il ricco epulone - 6) La passione di Gesù nella prospettiva lucana - 7) Il mito della resurrezione - Conclusione - Appendice su Brandon
Chi rappresenta Luca? Solo l'autore del terzo vangelo? No. Se fosse solo questo, non sarebbe valsa la pena scrivere un libro del genere. Rappresenta invece le posizioni moralistiche, sul piano personale, e opportunistiche su quello politico, che impediscono di credere in un mutamento significativo della realtà; quelle posizioni che non aiutano a sperare, ma solo a illudersi che si possa vivere dignitosamente anche senza far nulla, o quasi nulla. Di qui l'esigenza d'essere espressamente “contro”. E siccome Luca, di tutti gli evangelisti, è quello più vicino al mondo greco-romano, che non è molto diverso dal nostro, è soprattutto la sua filosofia di vita che bisogna cercare di superare.
In particolare qui si è tentato di capire perché il suo moralismo e il suo opportunismo favoriscono la conservazione dello status quo. Non si è perso tempo a dimostrare che tutto quanto Cristo ha fatto di “sovrumano” è storicamente insostenibile. Lo si è dato per scontato. E questo sicuramente non piacerà agli esegeti confessionali. D'altra parte anche quelli che non lo sono, diranno che, allo stato attuale delle fonti, così fortemente tendenziose, una lettura alternativa è “vanità delle vanità”.
(torna su)1) Biografia di Luca
Il Canone Muratoriano, della fine del II sec. d.C., dice che Luca ha scritto il terzo vangelo (a partire dalle vicende del Battista), che era un medico1, che fu compagno di viaggio di Paolo di Tarso (probabilmente fino a Roma), e che non ha mai conosciuto Gesù di persona, quindi non è stato testimone oculare di nessuno dei fatti che racconta.
Molto di più non sappiamo. Il Prologo antimarcionita (anch'esso del II sec.) aggiunge soltanto ch'egli era siriano di Antiochia, aveva letto i vangeli di Marco, scritto in Italia, e di Matteo, scritto in Giudea, rimase celibe e morì a 84 anni a Tebe, in Beozia (o in Bitinia, secondo Gerolamo, il quale sostiene anche che le sue ossa furono trasportate nel IV sec. a Costantinopoli).2 Successivamente, nel periodo delle crociate o forse in quello dell'iconoclastia, le sue spoglie sarebbero giunte a Padova, dove tuttora si troverebbero nella basilica di santa Giustina (si è appurato che la cassa di piombo che lo contiene è effettivamente del III-IV sec.), mentre la testa sarebbe stata trasferita dall'imperatore Carlo IV di Lussemburgo e Boemia a Praga nel 1354.
Il vangelo lo scrisse nella greca Acaia (e forse in Beozia), dopo la morte di Paolo, rivolgendosi esplicitamente ai cristiani di origine pagana, per cui si può presumere sia stato largamente ispirato dallo stesso Paolo, come vuole peraltro il teologo Origene (Paolo arrivò ad Antiochia nel 44). Gli esegeti ritengono, con buona approssimazione, che sia stato redatto tra l'80 e il 90 d.C. (di sicuro dopo la distruzione del Tempio del 70). Alcuni pensano che il testo sia stato scritto dopo il 93, cioè dopo che Giuseppe Flavio pubblicò le sue Antichità giudaiche, che Luca doveva aver letto.
Luca scrisse anche gli Atti degli apostoli, dove i motivi teologici sono già presenti nel vangelo. Gli Atti li concluse probabilmente a Roma: stranamente però in questo testo non viene citata neanche una delle lettere di Paolo. Gli Atti rappresentano una prosecuzione cronologica del vangelo, in quanto, mentre in questo la missione di Gesù inizia a Nazareth di Galilea e si conclude a Gerusalemme; in quelli la missione degli apostoli inizia a Gerusalemme e si conclude a Roma.
Luca si pone come un teologo politico che vuol fare un'opera di storia, rivolta a un pubblico sufficientemente colto, in quanto il suo greco è abbastanza raffinato. Che si rivolga a dei cristiani di origine ellenica è dimostrato dal fatto ch'egli è molto interessato all'universalismo del messaggio cristiano, visto in chiave spiritualistica, sulla scia della teologia paolina, della quale però non tratta i temi del rapporto tra fede e opere o tra legge e vangelo, né della giustificazione mediante la fede e neppure della circoncisione, forse perché considerati troppo ebraici.
D'altra parte Luca non è neppure mai stato in Palestina: a volte confonde i termini “Giudea” e “Galilea”; situa Nazareth su di un monte; pone la regione di Gerasa di fronte alla Galilea, sul lago di Genezaret, mentre la cittadina si trova a 50 km dal lago, nella Decapoli; descrive gli usi e i costumi palestinesi con la mentalità e l'occhio di un ellenista: immagina le case palestinesi costruite come quelle greco-romane, con cantina, atrio e diverse stanze, e ricoperte di tegole; crede che abitualmente i Giudei assumano la posizione sdraiata per mangiare, suppone che il vento caldo sia lo scirocco (vento del sud), mentre è il vento dell'Oriente che porta la calura, ecc. Non da ultimo ignora i rituali del Tempio di Gerusalemme e non si interessa ai problemi della Legge.3
Per quasi il 40% del proprio vangelo Luca dipende da Marco, dal cui vangelo ha epurato tutte le parole ebraico-aramaiche; poi vi è ovviamente la cosiddetta e misteriosa “fonte Q”, che doveva contenere un certo numero di detti e sentenze di Gesù, utilizzata anche nel vangelo di Matteo.4 Tuttavia per un terzo circa del suo vangelo egli utilizza del materiale proprio (p.es. i racconti dell'infanzia di Gesù, e qui la leggenda vuole ch'egli si sia servito anche della madre di Gesù come fonte, diventando di questa, addirittura, l'iconografo). Si noti che ben 18 delle sue 24 parabole non esistono negli altri Sinottici.
Oggi molti esegeti pensano che Luca avesse sottomano anche il vangelo matteano: p.es. l'idea di una genealogia di Gesù la prende da questo vangelo, ma siccome Luca si rivolge a un lettore di origine pagana, la fa partire da Adamo.
Caratteristica fondamentale di Luca è quella di negare qualunque responsabilità a carico dei Romani riguardo alla crocifissione del Cristo: il che lo porta inevitabilmente ad assumere posizioni antisemitiche e a smentire la dichiarazione iniziale riportata nel suo stesso vangelo, secondo cui sarebbe stato molto scrupoloso nel raccogliere informazioni prese da “testimoni oculari” (1,1-4). D'altra parte per lui il cristianesimo non è pericoloso per l'impero romano: per tre volte il governatore Pilato afferma l'innocenza di Gesù. Lo stesso Gallione e altri ufficiali romani, negli Atti, affermano la stessa cosa nei confronti di Paolo.
Da ultimo si può far notare che secondo alcuni esegeti questo vangelo s'è posto il compito di contrastare la religione mitraica, sviluppatasi inizialmente in ambienti indo-iranici-babilonesi, nel III sec. a.C., e poi diffusasi come culto solare universalistico, nel I sec. d.C., grazie ai mercanti, agli schiavi e soprattutto ai militari romani, che ne vennero a conoscenza mentre combattevano contro i Persiani.
Infatti non può essere considerato casuale che il culto del dio Mithra abbia così tante affinità con quello cristiano: la nascita del redentore del mondo è posta al 25 dicembre, in una grotta, coi pastori come primi adoratori, ed è venerato la domenica (di cui restano tracce nei nomi Sunday e Sonntag). Il culto è strutturato sulla base di sacramenti assai simili a quelli cristiani: battesimo, cresima, eucaristia (con tanto di rito dell'ultima cena), estrema unzione...; caratterizzato da una teologia identica a quella paolina: rivelazione divina, immortalità dell'anima, resurrezione dei corpi, giudizio finale universale... Non a caso il mitraismo era penetrato in Cilicia, terra di Paolo, un secolo prima della sua nascita. Tale culto fu soppresso dallo Stato cristiano nel IV secolo.
(torna su)2) Gli inizi della predicazione di Gesù
È singolare come Luca, quando inizia a parlare di Gesù, raccontando la sua infanzia ed elencando persino la sua genealogia5, in realtà non sappia nulla di ciò che lui ha davvero fatto in Giudea prima di trasferirsi in Galilea.
Luca dà per scontato che i genitori di Gesù vivessero a Nazareth di Galilea, una cittadina che nelle fonti ebraiche non è menzionata prima del III sec. Nella sua fantasiosa cronistoria essi si spostarono a Betlemme, perché questa era la città di Giuseppe, padre di Gesù, ove doveva recarsi per adempiere alle regole del censimento romano voluto dall'imperatore Cesare Augusto. Da dove Luca abbia preso queste informazioni non è dato sapere.6 Con quelle poi relative ai re Magi siamo ben oltre i confini dell'apocrifo.
Non pochi esegeti sono convinti che l'originario vangelo di Luca inizi soltanto dal capitolo 3, quindi anche in questo caso, come in tutti gli altri vangeli, avremmo a che fare con una stesura riveduta a più riprese. Naturalmente vi sono molti altri indizi che lo confermano, ma discussioni di questo genere le lasciamo volentieri agli specialisti. Non dimentichiamo che non esiste prova certa dell'uso di questo vangelo prima del 150 circa.
Da un lato Luca sembra sapere che le origini di Gesù siano giudaiche e non galilaiche; dall'altro però preferisce non approfondire la cosa, lasciando credere che in Giudea egli fosse soltanto nato e che in realtà fosse cresciuto in Galilea. Il che però contrasta nettamente con quanto viene detto nel quarto vangelo, secondo cui Gesù si trasferì in Galilea come un esiliato (portando probabilmente con sé sua madre), ricercato dalla polizia del Tempio, in seguito al fallito tentativo di scatenare una sommossa popolare contro la corrotta casta sacerdotale.
Inoltre Luca non sa nulla dei rapporti tra Gesù e il movimento del Battista, se non quelli parentali tra Maria ed Elisabetta7, e si inventa il battesimo di Gesù ad opera del Precursore, sulla falsariga del protovangelo marciano. Quando comincia a parlare del Cristo adulto in Galilea, scrive che “la sua fama si sparse per tutta la regione” (4,14), ma senza spiegarne il motivo. Infatti Gesù non ha ancora compiuto nulla per meritarsela.
Luca sa soltanto che quando Gesù entra in Galilea era già famoso, ma non ne conosce la ragione, che invece è ben spiegata nel quarto vangelo. Gesù aveva già cercato di compiere un'insurrezione contro i sommi sacerdoti e il partito sadduceo della capitale giudaica, ricevendo il plauso di Nicodemo, fariseo progressista. E nel dialogo coi Samaritani aveva fatto chiaramente capire di non riconoscere più alcun primato storico e teologico al Tempio di Gerusalemme, per cui non avrebbe mai cercato di realizzare un regno politico sulla base di una determinata rappresentazione della divinità. Contro i Romani si doveva combattere una lotta armata, ma non in nome di Dio. Quando arrivarono, lui e i primi discepoli8, in Galilea, lo accolsero festanti, proprio per quello che aveva fatto e detto in Giudea e in Samaria.
Luca sa soltanto qualcosa, ma non sa ricostruire i fatti: gli manca la fonte giovannea. Eppure, nella premessa del suo vangelo, egli si vanta d'aver contattato dei “testimoni oculari” e di essersi “accuratamente informato di ogni cosa dall'origine” (1,2 ss.). Nondimeno c'è in Luca una convinzione che manca nei due vangeli di Marco e di Matteo: secondo lui Gesù era un politico, seppure di stampo religioso.
Tale convinzione dipende probabilmente dal fatto che nel suo vangelo c'è meno autocensura. Lo si capisce sin dal primo racconto significativo: quello della sinagoga di Nazareth (4,16 ss.). Da questo ambiente, per la prima volta, Gesù viene espulso, rischiando anche di morire, sebbene nel versetto che precede tale pericope sia scritto: “Insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti” (4,15).
Improvvisamente lo detestano, ma perché? Luca non è un fine teologo: non possiamo aspettarci molte spiegazioni da lui. Sembra piuttosto svolgere la parte del giornalista amante della cronaca o della storia (che, più che altro, è romanzata), soprattutto perché affascinato dai grandi personaggi, quelli che han deciso, con loro comportamento, determinati eventi. Si avverte chiaramente che dietro questo autore non vi sono tradizioni consolidate di una realtà popolare cui fare riferimento. Luca sa di appartenere a una cultura o a una civiltà pagana, dove l'elemento individualistico gioca una parte di rilievo. Non è da escludere, in tal senso, ch'egli avvertisse le popolazioni della Palestina, così riottose alla dominazione romana e così intellettualmente dotate, come una realtà di un certo interesse, anche se nel momento in cui scrive il vangelo egli è lontanissimo dall'idea di voler associare la cultura ebraica a un'istanza politica di liberazione contro Roma. L'immagine che dà del Cristo è nettamente subordinata a quella, spoliticizzata, che va predicando Paolo di Tarso.
La suddetta pericope sulla sinagoga è piuttosto lunga ed è svolta in maniera molto più significativa di quanto faccia Marco nella sua versione (1,21 ss.), dove il tutto si riduce alla guarigione di un ossesso in un giorno vietato, il sabato, in cui, per definizione, non si doveva far nulla, ad eccezione del salvataggio della vita in caso di estremo pericolo.
Un racconto, quello marciano, del tutto inventato, scritto a bella posta per mostrare l'estrema diversità, priva di soluzioni di continuità, tra l'insegnamento del Cristo e quello rabbinico. Una diversità che viene ulteriormente accentuata dal fatto che Gesù sa fare guarigioni portentose (e addirittura esorcismi), mentre chi frequenta la sinagoga ne è incapace. Qui si può ben vedere la grande ostilità tra gli ebrei di origine galilaica (influenzati dal movimento zelota9) e quelli che seguivano le direttive e le tradizioni della cultura giudaica. Nel racconto marciano Gesù si presenta subito come un soggetto speciale, di natura “divina”, o quasi, tant'è che il demone dell'ossesso lo qualifica con l'appellativo di “Santo di Dio” (Mc 1,24).10
Niente di tutto ciò in Luca, dove le cose appaiono molto più sfumate. Per non far vedere che ha sottomano il vangelo marciano, ambienta la scena a Nazareth (4,16 ss.), facendo capire che gli astanti della sinagoga sapessero già dell'esorcismo compiuto a Cafarnao (Carpenaum), che però nel suo vangelo avviene dopo l'espulsione dalla sinagoga (4,31 ss.). Tale sequenza dei fatti è abbastanza strana, poiché, se li avesse invertiti di posto, il tutto sarebbe stato più coerente.
La descrizione della scena nella sinagoga non presenta alcunché di magico, anzi, rispecchia quanto in genere accadeva in quei luoghi: apertura intenzionale di una pagina delle Scritture e commento personale. Se i rabbini permettono di fare questa cosa a Gesù, significa che lo reputavano un apprezzato intellettuale.
Il testo scelto è quello di Isaia (61,1-2a)11, il più grande profeta anticotestamentario. E Gesù sembra aver scelto un brano con cui può spiegare ciò che vuol fare nel suo presente, per indicare una certa continuità col passato. A dir il vero il brano originario di Isaia appare più denso di contenuto e meno mistico di quello riportato da Luca. Infatti si parla di “liberare gli schiavi” e non soltanto di “scarcerare i prigionieri” o, genericamente, di “rimettere in libertà gli oppressi”; inoltre non si fa cenno al miracolo di “ridare la vista ai ciechi”.
La pericope non è facilmente comprensibile, poiché si ha la netta impressione che Luca si riferisca a un evento precedente, che se davvero è quello dell'ossesso esorcizzato all'interno della sinagoga di Cafarnao, stranamente Luca lo mette dopo. E comunque nel suo vangelo non vi è nulla prima di questo scontro nella sinagoga di Nazareth che giustifichi la rinomanza del Cristo.
Curiosamente i rabbini lo definiscono “medico”, e siccome si parla di Cafarnao, vien facile pensare che l'autore si stia riferendo proprio al racconto in cui, nei panni di un dottore, aveva guarito un malato di mente (definito “posseduto”, nel racconto).12
Qui però l'intervento di Gesù si fa subito critico verso l'atteggiamento degli astanti. Il commento dato ai passi di Isaia è brevissimo: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura” (4,21). In che senso però non viene detto. Gesù preferisce subito polemizzare col proprio interlocutore. Ciò è poco spiegabile, in quanto Luca, poco più sopra, aveva appena scritto che quando insegnava nelle loro sinagoghe era “glorificato da tutti” (4,15).
Questo strano modo di fare, da parte dell'autore, forse si può spiegare dicendo ch'egli doveva sapere del dissidio che vi era stato tra Gesù e i suoi compatrioti giudaici, ma siccome ha voluto ambientare quasi tutta la sua attività in Galilea (condizionato, in questo, dal vangelo di Marco), ha deciso di trasferire qui quel dissidio, circoscrivendolo alle due città di Nazareth e Cafarnao. E cosa fa dire a Gesù contro i rabbini di Nazareth? Che “Nessun profeta è ben accetto nella sua patria” (v. 24).
In altre parole Gesù aveva preferito agire anzitutto a Cafarnao (in questo vangelo però la cosa accade successivamente), proprio perché si sentiva ostacolato a Nazareth, ove appunto era ritornato dopo che non si poteva più evitare di credere ch'egli fosse divenuto molto popolare. E qui non solo fa sue le parole di Isaia, per le quali aspira a diventare “Unto del Signore”, cioè messia politico-religioso, ma si identifica anche con i profeti Elia ed Eliseo, lasciando chiaramente intendere che il messaggio di Isaia non lo realizzerà con l'aiuto dei rabbini o del clero, ma per conto proprio, con chi egli vorrà scegliere (i profeti erano personaggi non istituzionali, non in linea coi poteri dominanti). Non sembra trattarsi quindi di un semplice invito alla conversione, come appariva nel Battista.
Luca non spiega assolutamente il motivo per cui la tensione fra Gesù e i rabbini fosse così acuta sin dall'inizio della sua predicazione. Si limita semplicemente a dire che, “udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori della città, e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò” (vv. 28-30). Incredibile un livore così acceso agli inizi della sua carriera, un odio così mortale nei confronti di un loro compatriota e correligionario, che, da come trattava le Scritture, non appariva certo uno sprovveduto.
C'è chi ha visto in questa pericope una sorta di “vangelo nel vangelo”, in quanto vi è condensata, in maniera paradigmatica, tutta quanta l'esperienza messianica del Cristo e dei suoi discepoli: offerta del vangelo ai Giudei, iniziale accettazione, rifiuto radicale, interlocuzione col mondo pagano. Se è così, si tratta di una ricostruzione dei fatti del tutto fantastica. Non meno peraltro di quella delineata nel vangelo di Marco, dove Gesù vorrebbe compiere dei miracoli, ma non può farlo per mancanza della fede, mentre qui i nazareni che credono nelle sue parole li vorrebbero, ma lui si rifiuta di farli.
Subito dopo Luca inserisce il racconto di Cafarnao, preso dal vangelo di Marco, sbagliando – come si è detto – la scansione temporale. Evidentemente egli doveva rendere conto di una tradizione già consolidata (quella petro-paolina espressa nel vangelo marciano), anche se, di tanto in tanto, si serviva di altre fonti.
Praticamente dal racconto della sinagoga di Cafarnao alla guarigione della suocera di Pietro, alla missione in Galilea, alle guarigioni del lebbroso e del paralitico, alla chiamata dei primi discepoli, con tanto di pesca miracolosa, alla chiamata di Levi, alla questione del digiuno e del sabato, alla guarigione dell'uomo dalla mano paralizzata, alla scelta dei Dodici apostoli, è come se si leggesse un testo più o meno copiato dal vangelo di Marco, in cui pochi elementi vengono modificati, anche se stranamente, mentre sui primi undici nomi degli apostoli le versioni di Matteo e Luca concordano, sul dodicesimo Matteo dice che si chiamava Taddeo, Luca invece che si chiamava Giuda di Giacomo.13
Singolare che nell'elenco dei Dodici Luca dica che Simone (normalmente detto “il Cananeo”) era uno zelota. Evidentemente, quando iniziò a scrivere il suo vangelo, quell'appellativo non voleva dire più nulla ai cristiani, men che meno a quelli di origine pagana, cui egli si rivolge. Marco invece si è guardato bene dal farlo, anche perché, molto probabilmente, lo stesso Pietro aveva militato in quel movimento.14 Nei Dodici comunque confluiscono gli scontenti degli altri partiti o movimenti (essenico, farisaico, zelota...).
(torna su)3) Il discorso sulla Montagna
Qualcosa di diverso, rispetto al vangelo di Marco, avviene col discorso di Gesù sulla montagna (6,17 ss.), che nel primo vangelo, pur scritto in maniera organica, non c'è, e che sembra essere sostituito da una serie di parabole slegate tra loro.
A Luca invece pare abbastanza naturale inserirlo a questo punto, in quanto il suo Cristo vuole essere un predicatore politico-religioso, e non soltanto religioso, come in Marco, dove il Cristo si cimenta anche in una notevole quantità di guarigioni e di prodigi di varia natura.
Anche da questo si vede benissimo che i due vangeli sono stati scritti in momenti molto diversi tra loro, al punto che vien da pensare che Luca abbia mentito quando, nel suo prologo, sostiene d'essersi “accuratamente informato di ogni cosa dall'origine” (1,33).
Peraltro, lo stesso Luca afferma che, prima del suo, erano stati scritti “molti” racconti sul Cristo, da parte di “testimoni oculari” (1,2). Ma a quali testi o a quali autori si riferisca non è dato sapere, anche perché dà l'impressione di non aver mai letto o potuto leggere il vangelo di Giovanni. Non restano quindi che i testi apocrifi, sulla cui attendibilità storica, però, è difficile scommettere.
Vediamo ora il discorso sulla montagna di Galilea (Tabor). Un discorso del genere, rivolto a “una gran folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme e della costa di Tiro e Sidone” (6,17), neppure nel vangelo di Matteo è presente, dove infatti l'autore fa parlare Gesù solo agli apostoli.
Sembra che qui Luca non sappia quel che dica o comunque non sappia giustificare le sue affermazioni. In quel momento Gesù era in Galilea, sul monte Tabor, e aveva svolto la sua missione prevalentemente in questa regione, per quanto l'autore dica che “andava predicando anche nelle sinagoghe della Giudea” (4,44). Com'è possibile un afflusso così straordinario di persone provenienti da territori non galilaici? Persino da Tiro e Sidone vengono a sentirlo, quando Matteo (10,5), nel discorso rivolto ai Dodici, intima di non andare tra i pagani e di non frequentare assolutamente i Samaritani, che pur erano ebrei come gli altri e che avevano riservato al Cristo un'accoglienza festosa l'indomani della cosiddetta “epurazione del Tempio”.
In sostanza si ha l'impressione che nel vangelo di Luca il discorso sul monte Tabor sia stato un evento molto importante, preparato a tempo debito, e che doveva apparire come una sorta di manifesto programmatico, in cui veniva delineata la strategia generale per realizzare il “regno di Dio”.
Naturalmente anche Luca deve fare molte concessioni allo stereotipo marciano che vede nel Cristo un grande taumaturgo, disposto a compiere guarigioni d'ogni tipo, ma nel complesso il discorso merita d'esser preso in considerazione.
Esso sembra essere diviso in quattro parti ben distinte: la prima (vv. 20-26) è una filippica contro i ricchi e una consolazione a favore dei poveri; la seconda (vv. 27-38) si presenta come una metodologia a favore dei poveri, che però è piena di rassegnazione; la terza (vv. 39-45) è un rimprovero nei confronti dei discepoli più intellettuali, più impegnati, che perdono tempo a giudicarsi a vicenda, a gareggiare su chi tra loro è il più autorevole, mentre dovrebbero limitarsi a guardare e praticare le buone opere; l'ultima (vv. 46-49) è un invito a tutti a essere coerenti, mettendo in pratica quanto ascoltano da lui. A questo discorso, nel suo vangelo, non seguirà alcuna iniziativa concreta; non viene neppure detto che li congedò.
La pochezza “politica” di tale discorso sta nel fatto che mentre all'inizio sembra che Gesù voglia far capire ai poveri che la loro sofferenza sta per finire; nel prosieguo invece vi è una grande disillusione: infatti devono amare i loro nemici, fare il bene a quelli che li odiano, benedire quelli che li maledicono, pregare per quelli che li oltraggiano, porgere l'altra guancia a chi li percuote, cedere anche la tunica a chi porta via loro il mantello, dare a chiunque chiede, senza richiedergli nulla, e così via.
Questo non è un messaggio politico ma etico. Ed è impensabile credere che migliaia di persone, sofferenti, abusate, vittime di ingiustizie e soprusi d'ogni genere si fossero spostate di non pochi chilometri per sentirsi dire parole così rinunciatarie, come se si fosse proclamata beata la stessa povertà! È impossibile non pensare che Luca abbia scritto un testo che non corrispondeva affatto alla realtà (se non forse nella prima parte) e che Gesù deve per forza aver detto a quella folla di tenersi pronta a una insurrezione armata. Cioè anche ammettendo che Gesù abbia esposto tutti quei precetti etici, essi potevano avere un valore effettivo solo se in prospettiva ci fosse davvero stata una rivoluzione, altrimenti apparivano facilmente come una presa in giro. Quelli infatti sono precetti che, in una prospettiva eversiva, possono soltanto invitare alla pazienza, certamente non alla rassegnazione; possono suggerire un comportamento prudente, non estremistico o non individualistico, ma solo perché la strategia generale, cioè l'obiettivo finale è quello di una sommossa popolare con cui liberarsi degli occupanti stranieri e dei collaborazionisti interni.
A questo discorso, quindi, manca la parte finale, quella che avrebbe giustificato tutto il resto. Non a caso nel quarto vangelo, quando Gesù fa un discorso analogo ai Galilei, alla fine pretendono ch'egli diventi re e che vada a Gerusalemme a fare la rivoluzione. Viceversa, Luca fa seguire a questo discorso la guarigione del servo del centurione romano (7,1 ss.), lasciando così credere che l'insurrezione non era indispensabile, in quanto anche tra i Romani si potevano trovare persone dabbene, giuste, che nutrivano sentimenti compassionevoli per i loro schiavi, che amavano Israele e che costruivano sinagoghe per gli ebrei. Nei suoi confronti Gesù arriva persino a dire che “neppure in Israele ho trovato una così gran fede” (7,9). Dunque che senso avrebbe avuto liberarsi dei Romani? Al massimo ci si doveva liberare del peso delle autorità giudaiche o delle loro tradizioni obsolete, dei loro precetti veterotestamentari.
(torna su)3.1) Dopo il discorso
Giovanni Battista, saputo ciò che Gesù aveva detto sul Tabor, invia alcuni suoi discepoli per sapere che cosa egli ha intenzione di fare in Giudea. Ma lui risponde soltanto una cosa, piuttosto astratta: “Il vangelo è annunciato ai poveri” (7,23). Poi Luca gli fa fare una serie di guarigioni miracolose, al fine di dare sostanza a ciò che ha appena detto, dimostrando così d'essere superiore al Precursore, che non aveva mai fatto alcun prodigio. Dopodiché Gesù congeda quella delegazione, mettendosi a parlare dei meriti di Giovanni alla folla lì presente; e se la prende soprattutto con gli scribi e i farisei che non si fecero battezzare nel Giordano. Tutto qui.
Gesù è convinto che, come non hanno ascoltato Giovanni, non ascolteranno neppure lui. Uno dei farisei però, un certo Simone, rimasto colpito dalle sue parole, lo invita a casa sua. E qui succede qualcosa che ha davvero poco senso. Una prostituta, conosciuta da Simone, entra nella sua casa, perché aveva saputo che vi era Gesù. Appena lo vede, gli bagna i piedi con le lacrime, glieli bacia e glieli profuma con un prezioso olio contenuto in un vaso di alabastro.
A motivo del mestiere della donna, Simone si scandalizza, ma non dice nulla a Gesù, il quale però è in grado di intuire il suo pensiero, poiché anche lui sa che è una prostituta (la quale, stranamente, compie lo stesso gesto della sorella di Lazzaro, a Betania, in tutt'altro contesto e senza alcun riferimento alla prostituzione).
Insomma, alla fine Gesù elogia la donna per aver fatto delle cose che, in genere, solo i servi fanno; e poi, mettendola a confronto con Simone, che si è limitato soltanto a invitarlo a pranzo, gli fa capire chiaramente che preferisce la donna, per cui, anche se essa viene considerata una pubblica peccatrice, lui la perdona di tutti i peccati, ritenendola alla pari di tutti gli altri. Al che alcuni invitati mormorano tra loro dicendo: “Chi è costui che perdona anche i peccati?” (7,49). Infatti, secondo la teologia dominante solo Dio può farlo.
In sé, cioè per come le cose sono state descritte, il racconto appare inverosimile, però qui si può intravedere una traccia di quell'ateismo etico che ha sempre caratterizzato la predicazione del Cristo, per quanto Luca si guardi bene dall'approfondirlo.
Tale racconto è servito al redattore anche per far vedere che le donne hanno avuto un ruolo molto importante nella formazione del movimento nazareno (o gesuano): questa è una specificità del suo vangelo. Infatti, tra le seguaci del movimento egli cita Maria Maddalena (ex-indemoniata!), Giovanna, moglie di Cuza, l'amministratore di quell'Erode Antipa che fu uno dei nemici principali di Gesù in Galilea, Susanna (di cui nulla si sa) “e molte altre che assistevano Gesù e i suoi [apostoli] con i loro beni” (8,2 s.).
Quando parla di un'altra donna importante, la madre di Gesù, evita i toni sprezzanti di Marco, il quale aveva mostrato che i parenti di Gesù, almeno inizialmente, erano contrari alla sua predicazione. Luca è più sfumato, anche perché ha parlato fin troppo bene di Maria nell'esordio del suo vangelo, per cui qui si limita semplicemente a dire che, più importanti dei suoi parenti, sono i suoi discepoli (8,21).15
Il fatto che Luca avesse una conoscenza così specifica di Maria può anche far pensare che la tradizione lucana abbia avuto un contatto con quella giovannea. Lo dimostra l'inserimento nel IV vangelo di alcune pericopi di chiara impronta lucana: l'adultera, le nozze di Cana, la guarigione del figlio di Cuza e persino il timore superstizioso che Pilato fa mostra d'avere nei confronti di Gesù quando viene a sapere che si era dichiarato “figlio di Dio” (Gv 19,8 ss.).
(torna su)4) L'impotenza di Gesù e i limiti di Luca
L'uso delle parabole, la tempesta sedata, la guarigione del Geraseno, dell'emorroissa, il ridestamento della figlia di Giairo, la missione dei Dodici, quello che Erode Antipa pensa di Gesù – son tutte cose che Luca prende dal vangelo di Marco, a testimonianza che di tutte le fonti di cui egli si è avvalso, è questa la più importante.
Stranamente non ha riportato il racconto dell'esecuzione del Battista, pur avendo fatto lodi sperticate ai genitori di Giovanni nel prologo del suo vangelo: il che fa pensare che Luca fosse piuttosto riluttante ad accettare, nel suo vangelo, racconti troppo truci o sensuali.
Al pari di Marco, invece, deforma completamente il senso della cosiddetta “moltiplicazione dei pani”, trasformando quello che dovette essere un evento politico (intuibile solo nel quarto vangelo) in un qualcosa di assolutamente mistico. Si può dire che questo episodio, così cruciale per la missione di Gesù in Galilea (al punto che, proprio a causa del suo rifiuto di diventare re, moltissimi Galilei smisero di seguirlo), non fu capito per nulla da Luca. Questo perché egli è prono completamente alla teologia petro-paolina. Lo si vede bene anche dalla decisione di accettare i tre annunci della passione.
Il suo Cristo è destinato a morire. Di diverso, rispetto a Marco, si può forse dire che la croce non rientra tanto nell'insondabile prescienza divina, quanto, più semplicemente, nel fatto che uno come Gesù non poteva che essere eliminato da una cultura che voleva restare tenacemente legata al proprio passato.
Da Luca Gesù viene semplicemente paragonato al Battista (dal quale si differenzia soltanto per i prodigi che sa compiere), nonché a tutti i profeti dell'Antico Testamento, che di regola venivano eliminati dai vari potenti di turno. Il Gesù di Luca non può realizzare il regno di Dio semplicemente perché le autorità religiose glielo impediscono: “anziani, capi dei sacerdoti, scribi...” (9,22). Non c'è dissidio nei confronti dei Romani.
Non è però solo questione di autorità religiose. Luca sottolinea che anche i Samaritani sono ostili ai Dodici, poiché vedono che essi hanno rapporti più coi Giudei che non con loro; anche città come Corazin, Betsaida, Cafarnao..., per l'atteggiamento che hanno, Gesù le considera inferiori alle fenice Tiro e Sidone. Di origine pagana, Luca ci tiene a sottolinearlo: non ama fare questioni di tipo teologico. D'altra parte di professione faceva il medico. In Gesù aveva visto un “sant'uomo”, poco compreso dai suoi discepoli e ingiustamente ucciso dai suoi nemici e, per questo, meritevole d'essere considerato “figlio di Dio”.
Il vero credente, per lui, è il buon samaritano (10,25 ss.), una splendida parabola in cui l'etica, ad essa sottesa, presume di porsi a livello universale, superando tutte le distinzioni socio-culturali o etnico-religiose. In questo il vangelo lucano rappresenta la prosecuzione convincente di quello marciano, in quanto i suoi lettori non hanno più alcun interesse per le vicende della Palestina e non amano speculare troppo sul piano teologico: sono cristiani di origine gentile, sufficientemente benestanti per non desiderare alcun rivolgimento politico, aperti alla diversità, formalmente democratici sul piano politico ed egualitari nel rapporto di genere.
Luca dà spesso l'impressione di provenire da un mondo dominato da egoismi di tipo economico, che rendono molto difficile la vivibilità dell'etica. In sostanza vuol far capire che se tutti seguissero l'esempio del buon samaritano, sarebbero più contemplativi come Maria, sorella di Marta, sarebbero più generosi e altruistici nei confronti del prossimo, chiederebbero a Dio di avere soltanto il pane quotidiano e di essere perdonati dei loro peccati, coltiverebbero il senso dell'amicizia tra pari e dell'amore per i figli. Questa l'etica umanistica, a sfondo religioso, priva di valenza politica eversiva, di Luca.
Il suo Gesù faceva sì “politica”, ma solo per insegnare il comandamento dell'amore universale, associato a una concezione spiritualizzata di Dio, priva di riferimenti nazionalistici o etnico-tribali. Il suo Gesù è costantemente alle prese con una “generazione malvagia”, che non lo ascolta o non vuole comprenderlo o non vuole mettere in pratica i suoi insegnamenti, e che contro di lui proferisce falsità, o che, al contrario, per potergli credere, chiede che faccia cose assolutamente straordinarie.
È curioso come in Luca, ogniqualvolta Gesù parla di etica umanistica, vi sia un fariseo che lo inviti a casa propria (11,37 ss.). Ciò probabilmente sta a dimostrare che il suo rapporto con i farisei era più stretto di quel che non appaia negli altri vangeli16, a meno che Luca non abbia usato questa categoria di persone in maniera simbolica, per indicare il significato dell'ipocrisia.
Nel racconto precedente, infatti, il fariseo Simone si era meravigliato che Gesù accettasse di farsi baciare i piedi da una prostituta; ora invece questo fariseo si meraviglia che non faccia le abluzioni prima di pranzare. I farisei lo conoscono come un anti-conformista, un anti-tradizionalista e si stupiscono quando lui dimostra di esserlo troppo. D'altra parte il Gesù di Luca è avverso a tutto il giudaismo, che viene accusato d'aver fatto fuori tutti i profeti più significativi del popolo ebraico, “da Abele a Zaccaria” (11,51). Ce l'ha con l'intera generazione ebraica del suo tempo. Gli unici che risparmia (e non in maniera assoluta) sono i suoi più stretti collaboratori.
L'odio delle autorità giudaiche verso di lui non è che una conseguenza della più generale avversione che nei suoi confronti nutrivano gli scribi e i farisei. Indubbiamente in tale contesto l'immagine che Luca dà degli scribi e dei farisei è quella di essere dei teologi e dottori della legge alquanto ipocriti, dei quali non ci si può assolutamente fidare. E la causa ultima di tale atteggiamento la fa risalire all'egoismo, all'avarizia, alla cupidigia. Si è falsi proprio perché si vogliono nascondere degli interessi privati di natura economica.
Luca ha poco sentore delle questioni più propriamente ideologiche. Non ha una consapevolezza storica del ruolo della Giudea nel proprio rapporto con l'invasore romano. I difetti che vede, del giudaismo, sono di natura individuale o di ceto o di casta. Non ha la capacità di vedere degli aspetti positivi: quando questi vi sono, nell'insieme del suo vangelo, appartengono a persone di origini umili o provenienti dal paganesimo, oppure ai grandi profeti veterotestamentari.
D'altra parte per lui il problema dell'avarizia o la necessità di accumulare risorse oltre le proprie esigenze, non riguarda solo il mondo ebraico, ma anche quello pagano. Lo dice chiaramente nella parabola del “ricco stolto” (12,13 ss.) e nelle istruzioni che Gesù dà ai propri discepoli, che sono del tutto di carattere generale, utilizzabili anche da un seguace del buddismo (12,22 ss.).
Tutta la sua filosofia di vita è sostanzialmente di natura etica, in cui gli aspetti religiosi fanno da cornice. Quando Luca esamina i rapporti di classe, quelli tra padrone e servo, dice delle cose che avrebbe potuto dire un qualunque filosofo stoico o epicureo. La regola generale, relativamente a tali rapporti, è la sottomissione, umile e paziente, da parte del servo, ma anche la gratitudine e il riconoscimento del merito da parte del padrone. Per convincersene è sufficiente leggersi la parabola dei due servitori (12,41 ss.), dove il padrone, se vedrà che il suo servo, mentre lui era assente, gli sarà rimasto fedele, al suo ritorno lo farà diventare amministratore generale della tenuta.
Come si può ben notare questa, di Luca, è una filosofia politica moralistica, che non mette in discussione i rapporti economici di proprietà, di sfruttamento. Il servo, infatti, se anche diventerà amministratore generale, sarà sempre un salariato. È del tutto inutile, quindi, dire, da parte di Luca, che Cristo è “causa di divisione”: “Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione” (12,51). La “divisione” di cui parla Luca non serve affatto a risolvere i conflitti sociali; non è la richiesta da parte di un leader che vuole preventivamente capire chi sono i suoi alleati, al fine di poter compiere una rivoluzione. Tant'è che quando egli fa riferimento al conflitto sociale tra un creditore e un debitore (12,58 s.), prospetta soltanto di mettersi d'accordo prima di arrivare in tribunale, poiché, in caso contrario, il debitore perderà di sicuro, e giustamente.
Questo significa che per Luca soltanto l'etica può risolvere i problemi sociali, non la politica. Gesù viene visto come un profeta che ha sacrificato la propria vita per affermare un'etica-religiosa più radicale delle precedenti. Luca, col suo vangelo, presumeva d'aver posto le basi per un superamento pacifico, lento, ma progressivo di tutte le filosofie pagane di orientamento stoico ed epicureo.
Ha trasformato Gesù in un novello Socrate, facendo ampie concessioni agli aspetti mistici che la tradizione petro-paolina gli aveva già riservato in precedenza. D'altra parte Luca non vuol dare al suo vangelo un contenuto eversivo. Quando fa capire che l'etica-religiosa di Gesù voleva essere fortemente innovativa, sta soltanto illudendo i suoi lettori. È facile far passare un martire (del sistema o dei poteri dominanti) come una persona assolutamente rivoluzionaria (quanto meno nell'atteggiamento personale, nella nuova mentalità che i suoi adepti dovevano dimostrare di possedere).
All'inizio del cap. 13 egli parla di alcuni Galilei (presumibilmente zeloti recatisi a Gerusalemme17) fatti fuori da Pilato, e spiega l'accaduto in modo a dir poco sconcertante. Da un lato, infatti, dice – giustamente – che non si può associare quell'esecuzione a una colpa effettiva dei Galilei18; dall'altro però sostiene che se gli ebrei non si ravvedono, non si pentono dei loro peccati, faranno tutti la stessa fine (sic!). Il che, in altre parole, voleva dire che, prima di una lotta armata contro un potente nemico, per il quale si soffre ingiustamente, occorre pensare a se stessi, alla propria integrità morale, alla propria irreprensibilità. Ora, se questa non è una filosofia politica conservatrice, che cos'è?
Può essere considerato politicamente progressista il Gesù di Luca solo perché il capo della sinagoga si oppone alle guarigioni compiute di sabato (13,14)? O solo perché Erode vuol vederlo morto (13,31)? O perché ha il coraggio di dire che Gerusalemme lapida tutti i suoi profeti (13,34)? Esattamente come gli altri evangelisti, Luca non può rinunciare all'antisemitismo che li caratterizza, per cui, ad un certo punto, è costretto a dire che il regno di Dio sarà realizzato da cristiani di origine pagana, provenienti da qualunque parte della Terra (13,29). Egli non riesce assolutamente a capire che la predicazione del Cristo, avendo un contenuto politico-rivoluzionario, non poteva non suscitare un odio feroce sia da parte dei partiti ebraici collusi col nemico o fortemente legati a tradizioni divenute obsolete e del tutto inutili ai fini della liberazione nazionale, che da parte delle stesse forze di occupazione romana, le quali, infatti, per farlo fuori, collaborarono ampiamente con i sommi sacerdoti, i sadducei, gli anziani, molti scribi e non pochi farisei, cioè con la stragrande maggioranza del Sinedrio.
Luca è ostile al potere politico, ma lo è solo sul piano etico: di qui le sue astrattezze, i suoi moralismi, le sue esagerazioni... Lo si vede anche quando, parlando dei pranzi presso qualcuno, suggerisce di mettersi all'ultimo posto, affinché sia il padrone di casa a chiederci di prendere un posto migliore (14,7 ss.). Oppure, quando a invitare qualcuno siamo noi stessi, ci chiede di scegliere chi non potrà ricambiare: poveri, storpi, zoppi e ciechi, così si verrà ripagati nel giorno del giudizio (14,12 ss.).
Luca non ama le relazioni di parentela: lo dice più volte; quando parla di “divisioni sociali”, intende più che altro riferirsi a quelle interne a una famiglia, a un parentado (14,26; 12,52 ss.). E dice espressamente che non è indispensabile usare le relazioni di parentela per costruire il regno di Dio. La sequela al Cristo è moralmente molto esigente, per cui va fatta per esclusive ragioni di coscienza. Paradossalmente sarebbe meglio frequentare la feccia della società (pubblicani, peccatori, reietti d'ogni genere), piuttosto che parenti o intellettuali che si vantano di avere la verità in tasca (15,1 ss.).
Se si guarda al modo in cui Luca tratta i rapporti di famiglia, la parabola del figliol prodigo (15,11 ss.) è emblematica. Per dimostrare che l'etica è superiore a qualunque altra cosa, a Luca basta un piccolo gesto (nella fattispecie il pentimento del figlio dissoluto e dissipatore) per ribaltare la convenzionalità dei rapporti tradizionali tra padri e figli, cioè la modalità standard di una relazione autorevole, che l'altro figlio aveva costantemente rispettato e per la quale non era mai stato premiato. A Luca preme mettere in risalto l'eccezionalità del gesto (in questo caso il perdono di un padre, il quale, in un contesto di normalità, sarebbe apparso quanto meno ingenuo, buonista, troppo indulgente). Non è da escludere che in questa parabola Luca abbia voluto criticare quei padri ebrei troppo attaccati al denaro e che non avrebbero mai accettato di riconciliarsi con un figlio pentito, proprio perché questi, dopo aver chiesto in anticipo la propria parte di eredità, l'aveva sperperata tutta.
Anche l'altra parabola dell'amministratore infedele (16,1 ss.) è peculiare di Luca, non essendo stata presa dal vangelo di Marco. Possiede una morale che non senza fatica potrebbe essere definita “cristiana”. Un fattore, accusato dal suo padrone di scialacquare i suoi beni, rischia il licenziamento se non giustificherà tutte le spese. Senonché quello convoca tutti i debitori del padrone e condona, di nascosto, una parte del loro debito, sperando che, nel caso venga licenziato, lo vorranno in qualche modo aiutare. Naturalmente il padrone lo scopre, ma, invece di punirlo, lo elogia per la sua avvedutezza!
Dove sta la morale in questa parabola? Da nessuna parte. Semplicemente Luca ha voluto mettere a confronto l'atteggiamento dei pagani con quello che dovrebbero avere i cristiani, ovviamente su un altro versante. Quale? Luca in pratica fa questo ragionamento: se un padrone di religione pagana arriva a complimentarsi per l'astuzia dimostrata, sul piano economico, da un proprio dipendente, il quale però l'ha usata contro lo stesso padrone (ma di questa “inezia” Luca non si preoccupa), a maggior ragione dovrebbero essere avveduti i “figli della luce”, dimostrando d'essere pronti ad aiutarsi con tutto ciò che le circostanze mettono loro a disposizione, in attesa di poter dare il meglio di sé quando esse saranno più favorevoli (ed eticamente irreprensibili). Dunque, “fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste; perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne” (16,9).
Singolare che in Luca, che è un autore moralista per definizione, si trovi un passo del genere. Sembra quasi impossibile non interpretare la parabola secondo lo standard del cinismo o dell'opportunismo. Eppure il ragionamento, per uno che ha rinunciato a priori a cambiare il sistema, non è sbagliato. Farsi degli amici con le ricchezze ingiuste altro non significa che uscire dal proprio isolamento, dal proprio individualismo, sfruttando al meglio, per quello che sono, le condizioni in cui si vive, senza metterle in discussione, poiché ci sono date dal destino (un cristiano direbbe: “da Dio per metterci alla prova”). Luca è convinto che le contraddizioni antagonistiche del sistema siano un peso inevitabile da sopportare. L'importante è che, in tale passività, non si perda il senso del proprio valore, della propria diversità, della propria umanità.
Ciò che più importa, infatti, è essere convinti che, prima o poi, la situazione cambierà, e quando ciò avverrà, se saremo stati onesti con noi stessi, soffrendo il peso delle antinomie indipendenti dalla nostra volontà, raccoglieremo i frutti meritati. Questo perché la morale è un fatto tutto interiore, che esteriormente può esprimersi in varie forme, a seconda delle situazioni. È forse questa una forma di incoerenza? di ipocrisia? No, perché se il soggetto è materialmente debole, è povero, e privo di mezzi sufficienti per essere pienamente coerente, la sua ambiguità nell'agire concreto non gli potrà essere addebitata come una colpa. Luca non sta dicendo al cristiano privo di mezzi materiali che può lasciarsi determinare completamente dalle circostanze, ovvero che, in condizioni di gravi difficoltà non può essere considerato responsabile di alcunché. Gli sta invece chiedendo di conservarsi puro nelle intenzioni, anche se nella pratica non potrà esserlo; e di essere soprattutto convinto che prima o poi le circostanze cambieranno. Infatti, “chi è fedele nelle cose minime, è fedele anche nelle grandi” (16,10). “Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste” [cioè se non siete stati onesti, puri di cuore, pur essendo condizionati dalla negatività della vita], “chi vi affiderà quelle vere?” (16,11).
Detto altrimenti, come si potrà essere riconosciuti nel proprio valore, quando quelle antinomie non esisteranno più, se, quando c'erano, non si è stati capaci di sopportarle con dignità? “Se non siete stati fedeli [con voi stessi] nei beni altrui [nella gestione di beni che non vi appartenevano e che a voi apparivano ingiusti], chi vi darà i vostri?” (16,12), cioè dove troverete qualcuno, quando i tempi saranno cambiati, che si fiderà della vostra moralità? Non è possibile aspettare la fine dei tempi prima di scegliere tra “Dio e Mammona” (16,13).19 Se nella società dominano le ricchezze, in coscienza deve dominare la fede.
Ecco, questa è la concezione stoica della vita che ha il moralista Luca. Ed è sulla base di questa concezione ch'egli può tranquillamente condannare il comportamento dei farisei, i quali non vivono – secondo lui – le contraddizioni del loro tempo con un senso di fastidio. “I farisei amavano il denaro... e si beffavano di Gesù” (16,14). Si erano adeguati all'andazzo dei tempi, pur proclamandosi apertamente giusti e onesti “davanti agli uomini” (16,15).20
Ora, poiché “Dio conosce i cuori degli uomini”, a partire dal Cristo non è più possibile entrare nel “regno di Dio”, se non facendo violenza a se stessi (16,16). Tutto è diventato più impegnativo, più maledettamente esigente, proprio perché ciò che è in gioco è la coscienza.
Luca è così moralista che anche quando parla di divorzio, lo esclude in qualsiasi caso, cioè anche nel caso di concubinato, di cui parla Mt 5,32. Per lui il matrimonio è come lo vogliono oggi i membri del clero cattolico-romano: assolutamente indissolubile.
Altra parabola tipicamente lucana è quella di Lazzaro21 e del ricco epulone, priva di riscontri negli altri vangeli.22 Perché è tipica di lui? Lo si capisce dall'ultimo versetto: “Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti resuscita” (16,31).
Anche prescindendo dal tono vagamente antisemitico del testo, in quanto viene avvalorata l'identificazione di ebreo e ricco egoista, resta il fatto che solo un moralista può ritenere irrecuperabile una persona agiata. Chi pensa che tutto dipenda dall'etica (e non anche dalla politica), tende inevitabilmente a irrigidirsi quando vede che le cose non migliorano. Ci si sforza d'essere virtuosi e si diventa eccessivamente severi con chi non ci imita. E questo senza capire che la morale è perlopiù determinata dalla posizione di classe che si ha nei rapporti sociali di proprietà, al punto che, una volta mutati questi, facilmente muta anche quella; e se non muta, si può sempre ricorrere all'apporto rieducativo da parte di chi ha contribuito a mutare il sistema.
La spiegazione della parabola viene fatta da Luca nei versetti successivi alla pericope, anche se non in maniera esplicita, là dove parla del perdono. Cioè mentre nella parabola il perdono è escluso, o comunque è escluso che si possano concedere “sconti morali” per l'aldilà a chi sulla Terra si è comportato come un perfetto egoista; nella spiegazione invece viene detto che se uno chiede perdono di quello che ha fatto, va sempre perdonato. Moralista, Luca, era prima, nei panni di un Catone il censore; e moralista resta adesso, quando scrive: “Se ha peccato contro di te sette volte al giorno, e sette volte è tornato e ti dice: Mi pento, perdonalo” (17,4).
Certo, uno può pensare che Luca voglia difendere a spada tratta i cristiani, che tra di loro si devono considerare “fratelli” (v. 3), dimostrando così d'essere migliori degli ebrei, da lui qualificati come “egoisti”. In realtà è la frase in sé che sa di moralismo, in quanto, piuttosto che affrontare alla radice il problema (e ciò non può essere fatto con la sola etica), ci si limita, per così dire, a chiudere un occhio. Questo è un limite caratteristico di tutte quelle posizioni sociali che sganciano la morale dalla politica. Alla fine la loro morale rischia di diventare convenzionale, pura forma senza sostanza. Anzi si rischia addirittura di cadere in soluzioni estreme. Infatti se il fedele, da un lato, deve essere sempre disposto a perdonare; dall'altro però Luca arriva ad affermare: “Sarebbe meglio per lui [per chi provoca scandali, quelli che turbano la coscienza dei puri] che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare” (17,2).
Di fronte a determinate colpe morali, Luca (o comunque l'autore di questo vangelo) non esclude la necessità della pena di morte, a meno che non si voglia interpretare queste sue parole come una forma d'induzione al suicidio, che il colpevole, se avesse un minimo di coscienza, dovrebbe prendere in seria considerazione. La comunità cristiana, infatti, ha la pretesa di affermare un'etica superiore a quella ebraica e pagana, per cui non può tollerare cedimenti in questo campo.
D'altra parte – prosegue Luca, identificandosi con Gesù – “Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: Sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe” (17,6). Cioè per essere eticamente perfetti non ci vuole una personalità eccezionale. Quindi non ci si può meravigliare che il moralista sia costretto a perdonare sette volte al giorno lo stesso colpevole, pur di conservare integra la propria comunità e, in fondo, la propria coscienza; o, nel contempo, sia costretto a invocare una sentenza capitale nei confronti di chi si comporta nella maniera più indegna possibile.
Il moralista Luca non sta chiedendo la Luna, ma solo un briciolo di fede nel valore della morale, del suo potere redentivo. Tutto sommato egli non era neppure tanto religioso: la fede, nella sua concezione di vita, era soltanto la cornice in cui la morale si muoveva. Lo dice anche in maniera abbastanza evidente là dove parla dei doveri del servitore: “Quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare” (17,10).
Questo per dire che la morale di Luca è sostanzialmente una morale pagana che rifugge dai circoli aristocratici o intellettualistici della filosofia stoica, e che non ama neppure rifugiarsi in comunità isolate come quelle epicuree. È una morale che mira ad approfondire se stessa alla luce del sacrificio di un innocente come Gesù. Non vuole essere affatto una morale eversiva, ma anzi si presenta come molto conservativa e tutta interiore, quale risulta appunto dal comportamento del servo, che non chiede d'essere valorizzato nel proprio merito. Una morale del genere la si ritrova anche in Kant, laddove parla di “dovere per il dovere”.23
D'altronde per Luca, come per Marco, Gesù diede il meglio di sé non sul piano politico, ma su quello esistenziale dell'autoimmolazione, con cui poté dimostrare al mondo intero che la sua etica era nettamente superiore a quella pagana (superficiale nelle questioni più profondamente religiose) e anche a quella ebraica, che invece sulle questioni religiose tende a fanatizzarsi.
Oltre a questo aspetto etico-esistenziale, che Luca vuole esaltare al massimo, in quanto coincidente con la morte del Cristo, come se fosse la stessa esecuzione capitale a dare definitiva conferma alla grandezza della nuova etica religiosa, un altro aspetto viene particolarmente valorizzato: la capacità che Gesù aveva di compiere straordinarie guarigioni e prodigi di varia natura. Il regno di Dio su questa Terra viene anticipato da una serie di guarigioni umanamente inspiegabili, razionalmente inconcepibili.
Il Gesù taumaturgo si serve di guarigioni prodigiose, che solo lui è in grado di fare, per obiettare ai farisei che il regno di Dio non è una promessa destinata a realizzarsi soltanto alla fine dei tempi, ma è già in mezzo a loro, in maniera molto concreta (17,20 s.). Su questo, Luca, non è molto diverso da Marco. Infatti è tipico della mentalità pagana (e quella galilaica in parte lo era) affidarsi all'elemento miracoloso quando con la propria morale non riesce a risolvere gli antagonismi sociali (tant'è che, sotto questo aspetto, non si può pensare vi sia molta differenza tra un imperatore romano che trionfa da vivo o un messia ebraico che trionfa dopo morto, entrambi considerati, dal punto di vista della superstizione popolare, autentici “figli di Dio”).
Attenzione che con il Luca moralista non si scherza. Per lui la morale è una cosa molto più seria della politica, in quanto riguarda gli individui singoli, la loro coscienza personale. E quando verrà il giorno del giudizio, Cristo saprà distinguere il vero dal falso discepolo. Apparentemente infatti si è tutti uguali, come ai tempi di Noè, prima del diluvio universale, o come ai tempi di Lot, prima che Sodoma venisse distrutta: “Si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, si prendeva moglie, si andava a marito” (17,27 s.). Quando poi, improvvisamente, il Figlio dell'uomo si manifesterà, le apparenze svaniranno, i criteri di giudizio saranno ribaltati: “Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà; ma chi la perderà, la salverà. In quella notte due saranno in un letto: l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme: l'una sarà presa e l'altra lasciata” (17,33 ss.). E così via, come in un film horror, con la differenza che non si colpirà a caso (solo gli sprovveduti lo penseranno), ma si colpirà a ragion veduta: quella di cui solo il Cristo “giustiziere” potrà esser certo.
Intimoriti al sentire queste parole apocalittiche, i discepoli si chiedono se mai potranno avere un faro con cui orientarsi. Ma lui, come un padre ultrasevero, che vuole educare i propri figli con lo strumento della paura, si limita a dire: “Dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le aquile” (17,37). Quelle aquile che, peraltro, in Palestina vedevano assai raramente, se non qualcuna sul monte Carmelo nell'alta Galilea. Ma anche questo fa parte della psicologia del terrore, il quale diventa ancora più grande quando si viene minacciati da qualcosa che non si conosce esattamente.24
In un'altra parabola – e qui bisogna dire che in Luca vi era una spregiudicatezza molto moderna – Dio viene equiparato a un giudice ateo, che “non aveva rispetto per nessuno” (18,2).25 Costui, siccome aveva a che fare con una vedova che lo importunava di continuo, perché voleva avere giustizia nei confronti di qualcuno, ad un certo punto decise di esaudirla, non per un senso di giustizia, ma proprio per non averla più tra i piedi. Ora, che c'entra Dio in tutto questo? Scrive Luca: “Dio non farà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà egli nei loro confronti?” (18,7). La domanda, ovviamente, è retorica: se un giudice ateo, seppur per vie traverse, si decide a far giustizia, figuriamoci se non la farà un giudice religioso.
Ma è il finale della parabola a lasciare allibiti. Infatti, se da un lato è stato possibile fare un confronto, seppure sui generis, tra un giudice ateo e uno religioso; dall'altro come si può farlo tra la vedova insistente e i discepoli del Cristo? La conclusione della parabola appare, nel contempo, serafica e agghiacciante: “Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?” (18,8). Luca non era certamente uno di quelli che credeva nei 144 mila eletti!
In quanto moralista, egli non salva neppure i farisei eticamente irreprensibili, quelli che non sono “rapaci, ingiusti, adulteri” (18,11); quelli che digiunano e pagano tutte le tasse. Perché non li salva? Semplicemente perché si vantano di essere giusti, onesti, autorizzati a criticare chi, per definizione, non può essere perfetto come loro, che nella parabola è rappresentato dal “pubblicano”, cioè dall'ebreo che faceva gli interessi dell'occupante romano e che nella parabola chiedeva perdono a Dio delle proprie contraddizioni.
Luca si sforza d'essere il più chiaro possibile, nei limiti della sua visione moralistica delle cose. Cerca di trovare dei parametri oggettivi a un'etica che, essendo priva di risvolti politici, resta necessariamente soggettiva. E per lui è abbastanza difficile trovarli nel mondo degli adulti, che gli sembrano irrimediabilmente corrotti, perduti. Ecco perché, ad un certo punto, è costretto ad affermare, non senza una punta d'amarezza e di disincanto, che “chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto” (18,17). Questo perché la morale più sana non è quella “civile”, bensì quella “naturale”, quella che ancora deve svilupparsi.
Con questo Luca non vuol dire che non sia possibile incontrare gente che, in tutta onestà, è intenzionata a tornare all'innocenza perduta. L'esempio del giovane ricco è eloquente: “Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?” (18,18). Luca tuttavia fa capire che non bastano le buone intenzioni. E Gesù, come un novello Socrate, è subito pronto a smontarle: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio” (18,19).26 “Accidenti Luca, che severità!”, verrebbe da dire.
Ma non stupiamoci di questo, poiché “buono” voleva dire “perfetto”, e qui Gesù non vuol far credere che una morale accettabile o apprezzabile sia possibile solo in persone molto particolari, dotate di grandi virtù. Una morale sana dovrebbe essere alla portata di chiunque, cioè anche di chi a volte può apparire egoista, crudele, cinico, ma che poi di queste sue bassezze si pente. Qui, per Gesù, solo uno è perfettamente coerente: il Padre eterno; gli altri sbagliano tutti, incluso se stesso. Ecco perché dice al giovane ricco che, per essere sufficientemente “morali”, basterebbe rispettare almeno cinque comandamenti (quelli che anche un qualunque pagano avrebbe dovuto avere nel suo codice d'onore o di vita): “Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre” (18,20).
Vengono esclusi, tra i comandamenti indispensabili per avere la vita eterna, proprio quei tre che riguardano il rapporto con Dio e che rendevano Israele un popolo unico. Non solo, ma “non frodare” (cioè “non imbrogliare”, in relazione al salario che si deve riconoscere all'operaio) non era proprio un comandamento, bensì un semplice precetto preso dal Deuteronomio (24,14). Lo stesso “onore” che si doveva attribuire ai genitori, implicava il sostentamento economico.
Il giovane rispose che tutto questo l'aveva rispettato, ma che non gli bastava. Gesù non si azzarda a dire che “essere molto ricchi” e “non rubare” e “non frodare” sono atteggiamenti abbastanza incompatibili (l'avrebbe mortificato), ma gli prospetta una soluzione molto radicale alla sua esigenza di perfezione: vendere tutto, darlo ai poveri e diventare un suo discepolo. Toccato in un nervo scoperto, il giovane se ne andò. L'unica cosa che gli mancava era in realtà la più importante di tutte.
Morale della favola? È impossibile per i ricchi essere eticamente irreprensibili. Strano che venga detto questo, poiché il giovane lo era, avendo rispettato alla lettera i cinque precetti. In realtà che cosa Gesù (alias Luca) aveva voluto dire? Semplicemente che chi ha già tutto, materialmente, non vede la realtà come chi non ha nulla. La percezione che si ha del bene è diversa: nel giovane ricco, infatti, il rischio era quello di vivere il bene in maniera formale, di metterlo in pratica senza una forte convinzione. Non a caso è bastato chiedergli di rinunciare a qualcosa che per lui era molto importante, per smontarlo subito nel proprio idealismo. I ricchi, quindi, non si salveranno finché resteranno ricchi, a prescindere dalle loro intenzioni. “È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago” (18,25).
Al che i discepoli, sconsolati, non possono che chiedergli chi si salverà. Tranquilli – risponde loro Gesù –, “quel che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio” (18,27). È già qualcosa. Se avesse detto che non è lecito pensare a un'equivalenza di “moralità” e “povertà”, li avrebbe spiazzati completamente. Eppure, se l'avesse fatto, avrebbe detto una cosa sacrosanta. Pensare di salvarsi solo perché si è poveri sarebbe una stupidaggine imperdonabile per chi vuol fare del bene anzitutto una “questione di coscienza”.
Certo, una ricchezza smodata può essere, in sé, una condizione che non facilita la salvezza morale, ma ritenere che la povertà sia un'agevolazione rischia d'essere soltanto un miraggio. Ciò però non viene detto da Gesù ai propri discepoli, i quali possono soltanto sperare, dopo aver rinunciato ai loro beni, nella divina clemenza. E, per non avvilirli, in quanto si rende conto di avere dei criteri di moralità troppo esigenti, Gesù è indotto a fare la seguente confessione ai discepoli più stretti: “Non vi è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà” (18,29 s.).
Meno male che qui non si è fatto riferimento alla sola “vita eterna”, ma anche al “presente”, altrimenti l'avrebbero abbandonato tutti. In che senso però egli intenda la frase riferita al “tempo presente” non è dato sapere. La parabola del giovane ricco non si conclude come la storia di Giobbe, che riebbe tutto dopo aver dimostrato, pur nelle sue terribili avversità, la coerenza della fede. Nel vangelo di Luca Gesù si limita a fare una semplice promessa, ancorché impegnativa, che forse si sarebbe anche potuto risparmiare, in quanto, per un vero moralista, la ricerca del bene dovrebbe soddisfare la coscienza in sé e per sé, non per i risultati materiali che si ottengono. Comportarsi bene solo per ottenere qualcosa sarebbe una contraddizione in termini, direbbe Kant: non darebbe sicurezza sulla genuinità delle proprie intenzioni. Luca però non può far questo discorso, proprio perché non vuole presentare un Cristo isolato, che si ritiene nettamente superiore a tutti gli altri. Quando si hanno dei discepoli, un minimo d'indulgenza va tollerata.
E comunque là dove è scritto che chi ha rinunciato a tutto, riceverà “cento volte tanto”, non si deve intendere quel numero sul piano quantitativo, bensì qualitativo: nel linguaggio biblico “cento” significa “benedizione”, qui contrapposta a “perdita”. E in questa benedizione è inclusa la persecuzione da parte di una società basata sul potere e sull'avere.
(torna su)5) Il ricco epulone
(Lc 16,19-31)
[19] C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente.
[20] Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe,
[21] bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe.
[22] Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
[23] Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui.
[24] Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura”.
[25] Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.
[26] Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né da voi si può arrivare fino a noi”.
[27] E quegli replicò: “Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre,
[28] perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento”.
[29] Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.
[30] E lui: “No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno”.
[31] Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi”.
I
Questa parabola è fatalista per quanto riguarda l'idea di giustizia sociale sulla Terra, ed è schematica per quanto riguarda l'idea di giustizia sociale nei Cieli.
È fatalista perché considera “ricchezza” e “povertà” come condizioni “scontate”, volute da Dio per mettere alla prova la gente: il ricco avrebbe dovuto aiutare il povero (cosa che qui non avviene), mentre il povero avrebbe dovuto rassegnarsi alla propria povertà (cosa che qui avviene).
La parabola è anche schematica, perché considera la salvezza nei Cieli e la condanna agli inferi come cosa “acquisita”, “definitiva”. Il ricco epulone non può salvarsi neppure se si pente e Lazzaro, da parte sua, non potrebbe aiutarlo a pentirsi neppure se volesse, perché tra i due è stabilito “un grande abisso” (v. 26).
L'abisso che c'era sulla Terra e che Lazzaro sopportava, ora lo deve sopportare il ricco epulone negli inferi, per sempre: cosa che però non gli riesce, e non tanto perché sia “umano” non poter sopportare un dolore senza fine, quanto perché – secondo l'autore di questo racconto – chi ha avuto tutto dalla vita non può sopportare di non aver nulla dopo morto.
La parabola è schematica, cioè categorica, proprio perché fatalista. Il finale lo conferma. L'autore della parabola è convinto che chi è ricco non potrà mai diventare “giusto”, neppure se vedesse un morto resuscitare (v. 31).
Il difetto della morale della parabola non sta tanto nel fatalismo riferito alla possibilità di “fare giustizia” da parte del ricco epulone, quanto piuttosto nel fatalismo riferito alla possibilità di “farsi giustizia” da parte del “povero Lazzaro”.
L'autore della parabola (un ebreo convertito al cristianesimo con evidenti tracce antisemitiche), partendo dal presupposto che i poveri non sono capaci di “farsi giustizia”, ritiene che la giustizia sulla Terra non sia possibile, in quanto i ricchi, proprio perché ricchi, non sono disponibili a “fare giustizia” spontaneamente.
Il limite di questa parabola non sta ovviamente nel voler far credere che per indurre un ricco a “fare giustizia” siano sufficienti la Legge mosaica e l'insegnamento profetico (v. 29), cioè che per “fare giustizia” nel presente sia sufficiente rifarsi a quanto di meglio ha prodotto, nel passato, il popolo ebraico (posizione, questa, che, oltre che fatalistica, sarebbe ingenua); ma sta piuttosto nel voler far credere che la pretesa ebraica di realizzare la giustizia in nome di Mosè e dei profeti è illusoria e alla fine produce soltanto dei personaggi come appunto il ricco epulone.
Il giudizio critico dell'autore parte dal presupposto che tra ebraismo e cristianesimo non vi possa essere che una contrapposizione frontale, senza mediazione alcuna, e che, di conseguenza, proprio il fallimento storico dell'ebraismo costituisce la più sicura garanzia del successo del cristianesimo.
L'autore crede di aver trovato una conferma al proprio fatalismo nel fatto che Gesù Cristo è stato crocifisso e che a lui non hanno creduto neppure quando hanno detto ch'era risorto. Forse l'autore, per un certo periodo di tempo, aveva sperato, nel proprio fatalismo di fondo, che gli ebrei avrebbero creduto al vangelo cristiano, almeno di fronte all'annuncio della resurrezione (col quale si poteva perdonare il delitto della croce) e che in virtù della fede in questa resurrezione si sarebbero anche potute migliorare le condizioni degli oppressi. Se è così, allora il cristiano di origine ebraica che ha scritto questa parabola, doveva essere di modeste condizioni sociali, attento ai problemi della giustizia, non disponibile però a impegnarsi in un progetto politico rivoluzionario.
Tuttavia, anche se non sembra, la parabola era abbastanza progressista nel tempo in cui venne scritta, poiché allora si riteneva, negli ambienti ellenistici, che solo i ricchi avrebbero ottenuto il paradiso, o che comunque dopo la morte tutti sarebbero finiti nell'Ade (un inferno deprimente), quindi senza nessun vantaggio per i poveri e gli schiavi.
II
Più in generale qual è il limite della parabola? Il suo autore è convinto che il ricco non rinuncerebbe alle proprie ricchezze neanche se vedesse un uomo risorgere. Con ciò egli implicitamente ammette che la teoria apostolica (petrina) della resurrezione di Cristo non ebbe alcuna efficacia per la modificazione dei rapporti di sfruttamento esistenti nella società schiavistica.
Questa parabola, che sia nata in ambiente ellenistico-cristiano o in ambiente ebraico-cristiano, manifesta comunque indirettamente la limitatezza strutturale del cristianesimo e di qualunque religione sul piano sociale. L'autore può anche averla scritta per mostrare che la legge mosaica e tutto il profetismo veterotestamentario si sono rivelati assolutamente impotenti di fronte all'oppressione della società schiavistica, ma se essa voleva lasciare intendere che i ricchi cristiani di origine pagana o di origine ebraica non arriveranno mai – appunto perché “cristiani” – ad adorare il “dio quattrino”, così come i ricchi di religione ebraica, allora bisogna dire che la sua pretesa alternativa è non meno illusoria di quella ebraica. Anche perché l'autore è esplicito nel sostenere l'impossibilità di trovare una qualunque mediazione tra ricchezza e povertà e nel contempo l'impossibilità di ribaltare le cose a favore dei ceti non abbienti, tant'è che la possibilità del riscatto, per il povero o lo schiavo, egli la relega nel mondo dell'aldilà. Il povero Lazzaro, infatti, quand'era in vita, si limitava a supplicare la pietà del ricco e non opponeva alcuna resistenza all'ingiustizia sofferta. In particolare il v. 25 pone l'ingiustizia a livello di un male da sopportare. Superata la prova, con la pazienza e la rassegnazione, lo schiavo otterrà nell'aldilà la ricompensa.
Sulla necessità di questo atteggiamento rinunciatario facilmente potevano trovarsi d'accordo cristiani d'origine ebraica e pagana. Ricchi e poveri, per Luca e per tutto il cristianesimo primitivo, sono appunto un dato della natura voluto da Dio. Al cristianesimo non si chiede più di quanto in precedenza si chiedeva alla legge mosaica, cioè la pura e semplice predicazione della pazienza per il povero e della pietà per il ricco.
Ovviamente la parabola avrebbe potuto concludersi con una diversa morale, forse più ebraica che cristiana, ma certamente meno scettica di quel che qui si può constatare: e cioè che chi è abituato a vivere nel lusso sfruttando il prossimo, potrebbe rinunciare a questo tipo di vita soltanto se qualcuno ve lo obbligasse.
III
Forzando un po' la mano si potrebbe dire che la parabola è attraversata da una certa tendenza antisemitica, in quanto l'incredulità dei Giudei – qui rappresentati dal ricco epulone – nei confronti del Cristo e del cristianesimo apostolico – qui rappresentati dal povero Lazzaro e da Abramo – viene considerata come assolutamente inevitabile.
Forse non è semplicemente una parabola contro i ricchi o la ricchezza in generale, a favore della speranza di una ricompensa ultraterrena, poiché, in tal caso, sarebbe del tutto normale annoverarla tra quelle del mondo islamico.
Probabilmente non è neppure una parabola preposta a insegnare la cosiddetta teoria della “non resistenza al male”, perché prevedere come ricompensa a un'azione ideale qualcosa di molto materiale, è senza dubbio limitativo dal punto di vista etico-religioso.
Questi aspetti sono certamente presenti nel testo e anche in maniera esplicita. Tuttavia qui si ha l'impressione che il leit motiv del racconto stia piuttosto in una sorta di malcelato disprezzo nei confronti del ceto ebraico benestante, e non tanto o non solo perché “benestante”, quanto soprattutto perché “ebraico”.
Se Luca – che era di origine pagana – avesse voluto scrivere una parabola contro l'uso illecito delle ricchezze, non avrebbe avuto bisogno di scegliere uno sfondo e dei personaggi che ricordano così da vicino l'ebraismo. Sarebbe subito apparsa una scelta forzata e lontana dal suo stile accorto. Peraltro avrebbe ottenuto un effetto di dubbia efficacia pedagogica nell'ambito di una comunità cristiana di origine ellenistica.
Questa parabola contiene elementi troppo artificiosi perché si possa pensare ch'essa rifletta una qualche situazione sufficientemente realistica.
Il povero Lazzaro infatti sembra rappresentare il proletariato ebraico che, emancipatosi dall'ideologia giudaica dei ceti possidenti, che lo discriminava culturalmente e l'opprimeva materialmente, diventa, nei panni di Abramo, una sorta di parvenu cristiano, fondamentalmente razzista e soprattutto antisemita, in quanto ipostatizza un atteggiamento incredulo e volgarmente materialista da parte dei possidenti ebrei.
Abramo rappresenta ciò che Lazzaro avrebbe voluto essere sulla Terra quand'era ebreo e ciò che è diventato abiurando l'ebraismo.
In questo racconto la ricchezza è stata vista non tanto per fare una critica al suo uso smodato o a quello ch'essa rappresenta in sé, ma come occasione per condannare un ceto sociale e, con esso, un'etnia, un popolo, una cultura, una religione, senza soluzione di continuità.
Una parabola del genere non solo non può essere uscita dalla penna di Luca, ma meno ancora potrebbe essere uscita dalla bocca del Cristo, sia perché questi, nei vangeli, non ha mai negato a nessuno la speranza della conversione – tant'è che lo stesso Luca non ha scrupoli nel sostenere che persino Zaccheo, un capo degli agenti delle tasse, era disposto a seguire il messia in cammino verso Gerusalemme per l'ingresso trionfale; sia perché non è condannando la ricchezza in maniera così moralistica (chi ha goduto sulla Terra soffrirà nei Cieli) che si sarebbe potuta ottenere la giustizia sociale in Israele. Cristo non era un profeta ma un leader politico.
In definitiva, una parabola così dominata dalla logica del risentimento, può essere stata solo aggiunta al testo di Luca.
Peraltro, se accettiamo che Luca abbia scritto anche gli Atti degli apostoli, la suddetta parabola si presenta come la negazione della storia del più grande apostolo del Nuovo Testamento, Paolo di Tarso, che si convertì non solo perché era giunto alla conclusione che la Legge e i Profeti non erano più sufficienti a garantire la libertà personale, ma anche perché ad un certo punto si persuase che la scomparsa del Cristo dalla tomba poteva essere considerata come un fatto realistico, da utilizzare strumentalmente come chiave di volta per elaborare una nuova ideologia religiosa, alternativa sia al vecchio giudaismo che alle teorie professate dal Cristo in persona.
Addendum
Se Gesù fosse stato un “maestro di virtù” o un filosofo, probabilmente avrebbe formulato una teoria del giusto agire, una sorta di criteri generali del comportamento etico o della buona condotta. È invece netta l'impressione ch'egli prendesse i valori della cultura ebraica come terminus ad quem di tutte le sue diatribe; semmai ne contestava l'applicazione. Inoltre, siccome era un politico e non un teologo, la questione etica e la critica che ne seguiva avevano sempre come fine la liberazione d'Israele, cioè non erano mai considerate in se stesse. D'altra parte egli doveva essere consapevole che sul piano etico il giudaismo aveva una morale superiore a quella ellenistica: non c'era bisogno d'inventarsene un'altra. Lo dimostra, peraltro, nel suo dialogo con la samaritana, alla quale afferma che l'etica dei Giudei è superiore alla loro (Gv 4,22). Il vero problema era quello di come salvaguardarla all'interno di un sistema oppressivo quale quello imperialistico romano e collaborazionista sadduceo. Qui i Samaritani – essendo questa una questione puramente politica, in quanto si sarebbe dovuta compiere una liberazione nazionale – avrebbero potuto riscattarsi agli occhi dei Giudei, che li consideravano equivalenti ai pagani.
Oltre a ciò bisogna dire che Gesù non può aver predicato la realizzazione di un “regno di Dio”. E questo per due ragioni: il concetto di “Dio” supponeva un'interpretazione rabbinica della sua volontà e un'amministrazione sacerdotale della devozione popolare nei suoi confronti – e Gesù è contrario sia ai rabbini che ai sacerdoti, proprio perché entrambe le categorie sociali lo detestano (lo accusano di ateismo, lo minacciano di morte, lo perseguitano in varie maniere); sia perché la parola “regno” per qualunque ebreo voleva dire che un rappresentante di Jahvè (cioè un sovrano) avrebbe governato col placet della casta sacerdotale, e avrebbe anche potuto assumere atteggiamenti dittatoriali, pur di salvaguardare gli interessi dello Stato o dei gruppi di potere.
L'obiettivo che Gesù aveva di realizzare la giustizia sociale o l'uguaglianza sociale, era impossibile conseguirlo all'interno di un “regno monarchico”, inevitabilmente soggetto alle pressioni da parte delle élite dominanti. Non a caso tutti i regni edificati in Israele in precedenza, erano finiti rovinosamente. Anche quando, coi Maccabei, gli ebrei riuscirono a liberarsi dell'oppressione ellenistica, il successo durò molto poco, in quanto Israele fu di nuovo occupata dai gentili, che in quel momento provenivano da Roma.
(torna su)6) La passione di Gesù nella prospettiva lucana
I
Che l'evangelista Luca sia poco avvezzo ai sofismi della teologia lo si evince abbastanza facilmente là dove parla del terzo annuncio della passione di Gesù. Da un lato infatti, onde dimostrare che il Cristo era una persona assolutamente straordinaria e di natura divina, scrive che tutto quello che gli faranno era già stato previsto dai profeti (18,31). Dall'altro invece sostiene che gli apostoli non capiscono assolutamente nulla di quanto riescono ad ascoltare.
Strano che non capissero – visto ch'erano tutti ebrei con un certo grado d'istruzione – ciò che i profeti, con molta chiarezza – secondo Luca – avevano preventivato. Qui ci sarebbe molto da dire, ma sarà sufficiente accennare a qualche incongruenza, non rientrando nei nostri interessi una disamina di questioni propriamente teologiche.
Anzitutto nessun profeta ha mai parlato di un messia che sarebbe morto e risorto. L'unico ad aver parlato di “resurrezione” è stato il profeta Ezechiele al cap. 37, in una descrizione piuttosto macabra, degna di un film surreale. Il concetto di “resurrezione” non ha mai fatto parte della cultura ebraica, quanto piuttosto di quella pagana (basti pensare ai miti di Dioniso e di Mithra). Se davvero Gesù avesse detto una cosa del genere, l'avrebbero preso per pazzo e avrebbero smesso di seguirlo.
La seconda incongruenza è deducibile dalla prima: andare con lui a Gerusalemme per vederlo morire con assoluta sicurezza sarebbe stato del tutto insensato. Gesù e i Dodici salirono nella Città Santa nel periodo di Pasqua non per predicare una nuova “etica religiosa”, concretizzata in un movimento galilaico, quanto per compiere una insurrezione antiromana con l'aiuto di tutte le forze progressiste della capitale. Tale decisione venne definitivamente presa a Betania e gli apostoli la condividevano, per cui ne erano perfettamente consapevoli.
L'unica cosa interessante di quanto scrive Luca è il titolo che Gesù attribuisce a se stesso: “Figlio dell'uomo”, cioè messia con caratteristiche umane e quindi democratiche, pluralistiche. Altrove si usa l'espressione “Gesù il Nazareno” (18,37). Il cieco risanato a Gerico lo chiama “Figlio di Davide”, un titolo che Gesù difficilmente avrebbe dato a se stesso, in quanto troppo connotato giudaicamente, anche se, approfittando di quel titolo inadeguato, Gesù premia la fede del cieco e lo guarisce. Quel postulante, come condizione per seguirlo, chiedeva la vista, e Gesù gliela diede, proprio per dimostrare ch'era ben di più di un semplice messia davidico. Il cieco aveva creduto che Gesù avrebbe potuto fare il miracolo (infatti lo chiama anche “Signore” quando gli si avvicina), e questo, nel racconto simbolico, è motivo sufficiente per dimostrare che quell'uomo aveva avuto “fede”. D'altra parte il cieco si era mosso individualmente e con caparbietà, vincendo le resistenze altrui. Forse la sua vera fede – in questo racconto che Luca copia da Marco –, quella che gli permise di recuperare la vista, stava proprio nella sua caparbietà a non rispettare le convenzioni formali, facendo valere la realtà del suo bisogno. Saper andare controcorrente è, per Gesù, un segno di maturità.27
Anche la conversione di Zaccheo, come molti altri racconti, è propria del vangelo di Luca (19,1 ss.). Questo capo dei pubblicani veniva ovviamente considerato un venduto all'imperialismo romano, in quanto si comportava esosamente coi propri concittadini e correligionari. Eppure Gesù gli dice che si è salvato solo perché ha promesso di restituire la metà dei suoi beni ai poveri e il quadruplo a chi aveva frodato.
Si noti la mistificazione del redattore. Da un lato dice che Gesù sta per entrare a Gerusalemme; il che lascia pensare che lo faccia in maniera pubblica, con tanto di seguito popolare: lo stesso Luca scrive che “era vicino a Gerusalemme e i discepoli credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente” (19,11). È qui evidente che l'autore non poteva non sapere che la salita di Gesù nella capitale aveva un chiaro scopo politico, quello per cui in tanti lo seguivano.
Dall'altro però egli si limita a circoscrivere la realizzazione del regno a un'opera di smontaggio di quelli che vengono considerati i pregiudizi altrui. Tutti infatti, a Gerico, mormoravano: “È andato ad alloggiare in casa di un peccatore!” (v. 7). Cioè proprio nel momento in cui sta per compiere un'insurrezione antiromana, premia la buona volontà risarcitoria di un ebreo collaborazionista.
Qui delle due l'una: o il Cristo politico è stato trasformato in un semplice profeta morale, ma allora non si capisce la volontà di entrare pubblicamente nella città, con tanto di seguito popolare; oppure Zaccheo si era deciso, come già Levi-Matteo, ad abbandonare il proprio mestiere e a diventare discepolo esplicito di Gesù; in tal caso però la “salvezza”, data dal regno, non poteva essere una questione meramente personale. Luca s'impantana in una contraddizione insostenibile.28
E i nodi non vengono certo sciolti dall'agghiacciante parabola delle dieci mine (19,11 ss.), nella quale egli si diverte a mettere a confronto l'importanza della morale personale, espressa da Zaccheo nella precedente pericope, con la spietatezza di chi non è abituato ad avere riguardi per nessuno. Anche questo modo di procedere è un classico dei moralisti. Invece di mostrare che una morale personale non è sufficiente per cambiare il sistema e che occorre un rivolgimento politico, che ribalti i poteri dominanti, si preferisce far vedere che senza quella morale l'alternativa è semplicemente terribile.
Qui si fa persino fatica a capire come mai una parabola del genere, in cui un nobile, recatosi in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno, al suo ritorno premi soltanto i servi affaristi, punendo gli incapaci e mandando a morte i sediziosi, sia stata messa nel suo vangelo. È infatti impossibile equiparare Gesù a un personaggio così esoso e spietato. Si ha l'impressione che Luca l'abbia usata come una sorta di spauracchio: ora che Gesù si avvicina a Gerusalemme, chi ancora tentenna nel vivere una coscienza davvero morale, non avrà più tempo per rimediare e verrà espulso dalla comunità. Cioè non bisogna illudersi che sul piano etico il Cristo debba essere per forza più tollerante di un qualunque sovrano pagano.
II (fonti)
L'ingresso trionfale nella capitale giudaica (19,28 ss.) contiene aspetti inequivocabilmente politici, di cui però Luca non si preoccupa, anche perché ad essi non fa seguire alcunché.
Gli aspetti politici sono l'accurata preparazione dell'ingresso, l'uso del puledro, i mantelli stesi sulla via, l'acclamazione generale della folla e soprattutto la qualifica di “re”, che equivaleva a quella di “messia liberatore” e certamente non a quella, troppo limitativa, di “messia redentore”; anche perché, di fronte ai farisei che chiedono a Gesù di far tacere i propri discepoli, che proferiscono parole chiaramente sovversive, egli risponde, seccato: “Se costoro tacciono, grideranno le pietre” (v. 40).
Istintivamente verrebbe da pensare che Luca si sentisse più libero degli altri evangelisti nel sottolineare gli aspetti politicamente eversivi della predicazione di Gesù. Invece è solo un'apparenza. Infatti cosa fa Gesù una volta entrato in città? Fa il profeta, non il messia; si lamenta, non chiede di ribellarsi. Luca lo fa parlare come se già sapesse che Gerusalemme verrà completamente distrutta dai Romani. In sostanza il Gesù del suo vangelo sta rimproverando gli ebrei di essere stati troppo politicizzati (troppo nazionalistici) e troppo poco etici (nel senso della nuova religione), cioè troppo poco disposti a cercare un'alternativa in chiave pre-politica o anti-politica.
Gerusalemme è destinata alla distruzione perché nel Cristo non ha saputo trovare la propria “pace” (19,42). Ma quale pace sarebbe stata migliore se non quella ottenuta dopo aver cacciato gli invasori dalla Palestina? Secondo Luca la vera “pace” è soltanto quella della coscienza. Tuttavia in virtù di tale “coscienza” Gesù, nei Sinottici, riesce soltanto a cacciare i mercanti dal Tempio29, mostrando che l'etica religiosa è sempre superiore alla ricerca del guadagno economico. Dopodiché Luca si limita a dire che la distruzione di Gerusalemme va interpretata come una “punizione divina” per non aver accettata la nuova coscienza religiosa, benché la morte di Gesù venga interpretata dalla comunità cristiana primitiva come una “necessità divina” (ch'era il modo per giustificare il fallimento dell'insurrezione nazionale).
Niente quindi di particolarmente rivoluzionario nell'ingresso messianico, anche se il clero, colpito nei suoi interessi materiali, sta già tramando su come farlo fuori, aggirando il consenso popolare. In pratica Luca già prospetta che lo scontro decisivo non sarà tra il movimento nazareno e l'occupante romano (ivi inclusi i collaborazionisti tra i partiti di governo), ma sarà tra il cristianesimo e l'ebraismo, in cui il ruolo di Roma, in quel frangente, risulterà del tutto irrilevante. In questo Luca resta completamente in linea alla ricostruzione dei fatti voluta dalla teologia petro-paolina.
Luca non mostra alcuna simpatia per le autorità religiose, per cui non è in grado di distinguere – come invece viene fatto nel quarto vangelo – chi era risolutamente contro Gesù da chi invece aveva assunto un atteggiamento interlocutorio, possibilista. Infatti quando l'alto clero chiede a Gesù con quale autorità stava facendo l'epurazione del Tempio (Lc 20,1 ss.), Gesù taglia corto e si rifiuta di rispondere, da vero moralista. Gli basta ricordare che come essi non avevano creduto nel Battista, così non crederanno neppure in lui. Dà per scontato che il potere religioso non sia in grado di capire alcunché, per cui il dialogo diventa subito molto difficile. Anche nei confronti degli scribi in generale mostra la medesima intransigenza: “Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti e hanno piacere di esser salutati nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti; divorano le case delle vedove, e in apparenza fanno lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più severa” (20,46 s.).
Tale intransigenza viene confermata nella parabola dei vignaioli omicidi (19,9 ss.). Gesù avverte d'essere un condannato a morte; si serve della folla soltanto per allungare il più possibile il momento della sua fine.30 E così, paradossalmente, se è vero che l'alto clero sta cercando il momento favorevole per eliminarlo, lui stesso però, con le sue continue provocazioni, dà l'impressione di essere favorevole a questa decisione. Infatti vuole morire come un personaggio pubblico, facendo della propria morte un monito d'insegnamento morale per tutti gli ebrei della Palestina, anzi, se possibile, per il mondo intero.
Qui c'è un'autentica mistica della morte, nel senso che il Cristo di Luca attribuisce a questa esecuzione capitale un significato più “salvifico” (soteriologico) di ciò che non era riuscito a ottenere con la propria morale mentre era in vita. Ossia, ciò che non poté ottenere la vita, l'otterrà la morte. Almeno questa è la speranza, anche se Luca vuol farla passare come una certezza: “La pietra che i costruttori hanno scartato, è diventata testata d'angolo” (20,17). E la conseguenza è terribile, poiché “chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e a chi cadrà addosso, lo stritolerà” (v. 18).
Il moralista Luca, su questo punto, non ama scherzare. Il compito era quello di accettare una morale alternativa a quella dominante; non si chiedeva di fare una rivoluzione politica vera e propria; l'impegno era minore; e tuttavia chi l'ha rifiutato, ne pagherà molto care le conseguenze, più di quanto possa immaginare. Quando sono in gioco i destini della morale, non si può essere troppo buoni. Un Luca – come si può ben notare – più realista del re.
III
Il tributo a Cesare (20,20 ss.) è collocato in questo frangente, rispettando la cronologia marciana, poiché Luca gli vuole attribuire un connotato politico, in quanto, sin dalla premessa, egli afferma che i sacerdoti speravano di coglierlo in fallo su una questione molto spinosa, quale appunto il pagamento delle tasse ai Romani; ciò al fine di poterlo poi riferire al governatore Ponzio Pilato.31
L'episodio – come sappiamo – è del tutto inventato e per una serie di ragioni, tra le quali la maggiore era che Cristo non aveva mai predicato un “regno di Dio”, ma semmai un “regno degli uomini”; anzi neppure un “regno”, con tanto di monarca, bensì una “democrazia”, in cui vigesse il principio dell'uguaglianza sociale.
In secondo luogo chi ha intenzione di fare un'insurrezione armata contro l'occupante straniero, rappresentato da Pilato, non può affermare che il tributo va dato a Cesare come una cosa scontata, solo perché vi è l'effigie dell'imperatore impressa sulle monete. Il tributo, al massimo, poteva essere pagato in via transitoria, in attesa appunto di compiere la liberazione nazionale.
In terzo luogo Cristo non avrebbe mai potuto ammettere un “potere” sacerdotale totalmente indipendente da quello politico, meno che mai se questo potere presumesse d'avere caratteristiche anche “civili”, come appunto avveniva nella Giudea del suo tempo, per quanto la casta sacerdotale, nei suoi massimi livelli, fosse completamente controllata da Roma.
La distinzione di Chiesa e Stato appartiene alla teologia petro-paolina, che se ne servì per illudere i cristiani che bastasse tale rivendicazione per lottare politicamente contro le autorità imperiali, notoriamente molto oppressive, ovvero per illuderli che si poteva comunque vivere, in coscienza, un'esperienza di libertà, pur in presenza della dittatura imperiale. L'unica condizione che veniva chiesta ai fedeli era quella di non riconoscere agli imperatori alcun carattere di “divina sacralità” (il che comunque comporterà persecuzioni a non finire).
Quando Gesù Cristo, l'indomani dell'epurazione del Tempio (con cui tentò, inutilmente, di estromettere la casta sacerdotale dalla sua gestione abusiva), si rifugiò in Samaria, prima di stabilirsi in Galilea, parlò soltanto di libertà di coscienza, nel senso che ognuno doveva essere lasciato libero di credere nella religione che voleva; il futuro Stato palestinese, resosi indipendente da Roma, avrebbe poi assicurato un atteggiamento equidistante nei confronti di tutte le religioni e di tutte le modalità in cui si viveva una medesima fede.
Ecco perché non avrebbe mai potuto chiedere un regime di separazione in cui gli ebrei avevano il diritto di ribellarsi allo Stato romano soltanto quando, pagando il tributo colonialistico a Cesare, venivano obbligati a rinunciare all'indipendenza della loro teologia-politica (che era come dire: quando lo Stato non li obbligava a considerare Dio più importante di Cesare, non c'erano ragione di ribellarsi politicamente). Al massimo avrebbe potuto chiedere il regime di separazione per far sì che l'impegno politico a favore della liberazione nazionale non dipendesse in alcun modo dal proprio atteggiamento nei confronti della religione (ch'era appunto quanto aveva chiesto di fare ai Samaritani). La frase “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” era di Paolo (in questo politicamente opportunista), non di Gesù, che non avrebbe dato niente a nessuno dei due. Il che non vuol dire che quella frase non risultasse scomoda agli imperatori, abituati a considerare la religione un instrumentum regni.
Detto questo, la suddetta pericope si commenta da sé: la sua decisa improbabilità storica è relativa anche al fatto che, in quel momento, non avrebbe avuto alcun senso porgli una domanda di cui si doveva per forza già sapere la risposta.
Il dibattito coi sadducei sulla resurrezione è ancora più inverosimile, anche se Luca continua a porsi, in maniera acritica, sulla falsariga del vangelo marciano. Come questa pericope sia finita nei vangeli è poco spiegabile, sia perché Gesù non ebbe mai modo di confrontarsi personalmente col partito sadduceo, troppo conservatore per poterci ricavare un'intesa significativa su qualche obiettivo eversivo; sia perché l'argomento in sé esulava del tutto da quelli che Gesù proponeva con la sua predicazione itinerante. Vien quasi da pensare a un'influenza esterna da parte di Paolo di Tarso, il cui partito farisaico non aveva altro da fare nel Sinedrio che accapigliarsi coi sadducei su un argomento così astruso: lo stesso Paolo lo sfrutta per uscire indenne da una situazione non facile (At. 23,6). È interessante comunque che nella pericope sulla resurrezione venga detto che gli esseri umani sono destinati a esistere, che lo vogliano o no.
Luca, il moralista, non può che nutrire disprezzo per i poteri costituiti (nella fattispecie giudaici), generalmente corrotti e arroganti. Sicché quando Gesù vede una povera vedova (21,1 ss.) che fa una piccola offerta nella cassa del Tempio, la esalta come donna molto generosa, in quanto aveva donato ciò che le serviva per vivere, mentre i ricchi, anche quando fanno cospicue offerte, rinunciano di fatto solo al superfluo. È tutta qui l'etica religiosa che Gesù propone nella Città Santa.
La donna non viene compatita come una povera illusa, che con la propria offerta, ancorché minima, contribuisce a sostenere l'arroganza del potere costituito. Già da questa incapacità di capire quando un'azione morale (anche nei suoi livelli meramente intenzionali) può sortire effetti opposti a quelli voluti, si dovrebbe arguire che i vangeli sono testi profondamente mistificanti. Lo sono proprio in quanto fanno del bene morale, dell'etica personale, della coscienza virtuosa un qualcosa che si pone in alternativa alla realizzazione della giustizia sociale, della democrazia politica, della liberazione nazionale dallo straniero che opprime.
C'è da dire che quando Luca scrive il suo vangelo, Gerusalemme era già stata distrutta dai Romani, per cui gli è relativamente facile distinguere tra “buoni” e “cattivi” o attribuire alle autorità costituite e ai partiti politici ostili a Gesù la causa di quella distruzione. Tanto più ch'egli non fu né un giudeo che credeva nella liberazione della Palestina, né un seguace diretto di Gesù. Non aveva modo di nutrire rimpianti o nostalgie, né si sentiva in dovere di compiere alcuna autocritica.
Peraltro il suo punto di riferimento è la teologia paolina, che si è formata approfondendo il tema petrino della resurrezione del corpo di Gesù: non riesce neppure a vedere i contrasti insanabili tra Pietro e Giovanni, e non gli interessa mettere in risalto le peculiarità degli apostoli. Tutta la vicenda del Cristo viene trattata in maniera distaccata, senza alcun vero riferimento storico, proprio perché l'unica cosa che gli interessa è servirsi del Cristo per dimostrare la fondatezza dell'etica-religiosa paolina. La durezza o spietatezza di certi suoi racconti risulta essere inevitabilmente condizionata da un certo antisemitismo.
IV
Il discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi (21,5 ss.) ha il sapore di una piccola apocalisse. Proprio per questa ragione bisogna dire che appare fuori contesto, in quanto sembra un discorso che un leader politico come lui non avrebbe mai potuto fare in quel momento, non foss'altro perché, una volta entrato nella capitale, rischiando d'essere immediatamente arrestato (in quanto ricercato dalle forze dell'ordine), l'unica cosa che poteva dire sarebbe stata quella di prepararsi all'insurrezione, senza svelare in pubblico tutte le modalità operative, tant'è che queste vengono decise di notte, alla presenza dei discepoli più fidati, durante la cosiddetta “ultima cena”.
Luca scrive che “di giorno Gesù insegnava nel Tempio; la notte usciva [dalla città] e la passava sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel Tempio ad ascoltarlo” (vv. 37-38). Senza dubbio, quindi, vi era prudenza nell'atteggiamento del Cristo, ma vi doveva essere anche decisione, poiché non era più il caso di perdere tempo a insegnare il vangelo alla folla.
In questo discorso, che Luca scrive col senno del poi, si dà per acquisita la distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani (vv. 6;20;24). Il che conferma la tesi, da tempo consolidata, che tutti i vangeli siano stati scritti quando i testimoni diretti degli eventi che vi sono raccontati erano morti da un pezzo, sicché nessuno avrebbe potuto contraddire delle ricostruzioni così fantasiose. Se infatti il discorso fosse attendibile, anche solo un minimo, sarebbe stato del tutto incomprensibile ai cittadini della capitale. Invece così appare come un vaticinium ex eventu.
È come se Cristo avesse detto: “Poiché stanno per giustiziarmi contro ogni senso della morale, la fine che vi aspetta, ad opera dei Romani, sarà tanto terribile quanto inevitabile”. Ora, se davvero avesse detto una cosa del genere, l'avrebbero preso per pazzo, anzi, l'avrebbero linciato senza neanche fargli un processo, in quanto sarebbe apparso un intollerabile disfattista sul piano politico. Nemmeno i sommi sacerdoti erano così tanto rinunciatari. Sopportare con rassegnazione ci può stare, ma giustificare l'autolesionismo no. Insomma avrebbe fatto la fine di Stefano, riportata negli Atti degli apostoli (7,51 ss.).
In questo discorso di Gesù Luca fa chiaramente riferimento all'attività di Paolo di Tarso, là dove dice che metteranno i discepoli in prigione e li trascineranno davanti a re e governatori e che ciò va sfruttato come occasione per rendere testimonianza della nuova religione (v. 12 s.).
Che Luca ritenesse del tutto irrilevanti i rapporti di parentela rispetto a quelli infracomunitari, è confermato dal v. 16, ove dice: “Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici; faranno morire parecchi di voi”. Cosa che, dirla a un ebreo, sarebbe stato come bestemmiare.
La distruzione di Gerusalemme vien considerata praticamente una “vendetta divina” (v. 22), nel senso che Luca sembra lasciar capire che, a seguito della morte ingiusta del Cristo, Dio si servirà dei Romani per eliminare i Giudei dalla Palestina; cioè non lo farà direttamente, p. es. attraverso fenomeni naturali (come fece con Sodoma e Gomorra), ma indirettamente, utilizzando i peggiori nemici d'Israele.
Questo modo di ragionare lo si ritrova in tutte le religioni; persino oggi vi è chi pensa che determinate calamità (p.es. la diffusione dell'AIDS o i fenomeni tellurici) siano la giusta punizione divina nei confronti di qualche grave colpa morale, che gli uomini non hanno voluto affrontare con adeguata fermezza. Tale modo di vedere la realtà, quella densa di contraddizioni insopportabili, è tipico delle posizioni moralistiche, e quindi anche di quella lucana. Che sono poi posizioni individualistiche o di comunità settarie, autoreferenziali, dove ci si sforza di essere moralmente perfetti, dopodiché, quando si constata che, nonostante i propri sforzi, la società è rimasta uguale, si comincia a profetizzare la fine del mondo o a desiderare interventi punitivi da parte della divinità; e quasi ci si compiace nel vedere che da quelle contraddizioni scaturiscono effetti deleteri per l'intera società, nella convinzione, in forza della propria comunità settaria e della propria integrità morale, di riuscire ad esserne risparmiati.
Da notare che Luca non dice mai che Gerusalemme sarà distrutta dai Romani: preferisce usare la parola generica “pagani” (v. 24), al fine di permettere ai cristiani d'essere più tollerati dagli imperatori. In tutti i vangeli gli autori si sforzano di far vedere che i cristiani sono irriducibili avversari degli ebrei, ma anche potenziali alleati dei pagani (nella fattispecie i Romani), all'ovvia condizione che si possa considerare soltanto il Cristo l'unico vero “Figlio di Dio”: cosa che però gli imperatori, affetti da egocentrismo politico, non potevano accettare.
Il principato dittatoriale era nato infatti in antitesi alla corrotta repubblica senatoria, e tutti gli imperatori erano convinti che la loro propria divinizzazione avrebbe contribuito a tenere unito l'impero contro le istanze autonomistiche ed egoistiche dei grandi proprietari terrieri, rappresentati appunto dai senatori, ben presto imitati da quella borghesia affaristica e imprenditoriale che riuscirà, col tempo, a entrare in Senato, facendo leva sulla propria spregiudicatezza.
Ciò, in realtà, fu una grande illusione, poiché gli imperatori, pur avendo dalla loro parte gli eserciti, non ebbero mai la forza e, in fondo, neppure la volontà di ridimensionare il potere economico dei latifondisti; semplicemente si limitarono a ridurre di molto quello politico dei senatori, e la ricerca di una propria divinizzazione doveva appunto dimostrare ch'essi fruivano di un potere autonomo, indipendente da quello parlamentare.
V
L'ultima parte del vangelo di Luca, dedicata alla morte e presunta resurrezione di Gesù Cristo, è la meno significativa, in quanto egli non poteva discostarsi dall'impostazione generale che ne aveva dato la teologia petro-paolina. Luca poi, che non fu testimone di nulla, meno ancora avrebbe potuto scrivere qualcosa di originale. Non aspettiamoci quindi di trovare negli ultimi tre capitoli dei passi davvero importanti, anche se non mancheranno delle sorprese, poiché l'autore di questo vangelo, non essendo legato ad alcuna tradizione specifica dell'ebraismo, a volte sembra sentirsi libero di dire cose in controtendenza.
Al cap. 22 la passione del Cristo inizia col tradimento di Giuda, la cui motivazione resta piuttosto ambigua32, in quanto la decisione delle autorità giudaiche di ricompensarlo con del denaro (il cui importo non viene specificato) è successiva all'idea di consegnarlo “ai capi dei sacerdoti e ai capitani” (v. 4). Si noti che mentre nel vangelo di Giovanni Giuda decide di tradirlo la notte stessa dell'ultima cena (e non necessariamente nel momento in cui cenavano), a prescindere da qualunque patteggiamento monetario (ciò a testimonianza che il tradimento poteva avere motivazioni politiche, le quali probabilmente erano le stesse di Caifa33, espresse in Gv 11,49 ss.); qui invece il tradimento avviene prima ancora che Gesù e gli apostoli entrino in città per celebrare il giorno degli azzimi, cioè per fare la cena pasquale.
Piuttosto, anzi, si deve notare come il Cristo venga presentato, insieme ai discepoli, come un ebreo osservante delle tradizioni mosaiche: il che è tutto da dimostrare, in quanto non lo si vede mai celebrare dei riti religiosi, sostenere, come un rabbino, il valore della legge mosaica o il primato del Tempio, rispettare il sabato o le regole dietetiche. Questo per dire che per un leader che si accinge a fare l'insurrezione nazionale non doveva essere particolarmente cogente il rispetto della festività degli azzimi.
Il fatto è che nei vangeli, essendo l'intenzione dei redattori quella di presentare un Cristo “religioso”, la Pasqua viene ad acquistare tutta una valenza teologica particolarmente rilevante. L'ultima cena diventa l'occasione per sostituire una cerimonia simbolica con un'altra. Gesù diventa, misticamente, il nuovo agnello pasquale che offre se stesso in sacrificio volontario, come pasto totemico, per essere consumato dai propri discepoli, presenti e futuri, a ricordo di ciò che ha fatto. Si è cioè in presenza di una sorta di memoriale metaforico, in cui viene ricordata un'autoimmolazione nei confronti della quale i discepoli futuri, se potranno non sentirsi responsabili della sua morte, come quelli a lui contemporanei, dovranno però sentirsi responsabili come appartenenti a un genere umano incapace di vero bene (a causa del peccato originale) e quindi costantemente bisognoso del perdono divino. Quanto al vino, esso rappresenta il sangue versato per il bene dell'umanità: è un vero e proprio patto di fedeltà, come quelli che avvengono negli ambienti massonici o esoterici.
Egli sa già di dover morire e fa partecipi gli apostoli della sua decisione, che poi non viene presentata come una decisione di carattere “personale”, quanto come una decisione “collegiale”, presa in un suo stretto rapporto col Padreterno, anzi con la divina Trinità (ciò di cui gli apostoli erano totalmente a digiuno).
Esattamente come gli altri evangelisti, Luca ricostruisce il passato alla luce della mistificazione che la teologia petro-paolina ha elaborato pochi decenni prima della sua conversione al cristianesimo. E fa questo senza rendersi conto che nel caso in cui Gesù avesse davvero parlato in quella maniera, nessuno avrebbe potuto capirlo, sicché sarebbe stato del tutto naturale che gli apostoli avessero ripensato seriamente l'idea di proseguire la sequela di un folle così stravagante; a meno che, ovviamente, l'autosuggestione non fosse stata così forte da convincerli ad immolarsi insieme a lui (la follia infatti, in certe comunità settarie, è contagiosa); nel qual caso però Giuda avrebbe svolto il ruolo dell'unico discepolo sano di mente.
Si noti anche come Luca riporti fedelmente quella curiosa frase del vangelo di Marco secondo cui “Il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tradito!” (22,22). Che significato logico abbia questa frase è difficile decifrarlo. Infatti se Gesù “doveva” morire, perché così “voleva” Dio-padre, il tradimento perde molta della propria gravità; anzi, Giuda può anche passare alla storia come l'unico apostolo che avesse davvero capito le intenzioni suicide del Cristo; sicché non avrebbe fatto altro che agevolarne la realizzazione.
Certo, l'ideale sarebbe stato che il Cristo venisse catturato senza tradimento, ma se voleva davvero morire, perché circondarsi di tanta folla34 quando amava predicare nei pressi del Tempio? Perché nascondersi di notte nel Getsemani? Questo esporsi e celarsi di continuo sembra essere un gioco delle parti, come il gatto col topo. Voleva morire, ma non voleva farlo sembrare un suicidio; voleva che lo prendessero, ma non senza che si facesse fatica a trovarlo; sicché il tradimento veniva a configurarsi come una manna piovuta dal cielo. Avrebbe impedito a chiunque di qualificare Gesù come un suicida.
Eppure tutti sanno che esiste anche l'istigazione a compiere atti criminosi. Se il leader di un movimento afferma, con sicurezza: “Ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola” (22,21); cioè se sta dando per scontato che un gesto terribile sta per compiersi, davvero sta cercando d'impedire con le sue parole che il gesto effettivamente si compia, o non sta invece favorendolo? La mistificazione ebraico-cristiana può essere condotta a livelli anche molto elevati – come appunto risulta in tutti i vangeli –, ma ad un certo punto i nodi vengono al pettine, proprio perché oltre a un certo livello non si può andare.
Ci rendiamo ovviamente conto che per un credente parole come queste possono risultare inaccettabili, ma qui nessuno mette in discussione l'esistenza storica di un uomo chiamato Gesù; anzi, si è cercato di valorizzarlo in un aspetto, quello politico, che i vangeli hanno colpevolmente omesso o trascurato, presentandosi, essi, come un tentativo di conciliazione della predicazione di Gesù col principato romano: cosa che sarebbe apparsa blasfema a tutti i partiti politici della Palestina di allora, incluso ovviamente quello nazareno. Persino quelli più conservatori e meno disposti alla guerra civile erano convinti che proprio mantenendo integre le tradizioni del passato, si sarebbe potuto meglio resistere allo stile di vita del mondo romano.
La critica all'interpretazione mistificante (in quanto chiaramente mistica) dei vangeli ha unicamente lo scopo di far rileggere questi testi (e tutto il Nuovo Testamento) in chiave etico-politica, ridando agli eventi ch'essi raccontano una rappresentazione più realistica e, speriamo, meno tendenziosa. Soprattutto si vuole qui smontare la convinzione che il cristianesimo abbia costituito un elemento “rivoluzionario”, sotto l'impero romano, solo perché veniva negata all'imperatore la pretesa divinizzazione, affermando un regime di separazione tra chiesa e Stato. Tale presunto carattere eversivo si è visto subito che fine ha fatto sotto Costantino e Teodosio.
VI
È curioso come Luca collochi, subito dopo l'annuncio del tradimento di Giuda, la discussione su chi fra gli apostoli fosse il più grande (22,24 ss.). In Marco si trova in tutt'altro contesto.
È una discussione squisitamente politica, il cui significato però è poco chiaro. Sembra che gli apostoli si preoccupino di sapere chi sarà il sostituto di Gesù nel caso in cui il tradimento abbia un esito tragico. Ma sarebbe stato realistico preoccuparsi di una cosa del genere in quel momento? Non doveva forse esser chiaro a tutti che, anche nel caso in cui il loro leader fosse stato catturato, l'insurrezione sarebbe stata fatta lo stesso; anzi, si sarebbe avuta una motivazione in più per farla: quella di liberarlo.
Se Luca ha voluto mettere questo brano subito dopo quello relativo al tradimento, per far vedere che gli apostoli ci tenevano a non voler apparire come Giuda (neppure sul piano ipotetico), bisogna dire che il risultato finale lascia alquanto a desiderare. Gli apostoli, infatti, sembrano comportarsi come adolescenti permalosi e vanagloriosi, che non tollerano neanche il più piccolo sospetto sulla loro integrità morale.
Al massimo quindi si potrebbe pensare che in quel racconto vi sia soltanto un pallido riflesso riguardo alla discussione sulla distribuzione di ruoli e incarichi stabilita proprio durante l'ultima cena: una discussione nel corso della quale forse ci possono essere state delle frizioni, delle piccole tensioni, ma niente di particolarmente grave, in quanto le cose principali dovevano per forza essere già state chiarite prima.
In ogni caso lo svolgimento che ne dà Luca è del tutto fantasioso. Gesù promette a chi gli resterà fedele un trono nell'aldilà, per giudicare “Le dodici tribù di Israele” (22,30). Dodici apostoli che giudicano dodici tribù (di cui, al tempo di Gesù, solo un paio erano rimaste). Ma Giuda non doveva tradirlo? O forse Luca sta già pensando a chi lo sostituirà, come farà negli Atti degli apostoli?
L'unica cosa interessante della pericope è che si contrappone la politica come servizio alla politica come dominio, la democrazia alla monarchia e all'aristocrazia. Chi s'impegna democraticamente in politica deve essere un idealista, cioè deve credere nella possibilità di cambiare le cose, deve essere una persona in grado di sopportare non pochi sacrifici, in quanto non avrà modo o tempo di pensare agli interessi personali, deve essere un militante moralmente irreprensibile, disposto all'autocritica, capace di collegialità e con un grande senso della concretezza e del realismo. Gesù chiede di imitare lui, non i grandi potenti della Terra, i quali sicuramente a Gerusalemme sarebbero entrati con un esercito ben armato, pronto a imporsi con l'uso della forza, come già avevano fatto e continueranno a fare i Romani (e altri prima di loro).
VII
Il racconto relativo al rinnegamento di Pietro ha un che di paternalistico (22,31 ss.). Si ha l'impressione che Luca voglia dire che di fronte a un impero come quello romano non vi era alcuna possibilità di vittoria politico-militare; l'unica, quindi, era di affidarsi alla salvezza etico-religiosa.
Qui Pietro viene presentato da Luca in due vesti: quella del giovane rivoluzionario (si può presumere zelota), sicuro di sé quando dice espressamente che per Gesù sarebbe stato disposto persino a morire (v. 33), e parecchio fiducioso sulle reali capacità delle forze galilaico-giudaiche in campo; e quella dell'uomo maturo, rassegnato, il quale dovrà semplicemente “convertirsi” al misticismo e “confermare” gli altri discepoli. Qui si può facilmente intravvedere che al tempo di Luca Pietro veniva considerato come uno dei fondatori del cristianesimo, con la sua interpretazione apodittica della tomba vuota come “resurrezione”, in luogo di quella sospensiva, problematica, interlocutoria circa una “misteriosa scomparsa del corpo”.
Stranamente però Luca fa dire a Gesù una cosa che all'apparenza non sembra avere alcun senso, come spesso succede nei vangeli. “Quando vi mandai [a predicare] senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: Niente. Ed egli disse loro: Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: Egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riferiscono a me, stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade! Ma egli disse loro: Basta!” (vv. 35-38).
Qui è evidente che Gesù sta prospettando ai discepoli due situazioni completamente diverse, di cui la prima sta per concludersi col proprio martirio, mentre nella seconda gli apostoli dovranno avere sufficiente energia per cavarsela da soli. Ma cosa c'entra la richiesta di acquistare delle spade? E perché metterle in relazione col fatto ch'egli verrà giudicato come un “malfattore”? Si noti, peraltro, che, come egli nomina la parola “spada”, subito alcuni discepoli gli porgono la loro. Ciò a testimonianza che andavano in giro armati e che soprattutto lo erano quando entrarono a Gerusalemme per l'ultima volta.
Qui delle due l'una: o Luca si è sentito libero di dire una cosa che forse avrebbe fatto meglio a tacere, in quanto non avrebbe dovuto turbare i suoi lettori; oppure il suo riferimento alla parola “spada” va interpretato in maniera puramente simbolica (in tal caso però gli apostoli non avrebbero capito le parole di Gesù, in quanto le prendono alla lettera).
Forse intendeva emulare san Paolo, che nelle sue lettere parla di corazza, elmo, scudo, spada in maniera metaforica, quando cerca dei paragoni per qualificare la fede e le virtù cristiane. Per Paolo infatti la battaglia del cristiano non era contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potestà dell'aria: una battaglia puramente spirituale (cfr 1Ts 5,8).
È stato forse questo ciò che Gesù ha chiesto agli apostoli, che avrebbero dovuto sentirsi, di lì a poco, come orfani del loro leader? Non sarebbe stato un modo di prendersi gioco di loro? Per quale motivo parlare con un linguaggio che non avrebbero assolutamente potuto capire? Gli evangelisti non si rendono mai conto che se anche Gesù fosse stato quel che dice d'essere nei loro testi, egli non avrebbe mai potuto usare un linguaggio indecifrabile per i propri interlocutori. Non è possibile giustificare delle espressioni così criptiche facendo leva sulla convinzione ch'egli avesse un'origine divina. Che speranza potrebbe avere un “extraterrestre” di essere apprezzato dagli esseri umani se mostrasse continuamente la propria superiorità? Gli uomini si sentirebbero completamente schiacciati e se anche avessero una prova assoluta della sua origine divina, non per questo si dovrebbero sentire maggiormente indotti a credergli. E questo atteggiamento circospetto varrebbe per tutti, ebrei e non ebrei.
Cerchiamo di spiegarci. Il Gesù dei vangeli, a contatto soprattutto con gli ebrei, esibendo continuamente la sua natura divina, nei confronti della quale essi restavano sempre increduli, ha fatto passare questo popolo per una massa di dannati senza alcun principio etico, incapaci di credere nell'evidenza e morbosamente fanatici. I vangeli, in altre parole, hanno usato la presunta e sbandierata divinità del Cristo in funzione nettamente antisemitica. Sotto questo aspetto vien da pensare che la crocifissione del Cristo possa anche trovare le sue motivate giustificazioni storiche (che sono poi prevalentemente politiche).
Questo poi senza considerare che se davvero Gesù fosse stato un dio e se da quello che faceva lo si sarebbe potuto facilmente capire, chi avesse rifiutato di credergli mentre lui era in vita, che parole potrebbe mai usare o quale atteggiamento tenere per poter essere perdonato, una volta giunto, con la propria anima, al cospetto di chi aveva deriso, tradito, torturato e crocifisso? Gli basterebbe forse la convinzione cristiana secondo cui il Cristo “doveva morire” per la salvezza dell'umanità intera? Potrebbe forse consolarlo questa assurdità, elaborata post-eventum, per giustificare la propria inettitudine politica? E se anche la sua anima venisse spontaneamente perdonata dal Cristo in persona, seduto sul trono della sua gloria, prima ancora ch'essa riesca a contrirsi per ciò che di vergognoso aveva fatto e detto contro di lui, davvero essa riuscirebbe a perdonare se stessa? Riuscirebbe a farlo al cospetto di tutti quelli che invece avevano creduto in lui? Si rendevano conto gli evangelisti di aver scritto qualcosa che, per molti versi, era assolutamente orribile? Si rendevano conto che se il Cristo era davvero una persona sovrumana, non avrebbe potuto mostrarlo neppure nella più piccola occasione, proprio per lasciare liberi gli uomini di credere o di non credere in lui? E quindi liberi di pentirsi umanamente nel caso in cui non gli avessero creduto?
VIII
Il racconto dell'agonia di Gesù nel giardino del Getsemani (22,39 ss.) pesca nel vero solo in questo senso: sia Gesù che gli apostoli temevano che, se Giuda avesse rivelato il nascondiglio segreto, per loro si sarebbe messa molto male e l'insurrezione – qualora la popolazione non fosse insorta – rischiava seriamente di fallire. È però assurdo pensare – come invece risulta dal testo – che solo lui, per tale ragione, fosse in apprensione.
Far dormire i discepoli, mentre lui suda sangue, è stata una scelta redazionale infelice. Luca ha voluto porre un abisso tra quei protagonisti, una distanza incolmabile, quando invece tutti erano pronti al peggio, anche perché la fuga, da quel posto, non era certamente facile. Se nel momento più delicato non si è capaci di estrema coerenza e determinazione, il fallimento può portare anche a conseguenze catastrofiche.
La città, nei suoi gangli vitali, andava occupata, dal Tempio alla torre Antonia, dal Sinedrio al palazzo di Erode. I sommi sacerdoti, i sadducei, molti esponenti del Sinedrio andavano arrestati o comunque resi inoffensivi, poiché dalla città non sarebbe dovuto uscire nessuno. Alla guarnigione romana e alla polizia del Tempio si sarebbe offerta la vita in cambio della resa. Altre condizioni non potevano esserci.
Tutte queste cose gli apostoli dovevano saperle perfettamente. È quindi assurdo pensare che nel Getsemani dormissero per la stanchezza o per la “tristezza” (v. 45). Né ha senso che Gesù abbia detto loro di “pregare per non cadere in tentazione” (v. 40). Quale “tentazione” potevano avere in quel momento e, per di più, mentre dormivano? Considerando che i vangeli sono una mistificazione a favore del compromesso tra cristianesimo, ideologia pagana e politica romana, la “tentazione” da superare poteva essere una sola, nella mente opportunistica di un redattore moralista come Luca: quella di voler comunque rischiare di compiere l'insurrezione, nonostante che il Cristo avesse già dichiarato d'essere disposto al sacrificio di sé, all'autoimmolazione per riconciliare il genere umano col Padre eterno.
Invece qual era la vera tentazione da superare? Quella di voler compiere ugualmente l'insurrezione, nonostante il tradimento di Giuda, o di non volerla compiere proprio a causa di tale tradimento. A volte, infatti, si può essere sicuri di farcela anche in presenza di un tradimento, benché gli strateghi sappiano bene che è di capitale importanza saper cogliere il nemico del tutto impreparato, incapace di reagire con la dovuta prontezza. Altre volte invece si sopravvaluta la gravità del tradimento di qualcuno.
Dunque cos'ha in mente il conservatore Luca? Che di fronte al tradimento di Giuda gli apostoli assumano un atteggiamento troppo illusorio o troppo rassegnato? Niente di tutto questo. Piuttosto egli ha in mente una cosa che nel contesto non poteva avere alcun senso. Vuol far apparire Gesù lontanissimo dai discepoli. Quello che Gesù chiede a Dio-padre è di non farlo morire, ma se questo desiderio è contrario all'economia salvifica che lo stesso Padre ha deciso per l'umanità, allora non si tenga conto della sua richiesta. La debolezza manifestata da Gesù, che Luca vuol far apparire “umanissima”, è quella della paura o della vigliaccheria, non nei confronti degli uomini ma nei confronti del Dio-padre, qui considerato come il “mandante” di tutta l'impresa soteriologica. Gesù non può avere neppure la tentazione di voler trionfare sui suoi nemici, usando i suoi poteri sovrumani. Non può provare un desiderio del genere proprio perché il suo messaggio vuol essere religioso, non politico e, in fondo, neppure politico-religioso (come p.es. quello che avevano gli zeloti).
Semplicemente quindi Gesù non vorrebbe morire, ma non può neppure disobbedire al Padre che lo vuole in croce, al fine di far perdere agli ebrei il loro primato storico (cioè il patto di alleanza privilegiata con la divinità) e di poter così offrire la salvezza etico-religiosa al mondo intero. Gesù non può fare la parte del suicida; è meglio far fare al Dio-padre la parte del giustiziere, che, dall'alto della sua insondabile saggezza, ha bisogno di qualcosa di terribile per ottenere un risultato grandioso, di carattere universale.
Tutto il mondo, infatti, deve sapere che se il cosiddetto “popolo eletto” ha ridotto così il più grande leader della sua storia personale e di tutta la storia del genere umano, allora vuol dire che, d'ora in avanti, tutti gli esseri umani vengono posti sullo stesso piano, cioè la divinità non farà più differenza tra ebreo e pagano, come non ne farà tra oppresso e oppressore, in quanto la liberazione viene necessariamente rimandata all'aldilà, quando di essa tutti potranno essere partecipi a pari titolo.
In ogni caso la tentazione cui gli apostoli avrebbero dovuto sottrarsi, e per la quale avrebbero dovuto vigilare e non dormirci sopra, era quella di reagire in maniera scomposta quando vedranno improvvisamente le guardie armate giungere al Getsemani per arrestarli tutti. Una tentazione in cui Pietro cadrà in pieno quando cercherà di ammazzare il servo del sommo sacerdote, cui però Gesù reagirà prontamente, offrendosi spontaneamente alla cattura, a condizione che i suoi discepoli possano dileguarsi.
IX (fonti)
L'ultima parte dei vangeli, a partire dalla cattura di Gesù nel Getsemani, per quanto mistificante essi possano essere, resta sempre straziante e, per molti versi, commovente. Non per questo, tuttavia, possiamo esimerci dal darne un'interpretazione la più possibile obiettiva. Se ci lasciamo condizionare troppo dall'emotività, finiremo col diventare complici di una insostenibile manipolazione dei fatti. Semmai sarà la storia a decidere quale esegesi si è maggiormente avvicinata alla verità dei fatti.
A proposito dell'arresto di Gesù, il racconto relativo al tradimento di Giuda (22,47 ss.) ha qualcosa di ripugnante, che Luca avrebbe potuto risparmiarsi, in quanto molto inverosimile, benché sia presente anche in Marco e Matteo. Si tratta del “bacio” che Giuda diede a Gesù. Che senso poteva avere? Forse per farlo riconoscere subito alla folla armata? Eppure è lo stesso Luca che fa dire a Gesù che ogni giorno era con loro nel Tempio a discutere (v. 53). Se Luca non seguisse pedissequamente la cronologia marciana dei fatti, secondo cui Gesù si recò a Gerusalemme solo una volta, per concludervi tragicamente la sua esistenza, dovremmo dire che è assolutamente contraddittorio che la milizia nel Getsemani avesse bisogno di un particolare segno di riconoscimento nei confronti di un uomo ch'era conosciuto sin da quando, all'inizio della sua carriera, aveva cercato di compiere una sommossa contro i gestori del Tempio.
O forse Luca voleva far vedere che Giuda stava tradendo per un fine di bene (ancorché male interpretato)? Per esempio quello di salvare Israele dalla ritorsione delle legioni romane (che si poteva facilmente presumere sarebbe stata terribile) di fronte al tentativo insurrezionale che i discepoli del nazareno volevano compiere. Ovvero l'aveva baciato per far vedere agli altri apostoli che tra i due vi era un'intesa privata, a loro del tutto sconosciuta? Gesù voleva forse farsi catturare e Giuda stava eseguendo un suo piano? E quindi, per non far capire questo patto segreto agli apostoli, aveva deciso di nascondersi con loro nel Getsemani?
Queste sono tutte supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Indubbiamente nel buio di quella notte, nell'intrico degli alberi, la turba armata poteva avere qualche difficoltà a scovare Gesù, ma nel quarto vangelo viene detto chiaramente che fu lui stesso a consegnarsi spontaneamente e nessuno, tra i nemici, dubitò che fosse proprio lui. Quindi non ci fu alcun bacio: semplicemente Giuda doveva per forza essere presente alla cattura. E tutta quella folla armata si spiega soltanto col fatto che Giuda doveva aver detto che gli apostoli avrebbero sicuramente difeso il loro leader con la spada; tant'è che Pietro lo fece anche prontamente, cercando di spaccare la testa al servo del sommo sacerdote (cosa confermata dall'evangelista Giovanni, che di quel servo conosceva, stranamente, anche il nome).
Un po' patetico il gesto di Gesù di riattaccare l'orecchio al servo (22,51): se davvero l'avesse fatto tutti sarebbero dovuti rimanere a bocca aperta. Chi stavano arrestando? Un prestigiatore? Un extraterrestre? In che maniera avrebbero potuto tenere legato un soggetto del genere? Luca purtroppo non perde mai l'occasione d'inventarsi qualcosa per rendere il suo eroe sempre più straordinario, e lo fa senza rendersi conto di ottenere, in questa maniera, proprio l'effetto contrario, cioè di trasformarlo in un qualcosa di favolistico, di fantasioso. Avrebbe fatto meglio a scrivere che l'autoconsegna spontanea di Gesù era correlata al fatto che in cambio egli aveva chiesto di lasciar andare liberi i propri discepoli: in tal modo non ci sarebbe stato alcuno scontro armato, dove sicuramente anche qualcuno di quegli armati ci avrebbe rimesso la pelle. In sostanza, anche in quel momento così drammatico, egli era stato in grado di conservare un ottimo sangue freddo, in quanto aveva capito subito che le forze in campo erano troppo sproporzionate per avere la meglio, mostrando, nel contempo, un alto senso della democraticità e dei valori umani.
Il bacio quindi è stato qualcosa del tutto fuori luogo, di tipo teatrale, per mettere in risalto una forzata contrapposizione tra mezzo (il bacio) e fine (il tradimento). Giuda non avrebbe potuto avere il coraggio di compiere una cosa così vergognosa in un momento come quello. Anzi, si può tranquillamente pensare ch'egli non volesse finalizzare il tradimento al patibolo, bensì a un semplice arresto. Gesù non doveva essere consegnato a Pilato, ma semplicemente fermato. Impossibile qui non vedere una responsabilità oggettiva da parte dei farisei.
I Sinottici, rappresentando Giuda così abietto e spregevole, l'hanno reso del tutto inverosimile; anche perché difficilmente Gesù avrebbe potuto tenere con sé, tra i discepoli più fidati, una persona del genere, né gli avrebbe mai permesso, in quel frangente, di baciarlo, sapendo benissimo che sarebbe stato un gesto ipocrita, meritevole di un'ampia vendetta da parte degli apostoli.
Si è detto che di notte sarebbe stato difficile catturarlo, ma è anche vero che non avrebbe avuto senso accedere al Getsemani senza torce e lanterne (Giovanni dice chiaramente che le avevano). Si è anche detto che se era davvero presente – stando al quarto vangelo – anche la coorte romana (18,3), che non conosceva Gesù come le guardie giudaiche del Tempio, è anche vero che la coorte sarebbe intervenuta soltanto in caso di estremo pericolo: cosa che non ebbe bisogno di fare appunto perché Gesù si arrese subito e non fu portato davanti a Pilato (che lo vedrà il mattino dopo), ma davanti ai sommi sacerdoti.
X
Nell'episodio del rinnegamento di Pietro (22,54 ss.) due cose saltano agli occhi: 1) la totale assenza dell'apostolo Giovanni (ma qui Luca si rifà a Marco); 2) la scena teatrale in cui Gesù, al momento del terzo rinnegamento, guarda Pietro in faccia, come per voler confermare la profezia di natura divina che gli aveva fatto poche ore prima.
Un'altra cosa però bisogna sottolineare: mentre nel quarto vangelo il canto del gallo è una semplice indicazione cronologica (s'era fatta mattina), seppur sfruttata da un secondo redattore di quel vangelo in chiave mistica, nei Sinottici viene dato per acquisito che andasse interpretata esclusivamente in chiave mistica. Quindi la fonte di questo misticismo non poteva essere che lo stesso Pietro, il quale, facendo coincidere il proprio terzo rinnegamento col canto del gallo, previsto dalla “natura divina” del Cristo, ha ottenuto un doppio risultato: 1) ha voluto dimostrare che Gesù era davvero una persona sovrumana; 2) ha voluto dimostrare che di fronte a una persona del genere l'essere umano è ben poca cosa, per cui la gravità del rinnegamento andava relativizzata.
In altre parole Pietro (qui come fonte di Marco e quindi indirettamente di Luca) si è umanamente abbassato per esaltare misticamente la natura divina del Cristo. In questa maniera persino il tradimento di Giuda perde la sua gravità: tutto viene ricompreso dentro una più generale mistificazione dell'operato del Cristo (sottoposto a una superiore volontà divina, non molto dissimile dal fato della cultura greca).
Sul piano più propriamente logistico Luca non spiega in alcun modo come Pietro potesse trovarsi nel cortile del sommo sacerdote: una cosa, infatti, era seguirli da lontano; un'altra poter accedere nel cortile della sua casa. Solo il quarto vangelo è in grado di spiegare la dinamica reale dei fatti, e soprattutto che ci si trovava in casa non del sommo sacerdote Caifa, ma di quello precedente, chiamato Anna o Anania, i cui ambienti Giovanni, evidentemente, doveva conoscere piuttosto bene, o doveva aver frequentato prima di entrare nel movimento nazareno e forse prima ancora di frequentare quello del Battista.35
Qui Luca riprende la traccia indicata da Marco, per il quale soltanto Pietro ha avuto il coraggio di seguire da lontano il gruppo armato che aveva arrestato Gesù. Un coraggio che verrà pagato, è vero, dal rinnegamento, ma che potrà comunque essere esibito nei confronti di tutti gli altri apostoli, fatti passare per dei codardi. Qui è difficile non vedere che – come d'altra parte già in Marco – tra Pietro e Giovanni i rapporti dovevano essersi irrimediabilmente guastati, e probabilmente quasi subito dopo la scoperta della tomba vuota.
Proseguendo nella contestualizzazione, appare piuttosto ridicolo che una serva riconosca Pietro come uno che era con Gesù: questo perché non viene detto quando l'aveva visto insieme a lui. Di sicuro, infatti, non poteva essere accaduto sul Getsemani, dove si prospettava uno scontro armato. E neppure durante l'ingresso messianico, dove sarebbe stato impossibile notare uno come Pietro tra centinaia, forse migliaia di persone. Anche qui bisogna andarsi a leggere il quarto vangelo, il quale afferma che la serva conosceva bene non Pietro bensì lo stesso Giovanni, sicché fu quest'ultimo a farlo entrare nel cortile col permesso della donna.
L'ultima scena ha qualcosa di quasi comico: una guardia lo riconosce tranquillamente come “galileo” e quindi dà per scontato che sia un affiliato del movimento di Gesù, eppure non fa nulla per arrestarlo. Naturalmente si può sempre pensare che, al momento dell'ingresso messianico, i Giudei si confondessero coi Galilei; ed è anche possibile che la guardia avesse dedotto la provenienza geografica di Pietro semplicemente sentendolo parlare, ma è davvero incredibile che nessuno abbia tratto da ciò le dovute conseguenze. Sarebbe stato alquanto pericoloso soprassedere al rischio che Pietro, in quell'occasione, potesse compiere un'azione ai danni del sommo sacerdote. Quella volta se qualcuno del servizio d'ordine fosse venuto meno ai propri doveri di vigilanza, poteva anche rimetterci la vita. Ma su questo neppure Giovanni fa chiarezza, probabilmente perché era proprio lui che garantiva a Pietro l'incolumità; e questo può anche far pensare che i rinnegamenti dell'apostolo siano stati una forma di sfiducia nei confronti dello stesso Giovanni, o comunque una cosa ch'egli avrebbe potuto tranquillamente evitare, senza rischiare più del dovuto.
In ogni caso quel che dà fastidio nel resoconto di Luca è che quando prende per buoni determinati racconti marciani, viziati da una certa tendenza mistica, li porta all'eccesso inserendoli in una cornice melodrammatica.
XI
Per come è stata contestualizzata, la parte relativa agli insulti, agli sberleffi e alle percosse a carico di Gesù, che Luca riporta alla fine del cap. 22, bisogna dire che è del tutto fantasiosa. Probabilmente è stata messa per far vedere la differenza tra Ebrei e Romani sul piano giuridico. Essendo profondamente antisemita, Luca ci tiene a inventarsi una sorta di processo giudaico, in cui l'accusato viene anzitutto schernito e malmenato (22,63), poi insultato (v. 65), infine interrogato e giudicato in maniera prevenuta, in quanto la sentenza risulta prestabilita.
Vi sono incongruenze inconcepibili in uno scrittore che si qualifica come storico. Anzitutto il fatto che le guardie, dopo aver bendato Gesù, gli chiedano d'indovinare chi è stato a percuoterlo. Come se sapessero che lui avrebbe potuto farlo! Cosa che, se poi l'avesse davvero fatta, li avrebbe lasciati sbigottiti e senza parole, al punto che forse avrebbero preferito liberarlo. Luca vuol far vedere che Gesù, pur potendo indovinare, a occhi chiusi, chi lo malmenava, si astenne dal farlo per mostrare la sua profonda umiltà, conformandosi così alla volontà divina, secondo cui egli doveva salire sul patibolo.
Non solo, ma egli lascia intendere che un atteggiamento così aggressivo e fuori luogo non avrebbero potuto tenerlo i militari romani (acquartierati nella fortezza Antonia). In verità però – come spiega Giovanni – furono proprio loro a comportarsi così, e ovviamente senza fare riferimento ad alcuna ipotetica natura divina del Cristo. Semplicemente si facevano beffe di lui, in quanto, vedendolo entrare in pompa magna a Gerusalemme, non potevano non aver temuto per la loro sorte, almeno per un momento, in via ipotetica. Tutto quello che gli fanno era appunto per screditarlo come messia o come pretendente al trono d'Israele.
Invece Luca se la prende con gli ebrei, ch'egli dipinge come aguzzini, poiché negano brutalmente ciò che per loro dovrebbe essere un'evidenza incontrovertibile, e cioè che Gesù era di natura divina. Luca sembra non capire che chiunque si fosse dichiarato “Figlio di Dio”, per loro era, peraltro giustamente, paragonabile a un bestemmiatore; diventava un eretico assolutamente insopportabile, meritevole di morte. Infatti, o si è tutti “Figli di Dio”, in maniera generica o traslata, o non lo è nessuno in via esclusiva.
Paradossalmente però, quando i sinedriti sentono affermare da Gesù in persona ch'egli è “il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio” (v. 69), pur arrivando a dire ch'egli si condannava da solo e che quindi non avevano bisogno di altra testimonianza contro di lui, invece di lapidarlo seduta stante (come p.es. faranno col diacono Stefano), decidono di consegnarlo a Pilato. Ma se la colpa era religiosa, cosa c'entrava l'autorità romana?
Qui Luca, riprendendo la tesi di Marco, è abbastanza scaltro: vuole dimostrare che Gesù è stato eliminato per motivi religiosi e che però questi motivi furono mistificati dal fatto che, consegnandolo a Pilato, i Giudei s'inventarono un pretesto di tipo politico, facendo vedere ch'esso non era meno importante dell'accusa di tipo religioso; in pratica temevano di non avere forze sufficienti per eliminare un soggetto così popolare.
Sui motivi religiosi ci sarebbe da scrivere un trattato a parte. Qui ci limitiamo a osservare l'assurdità della richiesta rivolta a Gesù di dichiarare se fosse davvero il Cristo, cioè il messia (v. 67), il liberatore nazionale: cosa che sapevano già, anche prima dell'ingresso trionfale in città. Peraltro, quello era un titolo che uno doveva guadagnarsi sul campo, dimostrando capacità organizzative, combattive, partecipative... Non era una prerogativa che uno poteva darsi da sé o che poteva ricevere per via ereditaria o attraverso un mandato del Sinedrio.
Quando le autorità vedevano che una persona era in grado di acquisire molta popolarità, si chiedevano se sarebbe potuta diventare un punto di riferimento politico significativo per la popolazione. Nei confronti del Battista, p.es., avevano mandato una delegazione di sacerdoti e di leviti (Gv 1,19) per sapere che intenzioni avesse sul piano politico, cioè se era disposto a diventare il messia. In fondo un messia liberatore lo aspettavano tutti, in quanto l'oppressione romana era divenuta insopportabile. Ma è altresì evidente che volevano essere le stesse autorità religiose a stabilire in che direzione egli dovesse muoversi. E purtroppo quelle autorità erano sommamente corrotte, sia perché appartenevano a una casta di privilegiati, sia perché erano colluse col potere romano. Da loro quindi non ci si poteva aspettare nulla di significativo. Anche il Battista l'aveva capito, per quanto non avesse avuto il coraggio di compiere, insieme a Gesù, l'epurazione del Tempio.
Ciò detto, appare davvero insensato che il Sinedrio (anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi) chiedesse a Gesù se fosse davvero il messia e che Gesù rispondesse: “Anche se ve lo dicessi, non credereste; e se io vi facessi delle domande, non rispondereste” (vv. 67-68).
Si noti come queste frasi del Cristo possano essere interpretate anche in maniera antisemitica. Luca infatti sembra dare per scontato che tra il Cristo e il Sinedrio non potesse esserci la possibilità di alcuna intesa. Nel quarto vangelo invece la cosa è molto più sfumata. D'altra parte se un leader si presenta come una “divinità”, avrebbe mai potuto esserci, da parte dell'interlocutore, una qualche forma di assenso? una qualche disponibilità al dialogo?
È incredibile che Luca sia così severo nei confronti dei membri del Sinedrio, quando, in tutti i vangeli, erano gli stessi apostoli a non capire nulla della natura divina del Cristo. Egli dà un'interpretazione dei fatti quanto mai tendenziosa e fuorviante. E questo non perché non vi fosse una incompatibilità di vedute politiche tra Gesù e i suoi oppositori, quanto perché quella incompatibilità, ch'era relativa, essendo basata su interessi in gioco molto diversi, che, a rivoluzione avvenuta, avrebbero anche potuto ricomporsi, Luca la rende assoluta, in quanto, da perfetto moralista qual è, in nessun caso – secondo lui – gli ebrei avrebbero potuto credere nell'autenticità di un'autodichiarazione, da parte del Cristo, favorevole alla propria “divino-umanità”.
In particolare Luca non si rende conto che se anche, in astratto, si potesse accettare il termine di “divinità”, questa dovrebbe essere una qualità generale appartenente a qualunque essere umano, poiché, nel caso la s'intendesse esclusiva di qualcuno, sarebbe un diritto pienamente umano considerarla del tutto infondata.
Il titolo di “messia” non era un qualcosa di spregevole o di inammissibile. Luca sembra avere, circa questo appellativo, delle idee piuttosto confuse, tant'è che, ad un certo punto, lo fa coincidere, arbitrariamente, con un altro titolo: quello appunto di “Figlio di Dio”, un titolo ch'egli attribuisce a Gesù in via esclusiva, come se soltanto lui avesse il diritto di esserlo.
In tale maniera Luca unisce un titolo politico a uno teologico, dando per scontato che tale identificazione fosse un dato acquisito da parte del Sinedrio. Nulla di più antistorico. Se avesse accettato il titolo di “messia”, il Sinedrio, al massimo, avrebbe potuto accettare anche quello di “Figlio di Dio” secondo un significato simbolico, certamente non letterale. Un messia liberatore avrebbe potuto essere considerato un “santo” sensu lato, nella misura in cui fosse effettivamente riuscito a liberare la Palestina dall'oppressione romana. Per un qualunque ebreo attribuire la “divinità” soltanto a una particolare persona, sarebbe stato assolutamente inconcepibile. Non a caso detestavano gli imperatori proprio su questo punto. E avrebbero trovato legittimo comportarsi nella stessa maniera anche nei confronti di Gesù. Luca, infatti, lo sa e ne approfitta per far coincidere una sentenza politica con una di tipo teologico-politico.
Questa cosa, la cui importanza è decisiva per capire la differenza tra ebraismo e cristianesimo, occorre che qui venga ribadita a chiare lettere: il Sinedrio – nella versione sinottica – condanna Gesù perché lui pretende d'essere un “Figlio di Dio” in via esclusiva, cioè non uno tra quei tanti che nel passato si meritarono un titolo del genere per meriti personali, ma l'unico, vero, “Figlio di Dio”, di “natura” non per “partecipazione”, secondo la teologia paolina. Infatti Gesù dice: “D'ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio” (v. 69). Per gli ebrei una frase del genere era una forma di “ateismo”, in quanto si riduceva Dio a un'espressione umana, gli si faceva perdere la qualità d'essere “totalmente altro”. Luca lo sa e se ne serve per attribuire al fanatismo religioso giudaico la decisione di mettere a morte Gesù.
Di che “fanatismo” sta parlando? Quello appunto di non credere nella eccezionalità o unicità del Cristo nell'ambito dell'intero genere umano. Questo modo di vedere le cose, da parte di un redattore che ritiene d'essere uno “storico”, è abbastanza incredibile, e lo sarebbe anche nel caso in cui lo storico dichiarasse d'essere una persona “religiosa”. Infatti gli apostoli hanno iniziato a credere in una possibile “divinità” del Cristo soltanto dopo la constatazione della tomba vuota. Qui Luca vuol far parlare Gesù come se questa acquisizione tutti avrebbero dovuto averla mentre lui era ancora in vita.
Dopo aver spoliticizzato al massimo la figura di Gesù, Luca ha trasformato un'accusa politica (che, p.es., avrebbe potuto avere il seguente tenore: “Vuoi fare un'insurrezione senza il consenso del Sinedrio?”, oppure: “Fare un'insurrezione contro una potenza come Roma, significa condannarci a una sconfitta sicura”, ecc.) in un'accusa esclusivamente teologica: “Chi si fa come Dio merita di morire, perché sommamente eretico”. Questo per dire che in quella udienza davanti al Sinedrio, per come viene descritta dai Sinottici e quindi anche da Luca, si ha l'impressione di avere a che fare non con uno bensì con due fanatismi: uno giudaico, che non vuole riconoscere a nessuno una qualità sovrumana; e uno cristiano, che vuole riconoscerla a priori esclusivamente al Cristo.
Ma se le cose stessero effettivamente in questi termini, davvero avremmo a che fare con un fondamentalismo di tipo giudaico? I membri del Sinedrio non avevano forse ragione a negare alla pretesa messianicità del Cristo la componente divina? Se le cose vengono affrontate esclusivamente sul piano teologico, i cristiani risultano essere molto più fanatici degli ebrei. Se invece vengono guardate soltanto su quello politico, allora bisogna dire che i membri del Sinedrio volevano la morte di Gesù perché sapevano bene che se egli, come messia, avesse trionfato sui Romani, il destino, per molti di loro, era segnato, in quanto si comportavano come una casta corrotta, privilegiata, complice di un potere oppressivo.
Aver trasformato un dialogo politico in un dialogo meramente teologico è stata un'operazione che ha mistificato profondamente la natura del problema, e in questo Luca non ha fatto altro che allinearsi supinamente alla lezione petro-paolina.
XII
I dialoghi tra Gesù e i suoi oppositori sembrano dialoghi surreali. Gesù parla come se provenisse da un altro pianeta e non fa (o non può fare) alcuno sforzo per farsi capire, proprio perché la sua semantica si pone a un livello troppo superiore, troppo complesso e sofisticato, non tanto perché vengono usate parole provenienti da un vocabolario difficile, p.es. filosofico, quanto perché esse rimandano a realtà o entità irrappresentabili dal punto di vista umano.
Gesù Cristo, semplicemente, non poteva essere capito per ciò che diceva, a prescindere dal significato delle sue singole parole, poiché dietro ad esse si nascondeva sempre qualcosa di mistico, di metastorico, di sovrumano. Non avrebbe potuto essere capito neppure se egli stesso lo avesse voluto, poiché, da come gli evangelisti lo rappresentano, sembra ch'egli stesso sia consapevole dell'incredibile abisso che lo separa dagli interlocutori. Parla come se fosse già morto e risorto. Ma perché lo si fa parlare così? Per scaricare tutte le colpe sugli ebrei di non averlo capito?
Oggi diremmo che siamo in presenza di un dialogo tra sordi, oppure di un dialogo kafkiano, in cui uno parla, dall'alto della propria competenza specialistica, e l'altro ascolta senza capire quasi nulla, oppure pone domande che non colgono l'essenza del problema. Dialoghi di tal fatta, ma senza intenti mistici, si ritrovano anche in molti testi platonici, ove Socrate ha sempre ragione e tutti gli altri sembrano non capire nulla o avere un senno molto ridotto a confronto del suo.
Il bello è che gli evangelisti non si preoccupano affatto di questa discrepanza comunicativa, che pur salta subito agli occhi; anzi, tendono ad accentuarla, proprio per avvalorare al massimo la loro fede religiosa, sminuendo la capacità d'intendere da parte degli ebrei. Questo, nel vangelo manipolato di Giovanni, è evidentissimo. L'incomprensione per le parole di Gesù, che i Giudei manifestano, viene addirittura attribuita a una pervicace volontà di non capire, di non ammettere l'evidenza della natura divina del Cristo. I suoi interlocutori vengono ridicolizzati, fatti passare per un popolo mentalmente chiuso, pervicacemente votato al male.
Quindi anche dalla modalità con cui vengono elaborate le discussioni tra Gesù e i suoi oppositori, si può facilmente notare un marcato antisemitismo nei vangeli. Gli interlocutori non solo non capiscono perché non vogliono capire, ma quanto meno capiscono tanto più fanno aumentare il grado teologico dei discorsi di Gesù.
XIII
Davanti al Sinedrio36, alla domanda: “Sei tu il Figlio di Dio?”, Gesù aveva dato la risposta: “Voi stessi lo dite” (22,70). Ora, davanti a Pilato, che gli chiede: “Sei tu il re dei Giudei?”, risponde nella stessa maniera: “Tu lo dici” (23,3). Là la domanda era di tipo teologico, qui è di tipo politico.
Luca fa passare Pilato per un governatore intelligente, in grado di rendersi conto che le questioni meramente religiose, finché restano interne al popolo ebraico, non sono di sua competenza; al massimo lo diventano nelle conseguenze che possono determinare sul piano politico.
In ogni caso le risposte di Gesù sono identiche. Che significato possono avere? Nella lingua italiana non è così chiaro. Se io dico: “Lo dici tu”, potrei anche escludere che una determinata affermazione sia davvero come la intende il mio interlocutore. Se invece dico: “Tu lo dici”, potrei voler dire che io lo confermo e che tu comunque devi assumerti le tue responsabilità per quello che dici. Cioè se dimostri d'essere cosciente di ciò che dici, non dovresti comportarti in maniera incoerente.
Ora, qui sarebbe difficile pensare che il Gesù di Luca voglia negare valore a ciò che i suoi oppositori dicono di lui. “Se sei il Figlio di Dio, dillo apertamente”; “Voi lo dite”; “Ecco, l'ha detto lui stesso, non abbiamo bisogno di altra testimonianza”. Cioè Gesù non ha avuto bisogno di confermare in prima persona ciò che gli altri pensavano di lui (dicendo: “Sì, lo sono”); eppure, dalla risposta che ha dato, gli oppositori han creduto che parlasse in prima persona. Quindi appare evidente che con quel suo modo strano di rispondere, egli intendeva dire qualcosa in prima persona.
In ebraico questo modo potrebbe anche essere una forma di galanteria, di rispetto dell'avversario. Se questi afferma una verità, Gesù non ha bisogno di ribadirla usando la prima persona: gli è sufficiente confermare una verità altrui (o una supposizione). Si risponde affermativamente a una domanda come per voler dire all'interlocutore che la risposta è già contenuta nella sua stessa domanda, per cui il merito della verità va al interlocutore, il quale, formulando correttamente la domanda, ha già capito il problema, il modo di affrontarlo e di risolverlo. Poi dipenderà da lui se sceglierà proprio il modo giusto o se invece lo vorrà rifiutare.
Tuttavia, se le cose stanno così, c'è qualcosa che non va. Infatti, nel primo caso, quello davanti al Sinedrio (che è un consesso politico-religioso), ci può stare, in astratto, la risposta teologica di Gesù (nel concreto, infatti, dobbiamo supporre che sia la domanda sia la risposta siano puramente redazionali). Nel secondo caso invece, quello davanti a Pilato, non si capisce il motivo per cui avrebbe confermato d'essere il re d'Israele. Il suo regno non era forse di un altro mondo? nella Gerusalemme celeste?
Ma la cosa più strana è un'altra ancora. I sinedriti consegnano Gesù sulla base di queste accuse: “sovverte la nostra nazione, proibisce di pagare i tributi a Cesare, dice di essere il Cristo re” (23,2). E sono accuse che, dal punto di vista politico, sono molto gravi per il procuratore romano. Quest'ultimo, però, dopo aver ottenuto conferma da Gesù ch'egli vuole porsi come re politico d'Israele, se ne esce con una conclusione sconcertante, per la quale si sarebbe meritato una immediata rimozione da parte del suo superiore: “Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo” (23,4). Lo dice come se sapesse in anticipo che i Giudei mentono, o come se sapesse che, siccome non hanno sufficiente credibilità per far fuori uno che gode di grande popolarità sul piano religioso, preferiscono delegare a lui la decisione di comminare una sentenza capitale sul piano politico. Oppure lo dice come se sapesse da tempo che l'accusato non è un leader politicamente pericoloso; ma, in tal caso, si deve tornare alla supposizione precedente: “i Giudei mentono”. E Pilato può anche pensare che mentano per mettere lui, che governa la Giudea, in difficoltà. Infatti, s'egli mandasse ingiustamente a morte qualcuno, la cui popolarità è notevole, potrebbe favorire una reazione non facilmente controllabile, oppure scatenerebbe delle accuse a suo carico, che una delegazione potrebbe riferire all'imperatore (come faranno i Samaritani, rovinandogli per sempre la carriera).
Qui però si ha l'impressione che Luca abbia fatto dire quelle parole rassicuranti a Pilato per mostrare che dal punto di vista politico Gesù non costituiva alcuna vera minaccia per Roma; sicché lo stesso titolo di “re d'Israele” avrebbe potuto essere interpretato in una maniera esclusivamente religiosa (ovvero in una maniera politicamente metaforica).
Restavano però le altre accuse, di cui una era chiaramente falsa (stando al vangelo di Luca), quella relativa al tributo da pagare a Cesare. Su tale questione Gesù si era già espresso, dichiarando che il tributo andava pagato, almeno finché nelle monete appariva l'effigie dell'imperatore.
Che Gesù poi fosse “politicamente sovversivo” non lo si può certo inferire dal vangelo lucano, dove la sua figura è del tutto mitologizzata. Peraltro, se davvero fosse stato così pericoloso, Pilato l'avrebbe saputo ben prima che glielo consegnassero e si sarebbe risparmiato di formulare una domanda banale. Qui è evidente che Luca vuol salvargli la faccia, facendolo passare per un'autorità onesta, ancorché ingenua, in quanto alla fine verrà raggirato dai “perfidi ebrei”.
Le autorità giudaiche quindi insistono, aggiungendo un ulteriore dettaglio: Gesù “ha iniziato a sobillare il popolo partendo dalla Galilea, e ora lo fa per tutta la Giudea” (23,5). Come noto, questa è una ricostruzione falsata della vita di Gesù, in quanto la sua prima azione politica eversiva la fece proprio in occasione dell'epurazione del Tempio. In Galilea egli si recò dopo la sconfitta di quel tentativo insurrezionale contro la casta sacerdotale (dovuta al mancato appoggio del partito farisaico, che pur privatamente, con Nicodemo, l'aveva condiviso); se non avesse scelto l'esilio, l'avrebbero sicuramente arrestato. Ecco perché quando ai Samaritani raccontò che per lui il primato storico-religioso del Tempio era finito e che se qualcuno voleva adorare il proprio Dio, poteva farlo dove gli pareva, essi esultarono. E lo fecero anche i Galilei, quando videro che egli non riconosceva più alla Giudea alcun primato storico-politico su tutta la Palestina.
Qui il fatto che Pilato mandi Gesù da Erode Antipa, tetrarca della Galilea, per farlo giudicare da lui, titolare di una diversa giurisdizione, è poco convincente. Probabilmente rientra nel tentativo redazionale di apologizzare la figura del governatore romano, che addirittura si fa scrupolo di non scavalcare la competenza di un'autorità non romana, ma semplicemente alleata, seppure obtorto collo, in quanto Erode ambiva a governare territori ben più ampi di quelli che gli erano stati assegnati.37 In ogni caso davanti a Erode Gesù non disse nulla, per cui l'incontro dovette risultare piuttosto insignificante, tant'è che nessun altro vangelo lo riporta (in genere gli esegeti lo ritengono del tutto spurio).
Peraltro Luca, immaginifico quanto mai, sostiene che Erode non vedeva l'ora di assistere a qualche “miracolo” (23,8) da parte di Gesù, come se il prigioniero fosse un fenomeno da baraccone. Già il fatto che Gesù non abbia mai compiuto “miracoli”, sarebbe sufficiente a dimostrare che la pericope su Erode è del tutto inattendibile. Lo stesso particolare del “manto splendido” (23,11), che pur si ritrova anche in Mc 15,17 ed è confermato da Gv 19,2, in riferimento al comportamento beffardo dei soldati romani, rende l'episodio poco verosimile. Semplicemente Luca ha ricostruito falsamente le cose in modo da attribuire a una milizia non romana l'indegna condotta tenuta dai soldati della fortezza Antonia nei confronti di Gesù.38
La cosa strana è che Luca conclude la pericope dicendo che, dopo aver saputo che Gesù era stato “vilipeso e schernito” (23,11), Pilato ed Erode, da nemici che erano, divennero “amici” (23,12). Se anche ci mettessimo nella testa di Luca, faremo fatica a credere che l'amicizia nacque proprio per aver trattato Gesù in quella maniera. Forse sarebbe meglio pensare che Pilato, vedendo Erode rimandargli indietro il detenuto e rinunciare così ai propri diritti giurisdizionali, considerò il gesto come una forma di sottomissione e non mancò di apprezzarlo. Qualcuno però potrebbe anche pensare che l'amicizia nacque dal fatto che nessuno dei due considerava Gesù un soggetto politicamente pericoloso; il che è storicamente falso, sia perché sono gli stessi vangeli che riferiscono intenzioni omicide da parte di Erode nei confronti di Gesù (Mc 8,15; Lc 9,9; Lc 13,31), sia perché, pur di vederlo sul patibolo, Pilato si dichiarò disposto a liberare uno che alla croce era già destinato, lo zelota Barabba.
XIV
Luca ha posto le basi di quella storiografia cristiana che, pur di vedere la Chiesa esistere indisturbata, è disposta a scendere a compromessi coi poteri dominanti. In tal senso ci si chiede se davvero il socialismo costituisca una laicizzazione del cristianesimo e non invece dell'ebraismo. Cioè ci si chiede se sia più facile laicizzare una dottrina religiosa spiritualistica, tutta proiettata verso l'esistenza ultraterrena, e non invece una dottrina più materialistica, intenzionata a realizzare i propri ideali su questo pianeta. Terra promessa o Gerusalemme celeste? Su quale obiettivo oggi sarebbe più facile trovare un'intesa?
Indubbiamente il cristianesimo ha un carattere universalistico che l'ebraismo non sembra possedere, essendo legato a troppe formalità legali e rituali, ma è anche vero ch'esso ha guadagnato tale carattere rinunciando completamente a una politica rivoluzionaria. Non solo, ma quando la teologia della Chiesa cattolico-romana si fonde con la politica, il risultato è tutt'altro che rivoluzionario, a meno che ovviamente la politica in questione non sia influenzata da dottrine di stampo socialista.
Generalmente, infatti, là dove la teologia cristiana si unisce alla politica, si formano integralismi e fondamentalismi di varia natura. La teocrazia medievale è stato l'esempio più eloquente, ma anche il millenario Stato della chiesa, assai peggiore di qualunque Stato confessionale o di qualunque Chiesa di stato.
Il meglio di sé il cristianesimo lo dà quando favorisce il regime di separazione tra Chiesa e Stato, quando accetta l'idea di libertà di coscienza (garantita da uno Stato laico) e quando s'impegna nel risolvere i problemi sociali. Se il cristianesimo si trovasse a vivere in un sistema democratico del genere, dove la giustizia sociale fosse un valore effettivo, la transizione dal cristianesimo al socialismo sarebbe indolore e, in un certo senso, spontanea. Lo stesso ebraismo non avrebbe bisogno, per arrivare al socialismo, di passare attraverso il cristianesimo.
XV
Quando fa parlare Pilato in veste di giudice romano, Luca lo mette di fronte ai “capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo” (23,13). Si fa fatica a pensare a un giudice di tipo “giuridico”; visto l'uditorio, sembra più che altro un giudice di tipo “politico”, cioè una sorta di “prefetto” che deve vagliare un'accusa relativa all'ordine pubblico.
Luca lo fa rivolgere a tutto il popolo ebraico, dai gradi più alti (quelli politico-religiosi), a quelli medi (gli scribi), sino agli strati sociali più bassi (il popolo). Si ha, in pratica, l'impressione che l'autore del vangelo voglia contrapporre una giurisprudenza romana, formalmente corretta, che sa distinguere un vero reato da uno presunto o fittizio, a una giurisprudenza ebraica, i cui accusatori non si distinguono tra loro e che, se potessero, compierebbero un linciaggio.
Luca non distingue i ruoli tra il popolo ebraico: tende a considerarlo come un unico nemico accusatore, dai vertici alla base. Si sta cioè comportando in maniera antisemitica. Non riesce a capire che la decisione del popolo, o meglio, di una sua parte, è stata nettamente strumentalizzata o manipolata da quella delle autorità, che non sono solo quelle politico-religiose ma anche quelle romane.
Una svista del genere porta infatti a credere ch'egli non abbia capito neppure il ruolo di Pilato. Dividere i protagonisti di quel processo politico (perché in fondo di questo si trattava e Luca non lo nega) in “buoni” (i Romani) e “cattivi” (gli Ebrei) non ha alcun senso. Non solo perché in quel momento storico i Romani rappresentavano gli occupanti oppressori, ma anche perché se Gesù non fosse stato quello che gli ebrei sostenevano, e cioè un “sovversivo” (23,14), non avrebbero potuto consegnarlo a Pilato, il quale certamente non si sentiva autorizzato a discutere o giudicare questioni “non politiche”.
Tuttavia, se Gesù era davvero un “sovversivo”, Pilato non poteva non saperlo. L'ingresso trionfale nella capitale era sì avvenuto in maniera pacifica, ma solo perché le autorità giudaiche e romane non avrebbero potuto far niente per impedirlo, e tutti sapevano che l'avevano fatto entrare come un “messia liberatore”. Sia le autorità ebraiche collaborazionistiche che la guarnigione romana stanziata nella fortezza Antonia39 sapevano di avere le ore, o al massimo, i giorni contati. Non avrebbe avuto alcun senso per un uomo come Gesù e per i suoi discepoli esporsi così tanto, senza prendere una decisione irrevocabile.
Luca quindi sbaglia due volte: nel considerare “colpevole” tutta la popolazione ebraica presente in città, che in ultima istanza non seppe impedire un processo farsa, e nel considerare la figura di Pilato come relativamente “innocente”, in quanto non intenzionato a emettere una sentenza di morte. La sua versione dei fatti non ha nulla di storico, proprio perché è politicamente tendenziosa, pregiudizievole.
Quando fa dire a Pilato di non aver trovato in Gesù nessuna delle colpe di cui l'accusavano, Luca non solo toglie a Gesù qualunque aspetto politico eversivo, ma avvalora anche la tesi marciana secondo cui le autorità religiose avevano consegnato Gesù a Pilato semplicemente per una questione di “invidia” (Mc 15,10). È evidente infatti che se tutte le accuse politiche erano false, non restavano che quelle religiose.
Nella versione lucana Pilato sembra rendersi conto di questa anomalia, tant'è che arriva a dire che se davvero Gesù fosse stato un politico sovversivo, Erode non gliel'avrebbe rimandato indietro, ma, quanto meno, l'avrebbe incarcerato e processato (23,15). Quindi agli occhi di Pilato il Sinedrio si era incaricato soltanto di consegnargli un pericoloso “eretico”, la cui popolarità impediva allo stesso Sinedrio di emettere una sentenza capitale; e siccome le autorità religiose sapevano che Pilato non era interessato a giudicare questioni di tipo teologico, pensarono bene a trasformarle in qualcosa di tipo politico. E Pilato, essendo da un lato un giudice imparziale, ma, dall'altro, un rappresentante dell'ordine pubblico, si sarebbe limitato, per non avere noie, cioè per soddisfare una richiesta così insistente (avanzata da autorità molto importanti), a processare un innocente per sedizione. In tale processo però le intenzioni originarie del procuratore romano sarebbero state quelle di comminargli una punizione fisica (la fustigazione), dopodiché l'avrebbe lasciato libero (23,16). In altre parole Pilato, col castigo della frusta avrebbe soddisfatto un'istanza politica impropria, pur ritenendo l'accusato giuridicamente innocente. Questa la versione di Luca.
C'è qualcosa di vero in tale ricostruzione dei fatti? Praticamente nulla: sia perché Gesù fu arrestato per questioni strettamente politiche (l'obiettivo era quello di un'insurrezione armata contro le forze romane e il potere giudaico alleato); sia perché lo stesso Pilato era stato costretto a imbastire un processo pubblico proprio a motivo della pericolosità politica dell'accusato. Un processo a porte chiuse sarebbe stato troppo pericoloso, soprattutto se la sentenza fosse stata di condanna capitale. Agli occhi di Pilato il processo pubblico avrebbe dovuto servire per dimostrare l'innocenza di Roma, cioè la volontà tutta ebraica di eliminare un soggetto scomodo come Gesù.
Insomma Gesù era temuto (da parte del Sinedrio) non soltanto come “eretico” (essendo sostanzialmente ateo), ma anche e soprattutto come “sovversivo”, in quanto minacciava il loro potere politico. Ma come “sovversivo” era temuto anche da parte del potere romano.40
Pilato quindi può anche aver detto che in Gesù non trovava nessuna colpa, ma solo per sentirsi dire, da quante più persone possibili, che Gesù invece era politicamente colpevole. In un processo politico, tenuto pubblicamente, è fondamentale per un giudice avere il consenso di una maggioranza qualificata, numericamente significativa. Tant'è che, per averla, fu anche disposto a lasciar libero il pericoloso Barabba al posto di Gesù.41 In tal senso non gli sarebbe importato affatto che il popolo ritenesse Gesù colpevole di non aver avuto il coraggio di ribellarsi a Roma in maniera del tutto autoritaria. L'importante era farlo fuori.
Si noti come Luca abbia tolto del tutto la flagellazione ordinata da Pilato subito dopo aver concesso di liberare Barabba. Ha voluto presentare un governatore sufficientemente immacolato. Senonché nel quarto vangelo appare molto chiaro che la fustigazione42 era stata escogitata da Pilato per convincere la popolazione che da un leader politico ridotto fisicamente a un nulla non avrebbero potuto ottenere alcunché. La cosa strana è che mentre in Giovanni, sensibile alle questioni politiche, Barabba viene presentato come un “brigante” qualunque (Gv 18,40), sebbene non sia da escludere una delle solite manipolazioni redazionali; in Luca invece, che spoliticizza quanto mai il Cristo, viene detto chiaramente che Barabba era stato incarcerato da Pilato “a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio” (23,19).
Barabba quindi era un sovversivo che aveva ucciso una guardia romana e che, molto probabilmente, era destinato al patibolo. Il Pilato di Luca accetta quindi di scambiare uno che avrebbe potuto essere qualificato come un “terrorista” con un altro che, per lui, non sarebbe stato colpevole di nulla. Egli avrebbe fatto questo per compiacere le autorità giudaiche, con cui era alleato, cioè l'avrebbe fatto non per convinzione ma per convenienza o per opportunismo.
Nel vangelo di Luca Pilato non aveva affatto l'intenzione di liberare Barabba, ma quella di liberare Gesù. Lo scambio lo fa solo dopo le molte insistenze popolari di veder crocifisso il Cristo, cioè quando “le loro grida finirono per avere il sopravvento” (23,23).
Nel vangelo di Giovanni invece appare chiaro che, dovendo scegliere chi dei due liberare, Pilato opta per quello meno pericoloso, nella convinzione che l'avrebbe presto ripreso. Di Barabba – come noto – non si sa nulla. Nei vangeli non lo si sente pronunciare una parola. Il suo stesso nome è puramente fittizio (è un patronimico), in quanto vuol dire “figlio del padre” (che è comunque una tipica denominazione messianica).43 Perché si sia conservato l'anonimato di quest'uomo resta un mistero, anche se è lecito pensare che quando si cela la vera identità di una persona è perché si teme che quella persona (o chi la conosceva) possa dare una versione dei fatti diversa da quella ufficiale. Possiamo soltanto ipotizzare che fosse un oppositore armato dei Romani, cioè un patriota, avvezzo a usare metodi che oggi definiremmo “terroristici”, e che era più importante degli altri due complici che vennero crocifissi insieme a Gesù. Lo scambio tra lui e Gesù doveva apparire sufficientemente equo agli occhi delle autorità giudaiche per poter ingannare il popolo. Cioè in sostanza le autorità dovevano convincere il popolo che Barabba offriva maggiori garanzie di successo contro Roma che non Gesù, quindi doveva per forza essere una persona di rilievo, che tutti gli abitanti della città ben conoscevano (Mc 15,7; Mt 27,16). (Sulla figura di Barabba vedi anche questo testo)
XVI
Il percorso verso il Golghota (23,26 ss.) contiene due aspetti che Luca non è in grado di spiegare. Il primo riguarda la figura di Simone di Cirene, che fu obbligato a portare la traversa (patibulum)44 della croce al posto di Gesù, che evidentemente non ce la faceva (d'altra parte pesava da 35 a 60 chili). Motivo di questo aiuto improvvisato? La pesante flagellazione, di cui però Luca non parla.
Restando su questo punto, risulta davvero strano che di uno sconosciuto come Cirene, preso a caso, lungo la strada, dal picchetto romano, ci si ricordi persino il nome, mentre non si dica nulla del vero nome di Barabba.
Il secondo aspetto da sottolineare è racchiuso nel v. 27: “Lo seguiva una gran folla di popolo e le donne che facevano cordoglio e lamento per lui”. Ma come! Luca non aveva detto che, al momento del processo, tra gli accusatori vi era anche l'intero popolo (23,13)? Solo ora scopriamo che una discreta fetta di popolazione stava dalla parte del condannato. Strano quindi ch'essa non si sia fatta sentire durante il processo-farsa. Oppure dobbiamo pensare ch'essa è stata fatta “tacere” dai redattori dei vangeli per poter manifestare meglio il loro antisemitismo? Infatti se tutto il popolo lo voleva morto, chi avrebbe potuto salvarlo?
Chi è dunque questa folla che fa da corteo al tragitto di Gesù verso il patibolo? Luca presume di spiegarlo subito dopo, facendo parlare Gesù alle donne: “Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli” (23,28); “perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?” (v. 31). Quindi la folla che segue Gesù non è altro che “legno secco” (naturalmente è escluso che vi fossero degli apostoli, in quanto per loro sarebbe stato troppo rischioso, anche se nel quarto vangelo non si spiega la presenza di Giovanni ai piedi della croce).
Ma se è “legno secco”, le lacrime che questa gente versa son come quelle del coccodrillo, cioè son lacrime tardive, ipocrite, sono il cordoglio di chi avrebbe potuto far qualcosa di significativo, ma non ha avuto il coraggio di fare assolutamente nulla. Luca, il moralista, non sa che farsene di queste lacrime. La gravità della sentenza che il popolo ebraico ha emesso a carico di Gesù è pari a quella ch'egli stesso ha emesso nei confronti del popolo ebraico.
Si noti, a tale proposito, come anche la crocifissione di Gesù (23,33 ss.) venga descritta mostrando un particolare odio nei confronti degli ebrei, il cui popolo si limita a “guardare” passivamente, mentre i magistrati si “beffano” di lui, dicendo: “Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'Eletto di Dio” (v. 35).
Davvero inverosimile che una parte delle autorità giudaiche, in quel momento, si comportasse così, anche perché quello che dicono ha il sapore di una manipolazione cristiana. Sembra essere infatti una sfida alla rivendicata natura divina da parte del Cristo. È come se gli chiedessero di compiere un miracolo, scendendo dalla croce, cioè sapendo bene che non può farlo perché per loro è soltanto un uomo.
A ben guardare ciò sarebbe stato assurdo anche se nelle loro parole di scherno non vi fosse stato alcun riferimento di tipo teologico. Infatti, avendo già ottenuto con l'inganno e la manipolazione dell'opinione pubblica l'obiettivo che si erano prefissate, le autorità non avevano alcun bisogno d'infierire, anche perché, comportarsi così davanti alla folla che aveva accompagnato Gesù sul Golghota sarebbe stato inopportuno, politicamente scorretto e forse anche un po' pericoloso.
Senonché persino i soldati lo scherniscono con le stesse parole, mostrando di avere la medesima consapevolezza dei magistrati: “Se tu sei il re di Giudei, salva te stesso!” (v. 37). Davvero inverosimile che dei militari si potessero comportare così nei confronti di uno che era quasi più morto che vivo. Peraltro Luca mostra di non conoscere l'utilità lenitiva del dolore che procurava la bevanda acetata offerta ai crocifissi. Infatti la ritiene un ulteriore gesto di scherno da parte dei militari.
Considerando che Luca ha evitato di attribuire ai soldati romani qualcosa di offensivo ai danni di Gesù, vien quasi da pensare che ai piedi della croce vi fossero due tipologie di militari: quelli Romani, che si limitarono a crocifiggerlo e a sorteggiare a chi di loro sarebbe andata la tunica di Gesù; e la milizia giudaica, che invece lo schernisce, ripetendo la stessa frase degli scribi. Che poi è sempre quella che ripete anche uno dei due “malfattori” giustiziati insieme a lui (v. 39).45 Luca usa un termine che fa pensare a dei criminali comuni, ma sarebbe stato più giusto chiamarli “patrioti”, seppur nei panni di terroristi zeloti, in quanto a un supplizio del genere generalmente venivano mandati gli schiavi ribelli o comunque i colpevoli di un reato d'insubordinazione, implicante almeno un grave delitto o un omicidio.
L'unica figura in grado di salvarsi da questa rappresentazione delle cose piuttosto squallida è l'altro condannato a morte, che però arriva a dire cose ancora più inverosimili di quelle fin qui viste. Infatti egli accusa il collega di comportarsi da ateo come i magistrati: non ha il “timor di Dio” (v. 40). Inoltre egli si autoaccusa, dicendo che quel castigo loro due se lo sono meritati per ciò che hanno fatto (v. 41).
Quindi Luca esclude che fossero lì per motivi politici; o comunque considera un delitto compiuto per motivi politici alla stregua di un reato comune. E pensare che poco prima aveva scritto che Barabba e gli altri suoi complici erano dei “briganti” (23,19), cioè dei “terroristi” che avevano compiuto una sommossa antiromana, con tanto di omicidio. Ora sono semplicemente dei “malfattori”, che però, se davvero fossero stati tali, non avrebbero dovuto essere giustiziati insieme a Gesù.
Luca è come se scrivesse nei panni di uno storico romano conservatore, il quale evita di fare distinzione tra omicidio di natura privata, compiuto per motivi personali, e omicidio di natura pubblica, compiuto per motivi politici. Chiunque compia un gravo atto eversivo, privato o pubblico che sia, viene da lui qualificato come un “malfattore”; e se anche questa sua qualifica non comporta un omicidio vero e proprio, il condannato merita comunque la massima punizione.
Uno dei due però si pente di ciò che ha fatto; è convinto che Gesù non meritasse quella pena, non avendo fatto – secondo lui – “nulla di male” (23,41); e, con fare del tutto cristiano, chiede a Gesù di ricordarsi di lui quando entrerà nel suo regno ultraterreno (v. 42); dopodiché ottiene una risposta affermativa.
Luca non fa che sovrapporre alle motivazioni politiche della condanna capitale quelle pre-politiche di natura etico-religiosa, suddividendo quest'ultime in due campi nettamente separati: quelle degli ebrei “fanatici”, i quali non riconoscono la natura divina del Cristo e che quindi vengono fatti passare per degli “atei”; e quella dell'ebreo “pentito”, a favore della fede cristiana. Una ricostruzione dei fatti, come facilmente si può notare, del tutto fantasiosa.
XVII (fonti)
La morte di Gesù (23,44 ss.) è descritta non solo con dei particolari del tutto fantastici, ma anche con altri di natura sibillina. I primi riguardano quella specie di eclissi solare che si verificò da mezzogiorno alle tre (v. 45), come se Dio volesse mostrare il proprio dolore o il proprio disappunto attraverso la natura; poi la frase, presa dal protovangelo marciano: “La cortina del Tempio si squarciò nel mezzo” (v. 45), per indicare la fine del primato storico-teologico di Israele; poi ancora la frase mistica che il Cristo morente rivolge al padre: “Nelle tue mani rimetto il mio spirito” (v. 46), come se fosse un docile esecutore di una volontà che gli era nettamente superiore e nei confronti della quale non poteva opporre alcuna resistenza46; infine una quasi professione di fede da parte del centurione romano, che, in questo modo, riscatta il comportamento imbelle del suo superiore, il prefetto Pilato: “Veramente quest'uomo era giusto” (v. 47).47
Luca qui non ha avuto il coraggio di far dire a un militare romano l'espressione riportata in Marco (15,39): “Veramente quest'uomo era figlio di Dio”, però fa presente che il militare era molto vicino alla fede cristiana, in quanto aveva riconosciuto l'innocenza del Cristo, mettendola in relazione alla “glorificazione divina” (23,47).
La parte più interessante (ma anche più criptica) riguarda il comportamento della folla ai piedi della croce: una parte “se ne tornava a casa battendosi il petto” (v. 48); un'altra parte (i parenti e le donne galilaiche) “stava a guardare queste cose da lontano” (v. 49). Vien da chiedersi, peraltro, perché “da lontano”, visto che l'avevano seguito da vicino durante il tragitto verso il Golghota? Luca lo spiega più avanti, quando si tratterà di seppellire il cadavere di Gesù: cosa che verrà fatta dai Galilei e da un giudeo di Arimatea (non di Gerusalemme), un certo Giuseppe, membro del Sinedrio,48 “uomo giusto e buono” (23,50), che “aspettava il regno di Dio” (v. 51) – certamente non quello “ultraterreno”, verrebbe da aggiungere. Egli “non aveva acconsentito alla deliberazione [di far morire Gesù] e all'operato degli altri [sinedriti]” (v. 51).
Ora però facciamo un passo indietro. Per quale motivo Luca scrive che “la folla che assisteva a questo spettacolo [la morte di Gesù], vedute le cose ch'erano accadute, se ne tornava a casa battendosi il petto” (v. 48)? Sembra una frase ironica, sarcastica, in cui il pentimento appare del tutto formale o convenzionale. Definisce la crocifissione uno “spettacolo” (teatrale?) per questa gente, che è gente giudaica, a differenza di quella del versetto successivo, ove Luca parla di “conoscenti” di Gesù e di “donne” provenienti dalla Galilea, che si limitano a “guardare queste cose da lontano” (v. 49), come se fossero due gruppi ben distinti, tra loro irriducibili.
Perché la folla galilaica (i discepoli) guarda soltanto e non si contrisce, non piange, non si dispera? E perché “da lontano”? Per timore forse d'essere accusati di complicità col “malfattore” appena giustiziato? Ma perché allora starsene lì, alla vista di tutti? O forse perché questa gente in città non ha un luogo preciso, una dimora in cui risiedere, essendo di un'altra regione? O forse perché sono in attesa di sapere cosa faranno di quel corpo appeso alla croce? Dovranno infatti seppellirlo lì, necessariamente, senza poterlo trasferire in Galilea, e dovranno far presto, perché con la Pasqua alle porte la legge impedisce il contatto coi cadaveri. Ma dove andranno a inumarlo non possono ancora saperlo.
Sembra che Luca abbia voluto distinguere, anzi opporre, a bella posta, i due comportamenti di fronte alla morte di Gesù: quello sincero e composto dei Galilei, e quello falso e ipocrita dei Giudei, i quali, al momento dell'ingresso di Gesù nella capitale, lo avevano accolto in maniera entusiastica, mentre il giorno dopo avevano deciso la sua condanna. Luca stava forse accusando i Giudei di essere “teatrali”? Dunque siamo ancora in presenza di un certo antisemitismo? pur in un frangente così assolutamente tragico?
Ma torniamo al momento della sepoltura. Chi chiese a Pilato il corpo morto di Gesù fu Giuseppe di Arimatea, il quale lo “avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto” (23,53). Era la tomba di un uomo facoltoso, quindi di lui stesso, che pensò di riservarla per il corpo di Gesù, mostrando, con tale disponibilità, di avere una grande considerazione di lui.
Luca poteva dirlo anche prima che tra i membri del Sinedrio non vi era affatto una unanime intenzione a eliminare il messia galilaico. Invece qui si limita a dare una semplice indicazione cronologica: “era il giorno della preparazione [parasceve], e stava per cominciare il sabato” (v. 54). Dunque Gesù era stato giustiziato di venerdì, il giorno precedente alla Pasqua ebraica, e si può presumere che Giuseppe abbia chiesto di avere il corpo verso il pomeriggio inoltrato, quando ormai stava per tramontare il sole, che per il computo ebraico voleva dire “sorgere il giorno dopo”, cioè appunto il sabato, giorno sacro (tanto più che quello era pasquale), in cui qualunque impurità era vietata, soprattutto il contatto fisico con un cadavere. Ecco perché il corpo fu avvolto nel lenzuolo così com'era, tutto sporco di sangue: la sepoltura era stata affrettata e la Sindone lo conferma, la quale contiene sì tracce di profumi, ma non perché provenivano dal corpo di Gesù. Quello era nato come lenzuolo funerario e veniva venduto coi profumi incorporati.
Luca dice che le donne avrebbero assicurato una sepoltura decente dopo la fine del sabato, preparando “aromi e profumi” (v. 56). Il fatto di rimanere uno o due giorni in quella tomba sigillata non avrebbe comportato la decomposizione del cadavere, anche se con tutte quelle ferite sarebbe stata sicuramente molto veloce. Strano che Luca non abbia fatto notare come fosse incongruente lo scrupolo di non seppellire quel corpo in maniera regolare, lavandolo e ungendolo, con ciò che di eversivo, nei confronti dell'ideologia giudaica, aveva compiuto Gesù. Si pensi solo alle sue ripetute trasgressioni del sabato. Davvero dunque quei discepoli galilei erano migliori della folla giudaica di Gerusalemme?
Non solo, ma non è neppure da escludere che i Sinottici si siano inventati l'intenzione delle donne di regolarizzare la sepoltura con tanto di aromi e profumi, proprio per giustificare la pusillanimità con cui si affrontò il divieto, relativo al sabato, di toccare dei corpi morti. Anche il quarto vangelo, su questo punto, è stato ampiamente ritoccato; in esso però si evita di dire che le donne, di buon mattino, si erano recate al sepolcro per ungere il corpo di Gesù; la cosa infatti, stando al manipolatore di Giovanni, era già stata fatta il giorno prima, addirittura da un discepolo occulto di Gesù, il fariseo Nicodemo, che portò “una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre” (Gv 19,39), una quantità assolutamente spropositata.
In realtà nel vangelo di Giovanni la tomba viene scoperta vuota casualmente da due donne, di cui una era la Maddalena, le quali non avevano alcuna intenzione di ripulire il corpo di Gesù. Peraltro nessuna delle due, neanche unendo le loro forze, sarebbe stata in grado di spostare la grossa pietra rotolante, a forma di mola, che chiudeva l'ingresso della tomba.
(torna su)7) Il mito della resurrezione (fonti)
I
Nel racconto della resurrezione (24,1 ss.) Luca mostra d'essere completamente dipendente da Marco, non solo perché “copia” da lui, ma anche perché fa capire da chi Marco stesso ha “copiato”.
Il fatto che Luca non capisca molto delle usanze ebraiche è testimoniato da molti indizi nel suo vangelo: in questa pericope lo si nota laddove scrive che le donne si recarono al sepolcro, trovando che la pietra che ostruiva l'ingresso era già stata spostata (24,1 s.). Chi l'aveva aperto? Per le donne sarebbe stato impossibile far “rotolare” quella pietra, che – come dice Mc 16,4 – era “molto grande”; quindi non avrebbe avuto alcun senso, per loro, recarsi alla tomba da sole, per imbalsamare Gesù. Questo poi senza considerare che in genere erano gli uomini che ungevano i cadaveri maschili.
La tesi che Luca sostiene è quella di Marco: l'unica spiegazione che si può dare della tomba vuota è che Gesù era “risorto” (v. 6). Questa però non è una tesi che si può “dimostrare” empiricamente, in quanto nel vangelo originario di Marco non vi è alcun racconto di “apparizione” del Cristo risorto. Infatti a sostenere questa tesi sono “due uomini in veste sfolgoranti” (v. 4). Nel primo vangelo si parla di un “giovane” (Mc 16,5). Vi si deve credere per fede.
L'unica “prova” che si può avere è che Gesù aveva “profetizzato”, quand'era in Galilea, che doveva essere crocifisso e il terzo giorno resuscitare (vv. 6-7). Il che però è abbastanza ridicolo, in quanto il Gesù storico non può certo essersi espresso in una maniera così mistica e innaturale, soprattutto in un ambiente ebraico; tant'è che gli Undici, quando ascoltarono le donne parlare di scomparsa del corpo, pensavano che “vaneggiassero” (v. 11). Eppure, se Gesù avesse davvero previsto come le cose sarebbero andate a finire, tutti avrebbero dovuto dare all'evento della tomba vuota una spiegazione univoca.
Quindi per un attimo il lettore può essere indotto a pensare che la tesi della “resurrezione” (qui fatta passare per una comunicazione trascendente da parte di due angeli) fosse stata elaborata dalla mente fantasiosa delle stesse donne: “Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo, e altre donne che erano con loro” (vv. 9-11).49 Invece no. Tra gli Undici, infatti, l'unico che vuole sincerarsi di persona di ciò che le donne hanno detto è – secondo Luca – Pietro, che “corse al sepolcro; si chinò a guardare e vide solo le bende; poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello ch'era avvenuto” (v. 12).
Si faccia ora attenzione a come è nata la principale mistificazione della teologia petrina. Anzitutto a correre verso il sepolcro non fu il solo Pietro, ma vi era anche Giovanni. È vero, quando entrarono nel sepolcro videro le bende per terra con cui era stato stretto il lenzuolo (la Sindone) che avvolgeva l'intero corpo di Gesù. Entrambi videro che il lenzuolo era stato piegato e riposto da un lato.
La reazione che ebbero però fu opposta: secondo Giovanni il corpo era stranamente scomparso e la Sindone era l'unico elemento che poteva provarlo, dato che se qualcuno avesse trafugato il cadavere, non si sarebbe preoccupato di sciogliere i legacci che la tenevano unita al corpo, di piegarla e di riporla da una parte; secondo Pietro invece Gesù era risorto e, per credere in questa interpretazione della tomba vuota, la Sindone non serviva a nulla, non offriva maggiori certezze.
Perché Luca parla solo di Pietro? Semplicemente perché fu la sua tesi a prevalere. Giovanni fu emarginato, talmente emarginato che il suo nome non appare neppure nel quarto vangelo (probabilmente tale censura fu una delle condizioni per poter divulgare il testo). Che conseguenze ebbe la tesi di Pietro sul movimento nazareno? Sul piano politico furono tragiche: si sarebbe dovuto rinunciare a compiere l'insurrezione armata, in attesa di un ritorno del Cristo risorto, che avrebbe dovuto trionfare non solo su Roma, ma anche sulle autorità giudaiche collaborazioniste. Sicché il movimento fu, in un certo senso, smobilitato. Si perse l'occasione favorevole per opporre politicamente l'intera Palestina alla Roma imperiale.
In attesa della trionfale parusia Pietro si accontentò di opporre il suo “cristianesimo” al giudaismo ufficiale. E fu solo quando si rese conto che l'idea di una imminente parusia era del tutto sbagliata, deciderà di andarsene da Gerusalemme, abbandonando persino l'intera Palestina.
La teologia paolina subentrò subito dopo, quando si volle trasformare Gesù in una divinità e addirittura nell'unico vero Figlio di Dio, in opposizione a tutti gli dèi pagani e alle pretese degli imperatori romani. Fu Paolo a posticipare l'imminente parusia trionfale del Cristo al giorno conclusivo della storia, chiamato, pomposamente, “giudizio universale”.
II
Il racconto dei discepoli di Emmaus è un sunto straordinario di tutta la teologia politica di Luca, la quale, considerando che è posteriore a quella petrino-marciana, ancora viziata da un certo galileismo, può essere ritenuta la capostipite della successiva teologia cristiana d'impronta paolina, caratterizzata da un'indubbia apertura universalistica del proprio accentuato misticismo.
Qui i protagonisti sono due giudei di Emmaus, una località del tutto sconosciuta, per quanto Luca sostenga fosse “distante da Gerusalemme sessanta stadi” (24,13), cioè sette miglia. Erano ammiratori di Gesù e ovviamente avevano rifiutato la decisione dei “capi dei sacerdoti” e dei “magistrati” di farlo giustiziare.
Improvvisamente Luca fa dire loro una frase che dovrebbe far sobbalzare il lettore cristiano (a testimonianza che l'autore, quando scrive, riesce a sentirsi anche più libero di Marco, ma proprio perché scrive in un periodo storico in cui le sue espressioni dal sapore politico non rischiavano più un'interpretazione avversa alla dominante teologia paolina). La frase che dicono è riportata al v. 21: “Speravamo che fosse lui a liberare Israele”.
Liberare da chi o da che cosa? Luca ovviamente non lo dice, altrimenti manderebbe all'aria il patto stipulato tra cristianesimo paolino e impero romano, secondo cui i cristiani eviteranno di mettere in discussione l'autorità imperiale e la pratica dello schiavismo, a condizione che l'impero eviti di considerare l'imperatore un “figlio di Dio” e che accetti la separazione tra Chiesa e Stato (onde permettere al cristianesimo una piena libertà di culto, incompatibile con la volontà imperiale, che considerava la religione pagana un instrumentum regni), a meno che ovviamente lo Stato non accetti di diventare “cristiano”, come appunto farà tre secoli dopo.
Di che cosa si lamentano i due discepoli di Emmaus? Del fatto che, pur essendo stato trovato vuoto il sepolcro di Gesù, non vi è alcuna traccia del suo corpo. Cioè essi non capiscono perché, se è risorto – come dicono –, non sia riapparso, realizzando l'obiettivo che si era prefissato in vita.
Si noti come da queste semplici affermazioni appaia molto chiaro che i due discepoli seguivano Gesù per motivi politici, non tanto religiosi. Si aspettavano cioè che “liberasse Israele”, non che “riconciliasse l'umanità col Padreterno”. Certo, Luca non può specificare che il nemico fosse Roma, ma anche il lettore più sprovveduto non può pensare che il nemico fosse soltanto la corrotta classe sacerdotale, gli ipocriti farisei, i cavillosi scribi, i conservatori sadducei, ecc.
Ma il problema non è tanto quello di capire chi sia il nemico da cui Cristo doveva liberare la Palestina. Qui infatti appare piuttosto evidente che i due discepoli di Emmaus rappresentano un'istanza politica destinata a venire contraddetta dall'istanza religiosa che, in quel frangente, Gesù stava per manifestare.
In questa lunga pericope si consuma la transizione dalla teologia politica di Pietro, che ancora contiene delle venature o velleità eversive, provenienti dagli ambienti zelotiani della Galilea, alla teologia politica di Paolo, il cui fariseismo spiritualizzato ha prodotto una sintesi inedita tra giudaismo ed ellenismo.
Si faccia ora attenzione a quel che risponde Gesù: “Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (vv. 25-27). Già da questa frase si può capire il passaggio dalla teologia petrina a quella paolina, assai più ferrata nelle Scritture, ancorché interpretate in maniera eterodossa.
L'obiezione del Cristo – detto altrimenti – appare essere la seguente: per giustificare la tesi della “morte necessaria” del messia liberatore, occorre andarsi a rileggere quei passi delle Scritture che, in qualche modo, l'avevano anticipata. Cioè la vera interpretazione di taluni passi profetici può dipendere soltanto da ciò che è accaduto al Cristo; quindi essi vanno riletti col senno del poi.
Se proprio si vuol rimanere nell'ambito del giudaismo, ci si deve convincere che in quei passi profetici si anticipava la venuta non tanto di un “Cristo liberatore”, alla stregua di un novello Davide, quanto piuttosto di un “Cristo redentore”, il cui messaggio di salvezza, non potendo imporsi con la forza delle armi, sarebbe stato ovviamente rifiutato dalle autorità costituite, abituate a ragionare secondo determinati rapporti di forza.
Il “Cristo redentore”, anche se è stato sconfitto materialmente, può ancora vincere spiritualmente, e anzi l'ha già fatto, proprio nel momento in cui ha accettato il suo destino. Pertanto la sua vittoria sta soltanto nella forza dell'esempio, nella persuasione ragionata, nella potenza della sua grazia (che viene elargita semplicemente a chi ha fede nella sua natura divina), nella legge dell'amore reciproco e universale, nella certezza che un regno di liberazione è possibile solo nella Gerusalemme celeste.
Ora, quali sono gli strumenti per credere possibile la realizzazione di tutto ciò, visto che non possono più essere quelli della lotta politica e armata? Devono essere quelli della presenza religiosa, che si muove alla luce del sole, senza alcuna clandestinità: sono i sacramenti, la reinterpretazione della Bibbia ebraica, la lettura del Nuovo Testamento e tutte le azioni di tipo liturgico, caritatevole, assistenziale, pacificatorio che la comunità cristiana può compiere. Ecco perché Luca scrive che i due discepoli capirono che il loro compagno di viaggio era Gesù proprio nel momento in cui celebra l'eucarestia.
Infatti se si accetta che il pane e il vino rappresentino, misticamente, il corpo e il sangue di Cristo, si è compreso adeguatamente il passaggio dal Cristo liberatore al Cristo redentore, per cui non si ha neppure bisogno di vederlo coi propri occhi, sensibilmente; lo si può percepire con la mente, sentirlo col cuore. Il Cristo della fede non è che un consolatore astratto di una speranza frustrata di risolvere sulla Terra le contraddizioni sociali. Diventa la proiezione mistica della propria impotenza, della propria disperazione, della propria alienazione.
Quando i due discepoli di Emmaus arrivano ad acquisire un forte senso di estraneazione dalla realtà, sono disposti a credere anche agli Undici, là dove affermano: “Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone” (v. 34). Ecco di nuovo confermata, da Luca in persona, che la tesi della resurrezione di Gesù fu inventata da Pietro, come risposta alla richiesta se proseguire sulla strada dell'insurrezione armata anche dopo che il leader del movimento nazareno era stato giustiziato. Il “coraggioso” Simon Pietro, colui che non avrebbe tradito il suo maestro per tutto l'oro del mondo, usò al posto della parola “liberazione” la parola “resurrezione”, facendo credere che si trattava comunque di una scelta politica, in quanto per lui non avrebbe avuto alcun senso che un Cristo risorto non fosse tornato in tempi brevi per trionfare sui suoi nemici.
Ora, siccome la teologia petrina non poteva ammettere di essersi clamorosamente sbagliata sulla durata di questi tempi, in quanto tutti erano convinti che, accettata l'idea di “resurrezione”, i tempi avrebbero dovuto essere relativamente brevi, la comunità cristiana decise d'inventare di sana pianta i racconti di riapparizione del Cristo, in un momento in cui nessuno avrebbe potuto smentirli.
Luca non può esimersi dal concludere il suo vangelo riportando uno di questi racconti. Egli si preoccupa di mostrare un Cristo redivivo del tutto normale, che mostra i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi, che mostra di avere un corpo umano e chiede di mangiare come se avesse fame. La teologia paolina vuole sforzarsi di dimostrare che quando parla di “Gesù risorto”, non ha intenzione di far assomigliare quest'ultimo a quei fantasmi o entità spirituali dei miti pagani. Bisogna dunque smetterla di vedere l'aldilà come molto diverso dalla vita terrena.
In questo straordinario racconto Gesù vuol far capire la propria natura sovrumana con i suoi gesti e le sue parole. E quello che dice è piuttosto sconcertante: tutto ciò che gli è accaduto era stato previsto nell'Antico Testamento; si trattava soltanto di rileggere i passi profetici, presenti anche nei Salmi e nella legge mosaica. Quindi praticamente l'istanza politica di liberazione che avevano i suoi discepoli era falsa, il desiderio di liberarsi dei Romani e delle autorità giudaiche colluse andava reinterpretato, in quanto non è indispensabile impedire all'oppressore di compiere il male. Sicché nessuno può sentirsi colpevole di non aver fatto un'adeguata resistenza alla decisione di crocifiggere il Cristo, né di non aver saputo compiere l'insurrezione dopo tale esecuzione. Tutto era già stato previsto dalla prescienza divina, che resta inaccessibile agli uomini, i quali possono comprenderla solo a posteriori, con l'aiuto della grazia.
Le Scritture non vanno interpretate in maniera storico-letterale o contestuale al tempo in cui furono prodotte. Esse vanno interpretate in maniera traslata, cioè simbolica o allegorica, in quanto prefigurano qualcosa che sarebbe potuto accadere soltanto molto tempo dopo. “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme” (vv. 46-47).50
Cioè quello che ha fatto il Cristo e il motivo per cui è stato giustiziato non avevano nulla di politico, ma solo di etico e, in particolare di etico-religioso: la politica è semplicemente una conseguenza indiretta. Il genere umano deve limitarsi a credere che il peccato originale causato da Adamo ed Eva è stato perdonato da Dio, pur avendo questo perdono richiesto l'orribile sacrificio dell'unigenito suo figlio, il quale, in fondo, è responsabile della stessa nascita del genere umano. Gesù Cristo infatti è il nuovo Adamo che ha perdonato il primo d'aver rifiutato di vivere nel paradiso terrestre. A partire dalla colpa edenica gli uomini non hanno più la possibilità di tornare all'innocenza perduta, però ora sanno che quella trasgressione non comporta una maledizione senza scampo. Gli esseri umani non potranno più ricostruire sulla Terra l'Eden originario, però se avranno fede nella grazia di Dio, che attraverso il sacrificio del Cristo li ha perdonati, potranno ricostruirlo nel regno dei cieli, là dove sarà la divinità a indicare loro cosa dovranno fare.
Come pegno della sua promessa Cristo assicura che verrà dato ai credenti l'assistenza dello Spirito santo: “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto” (v. 49). Cioè Dio-padre, come prima aveva mandato il Cristo in carne ed ossa, ora, dopo la sua morte, manderà lo Spirito, come strumento consolatorio per la perdita subita. Il Cristo infatti non ha motivo di continuare ad essere presente sulla Terra. Ora devono essere i discepoli a diffondere il suo “verbo” in tutto il pianeta, e lo faranno appunto con l'aiuto dello Spirito. Lui può soltanto limitarsi a benedirli e ad ascendere verso il cielo, da dove li aspetterà fin quando la storia umana sarà finita.
La bella favola viene conclusa da Luca con parole a dir poco sconcertanti: “Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel Tempio lodando Dio” (vv. 52-53). Stavano proprio nello stesso Tempio che il Cristo aveva definito “una spelonca di ladri”, il vertice della corruzione d'Israele, il principale protagonista della sua morte.
(torna su)Come conclusione vorrei che fosse chiara una cosa. Quando si prendono in esame i vangeli cristiani occorre fare distinzione tra falsificazione e mistificazione.
Se, di fronte alla tomba vuota del Cristo, Pietro parla di “resurrezione”, sta mistificando la realtà, in quanto avrebbe dovuto limitarsi a dire – guardando la Sindone – ch'era avvenuto qualcosa di strano, di inconsueto, per cui il giudizio andava sospeso.
Il concetto di “resurrezione” è un'interpretazione mistificante, in quanto, pur mettendoci la tomba vuota di fronte a un fatto umanamente poco spiegabile, non si può parlare di “resurrezione” o di “ridestamento”, almeno finché non si rivede viva una persona dichiarata morta in maniera incontrovertibile. E noi sappiamo che tutti i racconti di “riapparizione” del Cristo sono falsi.
Che Pietro non credesse utile la Sindone come “prova” della sua tesi, è dimostrato dal fatto che per credere nella “resurrezione” occorre soltanto la fede nella divinità del Cristo.
Ora, se il concetto di “resurrezione” è una mistificazione, che è stata usata per rinunciare all'insurrezione antiromana, il concetto di “ascensione” e soprattutto quello, elaborato da Paolo, di “esclusiva figliolanza divina” sono chiaramente delle falsificazioni. Cioè la falsificazione non ha preceduto la mistificazione, ma è avvenuto il contrario, proprio perché la mistificazione ha bisogno di stravolgere qualcosa di reale, non essendo una semplice invenzione di pura fantasia.
Questo però non è tutto. Noi siamo partiti dal presupposto che se la Sindone è vera, i vangeli mentono. Cioè la reinterpretazione dei vangeli in chiave politica l'abbiamo fatta proprio a partire dalla Sindone: non abbiamo cercato in questa una conferma dei vangeli. Nessuno schiavo ribelle sarebbe mai stato trattato in quella maniera, se non fosse stato considerato altamente pericoloso; e altamente pericoloso Gesù è stato ritenuto sia da parte del potere politico che da parte di quello religioso.
La Sindone però resta un reperto poco spiegabile sul piano umano. Quindi quale conclusione possiamo trarre alla luce di questo reperto storico e in considerazione del fatto che, secondo noi, il Cristo non ha compiuto nulla nella sua vita che potesse far pensare ch'egli avesse una natura sovrumana? La conclusione che si può trarre, secondo noi, è una sola: in quest'uomo, chiamato Cristo, c'era qualcosa, verificata solo dopo la sua morte, di umanamente poco spiegabile, ma non così inspiegabile da doverci indurre a pensare ch'esista una divinità.
Se nel Cristo c'è qualcosa che va al di là di ciò che, al momento, su questa Terra, siamo soliti qualificare con l'appellativo di “umano”, ciò non implica la necessità di dover credere nell'esistenza di una divinità totalmente diversa dall'essere umano, o che gli è nettamente superiore, in quanto possiede attributi, a noi sconosciuti o interdetti, come onnipotenza, onniscienza, onniveggenza, ecc. Anzi, noi possiamo tranquillamente affermare – per come il Cristo si è comportato quand'era in vita – che non esiste alcuna divinità e che egli sostanzialmente si dichiarasse ateo.
Quindi non solo abbiamo a che fare con un soggetto politicamente rivoluzionario, che avrebbe voluto compiere un'insurrezione democratico-popolare contro l'oppressore romano e i poteri collaborazionisti del mondo ebraico, ma abbiamo anche a che fare con un soggetto che di religioso non aveva nulla.
Come definire un soggetto del genere? L'appellativo ch'egli usava per se stesso, e cioè “figlio dell'uomo”, calza a pennello.51 Con un linguaggio più moderno, oggi potremmo sostituirlo con “prototipo dell'umanità”, almeno per quanto riguarda il genere maschile. Infatti, per quanto riguarda quello femminile si deve supporre un prototipo diverso, avente gli stessi attributi di eternità e infinità. In principio non esiste l'uno bensì il due, in cui gli opposti si attraggono e si respingono. Questa è una legge universale e necessaria.
Dunque il genere umano come si configura? Si configura con gli stessi attributi dell'universo, che non è mai stato creato ed è privo di un limite spaziale. Noi siamo destinati a esistere, non essendo mai nati. L'essenza umana è coeva all'eternità e infinità della materia energetica che permea di sé l'intero universo.
(torna su)Appendice su Brandon
Ci piace qui ricordare il pensiero di Samuel Brandon su Luca: un autore cui largamente le nostre tesi si ispirano. Lo ricaviamo dal libro Gesù e gli Zeloti, ed. Rizzoli, Milano 1983, pp. 306-7.
Lo scrittore del Vangelo di Luca evidenzia il carattere non violento di Gesù. Come mostrano gli Atti degli apostoli, egli intese presentare il cristianesimo come una religione che i Gentili gradivano e che i magistrati romani proteggevano dalla malvagità degli ebrei. Perciò era importante ritrarre Gesù come una persona mite per temperamento e per modo di agire, estranea alla politica nazionalistica ebraica.
Luca, che scrisse quindici o vent'anni circa dopo Marco, poteva considerare con più distacco gli avvenimenti del 66-70 d.C. e, diversamente da Matteo, non si rivolgeva a una cristianità ebrea minacciata dai pericoli che incombevano sulla comunità di Alessandria. Egli non nutrì i timori degli altri due evangelisti e per questo nulla gli impedì di riferire che uno dei discepoli di Gesù era uno zelota e che Gesù aveva ordinato ai discepoli di armarsi prima di andare sul Getsemani.
Il ritratto di Gesù come il Cristo non violento elaborato da Luca non è ottenuto per mezzo di tocchi così palesi come le aggiunte fatte da Matteo al resoconto di Marco dell'arresto al Getsemani. È una delineazione più sottile, che prosegue l'allusione irenica dell'episodio della nascita rendendo Gesù l'autore di nobili parabole come quelle del buon samaritano e del figliol prodigo. Si può intravvedere nel rimprovero di Gesù ai violenti discepoli che vorrebbero far scendere fuoco dal cielo per ardere alcuni Samaritani che non collaborarono [con loro], e nell'avvertimento contro le conseguenze della violenza quando gli viene riferita la strage di alcuni Galilei ordinata da Pilato e quando viene a sapere di quelli uccisi dal crollo della torre di Siloam. È abilmente suggerito dall'aggiunta delle disarmanti parole “Pace in cielo e gloria a Dio” alla nota di messianismo politico contenuta nelle salutazioni della folla in occasione dell'entrata trionfale a Gerusalemme. E l'accenno è riproposto nel successivo lamento di Gesù sul destino di Gerusalemme: “Se tu sapessi, almeno oggi, quello che occorre alla tua pace!”.
Pur rivelando il fatto molto significativo che prima di recarsi al Getsemani Gesù si accorse che i discepoli erano armati, Luca afferma che egli intervenne per impedire la resistenza opposta al suo arresto. Inoltre, inserendo nel racconto della passione il processo di Gesù davanti a Erode Antipa, egli ne fa testimoniare l'innocenza sia al dominatore ebreo della Galilea sia al governatore romano della Giudea. Le parole di perdono che Luca attribuisce a Gesù sulla croce, insieme con la modifica alla versione di Marco sulla dichiarazione dell'innocenza di Gesù fatta dal centurione, completano il quadro della vicenda di uno nato per portare la pace agli uomini e che pregò per i suoi assassini. Questa linea tematica è proseguita negli Atti ed è riassunta nel discorso di Pietro, in cui egli rimprovera gli ebrei per aver rifiutato Gesù.
(torna su)1 È l'unico degli evangelisti a ricordare l'ematoidrosi, cioè il sudore di sangue (22,46); si esprime inoltre con indulgenza sui medici (8,43); indica con maggior esattezza i fenomeni patologici; annota da quanto tempo duri la malattia; si sforza di distinguere le malattie vere e proprie dalle possessioni demoniache.
2 Non è mai stato chiarito se Luca sia morto martire (sotto l'imperatore Domiziano) o in maniera naturale.
3 La stessa data di nascita di Gesù non può certo essere quella indicata da Luca, cioè nel 6 d.C., durante il censimento di tutto l'impero, ordinato dall'imperatore Cesare Augusto, quando ci fu l'unico censimento romano in Palestina, organizzatore del quale fu Publio Sulpicio Quirinio, nominato governatore della Siria nel 6 d.C. Oggi invece viene comunemente collocata tra il 6 e il 7 a.C., quindi è da presumere che alla sua morte avesse circa 40 anni e che la realizzazione del suo movimento non sia avvenuta né in un anno (come dicono i Sinottici) né in tre anni (come dice il quarto vangelo), ma almeno in una decina d'anni.
4 Probabilmente la cosiddetta “fonte Q” non è altro che il vangelo aramaico di Matteo andato perduto, scritto molto tempo prima di quello che ci è arrivato. Una fonte che Marco poteva anche conoscere e che però non volle utilizzare, forse perché il protovangelo è frutto di una tradizione galilaica, meno speculativa di quella giudaica, cioè forse perché la tradizione galilaica, essendo più influenzata dall'ellenismo, rispetto a quella giudaica, preferiva focalizzarsi su altri aspetti, più pratici, più spettacolari, come p.es. i miracoli, le guarigioni, gli esorcismi... Il Gesù storico si poteva mistificare in due maniere: una più semplice, trasformandolo in un operatore di prodigi sensazionali; l'altra invece più complessa, trasformandolo in un rabbino alternativo all'ideologia religiosa dominante. Quindi il vangelo marciano sarebbe prioritario su Matteo e Luca relativamente ai fatti storici riveduti in maniera mistica; ma il vangelo matteano conterrebbe una fonte particolare, teoretica, che Luca andò a riscrivere sulla base della propria utenza di origine pagana. Quindi la fonte Q potrebbe essere precedente allo stesso vangelo marciano: non a caso la si ritrova anche nel vangelo apocrifo di Tommaso. Le stesse lettere paoline scritte negli anni 50 non sanno nulla del Gesù storico, non sono interessate ai fatti, proprio perché i fatti li danno per scontati: in un certo senso sono una “fonte Q” esse stesse. Fu Papia di Ierapoli il primo a sostenere ch'era stato Matteo a raccogliere i detti nella lingua aramaica di Gesù (un Matteo ovviamente diverso dal “Matteo” che ci è giunto). Il problema semmai è un altro: perché scrivere un vangelo in cui la parte centrale non fossero le parole ma i fatti (per lo più inventati) del Cristo? Questa cosa non poteva certo venire in mente a Marco, che del Gesù storico sapeva molto poco (semmai venne in mente a Matteo e Luca perché in realtà potevano considerare Marco come fonte di ispirazione). Siccome però Marco è stato discepolo di Pietro, si può pensare che l'idea di vangelo (nel senso di una biografia, molto sintetica, della vita pubblica di Gesù) venne in mente proprio a Pietro, forse perché la sua utenza, non essendo palestinese e non potendo quindi fruire di una tradizione orale, gli chiedeva con insistenza di delineare, almeno per sommi capi, la vita di un dio incarnato di cui, attraverso i pochi discepoli sopravvissuti, poteva soltanto ascoltare i detti.
5 Si noti come le due genealogie, di Matteo (42 generazioni) e di Luca (56 generazioni), siano molto diverse tra loro: persino i nonni di Gesù, padri di Giuseppe, sono diversi (per Matteo è Giacobbe, per Luca è Eli).
6 Il primo censimento in Giudea (6-7 d.C.) era relativo ai beni, non alla popolazione. Normalmente era sufficiente recarsi davanti al censore locale, dichiarando la propria situazione familiare e patrimoniale: mai le persone sono state obbligate a recarsi nei loro paesi d'origine, anche perché per fissare l'imposta sul reddito si dovevano censire i beni sul luogo di residenza di chi li possedeva. Peraltro se Giuseppe avesse avuto delle proprietà a Betlemme, amministrate da schiavi o servi (il che potrebbe spiegare il viaggio), Gesù non sarebbe nato in una grotta. E comunque non avrebbe avuto senso far fare un viaggio di 130 km a una donna che stava per partorire. Quel censimento scatenò la seconda rivolta di Giuda il Galileo, benché riguardasse solo Giudea, Idumea, Samaria e Siria, e non Galilea. Luca ha retrodatato il censimento di Quirinio con l'intento di collocare la nascita di Gesù a Betlemme (città in cui doveva nascere il messia, quale discendente di Davide, anch'egli nato nella stessa città). Di tale censimento Matteo non fa alcun cenno: egli infatti colloca la nascita di Gesù “al tempo di re Erode” (il Grande), quindi prima del 4 a.C. (anno in cui Erode morì, stando allo storico Giuseppe Flavio). Maria e Giuseppe abitavano sin dall'inizio a Betlemme: solo in un secondo momento si trasferiscono a Nazareth.
7 Tuttavia, mentre Matteo sostiene che la propria infanzia Gesù la passò in Egitto sino alla morte di Erode il Grande, Luca invece la colloca a Nazareth e non vede alcun rischio per la sua vita. Come noto, non ci fu alcuna strage di neonati innocenti di cui la famiglia di Gesù dovesse aver paura: semplicemente Erode eliminò una moglie, tre cognati, una suocera, tre figli e alcune centinaia di oppositori.
8 Stando al quarto vangelo i primi discepoli di Gesù furono ex-seguaci del Battista, ma non è da escludere fossero anche seguaci del movimento zelota, di origine galilaica, senza il quale sarebbe stato difficile epurare il Tempio e tentare un'insurrezione antisacerdotale.
9 Si noti come per gli zeloti se era vera la coincidenza di Stato teocratico e regno di Dio, non necessariamente tale Stato doveva essere legato al culto del Tempio, la cui classe sacerdotale veniva considerata particolarmente corrotta. Il messia che attendevano era di tipo teologico-politico e si preoccupavano di anticiparne la venuta con atti di terrorismo o sommosse di varia natura, di cui si resero responsabili a partire soprattutto dagli anni 50 del I sec. Da notare però che il movimento fondato da Giuda di Gamala (il galileo) e Saddoq non viene chiamato “zelota” da Flavio Giuseppe, ma “quarta filosofia”, dopo quella farisea, sadducea ed essena.
10 Tale appellativo va interpretato in senso metaforico o traslato, in quanto solo alla fine del vangelo si propone l'altro, ben più impegnativo, di “Figlio di Dio”, applicato da san Paolo al Cristo in via esclusiva.
11 Si noti che nel suo vangelo anche la predicazione del Battista (3,3-6) inizia con una citazione di Isaia (40,3-5), a testimonianza che tra i due Luca vede una certa continuità: cosa che non appare affatto nel quarto vangelo. Inoltre la figura del “servo di Dio” (Is 50,5 ss.) è stata ampiamente strumentalizzata dalla cristianità primitiva per giustificare la fine ingloriosa del Cristo.
12 Questa identificazione di Gesù profeta e guaritore è una costante nel vangelo di Luca, anch'egli medico e seguace di un altro profeta, Paolo, il quale però non attribuiva particolare valore ai miracoli del Cristo.
13 In tal senso si rimanda a quanto già scritto in Umano e politico. Biografia demistificata del Cristo; Guarigioni e Parabole: fatti improbabili e parole ambigue. Entrambi pubblicati su Amazon.
14 Ci pare quindi limitativo sostenere che Zelota sia una semplice traduzione greca dell'aramaico Kananaios. Anche Marco scriveva in greco. Piuttosto si dovrebbe pensare che al tempo del protovangelo il termine Zelota aveva ancora un significato eversivo e quindi scomodo per la rappresentazione edulcorata del messianismo antiromano del Cristo, secondo il cristianesimo petro-paolino.
15 Non è da escludere che quando nei vangeli si presentano i parenti di Gesù o qualche donna, come p.es. la Maddalena, in cattiva luce, sia un modo di mascherare un atteggiamento contestativo che alcuni discepoli avevano nei confronti della predicazione petro-paolina. Non dimentichiamo che, dopo la morte di Gesù, Maria andò a vivere con Giovanni, il quale era ostile a Pietro a motivo della sua interpretazione della tomba vuota. In Giovanni (7,2 ss.) quando Gesù contesta i suoi parenti è per far capire loro che l'idea di compiere una insurrezione a Gerusalemme, senza averla debitamente preparata, è puro avventurismo.
16 Qui si può ricordare che furono proprio i farisei, in Lc 14,31 ss., ad avvisare Gesù che Erode voleva ucciderlo. In quell'occasione egli apostrofa l'Antipa con la parola “volpe”, che non voleva dire “furbo” bensì “nullità”, appunto come una volpe nella Palestina d'allora. C'è un proverbio nel Talmud che dice: “Meglio essere la coda del leone che la testa della volpe”.
17 Il movimento zelota, sorto in Galilea nel 6 d.C., propugnava la lotta armata contro l'occupazione romana. Seguaci di Giuda Galileo, che guidò una rivolta antiromana al tempo del procuratore Quintilio Varo, gli zeloti erano molto attivi politicamente. Il procuratore Tiberio Alessandro fece uccidere i figli di Giuda Galileo, Giacomo e Simone. Essi ebbero una parte decisiva nella rivolta del 66-70, sotto la guida di Eleazaro, che dopo la valorosa difesa del Tempio, riuscì a tenere la fortezza di Masada sino al 73, ove tutti i 960 zeloti, pur di non essere schiavizzati, si diedero la morte. Flavio Giuseppe spesso li chiama col nome di “sicari”, per via della piccola sica (pugnale) con cui compivano le loro vendette contro soldati romani isolati e contro ebrei collaborazionisti. Non è da escludere che fossero zeloti anche Barabba e gli altri due crocifissi insieme a Gesù. Tra gli apostoli – stando ad alcuni esegeti – non vi era solo Simone il Cananeo, ma forse anche Pietro, a motivo del suo soprannome “barjiona” (latitante), e Giuda, sempre che “Iscariota” voglia dire “sicario” e non la città di “Keriòt”. Ma anche “boanerges” (figli del tuono), appellativo con cui si indicano i due fratelli Zebedeo, aveva un chiaro significato politico. Oggi addirittura vi è chi ritiene che anche il Taddeo o Lebbeo, citato nell'elenco dei Dodici da parte di Marco e Matteo, sia in realtà Giuda lo Zelota. La principale differenza tra i nazareni di Gesù e gli zeloti era che di quest'ultimi non si condividevano i metodi estremistici e l'ideologia integralistica, che non permetteva di fare distinzione tra politica e religione.
18 Più avanti Luca dice anche che non si può associare la caduta di una torre a Siloe, che uccise 18 persone, a una specifica responsabilità morale. Di questo evento però non si sa nulla.
19 “Mammona” in aramaico voleva dire “fiducia”, cioè la sicurezza che potevano dare le tasse, i depositi e le ricevute dei prestiti. Il Gesù di Luca (vedi anche 11,5 ss.) pare essere ostile al denaro custodito nei depositi, alle transazioni commerciali o monetarie in genere, in quanto tutto deve basarsi sulla reciproca fiducia, sullo scambio dei doni, sulla pratica del baratto. D'altra parte a quel tempo il denaro era una richiesta dei potenti o delle élite; per la gente comune serviva soltanto per pagare l'esattore (tasse, balzelli, decime, tributi...) o l'usuraio, e tutti sapevano che facilitava l'indebitamento. È piuttosto la tradizione protocristiana che ammorbidisce la critica di Gesù, limitandosi a sottolineare i pericoli etici in cui poteva incorrere chi amava il denaro (si veda ad es. in At 5,1 ss. il comportamento dei coniugi Anania e Saffira).
20 Giudizio, questo, molto pesante, in quanto i farisei, a differenza degli aristocratici sadducei, si opponevano alle influenze dell'ellenismo, per loro fonte di corruzione morale e d'infedeltà alla tradizione. A cavallo dell'era cristiana, fino alla catastrofe del 70, mentre i sadducei dominavano nel Tempio e nella vita politica, i farisei avevano conquistato sempre più il favore del popolo, soprattutto grazie ai dottori della Legge (scribi), affiliati, nella stragrande maggioranza, al partito farisaico. Il popolo era portato a vedere nei farisei i genuini difensori delle sue tradizioni, e conseguentemente della sua nazionalità e indipendenza. Non a caso furono perseguitati da Erode il Grande. Dei vari gruppi giudaici esistenti prima del 70 solo i farisei sopravvissero agli eventi di quell'anno, e da allora in poi l'ebraismo rabbinico fu improntato ai canoni del fariseismo. A differenza dei sadducei, essi riconoscevano l'autorità di una legge orale (interpretativa) a fianco della Torah scritta. Altri punti importanti della dottrina farisaica sono l'apertura universalistica; il riconoscimento dell'uguaglianza di tutti gli uomini; il valore dell'individuo; la retribuzione dopo la morte, l'immortalità personale e la risurrezione. Quanto all'idea di messianismo va detto che, per loro, una stretta osservanza della Legge avrebbe accelerato l'evento di un messia davidico che avrebbe instaurato il regno di Dio. Tuttavia praticavano una rigida separazione da quanti non aderivano ai loro princìpi, e affermavano la necessità di allontanare dalla comunità i peccatori. In campo politico erano moderati e non appoggiarono le rivolte antiromane organizzate dagli zeloti. Nei vangeli i farisei scompaiono quasi totalmente dai racconti della passione. Resta altresì significativo l'intervento di Gamaliele in favore degli apostoli, ricordato in At 5,35-39.
21 Altro personaggio, Lazzaro, di cui parla solo Giovanni, molto controverso (la stessa Maria Maddalena potrebbe essere considerata sorella di Lazzaro). Non è da escludere che sia stato chiamato con questo nome per ricordare quel Eleazar ben Yair (discendente di Giuda di Gamala, il Galileo), che guidò la grande rivolta zelota del 66-73, suicidandosi a Masada. Il vero nome di Lazzaro ci è rimasto ignoto, ma certamente doveva essere originario della Giudea, molto popolare e particolarmente amico di Gesù, tanto che solo a partire dalla sua morte venne deciso, a Betania, di compiere l'ingresso trionfale a Gerusalemme e l'insurrezione armata.
22 La analizzeremo, nel dettaglio, più avanti, perché troppo importante.
23 Il cristianesimo è una forma di stoicismo più consolatorio di quello pagano, in quanto se è vero che accetta la rassegnazione per come le cose vanno nel presente di questo mondo, è anche vero però che spera in una ricompensa per il tempo futuro in un altro mondo. Lo stoicismo invece sostiene che vi è maggiore integrità morale o purezza d'animo se si compie il proprio dovere per il dovere. Va comunque detto che mentre lo stoicismo era una filosofia per intellettuali, il cristianesimo voleva essere una religione per il popolo, il quale, non vivendo una vita agiata, aveva bisogno di credere che nell'altra vita vi fosse una qualche compensazione per le proprie sofferenze.
24 Anche nel Genesi Dio prospetta ai nostri progenitori, nel caso in cui avessero toccato l'albero proibito, una punizione che per loro, essendo i primi e unici esseri viventi, non avrebbe potuto avere alcun senso: la morte.
25 Si noti, en passant, il vecchio pregiudizio di far coincidere ateismo con cinismo o immoralità.
26 Si noti che una risposta del genere avrebbe potuto darla un qualunque zelota, per il quale nessun uomo poteva essere chiamato “signore”.
27 Sulla spiegazione dettagliata di questa pericope rimando al libro, già citato, Guarigioni e Parabole: fatti improbabili e parole ambigue.
28 Alcuni esegeti sostengono che quel Yochanan Ben Zakkai, discepolo di Hillel, che chiese e ottenne da Vespasiano di risparmiare, una volta occupata Gerusalemme, l'Accademia rabbinica di Javneh, con cui poté ricostruire il giudaismo, fu proprio il figlio del pubblicano Zaccheo.
29 Luca, in questo, riprende la cronologia marciana, che però è completamente sbagliata, in quanto – stando a Giovanni – l'epurazione del Tempio avvenne agli inizi della predicazione di Gesù, quando ancora viveva in Giudea, e non si trattò affatto di un gesto simbolico, ma politico, che lo costrinse all'esilio in Galilea. Il fariseo Nicodemo gli riconosce la giustezza etica dell'operato, ma non ne trae le debite conseguenze pratiche. Qui si può ricordare che tra i mercanti e l'amministrazione del Tempio vi erano accordi economici ufficiosi sulla concessione delle licenze commerciali, che potevano essere esercitate sin quasi a ridosso del Sancta Sanctorum, la cui grande tenda separava la parte più interna da quella esterna. L'epurazione del Cristo non aveva semplicemente lo scopo di riportare le cose alla legalità, ma proprio di cacciare i sadducei dal Tempio, ivi incluso il sommo sacerdote, anche perché il Tempio, per come era strutturato (con regole di accesso per pagani, donne ebraiche, maschi impuri o con difetti fisici, ecc.), rifletteva una società fortemente gerarchizzata, suddivisa per razza, sesso, purità legale e appartenenza sociale. Sotto questo aspetto prendere a frustate i mercanti sarebbe stato un gesto poco significativo, poiché essi erano soltanto l'ultimo anello della corruzione della casta sacerdotale.
30 Si noti come nel vangelo di Giovanni passarono almeno cinque giorni dal momento dell'ingresso messianico alla pasqua.
31 Riguardo a Ponzio Pilato si sa molto poco. Pare fosse nato in Abruzzo, a Bisanti, in provincia di Teramo, nel 16 a.C. e avesse imparato qui l'aramaico a motivo di una colonia ebraica presente da molto tempo. I suoi più antichi avi erano condottieri dell'esercito sannita: uno di loro avrebbe partecipato alla congiura contro Cesare. Circa la morte si sa ancora meno: giustiziato dall'imperatore Caligola; suicida in Gallia dopo esservi stato esiliato (37-41); convertito al cristianesimo per influenza della moglie Claudia Procula (canonizzata dalla Chiesa greco-ortodossa); morto a Vienne o a Latina. Di sicuro si sa che fu il quinto prefetto della prefettura della Giudea, in carica negli anni 26-36: aveva giurisdizione anche in Samaria e Idumea. Di regola risiedeva a Cesarea marittima, la città costruita con sontuosità da Erode il Grande, l'unica fornita di porto; tuttavia spesso si trasferiva a Gerusalemme, in occasione di feste (ad es. la Pasqua), per controllare meglio la situazione, sempre molto turbolenta. Secondo quanto riportato da Flavio Giuseppe, egli provò senza successo a romanizzare la Giudea, introducendo, in totale dispregio delle leggi ebraiche, immagini dell'imperatore a Gerusalemme (soprattutto nel palazzo di Erode): la protesta arrivò all'imperatore che lo obbligò a riportare le insegne e gli scudi a Cesarea. Provò anche a costruire un acquedotto con fondi del tesoro del Tempio destinati ad opere sacre: la decisione originò una rivolta che fu sedata in maniera sanguinosa. Il governatore della Siria, Lucio Vitellio, lo destituì nell'anno 36 a causa della durezza con cui aveva represso i rivoltosi Samaritani sul monte Garizim. Una lettera del re Erode Agrippa I lo stigmatizza a causa “della sua corruttibilità, della sua violenza, dei suoi furti, maltrattamenti, offese, delle esecuzioni capitali da lui decise senza processo, nonché della sua ferocia incessante e insopportabile”. Anche Filone di Alessandria (20 a.C.-45 d.C.) racconta della “sua venalità, la sua violenza, i suoi furti, i suoi assalti, la sua condotta fuori legge, le frequenti esecuzioni di prigionieri che non erano stati giudicati, e la sua ferocia senza limite”. Viceversa, è ricordato come martire dalla Chiesa copta e come santo dalla Chiesa etiope, ma queste tradizioni religiose sono sorte con l'intento di mitigare la colpa del governatore romano in tempi in cui il cristianesimo incontrava difficoltà nei rapporti con l'impero.
32 Siamo propensi a credere che Giuda provenisse da ambienti farisaici progressisti, il quale tradì in quanto riteneva l'insurrezione destinata al fallimento senza un appoggio esplicito dei farisei, i quali, a quel tempo, rappresentavano il partito democratico-popolare più importante della Giudea. D'altra parte lo stesso Cristo si rendeva conto che non sarebbe stato possibile avere la meglio sui Romani con un semplice colpo di stato, altrimenti l'avrebbe compiuto subito, appena entrato trionfalmente nella capitale. Una qualunque idea di messianicità, senza una forte partecipazione popolare, non avrebbe potuto avere successo contro l'esercito più forte del mondo.
33 Giuseppe detto “Caifa” (o Caiafa) fu sommo sacerdote, appartenente alla dinastia dei sadducei, e capo del Sinedrio ebraico, dal 18 al 36 (fu destituito da Vitellio). In tale carica (nominato da Valerio Grato) era succeduto al suocero Anna (Anania), in carica dal 6 al 15, di cui si parla nel quarto vangelo (tra i due ve ne sono altri tre di cui non sappiamo nulla). Dall'autorevole famiglia di Anna uscirono cinque sommi sacerdoti: una dinastia successivamente annientata dagli zeloti. Giuseppe Flavio, nelle Antichità Giudaiche, sostiene ch'era l'imperatore romano a nominare, di anno in anno, il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme; sostiene anche che talvolta i sommi sacerdoti compravano questa carica col denaro, senza però attribuire ciò a Caifa. Sempre nei racconti di Flavio viene detto che il sommo sacerdote poteva anche essere considerato il capo della nazione giudaica e che a volte era imparentato con il governatore romano della regione. L'assenza del nome di Caifa fra coloro che si lamentavano degli abusi di Pilato, fa pensare che tra i due i rapporti fossero buoni.
34 In Lc 21,38; 22,2.6 la folla sta dalla parte di Gesù; poi improvvisamente in 23,4-5.18 gli è contro, senza una vera motivazione.
35 Da notare che Lc 3,2 è convinto che sia il Battista sia Gesù abbiano iniziato la loro predicazione nel periodo in cui erano in carica due sommi sacerdoti: Anna e Caifa, quando invece era in carica solo il secondo. Come faceva inoltre a sapere che prima di Caifa vi era stato Anna resta un mistero, in quanto neppure Marco lo cita. Quindi o si tratta di un'interpolazione tardiva, desunta dal IV vangelo, oppure Luca poté in qualche accedere a una fonte giovannea.
36 Vi sono stati vari esegeti che hanno sostenuto che il giudizio a carico di Gesù non avrebbe potuto aver luogo né alla vigilia della pasqua, né durante una qualunque festa religiosa, in quanto era vietato; né di notte e neppure in una casa privata, ma solo presso il Tempio. Va però precisato che qui l'accusato stava per compiere una insurrezione armata, contro i Romani e i capi ebraici collusi: non avrebbe avuto alcun senso rispettare le regole formali della legislazione.
37 Durante il regno di Caligola, Erode Antipa – stando alle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio –, accusato di mire rivoluzionarie, fu mandato in esilio a Lugdunum (Lione), nelle Gallie (ma alcuni pensano che l'esilio fosse in Spagna), dove morì, forse per mano di un generale romano. La moglie, indirettamente responsabile di questa sua fine, in quanto aveva preteso per il marito il titolo di re, decise di seguirlo nella sventura. Sin dall'inizio della sua carriera Erode aveva chiesto all'imperatore Ottaviano il titolo regale, ma aveva dovuto accontentarsi di quello di tetrarca di Galilea e Perea, territori che governò dal 4 a.C. al 39 d.C. Giuseppe Flavio lo ritenne amico e confidente dell'imperatore Tiberio, al quale aveva dedicato la nuova città di Tiberiade sul lago di Genezareth, in Galilea. Fu responsabile dell'arresto e della morte a Macheronte di Giovanni il Battista, in relazione al fatto che Giovanni lo accusava di aver ripudiato la prima moglie e sposato Erodiade, sua cognata e madre di Salomè, in violazione della legge mosaica, in quanto non era lecito sposare la moglie del fratello se c'erano dei figli. Quel divorzio era stato anche una follia dal punto di vista politico, poiché guastò i rapporti con il vicino Regno dei Nabatei, il cui re, Areta IV, era padre della sua prima moglie e, appena poté, si vendicò dell'affronto, sconfiggendo Erode militarmente. Un amministratore di quest'ultimo, Cuza, era marito di Giovanna, una delle discepole del Cristo (citata solo in Lc 8,3 e 24,10).
38 Si noti, peraltro, che, sulla scia di Luca, secondo il vangelo apocrifo di Pietro la responsabilità della condanna di Gesù fu proprio di Erode Antipa, che subentrò a Pilato dopo che questi si lavò le mani.
39 La guarnigione romana si recava a Gerusalemme solo nel corso delle festività, quando era più facile per gli ebrei compiere delle attività eversive; tuttavia, a partire dagli anni 60 iniziò a insediarsi stabilmente.
40 Si noti, peraltro, che l'ateismo non piaceva neppure ai Romani: lo dimostra il fatto che le persecuzioni a carico dei cristiani venivano motivate anche dall'accusa di ateismo, in quanto non credevano in alcuna divinità pagana.
41 Molti esegeti sostengono che nella Giudea di allora non vi era affatto l'usanza di liberare un criminale durante la pasqua; ciò però non vuol dire che in quell'occasione Pilato non abbia trovato conveniente proporre a una folla, non facilmente gestibile, una sorta di baratto tra due detenuti, al fine di poter eliminare quello che per lui era più pericoloso. D'altra parte anche il procuratore della Giudea (dal 52 al 60) Marco Antonio Felice, nel tentativo di annientare il potere degli zeloti, favorì una fazione violenta dei sicari, dei quali si servì per l'omicidio dell'ex sommo sacerdote Jonatha, successore di Caifa.
42 La flagellazione veniva fatta con il flagrum, cioè con tre cordicelle di cuoio munite di manico, che finivano con due piombini pesanti distanziati da uno più piccolo. Ogni sferzata, da parte dei due militari, provocava perciò sei ferite lacero-contuse di circa tre centimetri. Sulla Sindone se ne contano più di 370. Ma il lenzuolo avvolgeva il cadavere solo sopra e sotto, non lateralmente. È presumibile perciò che sul corpo vi fossero da 500 a 600 di questi lividi con lacerazione delle carni. Dividendo per il numero di piombini, si può parlare di circa 100 frustate. Non era necessaria la flagellazione prima della crocifissione, anzi in genere erano in alternativa. Semmai il condannato poteva essere frustato durante il tragitto verso il luogo dell'esecuzione. Nel processo di Pilato la fustigazione è servita proprio per agevolare la crocifissione, benché nel vangelo di Luca non appaia così.
43 L'ultima grande guerra messianica degli ebrei fu condotta nel 132-35 da Simon Bar-Kocheba, “Figlio della stella”. È la stessa composizione del nome; rappresenta la stessa intenzione.
44 Come noto, la trave (stipes) era già piantata nel terreno. Generalmente i chiodi venivano messi solo nei piedi, per cui, se vi era sotto i piedi un sostegno di legno (suppedaneum) l'agonia poteva durare anche fino a tre giorni. La morte era per asfissia, ma nel Cristo si pensa sia stata per infarto.
45 Si noti come in Matteo entrambi i malfattori, che in realtà vengono chiamati “briganti” (termine politico per eccellenza), insultano Gesù.
46 Peraltro l'espressione del v. 46 è molto platonica, in quanto un ebreo non avrebbe mai potuto pronunciarla, non riuscendo a concepire un'anima senza corpo o un corpo senz'anima; e se la Sindone è vera, essendo stata essa una sorta di “esplosione di energia”, in cui l'intera fisicità del corpo è stata coinvolta, dovremmo dar ragione alle teorie ebraiche, non a quelle pagane.
47 La stessa espressione di sconforto: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (23,34) non può essere stata detta da Cristo, non solo perché ateo, ma anche perché gli uomini non possono essere perdonati da nessuno se non da loro stessi. In ogni caso non ha alcun senso che vengano “perdonati” o che si perdonino da soli se prima non saranno state poste le condizioni per cui non sia possibile compiere cose assurde, del tutto inspiegabili, nei confronti delle quali si ha persino il coraggio di trovare delle giustificazioni. Non è possibile attribuire alla natura umana l'incapacità di essere se stessa: così facendo si contribuisce a fare del Cristo un soggetto religioso e quindi a ritenere attendibile la suddetta espressione di sconforto.
48 Qualche esegeta pensa che Giuseppe di Arimatea sia stato mandato dalle autorità religiose a seppellire Gesù, non potendo stare i corpi appesi alle croci durante la festività pasquale. Ma questo non spiega il motivo per cui Giuseppe dovesse riservargli un sepolcro di lusso e non una fossa comune, in cui venissero interrati, insieme, i tre giustiziati.
49 Si noti come nella triade femminile iniziale Marco ponga Salome, madre dei fratelli Zebedeo, al posto di Giovanna, moglie di Cuza, funzionario di Erode.
50 Qui forse è il caso di precisare che il numero tre non voleva affatto dire che Gesù sarebbe dovuto risorgere il terzo giorno (come s'è voluto far credere santificando la domenica), ma che avrebbe vinto la morte. Nella cultura ebraica “tre” voleva dire “completamente”. Questo a prescindere dalla totale insussistenza di quelle profezie. I numeri, per gli ebrei, han sempre un significato simbolico: sette significa “tutto quello che uno ha”; dodici “il popolo di Israele”; quaranta “una generazione o tutta la vita”.
51 Forse i vangeli, purtroppo andati perduti, che mistificavano di meno il Cristo autentico, sono stati quelli degli Ebioniti e/o dei Nazarei e/o degli Ebrei (del II secolo), i quali usavano come fonte il vangelo originario di Matteo, non quello canonico, e che avevano rifiutato la predicazione petro-paolina, accettando solo un “Cristo umano” che si era preso a cuore la condizione delle classi marginali, ispirato dalla predicazione del Battista.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube