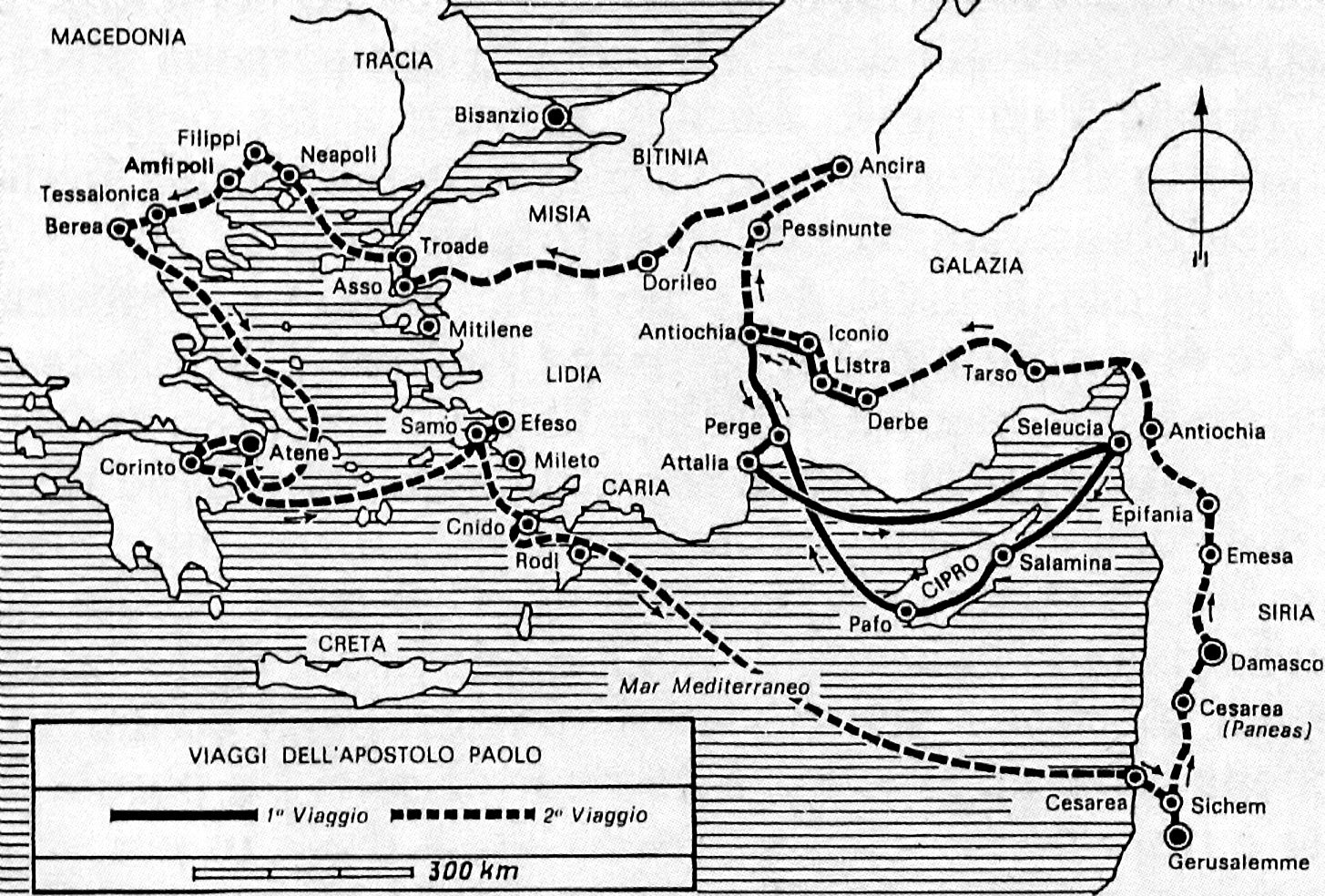
Home - Israele - Marco - Luca - Giovanni - Ateo-Sovversivo - Umano-Politico - Diatribe - Risorto-Scomparso - Parabole-Guarigioni - Atti - Lettere paoline - Esegesi - Esegeti - Apocalisse - Cristo in Facebook - Diario su Cristo - Bibbia
MIKOS TARSIS
OMBRA DELLE COSE FUTURE
Esegesi laica delle lettere paoline
Introduzione - 1) Cronologia paolina - 2) Lettera ai Romani - 2.1) Addendum. Exousiai e teologia politica - 3) Tessalonicesi I - 4) Tessalonicesi II - 5) Lettera ai Galati - 6) Lettera agli Efesini - 7) Lettera ai Filippesi - 8) Lettera a Filemone - 9) Timoteo I - 10) Timoteo II - 11) Lettera a Tito - 12) Corinzi I - 13) Corinzi II - 14) Lettera ai Colossesi - Conclusione - 15) Appendici. 15.1) Pietro I - 15.2) Pietro II - 16) Quali differenze tra ebraismo e cristianesimo? - 17) La religione ebraica e Roma - 18) La condanna pontificia dell'apostolo Paolo - 19) L'idea di resurrezione dei corpi
Per Paolo di Tarso, il fondatore, insieme all'apostolo Simon Pietro, del cristianesimo primitivo, il giudaismo era «ombra delle cose future», e queste cose altro non erano che la «sua» teologia mistica, ch'era, a sua volta, una radicalizzazione della teologia politica che il galileo Pietro aveva elaborato al cospetto della tomba vuota, parlando di «morte necessaria» (voluta da dio) e di «resurrezione» (corpo ridestato).
Oggi è diventato lo stesso «cristianesimo» un'«ombra delle cose future», e queste altro non sono che l'umanesimo laico e il socialismo democratico. Le quali hanno preso a formarsi, tra mille errori e contraddizioni, anche di una gravità eccezionale, seguendo un percorso spesso imprevedibile, ma sempre in linea con l'esigenza di recuperare qualcosa che si è perduto e di cui non si può fare a meno.
I
Il lato conservatore della teologia paolina sta proprio nella distinzione che viene posta tra Cristo e Dio, tra dio-padre e dio-figlio. Se Paolo avesse semplicemente detto che in Cristo vi è l'interezza dell'umano, l'originaria dimensione umana di cui noi abbiamo perduto memoria, non avrebbe fatto né un discorso politicamente rinunciatario, né alcun discorso di tipo teologico.
Se Cristo infatti rappresenta l'umano, qualunque concezione della divinità gli è già propria, cioè è già inclusa nell'umano.
Paolo non s'è reso conto che se Cristo fosse stato un «suo discepolo», difficilmente avrebbe portato la predicazione ricevuta alla più tragica conseguenza, quella appunto della crocifissione. Infatti se la realizzazione dell'identità umana non è possibile su questa Terra, a causa del peccato originale e delle sue conseguenze, dilatatesi e approfonditesi nel tempo a livello planetario, sarebbe stato sufficiente limitarsi a dirlo, senza bisogno di insistervi sino al punto da desiderare il martirio, o comunque questa soluzione estrema sarebbe rimasta una scelta meramente privata, un'eccezione alla regola, quella regola che era, e che ancora oggi è, della «rassegnazione metafisica».
Contro Paolo ce l'avevano i pagani politeisti e gli ebrei nazionalisti: gli uni lo accusavano, col suo monoteismo, di predicare una sorta di ateismo, in quanto il suo dio-padre restava rigorosamente invisibile, e nell'idea di resurrezione del Cristo (unica vera immagine di dio) bisognava credere come se fosse non una cosa simbolica, ma una realtà oggettiva. Gli ebrei invece lo accusavano di voler togliere a Israele la speranza di diventare una nazione libera dallo straniero.
Tuttavia, una volta distrutta Gerusalemme (nel 70 e poi di nuovo nel 135), veniva meno anche la necessità di trovare un accordo politico col giudaismo. Non restava che l'esigenza di trovare un accordo religioso col paganesimo, che sicuramente sarebbe stato molto più facile dell'altro, come poi la storia si preoccuperò di dimostrare, benché anche in questo caso i tempi dell'intesa furono piuttosto lunghi, essendo il politeismo una tradizione culturale molto radicata nelle società e civiltà basate sullo schiavismo e sul servaggio.
Il cristianesimo paolino riuscirà a convincere i pagani ad abbandonare tutti i loro dèi e ad accettare, in forma più ateistica (ch'era poi quella maturata negli ambienti ebraici), l'idea di un unico dio invisibile e irrappresentabile, nonché l'inedita idea di un figlio unigenito di dio morto e risorto, a lui consustanziale e nello stesso tempo incarnatosi come uomo (idea inedita in quanto la resurrezione andava intesa in senso letterale e non metaforico, come invece per altri culti pagani).
Se Paolo si fosse limitato a dire che non esiste alcun dio e che il Cristo aveva accettato di morire in croce non tanto per redimere gli uomini dal peccato originale, quanto per insegnare la necessità della democrazia, utile soprattutto quando si vuole compiere qualcosa contro l'oppressione, avrebbe fatto un discorso ateistico più coerente e avrebbe lasciato aperta la strada a soluzioni politiche rivoluzionarie.
La divinità è tutta racchiusa nell'umanità e, poiché la condizione naturale dell'umanità è quella terrena, almeno in quello che definiamo l'orizzonte storico, è proprio in questa dimensione che bisogna cercare di viverla, anche a costo d'essere «crocifissi». La «croce» è l'onere di cui eventualmente ci si deve far carico se, nel voler vivere la propria umanità in maniera integrale, hic et nunc, s'incontrano opposizioni risolute.
Se Paolo avesse detto questo, il problema sarebbe diventato un altro, e cioè quello di come affrontare l'illusione di credere che per dimostrare la propria umanità sia sufficiente farsi crocifiggere. Una cosa infatti è resistere all'oppressione, un'altra è provocare l'oppressore, facendo sì che ci si possa vantare della propria condizione d'oppresso, accampando pretese di verità e di giustizia, che di umano e di democratico non hanno proprio nulla.
Vittimismo infatti vuol dire fare dell'oppressione e soprattutto del martirio una sicura testimonianza di verità, a prescindere da qualunque altro comportamento.
L'unico modo razionale di tentare di uscire da questo rischio, da questo abuso della credulità, è quello di vivere la propria resistenza non in forma individuale, ma collettiva, misurando sempre l'entità delle forze in campo e chiedendosi continuamente se le esigenze dell'umano vengono rispettate in maniera adeguata. Se un perseguitato, solo perché tale, si sente migliore del proprio persecutore, è naturale che, nel caso in cui riesca ad andare al potere, assuma atteggiamenti anche più odiosi del proprio persecutore. Basta vedere cosa fece il cristianesimo dopo che, con Teodosio, divenne «religione di stato».
II
Se Paolo oggi fosse vivo sarebbe inevitabile porgli la seguente domanda: «Anche ammesso e non concesso che una liberazione effettiva su questa Terra non sia possibile, deve per forza esserci un dio-padre e un dio-figlio?».
Il cristianesimo ha voluto prendere alla lettera la questione della generazione ab aeterno, senza rendersi conto che se proprio si voleva trasferire nei cieli l'idea terrena di «famiglia», sarebbe poi stato impossibile sottrarsi all'osservazione critica di chi avesse ipotizzato che non la famiglia terrena è un riflesso di quella celeste, bensì il contrario (cfr p.es. l'opera di Feuerbach).
Peraltro una teologia davvero «democratica» avrebbe dovuto prevedere un ruolo femminile equivalente a quello di «dio-padre», sottraendo il misticismo all'egemonia del maschilismo. Se non esiste una «dea-madre», come può essere generato un «dio-figlio»? e poi perché generare un «dio-figlio unigenito» e non anche una «dea-figlia»? e perché non tanti «dèi-figli»?
Tutta la teologia cristiana, inclusa quella che s'è sforzata di vedere nello spirito santo una delle due «mani» di dio (intendendo l'altra il figlio), ovvero il lato «femminile» della trinità, resta profondamente maschilista (e politicamente monarchica). Una qualunque «teo-logia», cioè un qualunque «discorso-su-dio», non ha alcun senso razionale: l'uomo non può avvilupparsi in considerazioni che, in ultima istanza, restano del tutto indimostrabili o comunque non pertinenti alla propria esigenza di laica umanità.
Accettare, come presupposto gnoseologico, la presenza di una divinità, significa negare all'uomo la libertà di coscienza. O la divinizzazione è parte costitutiva dell'essere umano, oppure dio non esiste. Una qualunque ammissione della sua esistenza fa perdere all'uomo la sua autonomia, proprio in quanto diventa impossibile non arrivare a utilizzare le contraddizioni umane per sostenere che solo dio ne è privo e quindi può risolverle. L'esistenza di un dio assolutamente perfetto è una tentazione troppo grande per chi vuole rassegnarsi al male su questa Terra. Il che ovviamente non vuol dire che il credente sia un grande peccatore: «credere in dio» in fondo vuol dire - per tutte le religioni, non solo per quella cristiana - sforzarsi di tenere un comportamento degno, in previsione di un premio ultraterreno, a prescindere dall'intenzione che si ha di lottare in maniera più o meno convinta contro le ingiustizie sociali.
Resta tuttavia un fatto, abbastanza assodato, salvo eccezioni naturalmente. Di fronte ai peccati altrui, il credente, in genere, pecca di omissione, in quanto chiede, a chi li subisce, di pazientare sino alla fine dei giorni, sino al «giudizio universale». Anche quando s'impegna politicamente come cittadino, il credente parte sempre dal presupposto che gli antagonismi sociali non sono risolvibili sino in fondo, o comunque sono componibili solo parzialmente. La mediazione, che il credente cerca in politica, è solo uno strumento per attenuare, non per risolvere, gli opposti estremi. Anzi, nel peggiore dei casi, quello in cui si vuol fare del fondamentalismo dogmatico una regola di vita, è la stessa religione che si pone come uno degli estremi. E questo è tanto più vero quanto più essa si caratterizza in senso «monoteistico».
(torna su)1) Cronologia paolina
(molto approssimativa)
Nascita di Paolo 5-10
Scuola di Gamaliele a Gerusalemme 20-25
Vocazione cristiana 34-35
In Arabia e a Damasco 36-38
Prima visita a Gerusalemme 38-39
Apostolato in Siria e Cilicia 39-44
Primo viaggio missionario 45-49
Assemblea di Gerusalemme e incidente di Antiochia 49
Secondo viaggio missionario 49-52
- In Macedonia 50
- Corinto (1-2 Tessalonicesi) 50-52
Terzo viaggio missionario 53-58
- Efeso (1 Corinti, Galati, Filippesi) 53-54
- Macedonia (2 Corinti) 57
- Corinto (Romani) 57-58
- Filippi 58
Arresto a Gerusalemme 58
Prigionia a Cesarea 58-60
Viaggio a Roma 60-61
Prima prigionia romana (Colossesi, Filemone, Efesini) 61-63
Viaggio in Spagna (?), Asia Minore, Creta, Macedonia 63-66 (?)
Seconda prigionia romana 66 (?)
Martirio 67 (?)
Si noti che non pochi anni della vita di Paolo coincidono con la predicazione politica del Cristo, eppure la tradizione ha sempre escluso ch'egli abbia mai conosciuto personalmente Gesù. È credibile questa cosa? Siamo proprio sicuri ch'egli, quando Gesù era in vita, non sia stato uno dei suoi oppositori? Siamo sicuri che Paolo non abbia cercato di rimediare alla colpa di non aver creduto in Gesù quand'era vivo, decidendo di credergli quand'era morto? Siamo sicuri che Paolo non rappresenti quella corrente farisaica con cui Gesù cercò d'intavolare delle trattative politiche per l'insurrezione nazionale, e che proprio questa corrente fu quella che all'ultimo momento deciso di tradirlo? Siamo proprio sicuri che Paolo non sia stato protagonista di un doppio tradimento: il primo nei confronti del Cristo vivo e il secondo nei confronti del Cristo morto?
Per quale motivo Paolo perseguitava i cristiani? Molto probabilmente perché, predicando un messia morto e risorto, distoglievano gli ebrei dal lottare contro Roma. Ma allora Paolo voleva la stessa cosa del Cristo! Quindi perché si rifiutò di seguirlo quand'era vivo e accettò di farlo solo dopo ch'era morto? Il motivo è molto semplice: Paolo anteponeva l'ideologia giudaica alla politica del Nazareno, la cui ideologia aveva assai poco di teologico. Quando poi capì d'aver sbagliato, accettò l'idea regressiva di Pietro sulla resurrezione del Cristo per tradire quest'ultimo una seconda volta.
(torna su)2) Lettera ai Romani
I
Nella Lettera ai Romani, che è il documento fondamentale di tutta la dogmatica cristiana, Paolo esprime molto bene la sua concezione pessimista circa la possibilità che l'uomo ha di realizzare una società veramente democratica. L'uomo - a suo giudizio - è incapace di compiere il bene, cioè non ha alcuna possibilità di recuperare sulla terra l'innocenza perduta. Questo obiettivo potrà realizzarsi solo in una dimensione ultraterrena.
Si può anzi dire, in un certo senso, che per Paolo l'innocenza adamitica, non essendo l'uomo perfetto come dio, non poteva che andare perduta: era solo questione di tempo. Ciò che più importa, infatti - secondo lui -, non è tanto riconoscere questa innata inclinazione al male presente nell'uomo, quanto piuttosto essere disponibili al pentimento quando si cade nella colpa.
Se gli uomini fossero senza colpa, sarebbero immortali. La morte invece è il segno più tangibile che il peccato è connaturato all'essenza dell'uomo (5,12). «Il salario del peccato - dice Paolo - è la morte» (6,23).
In tal senso, la differenza tra l'ebreo e il gentile sta semplicemente in questo, che l'ebreo, in virtù della legge mosaica, aveva molta più «coscienza della caduta» (5,20) di quanta ne potesse avere il gentile, troppo caratterizzato da rapporti di tipo individualistico e quindi poco disposto a considerare le leggi in chiave etica o pedagogica.
Come si può notare, il modo di ragionare di Paolo è sempre di tipo metafisico e mai di tipo storico: per lui tutti gli uomini sono uguali, a prescindere dalle loro condizioni sociali di vita, proprio perché è la morte che li accomuna a un unico destino. Tutta la creazione «è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa» (8,20).
Paolo non vede la morte come un processo naturale, che non può di per sé pregiudicare la realizzazione di una società democratica, ma la vede come un processo coerente con la struttura di peccato che alberga nella coscienza umana. Non solo da questo limite l'uomo non può liberarsi, con le proprie forze, ma è proprio questo limite che - secondo Paolo - impedisce qualunque altra liberazione. L'uomo non sa neppure «cosa sia conveniente domandare» (8,26).
La prima parte della Lettera ha, in questo senso, un chiaro contenuto ideologico-politico. Infatti - dice Paolo -, se l'uomo avesse la possibilità di realizzare una società libera e giusta, non avrebbe crocifisso il Cristo, il quale è morto in maniera cruenta perché sapeva, a priori, che l'uomo non l'avrebbe spontaneamente accettato. Cristo è morto appunto per i peccati dell'uomo, ed è risorto per poterlo giustificare agli occhi di Dio.
Paolo aveva capito una cosa di fondamentale importanza: gli ebrei non avevano più il diritto di considerarsi migliori degli altri popoli solo perché possedevano la legge più democratica del mondo, quella appunto mosaica. Se fossero stati veramente migliori, non avrebbero ucciso il Cristo. Poiché invece l'hanno fatto, decade inevitabilmente il primato della elezione divina del popolo ebraico e, con esso, quello della legge mosaica. D'ora in avanti, la legge viene sostituita dalla coscienza (di fede) e l'elezione divina dall'uguaglianza di tutti i popoli di fronte a Dio.
Perché dunque il Cristo s'è lasciato uccidere? Per dimostrare agli uomini - dice Paolo - la loro incapacità di bene, ovvero per togliere agli ebrei (il «popolo eletto») l'orgoglio di credere che per realizzare il bene sia sufficiente conoscere o applicare la legge. «Mosè infatti - dice Paolo - descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la pratica vivrà per essa. Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo?» (10,5 s.).
Se i più fedeli osservanti delle norme legali (scribi e farisei) non sono stati capaci di riconoscere l'importanza del Cristo, ciò significa che l'applicazione della legge mosaica non può più essere un criterio per stabilire se esiste la possibilità o meno di realizzare il bene comune.
La legge è servita per la conoscenza del peccato - dice Paolo -, ma non ha aiutato, in positivo, a vivere il bene. La realizzazione del bene può essere solo frutto della coscienza, che è patrimonio di tutti, ed essa realizza il bene soltanto quando, credendo nella resurrezione dai morti, ritiene che l'unico «vero bene», sulla terra, l'abbia realizzato Cristo, che ha vinto la morte.
Paolo, in sostanza, ha tolto agli ebrei non solo la falsa pretesa di chi crede di giustificarsi obbedendo semplicemente alla legge, ma ha tolto anche la giusta esigenza di realizzare una società libera e giusta, al di là di quello che la legge prevede. In altre parole, egli non solo ha tolto agli ebrei, giustamente, la possibilità di realizzare per via giuridica la democrazia, ma anche la possibilità di farlo per via politica.
Paolo ha ritenuto, a torto, che gli ebrei avessero ucciso il Cristo non perché volevano una liberazione della Palestina secondo modalità politiche diverse, che il Cristo non poteva accettare, ma perché l'essere umano è fondamentalmente incline al male. Se il Cristo è stato ucciso dagli ebrei, che avevano le leggi più democratiche di quel tempo, sarebbe stato ucciso da qualunque altro popolo.
II
La seconda parte della Lettera (5,12 ss.) è più di carattere teologico-dogmatico. Paolo infatti cerca di dare una giustificazione religiosa, influenzata dall'orfismo, di questo suo pessimismo di fondo, chiamando in causa il mito del peccato originale, cui egli dà un'interpretazione alquanto particolare.
A suo giudizio l'uomo, simbolizzato da Adamo ed Eva, è incline al male sin dai tempi della creazione. Se così non fosse, Adamo ed Eva non avrebbero peccato. Avendolo fatto, essi hanno reso sempre più inevitabile tale tendenza al male, poiché le circostanze che influenzano gli esseri umani, diventano, col passare del tempo, sempre più opprimenti.
Il peccato di Adamo ha provocato l'ira di dio, che ovviamente - secondo Paolo - non poteva essere placata da un altro uomo. Poteva esserlo solo da un altro dio, assolutamente innocente e perfetto: il figlio di dio.
Per poter placare quest'ira, occorreva un sacrificio cruento: di qui l'inevitabile crocifissione del Cristo, il quale, in tal modo, ha potuto riconciliare l'uomo peccatore a dio.
Naturalmente dio rinuncia all'ira solo nei confronti del «peccatore pentito», che crede in Cristo, ma l'ira permane nei confronti di tutti gli altri, ebrei o gentili che siano, al punto che neppure il sacrificio di Cristo potrà impedire che a causa del «male» di questi «irriducibili» avvenga l'apocalisse dell'umanità (alla fine dei tempi), che inaugurerà il giudizio universale e aprirà le porte dei cieli ai credenti che avranno perseverato nella fede e che erano stati da dio «predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo» (8,29).
Perché è importante che vi sia questo «giudizio»? Perché secondo Paolo esso è l'unico criterio che permetterà di stabilire definitivamente la vera fede da quella falsa. Non essendo gli uomini in grado di giudicare se stessi, stabilendo in che modo il bene va concretamente realizzato, essi - secondo Paolo - hanno bisogno che un essere onnipotente e onnisciente lo faccia al posto loro, dall'esterno. D'altra parte - dice Paolo - dio è anche l'unico in grado di conoscere «i segreti degli uomini» (2,16).
Si badi, non è che Paolo voglia predicare la teoria secondo cui il bene nasce dal male (come gli rimproverano i suoi oppositori). Egli, è vero, ritiene che l'essere umano sia incapace di bene, ma questo ovviamente non lo porta a sostenere che l'uomo sia autorizzato a compiere il male. Il male va sopportato come un limite strutturale all'esser-ci, per dirla con Heidegger. L'uomo «nasce male», cioè contraddittorio, incoerente, e rischia continuamente - secondo Paolo - di «finire peggio», se non accetta di credere nella redenzione del Cristo, il cui definitivo compimento avverrà solo nel momento della parusia. Essendo incapace di bene, l'uomo può soltanto sperare, comportandosi senza fare «troppo male», d'essere perdonato da dio.
Nel pensiero di Paolo, Adamo non è che «figura di Cristo» (5,14): il suo peccato era previsto dalla scienza divina, così come l'espiazione del Cristo, per la giustificazione degli uomini. «Dio aveva prestabilito Cristo a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza» (3,25). Cioè a dire, dio - secondo Paolo - non ha voluto distruggere l'umanità intera, proprio perché attendeva che il Cristo, col proprio sacrificio, la riscattasse dall'ira che incombeva su di essa a causa dei peccati commessi.
Dio - dice Paolo - «ha sopportato con grande pazienza vasi di collera (leggi: i predestinati al male), già pronti per la perdizione, per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di misericordia, da lui predisposti alla gloria, chiamati non solo tra i giudei ma anche tra i pagani» (9,22 ss.).
Cristo è morto per tutti, ma soprattutto per coloro ai quali era stato promesso, affinché non disperassero nel vedere tanto male nel mondo. Nessun altro avrebbe potuto sacrificarsi al suo posto, poiché ogni uomo, di fronte a dio, ha sempre torto.
In questo senso, è bene precisare che per Paolo, se esiste una «predestinazione» da parte di dio, nei confronti degli uomini, tale predestinazione (nel bene o nel male) può anche essere «revocata», poiché dio può fare dell'uomo ciò che vuole. «Se tu [pagano] sei stato reciso dall'oleastro che eri secondo la tua natura e contro natura sei stato innestato su un olivo buono [il cristianesimo], quanto più essi [gli ebrei], che sono della medesima natura [del cristianesimo], potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo» (11,24).
Naturalmente il tempo e le modalità della revoca restano sconosciuti agli uomini, che devono limitarsi a un atteggiamento di «timore e tremore» al cospetto di dio, il quale - dice Paolo - «ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia» (11,32).
E, in ogni caso, anche se si fosse trovato qualcuno «disposto a morire per un giusto» (5,7), e quindi disposto a dimostrare quanto gli uomini non avessero bisogno di alcuna predestinazione, secondo Paolo non si sarebbe mai potuto trovare nessuno disposto a morire «per gli empi» (5,6), come appunto ha fatto il Cristo col suo amore infinito e incondizionato per gli uomini. Questo per dire che la redenzione-liberazione ci viene offerta in maniera assolutamente gratuita, «per grazia» (4,16) - dice Paolo -, a prescindere da qualunque nostro merito, cioè come una manna piovuta dal cielo, con la differenza però - rispetto alla «manna del deserto» - ch'essa deve indurci a rinunciare per sempre al sogno di costruire, con mezzi umani, la «terra promessa».
I cristiani non devono cercare la giustizia sulla terra, ma devono lasciar fare «all'ira divina» (12,19); devono «benedire» chi li «perseguita» (12,14); devono sì vincere «con il bene il male» (12,21), ma il loro «bene» non deve andare al di là della mera sopportazione.
«Ciascuno, infatti, deve stare sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio... I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male... Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dovete pagare i tributi...» (13,1 ss.). Il cristiano deve difendere la sua fede in Cristo, anche attraverso la predicazione e il martirio, ma per tutto il resto deve lasciar fare a chi detiene il potere.
In pratica, la resurrezione di Cristo è servita - secondo Paolo - a capire che dio non vuole distruggere l'umanità intera, a causa dei peccati ch'essa continuamente commette, ma vuole soltanto «giudicarla»: cosa che appunto farà alla fine dei tempi. Nell'attesa del «giorno del giudizio», l'uomo - dice Paolo - non deve ovviamente «restare nel peccato affinché abbondi la grazia» (6,1) - questa sarebbe un'interpretazione di comodo, opportunistica della sua Lettera.
In effetti, leggendo questa Lettera, viene abbastanza spontaneo chiedersi perché l'uomo debba fare di tutto per vincere il male, quando, di fatto, l'unico in grado di vincerlo è dio (o Gesù Cristo). Se la liberazione dal male può essere solo il frutto di una «grazia ricevuta», non si capisce perché l'uomo debba tormentarsi più del dovuto circa la sua incapacità di bene. Se l'uomo è nato «male», la responsabilità è di chi l'ha creato.
Paolo, tuttavia, non è disposto a concedere nulla a una morale lassista e relativista. Qui è l'influenza della filosofia stoica che gli impedisce di trarre dai suoi ragionamenti le conseguenze più estreme. Ecco perché egli è costretto ad affermare che i credenti devono considerarsi «viventi per Dio, in Cristo Gesù» (6,11). Il cristiano cioè deve cercare, per quanto può, di vincere il peccato e le sue inclinazioni al male: nel far questo, però, egli non si affiderà tanto alla volontà umana, quanto alla fede nella grazia divina.
Con ciò Paolo apre le porte all'autoritarismo ecclesiastico, solo in virtù del quale, di fatto, si può decidere quando esiste la grazia divina e quando no e in che modo essa può essere elargita. Poiché delle due l'una: o il cristiano decide per conto proprio il modo in cui affidarsi alla grazia divina, oppure l'istituzione lo decide per lui. In entrambi i casi si deve porre una delega di responsabilità. Sta in questo, sostanzialmente, la differenza tra protestantesimo e cattolicesimo romano.
III
L'ipocrisia di Paolo dove sta? Nel fatto che da un lato egli considera la morte fisica come un ostacolo insormontabile alla realizzazione della giustizia sulla terra; dall'altro invece egli sollecita a ricercare la giustizia della fede, nonostante la presenza della morte. Tra le due posizioni vi è un elemento che qui non appare, ma che è assolutamente indispensabile perché entrambe possano coesistere senza contraddirsi: questo elemento è appunto la Chiesa.
Se Paolo si rivolgesse al singolo cristiano, la sua Lettera porterebbe ad assumere un atteggiamento di tipo protestantico. Siccome invece la Lettera si rivolge alla comunità cristiana di Roma, con essa egli chiede implicitamente che l'istituzione ecclesiastica venga rafforzata al massimo, al fine d'impedire che l'uomo s'illuda di poter costruire il bene comune in virtù delle proprie leggi.
Paolo, come si può notare, ha una concezione alquanto bizzarra della legge. Egli infatti la considera come un oggetto a se stante, completamente avulso dalla società ch'essa rappresenta. Paolo ragiona da metafisico e, come tale, vede nella legge non una semplice espressione della libertà umana, ma una vera e propria incarnazione del male, o meglio un oggetto di tentazione che il male (il peccato) può utilizzare in qualunque momento contro la volontà di bene che l'uomo può avere.
È incredibilmente limitato Paolo quando sostiene di non aver «conosciuto il peccato se non per la legge» (7,7). «Prendendo occasione da questo comandamento (Non desiderare), il peccato - egli afferma - scatenò in me ogni sorta di desideri» (7,8). È lo stesso ragionamento che certi pedagogisti fanno rivolgendosi ai bambini o agli adolescenti, quando dicono che per essi niente è più desiderabile di ciò che viene vietato.
È singolare che una persona intellettualmente dotata come lui non sia riuscita ad accorgersi che la legge, di per sé, non può indurre al male più di quanto non possa indurre al bene. La legge è sempre e solo un riflesso della realtà sociale, e se un uomo si lascia dominare dalle tentazioni, non può certo la legge essere considerata più responsabile della realtà sociale ch'essa riflette.
Le leggi degli ebrei erano più democratiche di quelle pagane, poiché - dice Paolo - «ricercavano la giustizia» (9,31). Le tribù infatti erano meno caratterizzate dai rapporti di tipo schiavistico, anche se al tempo di Paolo questa caratteristica era sempre meno vera. In ogni caso solo uno sciocco avrebbe potuto attribuire alla legge mosaica il progressivo consolidarsi dei rapporti di tipo schiavistico, ovvero il fallimento della ricomposizione delle antiche usanze comunitarie.
Paolo qui, in maniera rovesciata, compie lo stesso errore degli scribi e dei farisei, allorché erano convinti che, per conservare l'originale spirito comunitario d'Israele, fosse sufficiente rispettare fedelmente la legge e tutte le tradizioni, orali e scritte, che ad essa si erano sovrapposte nel corso dei secoli.
La realtà è che gli uomini non hanno bisogno delle leggi per capire cosa è «bene» e cosa è «male». Quando ciò avviene, è perché sul piano sociale si è già persa questa capacità di discernimento. A quel punto si può anche istituire una legge che ristabilisca l'ordine, ma sarebbe ridicolo farlo con lo scopo di assegnarle un potere magico risolutivo. Questo era stato il limite della cultura religiosa mosaica, ma nel tempo in cui essa nacque e si sviluppò quel limite era stato in realtà un «progresso», in quanto l'esigenza di una «legge» veniva a regolamentare dei rapporti la cui conflittualità appariva socialmente irrisolvibile.
Viceversa, Paolo si ostina a contestare il valore della legge mosaica, perché non vuole scendere sul terreno concreto delle contraddizioni di tipo sociale. Le poche volte che, indirettamente, cerca di farlo, il risultato è sempre lo stesso: il male non sta nei rapporti sociali, ma nella coscienza dell'uomo, per cui non esiste legge che non possa essere strumentalizzata dal peccato.
Qui Paolo cade in contraddizioni difficilmente comprensibili: da un lato infatti afferma che la coscienza umana è dominata dal peccato; dall'altro sostiene che la Legge mosaica permetteva all'uomo di avere maggiore «coscienza» di questo peccato.
Così dicendo, Paolo fa dell'uomo un mostro inspiegabile. Non a caso, egli, ad un certo punto, arriva a dire, con un'analisi psicologica di grande forza emotiva, che l'uomo non fa ciò che vuole ma ciò che detesta (7,15), ammettendo, con ciò, che nell'uomo risiedono due forze contrapposte, di cui quella «malvagia» risulta, alla fine, dominante, salvo, beninteso, l'intervento salvifico di uno dio misericordioso.
Paolo non avrebbe mai ammesso che una tale lacerazione interiore potesse essere il riflesso di rapporti sociali antagonistici. Anzi, egli sosteneva il contrario, e cioè che l'antagonismo sociale era il prodotto di un «corpo votato alla morte» (7,24).
Non è in questo senso paradossale che, nella teologia paolina, dio-padre, nella sua infinità bontà, abbia creato un essere umano in grado di fare non il bene che vuole ma il male che non vuole (7,19), in grado di avere «il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo» (7,18)?
Tutte le idee politiche, teologiche, sociali e culturali della Lettera ai Romani poggiano su un'errata concezione della natura umana e dei rapporti sociali ch'essa dovrebbe naturalmente vivere. Paolo ha esteso all'essenza dell'uomo in generale quelle contraddizioni che in realtà sono frutto di rapporti sociali storicamente determinati, cioè non ha fatto altro, in ultima istanza, che legittimare il sistema sociale schiavistico.
Quando poi, a partire dal capitolo 8, Paolo inizia a parlare della «vita nello spirito», se è chiaro ciò ch'egli intende per «spirito» (tutto ciò che è contrario alle debolezze della «carne»), molto meno chiaro diventa ciò che egli intende per «vita». Infatti, i valori dello «spirito» - a giudizio di Paolo - non devono tanto servire a cambiare la «vita» sulla terra, quanto a ottenere la «vita» nell'aldilà (8,11).
Certo, se il cristiano, prima di diventare credente, era un «disonesto», ora dovrà cercare di diventare «onesto», ma ciò - secondo Paolo - non potrà mai comportare una lotta politica e sociale contro la disonestà altrui. Il cristiano deve sopportare la disonestà altrui cercando di essere il più possibile onesto e lasciando a dio il giudizio finale. D'altra parte - dice ancora Paolo - «le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere ricevuta in noi» (8,18). Quindi non resta che consolarsi.1
Addendum
2.1) Exousiai e teologia politica (Rm 13,1-7)
[1] Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. [2] Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. [3] I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa' il bene e ne avrai lode, [4] poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. [5] Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. [6] Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. [7] Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto, il rispetto.
Il problema principale che solleva Rm 13,1-7 e che ha coinvolto decine di esegeti, non è se col temine exousìai (o exusiai, come spesso s'incontra nelle translitterazioni) si devono intendere le autorità costituite pagane o cristiane, poiché l'autore anonimo della pericope è così conservatore, sul piano politico, che ovviamente intendeva riferirsi alle autorità qua talis, cioè a quelle che portano la «spada» (v. 4), dovendo far rispettare l'ordine pubblico, e che sono altresì autorizzate a esigere «tasse» e «tributi» (v. 7).
È chiaro che, essendo la pericope del II sec., l'autore aveva in mente le autorità romane; tuttavia essa è così esplicita nel suo significato di subordinazione politica che potrebbe benissimo essere utilizzata anche in una societas christiana.
Meno ancora il problema è di sapere se col termine exousiai andavano intese le autorità politiche vere e proprie, dell'orbe romano, oppure i «principati e le potestà spirituali». Quando si ha a che fare con un testo dal contenuto teologico-politico (il quale afferma, già nel primo versetto, che «non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio»), i termini «autorità politiche» e «potenze spirituali» sono ovviamente intercambiabili: le une giustificano o supportano le altre, secondo le necessità particolari di una determinata teologia politica, sia che essa pretenda di essere «rivoluzionaria» (come p.es. la teologia della liberazione, di matrice latinoamericana, fortemente influenzata dal marxismo) o che di fatto si ponga in maniera reazionaria (come p.es. la teologia dell'Opus Dei, di Comunione e Liberazione, dei Gesuiti ecc.).
Una teologia politica che professi un Cristo «liberatore» dirà che le «potenze spirituali» esigono delle «autorità politiche» più giuste e democratiche; viceversa, una teologia politica che professi un Cristo semplicemente «redentore», dirà che per amare dio occorre rispettare l'ordine costituito, proprio come vuole l'ignoto autore di questa pericope.
Il problema principale che l'exousiai solleva è in sostanza il seguente: fino a che punto il cristiano deve obbedire alle autorità costituite? Qual è il limite oltre il quale egli rischia di non potersi più definire «cristiano»?
Ecco, sotto questo aspetto, la pericope è gravemente lacunosa. Essa non prevede affatto la possibilità di uno Stato ideologico, confessionale, che obblighi i cittadini a una particolare professione di fede, e neppure prevede la possibilità di uno Stato autoritario, che abusi dei suoi poteri per discriminare e sottomettere i propri cittadini.
La pericope sembra dare per scontata la presenza di una sorta di Stato «laico e aconfessionale», tollerante nei confronti di qualunque religione; e soprattutto sembra dare per scontato che lo Stato, le sue leggi, i suoi governi, siano fondamentalmente giusti, equi, sufficientemente democratici per poter permettere al cristiano, o comunque all'uomo religioso, di vivere in tutta tranquillità l'esperienza della propria fede. Cosa che nell'antichità, ove tutti gli Stati, e soprattutto quello romano, erano espressione di società basate sullo schiavismo come sistema produttivo e quindi su concezioni di vita intolleranti, non s'era mai verificata.
Il concetto di «Stato laico» è, come noto, relativamente recente, ed è sempre stato un concetto più «giuridico» che «storico», in quanto sul piano pratico dei rapporti socio-politici con le varie religioni, gli Stati borghesi generalmente non riescono a rispettare in maniera coerente la laicità professata in sede giuridica.
Uno Stato veramente «laico» dovrebbe anche essere «democratico», ma uno «Stato democratico» è una contraddizione in termini, una contraddizione che il nostro anonimo interpolatore non sarebbe mai stato disposto ad ammettere, facendo egli parte, ovviamente, di un ceto possidente o comunque benestante.
L'autore, col suo linguaggio che tradisce «un'origine profana»2 o molto probabilmente gnostica, sembra aver ridotto il cristianesimo a una sorta di comportamento etico-sociale conformista, del tutto ligio ai doveri del cittadino imposti dallo Stato romano. In tal senso la pericope sembra essere un'interpolazione di origine non cristiana, ma pagana, o se vogliamo di origine molto più pagano-cristiana che ebraico-cristiana.
L'autore infatti sembra aver di mira quei cristiani che vogliono opporsi, in qualche modo, alle exousiai, o non obbedendo a determinate leggi (p.es. quelle che obbligavano a fare sacrifici agli imperatori); o rifiutandosi di pagare delle tasse ritenute inique.
Sia come sia l'autore sembra invitare i cristiani, con fare perentorio se non minaccioso, a rientrare nei ranghi, affinché dimostrino la loro fedeltà ai princìpi religiosi che professano e per evitare, ovviamente, in caso di opposizione, l'inevitabile ritorsione da parte delle autorità costituite, la cui legittimità non viene neanche ipoteticamente messa in discussione.
La pericope non s'interessa dei cristiani in quanto cristiani ma solo in quanto cittadini. L'autore sembra escludere a priori l'eventualità che i cristiani possano essere perseguitati per motivi ideologici, ed esclude altresì la possibilità che i cristiani, in quanto cittadini, possano disobbedire alle leggi o non pagare le tasse, a causa di uno Stato politicamente oppressivo o fiscalmente esoso.
A differenza di come s'è comportato il cristianesimo primitivo sino almeno alla svolta costantiniana, l'autore della pericope, in sostanza, non sembra essere disposto ad ammettere la possibilità che un cristiano, pur essendo leale, come cittadino, allo Stato, abbia il diritto di dissentire sul piano ideologico, proprio in quanto cristiano.
L'autore cioè sembra rifiutare di credere che il cristianesimo possa costituire un pericolo per lo Stato romano anche solo dal punto di vista ideologico. Egli è convinto che se il cristiano obbedisce alle leggi e paga le tasse, può essere considerato come un qualunque altro credente, tenuto a considerare qualunque autorità politica come una sorta di «funzionario divino» (v. 6).
L'autore ha la pretesa di voler far credere ai cristiani che lo Stato, essendo un'istituzione divina (o comunque voluta da dio), non può che promulgare giuste leggi e imporre tasse eque. Non a caso chiede di ubbidire non tanto per «timore della punizione» quanto per «ragioni di coscienza» (v. 5), proprio perché di fronte a uno Stato del genere, qualunque forma di ribellione è priva di senso, è preclusa a priori. Quindi non solo il cristianesimo non è pericoloso per lo Stato romano, ma neppure lo Stato è pericoloso per il cristianesimo.
Una pericope del genere non può essere maturata in un ambiente ebraico e neppure in un ambiente pagano di origine sociale umile. Il cristiano di origine pagana che ha formulato tale pericope doveva per forza essere una persona facoltosa, di alto rango, che non aveva propriamente capito come il modo migliore di sfruttare il cristianesimo a fini politici era quello di accettarlo come tale, cioè con la sua idea di formale separazione tra Stato e chiesa, e non invece di confonderlo con una qualunque altra religione pagana.
Per l'ingenuo, perché schematico, autore di questa pericope la possibilità per un cristiano di vivere una vita serena e tranquilla è strettamente subordinata alla capacità di non farsi valere come «cristiano» (tanto meno come «cittadino democratico»), cioè è correlata alla capacità di mescolarsi coi «cittadini anonimi» che obbediscono alle leggi, qualunque esse siano, e pagano le tasse senza discutere, nella convinzione che se le autorità sono volute da dio, non è un problema degli uomini quello di sostituirle.
Quanto sia lontano questo autore dai vangeli è facile intuirlo. «Coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere», dice il Cristo agli apostoli in Mc 10,42. Persino l'espressione politicamente innocua, ma ideologicamente eversiva, nei confronti dello Stato integralista romano, di Mc 12,17, e cioè «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio», risulta essere in stridente contraddizione con la pericope apocrifa in oggetto.
Per il cristianesimo primitivo Dio e Cesare erano considerate realtà diverse, che non si potevano confondere o identificare. Nell'Apocalisse di Giovanni lo Stato è addirittura considerato come «la bestia che sale dall'abisso» (13,1 ss.).
In sintesi la filosofia politica di questo falsificatore assomiglia molto di più al confucianesimo che non al cristianesimo. Essa è un chiaro invito alle classi marginali di tenersi entro i limiti della legalità istituzionale. E non è un caso che un termine come quello di exousiai si ritrovi ampiamente in quella che viene chiamata la «scienza esoterica cristiana».3
Gli esegeti progressisti si sono limitati a considerare apocrifa la pericope e a respingerne il contenuto, sulla base in verità di motivazioni più di forma che di sostanza. Viceversa, gli esegeti conservatori, pur non potendo negare l'inautenticità del testo, hanno preferito sostenere che dietro il termine exousiai si celano non le autorità terrene, bensì le «potenze celesti», nei confronti delle quali è più facilmente comprensibile la richiesta di una abnegazione assoluta, di una devozione totale.4
In sintesi
Paolo parte da una propria constatazione della realtà: gli uomini non sono in grado di costruire una società giusta, democratica; non ne sono capaci gli ebrei e tanto meno i pagani.
Nel complesso infatti gli uomini sono degli incapaci o perché non credono nel vero dio (pagani) o perché vi credono in modo inadeguato (ebrei). Nessuno può essere giustificato sulla base delle proprie opere, né i pagani, che peccano sia nel metodo (in quanto si abbandonano a ogni sorta di vizi), sia nel contenuto (in quanto sono idolatri), né gli ebrei, che peccano solo nel metodo (in quanto sono incoerenti con le verità di fede in cui credono). Il giudeo viene qui considerato più importante del greco, ma a causa di tale incoerenza Paolo ora si sente costretto a metterlo sullo stesso piano.
«I pagani, che non ricercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia che deriva dalla fede; mentre Israele, che ricercava una legge che gli desse la giustizia, non è giunto alla pratica della legge, perché non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse dalle opere» (9,30 ss.).
Il circolo vizioso in cui Paolo è caduto è in sostanza il seguente: da un lato egli ha attribuito alla mancanza di fede in dio la causa delle umane contraddizioni; dall'altro però appare evidente che l'esigenza di credere in dio nasce proprio dalla convinzione dell'impossibilità di poter risolvere, con mezzi umani, le contraddizioni della società.
Stando le cose in questi termini, l'uomo di Paolo diventa semplicemente un burattino nelle mani di dio. O, per meglio dire, l'uomo non è che un giocattolo imperfetto voluto dal figlio di dio, il quale, per riparare a un proprio capriccio, ha accettato di sacrificarsi, risparmiando all'uomo l'ira distruttiva del padre. Siamo insomma in piena mitologia.
(torna su)3) Prima lettera ai Tessalonicesi
La I lettera ai Tessalonicesi è la più antica5 di quelle di Paolo di Tarso, essendo stata scritta tra il 51 e il 52, dopo che in quella località (Tessalonica, Salonicco) la chiesa fu fondata nel corso del secondo viaggio missionario dell'apostolo, avvenuto tra il 49 e il 53 (cfr At 17,1-10). Probabilmente Paolo si trovava a Corinto, dove aveva incontrato Gallione, fratello maggiore di Seneca, dopo il discorso all'Areopago di Atene, e prese la decisione di scriverla solo dopo aver ottenuto notizie da Timoteo che l'aveva raggiunto, insieme a Sila, proprio da Tessalonica. E sarà proprio Timoteo a consegnarla a quei neo-convertiti.
La lettera evita quei toni apologetici che hanno invece Galati e la II Corinti, manca di quei profondi temi dottrinali che s’incontrano in Romani ed Efesini e non costituisce neppure una risposta a quesiti precisi, come invece la I Corinti. Il motivo di fondo è quello di precisare il tema della parusia e, in particolare, il rapporto che avrebbe dovuto esserci tra vivi e morti. Ma evidentemente il suo contenuto non fu capito granché, visto che ad essa Paolo fece seguire, dopo qualche mese, una seconda lettera.
La città di Tessalonica, ai tempi di Paolo, viveva uno dei periodi di maggiore floridezza economica. Conquistata dai romani nel 168 a.C., era diventata, nel 146 a.C., capitale di uno dei quattro distretti romani di Macedonia, ed era governata da un proconsole. Veniva considerata la città più fiorente della Grecia, anche perché col suo porto dominava l'Egeo. Nel 42 a.C., dopo la battaglia di Filippi, s'era guadagnata il titolo di «città libera» (con un proprio dèmos, assemblea cittadina, una propria bulè, senato, e propri politarchi, magistrati), essendosi schierata a favore di Ottaviano e Antonio contro Cassio e Bruto.
Durante la permanenza nella città, Paolo, insieme a Sila e Timoteo, predicò inizialmente (gli Atti parlano di tre sabati) nella sinagoga, la principale in quella parte di Macedonia, ma a causa dell'immediata e forte opposizione da parte degli ebrei, fu costretto ad andarsene soltanto dopo pochi mesi, trovando rifugio a Berea (Verria), a circa 80 km da Tessalonica. Il privilegio di «città libera» imponeva infatti l'obbligo morale di un lealismo oltre ogni sospetto, per cui si comprendeva bene l'allarme generale tra le autorità e la popolazione di fronte a un'accusa di insubordinazione politica e di alto tradimento.
Il contenuto della sua predicazione ci è noto proprio attraverso gli Atti: secondo un'interpretazione (naturalmente distorta) delle Scritture, egli sosteneva, sulla scia di Pietro, che il messia, nella persona di Gesù, doveva necessariamente morire per poi risorgere («essere ridestato da Dio»), al fine di liberare gli uomini dall'oppressione (dare loro «salvezza», soteriologia). Questa tesi (kerigma) fu accolta da pochi giudei, ma da molti greci, anche tra le donne aristocratiche.
La cosa fece andare su tutte le furie gli ebrei, che vedevano perdere consensi e soprattutto perché non potevano accettare l'idea di una fine del primato storico-politico d'Israele. Decisero quindi di denunciarlo, dopo aver fatto irruzione nella casa di un loro concittadino, Giasone, che probabilmente costituiva la base della missione dell'apostolo. L'accusa era quella di agire contro i decreti dell'imperatore, in quanto veniva a questi contrapposto un nuovo sovrano, Gesù. I politarchi (giudici della città) rimasero molto turbati e decisero di espellere immediatamente tutti i missionari.
In questa lettera, scritta per infondere fiducia ai neo-convertiti, che evidentemente avevano subìto vessazioni dopo la partenza forzata dell'apostolo, si usa, per la prima volta, il termine «Cristo» come nome proprio di persona e non più come «qualifica politica» (1,1.3). Lo stesso appellativo di «Signore», che i pagani usavano in senso «politico» e che i Settanta avevano dato solo a Jahvè, qui viene usato in un'accezione esclusivamente «religiosa» (essendo associato all'idea di «dio-padre») e attribuito unicamente al Cristo.
Paolo tuttavia, provenendo da un ambiente intriso profondamente di aspettative politiche, quale quello giudeo-farisaico, pur compiacendosi che i Tessalonicesi abbiano abbandonato i loro «idoli» (1,9), non si accontenta di anteporre alla loro religione una nuova religione6, ma è convinto che la sua nuova religione abbia un contenuto anche politico, in quanto il Cristo risorto, in virtù appunto della propria resurrezione, dovrà liberare coloro che credono in lui «dall'ira imminente» (1,10).
Se è vero quel che dice Pietro, e cioè che Cristo è risorto, allora deve apparire del tutto normale un suo «imminente» ritorno, altrimenti non avrebbe avuto senso morire in croce: sarebbe stato sufficiente morire di vecchiaia, di morte naturale, semplicemente per far credere nell'esistenza di un aldilà. Viceversa, un uomo che pretende di porsi come «liberatore nazionale», che si fa uccidere senza poter dimostrare che aveva politicamente e umanamente ragione, quando in realtà avrebbe potuto farlo tranquillamente, avendo fatto capire, con la resurrezione, ch'era più che un uomo, non può non tornare, a tempi brevi, in maniera trionfale, facendo giustizia dei propri nemici.
Questa convinzione non l'aveva solo Paolo, ma anche Pietro e altri apostoli ancora, con la differenza che mentre per Pietro e gli altri discepoli, presenti a Gerusalemme, Cristo sarebbe dovuto tornare per liberare la Palestina dai romani e costruire un nuovo regno davidico, per Paolo invece Cristo avrebbe dovuto abbattere l'intero impero romano, creando un nuovo regno in cui la differenza tra ebreo e pagano sarebbe scomparsa. Paolo in sostanza era convinto che se davvero il Cristo era risorto, non avrebbe avuto alcun senso che un avvenimento così straordinario dovesse restare circoscritto entro gli angusti confini di Israele, anche perché erano stati proprio i giudei a giustiziarlo.
Cioè, in sostanza, ed è in questa alternativa radicale che sta racchiusa tutta la biografia politica dell'apostolo Paolo, o i cristiani andavano perseguitati, poiché demotivavano la resistenza armata da parte degli ebrei, con la loro idea di attendere passivamente la parusia del Cristo, oppure, se avevano davvero ragione, non potevano averla solo per i destini di Israele, in quanto l'avvenimento che andavano predicando doveva per forza riguardare l'intero genere umano.
Paolo è assolutamente convinto che la seconda strada, da lui scelta negli anni 34-36, sia quella più giusta, quella più logica e naturale, quella più conseguente alla tesi petrina della «morte necessaria», e si serve delle persecuzioni subite a titolo dimostrativo (2,2): a Filippi fu addirittura incarcerato e fustigato.
Sostiene, non senza una certa fanatica autoesaltazione, di essere non solo un «inviato di Dio» (2,9.13), ma anche un «apostolo di Cristo» (2,6), non meno degli altri discepoli più vicini al messia, anche se questa sua qualifica gli verrà sempre contestata dalla comunità di Gerusalemme, la quale però, vedendo il suo grande zelo a favore dell'idea di resurrezione, sarà anche disposta a cercare dei compromessi per favorirlo nella sua predicazione, che in teoria avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente ai «gentili» o ai «non circoncisi», ma che nella realtà si rivolgeva anche ai giudeo-ellenisti, agli ebrei della diaspora.
In quanto giudeo predicava anzitutto ai giudei, nelle loro sinagoghe, ma, essendo convinto che non l'avrebbero ascoltato, approfittava subito del loro diniego per rivolgersi ai pagani, più sensibili a credere in fatti miracolosi e straordinari o in concezioni spiritualistiche, come appunto la resurrezione e l'aldilà. La sconfitta culturale che subirà ad Atene, in mezzo a un consesso di intellettuali, sarà tutto sommato un fatto isolato, che lo indurrà a rivolgersi unicamente a un uditorio più popolare.
Quando scrive questa epistola Paolo ha già rotto definitivamente con l'ebraismo classico, al punto che arriva a dichiarare ch'egli non farà nulla per il suo paese nel caso in cui venga distrutto da Roma (2,16): i giudei sono «nemici di tutti gli uomini» (2,15). La rottura è non solo politica, avendo essi ucciso il messia e i profeti, ma anche ideologica, poiché i giudei non hanno più alcun titolo per ritenersi migliori degli altri popoli. Infatti, se possono essere migliori di quei pagani dediti ai piaceri e alla cupidigia (4,5 s.), non sono certo migliori dei neo-cristiani di origine pagana, che sul piano etico si sforzano di condurre una vita irreprensibile, anzi sono «modello» per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Paolo stesso aveva cercato di dar loro il buon esempio, alternando la predicazione al lavoro manuale (2,9), per non essere a nessuno di peso e per distinguersi dai filosofi e predicatori girovaghi, che spesso agivano a scopo di lucro.
Qui il suo antisemitismo e antigiudaismo è così forte che si sente in dovere di affermare che la generazione dei Tessalonicesi a lui coeva vedrà il ritorno trionfale del Cristo (2,19) «con tutti i suoi santi» (3,13). È quasi fuori di sé. È convinto che prima risorgeranno quelli che sono già morti (come primo segno della parusia), poi sarà la volta dei viventi (tra cui lui stesso), che però, non essendo ancora morti, saranno «rapiti insieme con loro [coi defunti], sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria» (4,16 ss.). Una sorta di spiritualizzazione della politica ai limiti del patologico.
Cristo doveva tornare per dimostrare che senza di lui i giudei non sarebbero mai stati in grado di liberarsi dei romani e per dimostrare che, avendolo ingiustamente ucciso, sotto la denominazione di «nemico» non andava messo solo il romano oppressore e l'ebreo collaborazionista, ma anche il giudeo qua talis, fanaticamente legato alle proprie leggi e tradizioni. Il loro primato di «nazione santa», di «popolo eletto» era finito: ora il nuovo regno sarebbe stato «universale», «cosmico».
Come Pietro aveva ingannato i soli ebrei, così Paolo stava ingannando ebrei e pagani. Questi due apostoli, della prima e dell'ultima ora, erano così convinti della verità del loro nuovo vangelo, pur nella disperazione d'essere usciti politicamente sconfitti dagli eventi, che non s'accorgevano neppure di apparire seguaci di idee irrazionalistiche.
Paolo, come già i sinottici, si rende conto, in questa lettera, della difficoltà di precisare il momento esatto della parusia, per cui si limita soltanto ad affermare che quando ufficialmente si proclamerà «pace e sicurezza» (5,3), allora avverrà d'improvviso il ritorno trionfale del Cristo, paragonabile al furto di un ladro notturno, alle doglie di una donna incinta. Vuole a tutti i costi porre delle antitesi paradossali, per meglio indurre il lettore a stare sempre vigile, a non fidarsi mai di quello che vede.
Per «vigilanza» non si deve intendere una preparazione politico-militare attiva, come chiedeva Giovanni nella sua Apocalisse, scritta nell'imminenza dello scoppio della guerra giudaica. Le armi dei cristiani al seguito di Paolo sono semplicemente «spirituali»: la corazza della fede e dell'amore, l'elmo della speranza nella salvezza (5,8). Si tratta di attendere con pazienza, senza far nulla di violento; anzi, qualunque forma di persecuzione subita va considerata come un segno favorevole alla parusia.
La liberazione non può essere compiuta che da Cristo risorto, poiché s'egli non ha potuto compierla da vivo, usando gli strumenti della democrazia, è stato solo per dimostrare che il primato d'Israele era finito, ovvero che la società ebraica non era in grado di far valere un maggior senso della libertà e della giustizia sociale rispetto alle altre nazioni.
I giudei, il popolo politico più irriducibile della storia, non sapendo riconoscere il valore dei propri liberatori nazionali, arrivando persino a consegnarli al peggiore nemico, hanno fatto il loro tempo, sono giunti al collasso storico-nazionale, non hanno titoli per opporsi legittimamente all'imperialismo romano. È dunque giusto che vengano spazzati via dalla parusia del messia redivivo 7. Non si può transigere con loro: o si pentono di quello che hanno fatto e credono nella resurrezione, che apre la strada all'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a dio; o è meglio rivolgersi esclusivamente ai pagani, considerando finita la pretesa specificità ebraica. In questo Paolo era molto più risoluto di Pietro, e se in tutto quello ch'egli scrisse in questa lettera ci sarà qualcosa di «imminente», sarà soltanto la rottura tra i due, almeno finché Pietro non si deciderà ad abbandonare per sempre Gerusalemme.
(torna su)4) Seconda lettera ai Tessalonicesi
I greci di Tessalonica (Salonicco) avevano aderito con entusiasmo alla predicazione di Paolo e dei suoi discepoli, Silvano e Timoteo, diffondendone il messaggio in tutta la Macedonia e l'Acaia. Erano il fiore all'occhiello della predicazione di Paolo. L'idea stessa di «resurrezione» era per loro nuova, in quanto con essa si presupponeva «un ritorno in terra dall'aldilà», mentre fino a quel momento al massimo si era creduto, nel mondo pagano, in una concezione della «sopravvivenza» dopo la morte, in una «immortalità dell'anima».
Con questa seconda lettera, dal contenuto simile alla prima ma dallo stile più scialbo e distaccato 8, Paolo vuole rassicurarli che le sofferenze, le umiliazioni patite verranno presto premiate dall'imminente parusia del Cristo, che farà giustizia dei propri e dei loro nemici. In tal senso, le espressioni che usa sono particolarmente forti: «il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono al vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza» (1,7 ss.).
L'apostolo si era proposto d'incontrarli di nuovo, temendo che le persecuzioni avrebbero potuto seriamente danneggiare una comunità appena nata, ma non gli era stato possibile, per motivi a noi ignoti e che lui, nella precedente lettera, aveva attribuito genericamente a «satana». Qui tuttavia si sente in dovere di rettificare qualcosa d'importante, detto nella prima predicazione e confermato nella prima epistola. Qualcosa che gli deve permettere, da un lato, di non smentirsi, e dall'altro di non esaltare troppo i discepoli, inducendoli in false aspettative.
Lo scopo della lettera infatti è quello di ridimensionare quanti si lasciano «sconvolgere la mente» da «pretese ispirazioni», da «discorsi», «da qualche lettera data come nostra» (in 3,17 è costretto a spiegare il proprio autografo, onde evitare plagi o falsificazioni). Vi era stata, come si può facilmente dedurre, una sorta di generale euforia, in seguito alla sua predicazione, che ora però lui stesso doveva cercare di contenere entro limiti accettabili.
Per fare questo egli introduce per la prima volta un elemento di dissuasione per i più fanatici ed esaltati, in relazione alla parusia del Cristo: «quel giorno non verrà se prima non sia giunta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio» (2,2 ss.).
A cosa si riferisca Paolo non è dato sapere e lui si guarda bene dal fare delle precisazioni che contestualizzino i suoi generici avvertimenti. Indubbiamente l'imperatore Caligola, con la sua ossessione d'essere considerato una «divinità», al punto da voler far erigere una statua di Zeus proprio nel Tempio di Gerusalemme, può aver ispirato un visionario come Paolo, ma Caligola era morto nel 42, e questa seconda lettera è stata scritta dieci anni dopo, al tempo in cui regnava Claudio, il cui potere fu sicuramente molto meno dispotico del suo predecessore, anche se proprio negli anni 49-50 aveva espulso tutti i giudei da Roma (At 18,2).
Probabilmente Paolo aveva costatato che la tendenza alla divinizzazione da parte degli imperatori andava considerata irreversibile, per cui sarebbe stato inevitabile, prima o poi, una generale repressione di chi la pensava diversamente.
L'apostasia per lui è il rovescio della fede: un uomo (o comunque una potenza del male) si farà dio (esattamente come Cristo e, per questa ragione, sarà una sorta di «Anticristo») e si opporrà a qualunque forma di culto religioso che non sia il proprio. Con tali astrazioni Paolo non ha fatto altro che alzare il tiro, procrastinando a data da destinarsi il momento della realizzazione definitiva del proprio vangelo. Una realizzazione che va attesa passivamente, senza alcuna organizzazione di tipo politico o militare, ma semplicemente preparandosi, nello spirito, al grande evento, la parusia, che va comunque pubblicizzata con vigore, negando all'imperatore un qualsivoglia culto mistico. Il cristianesimo paolino non era esattamente analogo al classico stoicismo greco-romano.
Non potendo credere che il Cristo risorto abbia in mente di accettare la generale apostasia del genere umano, schiacciato dalla Roma imperiale, Paolo non può rinunciare all'idea di un'imminente e trionfale parusia. Per lui va considerato infinitamente più grave non tanto la generale schiavizzazione dei lavoratori imposta in tutto l'impero, quanto piuttosto il fatto che lo Stato sta diventando sempre più teocratico. Non ritiene che la schiavitù sia un elemento decisivo per far scoppiare la rivoluzione, o comunque non la ritiene un elemento su cui gli uomini possano far leva per opporsi efficacemente all'impero, la cui forza viene giudicata così enorme che solo un intervento esterno, di natura divina, potrebbe operare un vero rivolgimento, e questo intervento lo ritiene inevitabile non tanto per le sofferenze sociali degli uomini quanto per le loro sofferenze religiose, per la violazione insopportabile che viene fatta alla loro libertà di coscienza.
Essendo pienamente convinto di quanto afferma, Paolo non sta ingannando consapevolmente i suoi adepti: solo che ha promesso una cosa che tarda ad avverarsi e ora sta pensando ch'essa avrà più possibilità d'accadere quando le contraddizioni saranno ancora più esplosive. Da un lato è assolutamente convinto che i giudei non abbiano politicamente e militarmente alcuna possibilità di abbattere l'impero romano, dall'altro non può accettare l'idea che tale impero possa tranquillamente trionfare a dispetto dell'idea rivoluzionaria del Cristo risorto. I romani dovranno per forza creare una situazione umana e religiosa così assurda e sconvolgente da rendere assolutamente necessaria, inevitabile, la fine del mondo.
Il fatto che gli imperatori pretendessero d'essere considerati delle «divinità» doveva apparire a Paolo una insopportabile enormità, nei cui confronti la popolazione dell'impero non s'era ancora ribellata (diversamente da quella ebraica), proprio perché era Dio stesso a impedirlo, volendo che in tale assurdità si credesse sino in fondo (Dio manda una «potenza d'errore perché credano alla menzogna», scrive in 2,11), sicché alla fine, valendo il principio del «tanto peggio tanto meglio», il desiderio di un crollo dell'impero sarebbe stato inevitabilmente molto più forte ed esteso, e chi non aveva voluto credere nel Cristo (ovvero nel vangelo di Paolo) sarebbe stato giudicato molto più severamente.
È questa, come si può ben notare, una forma esasperata di estremismo, politicamente fatalistica, non molto diversa da quella delle correnti apocalittiche dell'epoca. La psicopatologia che aveva caratterizzato la conversione di Paolo sulla strada di Damasco, continua imperterrita anche dopo tale conversione.
La sua filosofia politica e religiosa si può riassumere, in sostanza, nei seguenti punti:
- lo schiavismo domina imperante, fa aumentare a dismisura l'autoritarismo, il militarismo, il fiscalismo, l'oppressione generale e nessuno riesce a superarlo;
- alla popolazione che non ne può più i cristiani dicono che bisogna aver fede nel Cristo risorto (sarà lui a risolvere il problema dello schiavismo, rendendo tutti uguali nel nuovo regno imminente);
- in attesa che la popolazione arrivi a credere in questa verità di fede, l'impero tenderà a diventare non solo sempre più schiavista, ma anche sempre più teocratico (in senso pagano), al punto che gli imperatori pretenderanno d'essere venerati come divinità; infatti con la teocrazia l'impero s'illude di poter frenare lo sviluppo delle proprie contraddizioni;
- a questo punto è meglio attendere che la teocrazia giunga alla sua massima espressione, poiché se lo schiavismo non riesce a far reagire le masse oppresse, l'idolatria pagana, quando raggiungerà l'apice, farà sicuramente reagire il Cristo risorto; quanto più aumentano teocrazia e schiavismo, tanto più le contraddizioni minacciano di esplodere e quindi tante più possibilità ci sono perché il vangelo si affermi. Gli uomini, prima di ottenere la liberazione, devono rendersi conto da soli dei loro errori.
L'impotenza politica dei giudei aveva generato in Paolo il misticismo dell'onnipotenza religiosa, nella convinzione che il satanismo dell'impero romano sarebbe arrivato a un punto tale da rendere inevitabile la parusia trionfale del Cristo e con essa la fine del mondo.
Paradossalmente l'aspetto più interessante di questa lettera non è nelle suddette farneticazioni, ma negli aspetti più dimessi e non per questo meno importanti che si evidenziano là dove si parla di comportamenti etici da tenere in attesa del «grande giorno»; in particolare si chiede di evitare la fornicazione 9 e gli atteggiamenti fraudolenti negli affari, gli stessi vizi segnalati precedentemente e che adesso paiono essere peggiorati.
Come già nella prima missiva, Paolo ribadisce che il suo vangelo è vero anche perché egli non ha mai approfittato di nulla per rivendicare un potere personale o qualche vantaggio economico, avendo sempre lavorato per sostentarsi, pur essendo nel suo diritto pretendere un compenso in ragione del fatto ch'egli svolgeva il mestiere dell'apostolo predicatore di Cristo (3,8 ss.).
Il motto che qui predica, e che verrà fatto proprio dai socialisti di tutti i tempi, è chiaro: «chi non vuole lavorare, neppure mangi» (3,10). Era forse un invito esplicito a rifiutare lo sfruttamento altrui, al punto che i servi o gli schiavi avrebbero dovuto ribellarsi ai loro padroni? Assolutamente no: era soltanto un avvertimento a quei fannulloni della comunità cristiana che, in attesa della parusia, avevano rinunciato a lavorare, vivendo da parassiti.
La nobilitazione del lavoro era comunque un principio nuovo per la società greco-romana, abituata a considerarlo un'attività o da schiavi o da stranieri o da cittadini di bassa categoria. Il cittadino aspirava a vivere di rendita per poter partecipare alla vita politica. Platone, Aristotele, Cicerone consideravano il lavoro incompatibile con la virtù.
(torna su)5) Lettera ai Galati
Premessa
Nella sua lettera ai Galati, Paolo aveva ragione a prendersela con chi, per distinguersi, dava più peso alle formalità che non alla sostanza, però aveva torto nel ridurre la sostanza a una questione di comportamento etico-religioso.
Quello che di lui non si può assolutamente accettare è l'idea di ridurre la «liberazione» (sociale, politica) a una libertà interiore, da viversi a livello di coscienza, salvo limitarsi, sul piano sociale a propagandare l'amore fraterno e l'assistenzialismo.
Nel momento in cui è sorto, il cristianesimo è stato una religione idealistica, che già aveva tradito il messaggio originario del Cristo. La differenza tra cristianesimo e stoicismo stava unicamente nelle origini ebraiche del primo, le quali mostravano un certo interesse per le questioni sociali. Nel senso che mentre l'ebraismo ortodosso cercava di risolverle nei limiti appunto della propria etnicità, il cristianesimo invece pretendeva di risolverle al di fuori di questi limiti, dando ad esse però una connotazione più astratta.
L'ebreo cercava l'eguaglianza a livello sociale per dimostrare che la propria nazione era migliore delle altre (quindi era un'uguaglianza tra ebrei, ivi inclusi quelli della diaspora); il cristiano invece cercava un'uguaglianza tra tutti i credenti, a prescindere dalla loro origine etnica o provenienza geografica. Senonché, nel fare questo, aveva trasformato l'uguaglianza in qualcosa di metafisico, che poteva realizzarsi compiutamente solo nell'aldilà e che sulla terra al massimo poteva esprimersi come assistenzialismo, senza mai mettere in discussione i rapporti di sfruttamento dominanti.
Con questo naturalmente non si vuole affatto sostenere che al tempo di Gesù Cristo l'ebraismo d'Israele non vivesse al proprio interno le differenze di classe e persino di casta; si vuol semplicemente dire che l'opposizione a queste differenze era molto forte e veniva ancora compiuta in nome di un'effettiva uguaglianza sociale (esseni, battisti, zeloti, nazareni e persino l'ala progressista dei farisei erano favorevoli a un ritorno al comunismo primitivo).
Nel cristianesimo l'idea di «comunismo primitivo» è stata subito trasformata nell'idea mistica di «comunione eucaristica» o, al massimo, in quella di «agape fraterna», in cui si cercava di condividere non il momento produttivo ma solo quello distributivo dei beni e, di questi beni, solo quelli non essenziali alla propria sopravvivenza. Nei suoi duemila anni di storia il cristianesimo non ha mai superato l'idea di «assistenzialismo» con quella di «comunismo», se non in talune esperienze monastiche, molto particolari, poiché anche qui, se veniva praticato il comunismo tra monaci, spesso questi non lo praticavano coi contadini che lavoravano le loro terre.
Il cristianesimo ha tolto all'uguaglianza la carica politica che aveva sotto l'ebraismo, anche se quest'ultimo l'aveva circoscritta entro i limiti della propria nazione (gli ebrei davano per scontato di non poter essere «uguali» ai pagani, anzi, si vantavano di non esserlo). Da un lato quindi era aumentata, col paolinismo, la consapevolezza dell'universalità del valore umano (cosa che però si era già potuta constatare nella stessa predicazione del Cristo); dall'altro era aumentata la praticabilità astratta di questo valore, conseguente al fatto che il cristianesimo era nato solo dopo il fallimento della rivoluzione politica del movimento nazareno.
Il tradimento operato dal cristianesimo petro-paolino ha comportato non solo l'astrattezza dell'universalismo etico-religioso (soteriologico), ma anche, inevitabilmente, la sua incoerenza con la pratica reale. Infatti, se nel contesto locale non si è capaci di realizzare la vera uguaglianza sociale, tutte le affermazioni universalistiche sull'uguaglianza etico-religiosa risulteranno meramente propagandistiche.
Non a caso il cattolicesimo-romano ha sempre considerato l'Europa occidentale il fulcro della civiltà post-pagana, assumendo atteggiamenti di superiorità ideologica nei confronti del mondo intero. È dovuto subentrare il protestantesimo prima che un nuovo continente, quello nord-americano, pretendesse di definirsi come nuova culla della moderna e contemporanea civiltà democratica.
Solo in apparenza quindi il tarsiota Paolo compì un'operazione passata alla storia come straordinaria e unica nel suo genere, trasformando il nazionalismo giudaico nell'universalismo cristiano. In realtà questa operazione era già presente, in nuce, nella predicazione laico-socialista o, se si preferisce, ateo-comunista del Cristo, contraria a qualunque affronto mistico ma anche meramente etnico della questione dell'uguaglianza. La frequentazione di Tiro e Sidone, della Decapoli e soprattutto il confronto coi samaritani, documentato nel IV vangelo, che parla anche di presenza di «alcuni greci» durante l'ultima pasqua (12,20 ss.), costituiscono chiari esempi di universalizzazione del problema della libertà e degli altri valori umani.
San Paolo si è anzi servito della propria concezione astratta e idealistica dell'uguaglianza non solo per delegittimare il giudaismo ortodosso, che sicuramente in merito era più concreto, ma anche per avvalorare le arbitrarie tesi petrine relative alla «morte necessaria» e alla «resurrezione» del Cristo, con cui si ponevano le basi mistiche per trasformare le rivalità politiche tra galilei e giudei in un conflitto di tipo religioso. Un conflitto che troverà il suo punto più alto di compromesso nella figura del giudeo Giacomo, fratello di Gesù, il quale arrivò ad accettare le tesi petrine, salvaguardando però tutte le specificità dell'ebraismo classico (circoncisione, cibi impuri ecc.).
Pietro infatti era anti-giudeo in quanto galileo e in quanto galileo concedeva spazi di manovra all'ellenismo pagano o almeno all'ebraismo ellenizzato. Ma proprio questa lettera ai Galati attesta l'avvenuto superamento del petrinismo da parte del paolinismo. Per Paolo non era più questione di contrapporre galilei a giudei o di trovare un compromesso tra queste due etnie o tra ebraismo ed ellenismo nelle zone della diaspora ebraica. Per lui il vero problema era quello di superare, consapevolmente e definitivamente, sia l'ebraismo sia l'ellenismo, in direzione di un nuova religione, che dell'uno avrebbe preso la sensibilità per le questioni sociali e dell'altro l'astrattezza dell'universalismo etico-religioso (un'astrattezza che da filosofica sarebbe potuta diventare facilmente teologica, essendo già imbevuta ampiamente di metafisica).
La vera culla del Cristianesimo è stata l'odierna Turchia, ove il confronto tra ebrei ed ellenisti era alla pari, ove gli ebrei-ellenisti potevano tranquillamente risiedere, senza rischiare d'essere espulsi dalle grandi città (come invece p.es. avveniva in Italia), e dove i pagani, vivendo nella periferia dell'impero romano, ne soffrivano maggiormente le contraddizioni sistemiche ed erano quindi più predisposti ad accettare nuove soluzioni di tipo religioso. Dall'incontro di queste due componenti si formerà appunto il cristianesimo.
I primi cinque versetti
L'autopresentazione di Paolo, nella intitulatio, ha lo scopo di dimostrare almeno tre cose, strettamente interconnesse:
- ch'egli si sentiva allo stesso livello d'importanza istituzionale dei più stretti discepoli del Cristo;
- ch'era stato proprio lui a formulare la teoria della «figliolanza divina del Cristo»;
- che questa teoria non gli era mai stata contraddetta dagli apostoli con cui era in contatto.
In altre parole egli non si sentiva discepolo di alcun apostolo, neppure di Pietro, di cui pur aveva accettato le due tesi fondamentali: quella della «morte necessaria» del Cristo e quella della «resurrezione» (accettò, in un primo momento, anche quella della «imminente parusia trionfale», come attesta la I lettera ai Tessalonicesi).
Dice di non essere discepolo di Pietro anche perché con questi aveva avuto una divergenza di vedute molto netta sul primato che l'apostolo ancora concedeva agli ebrei-cristiani nel loro rapporto coi cristiani di origine ellenistica.
Paolo vuole sostenere un rapporto privilegiato col Cristo, proprio per dimostrarne la natura divina. Compie cioè due tipi di mistificazione: far credere che Gesù non fosse un politico, far credere che fosse un dio. E si ritiene autorizzato a farlo perché prima di questa lettera aveva già avuto un certo successo nella diaspora ebraica e soprattutto tra i pagani, cosa che aveva confermato organizzando collette a favore della chiesa di Gerusalemme. Godeva insomma di un certo ascendente, anche se agli occhi dei giudei ortodossi e dei galilei più politicizzati appariva come un traditore da eliminare.
Il fatto ch'egli si qualifichi in modo così pretenzioso lascia pensare che al momento della stesura di questa lettera non esistesse più una vera opposizione alle tesi petrine. Egli poteva autoproclamarsi «apostolo» perché in realtà non c'era più alcun apostolo in grado di impedirglielo, salvo ovviamente Giovanni, che da tempo aveva rotto i ponti col petrinismo.
D'altra parte che gli apostoli della prima generazione fossero scomparsi quasi tutti è lui stesso a dirlo. Quando si convertì al cristianesimo petrino, incontrò a Gerusalemme solo Cefa e Giacomo (Giovanni viene citato al terzo posto, ma Paolo non dirà mai nulla di questo apostolo, per cui si può presumere che qui si tratti di un'aggiunta redazionale al testo).
Anzi, quando Paolo si convertì al petrinismo, a Gerusalemme i cristiani erano guidati da Giacomo, fratello di Gesù. Nella città santa persino Pietro, rispetto a Giacomo, era in posizione subalterna, proprio perché i giudeo-cristiani erano anzitutto «giudei», volevano restare «giudei» (legati al sabato, alla circoncisione, ai cibi impuri ecc.), e Giacomo era giudeo, mentre Pietro era galileo, anche se la sua interpretazione mistica della tomba vuota era stata accettata da Giacomo.
Quanto a Giovanni, se questi in un primo momento condivise l'idea di una misteriosa scomparsa del corpo di Gesù, non arrivò mai a sostenere che da ciò si dovesse desumere l'idea di attendere passivamente il suo ritorno trionfale. E infatti dal racconto degli Atti egli scomparirà molto presto.
Dunque se non riusciamo a comprendere il motivo per cui Paolo si autopresenta in una maniera così autoritaria, sarà difficile comprendere tutto il resto. Anche perché le comunità cui lui si rivolge conoscevano già la natura indipendente della sua predicazione, rispetto a quella apostolica vera e propria. L'idea di messia ch'egli andava divulgando era una prosecuzione di quella delineata da Pietro, ma con l'aggiunta di elementi del tutto ellenistici, che ne snaturavano completamente le caratteristiche politiche e che, per questa ragione, difficilmente Pietro avrebbe potuto partorire.
Qui è come se Paolo volesse ribadire con fermezza il valore della propria dottrina a chi, in quel momento, gliela stava negando. Le persone che l'osteggiano non possono che essere cristiani di origine giudaica (forse seguaci di Giacomo), i quali, pur avendo accettato le tesi della «morte necessaria», della «resurrezione» e della «figliolanza divina» del Cristo, ritengono che queste tesi non siano incompatibili con un primato d'onore da riconoscere ai giudeo-cristiani nel loro rapporto coi pagano-cristiani.
Le comunità cristiane di questa provincia romana erano state fondate da lui durante il secondo viaggio missionario (At 18,23) e la lettera, che si rivolge ad esse collettivamente, presenta un tono solenne e ufficiale, contiene aspetti polemici, sarcastici e persino intimidatori (in quanto si chiede di scomunicare gli eretici) e deve essere stata dettata da uno stato d'animo molto preoccupato, anzi infastidito (al punto che mancano del tutto le qualifiche onorifiche delle chiese destinatarie).
Paolo rivendica subito con decisione la propria originalità rispetto agli altri discepoli del messia, e lo si capisce dal fatto che considera Gesù Cristo figlio unigenito di dio-padre, quindi di natura espressamente sovrumana. Sicché se i Galati accettano l'idea della divinità del Cristo (cosa che avevano già fatto in precedenza), non possono ora rifiutare l'idea che il vangelo di Paolo provenga direttamente da Cristo e non dai suoi apostoli della prima ora.
È impressionante la sicurezza con cui egli fa valere delle tesi così mistiche. Evidentemente aveva avuto a che fare, durante il secondo viaggio, con adepti prevalentemente di origine pagana, i quali però, sentendo «altre campane», non ambivano a offrire particolari garanzie di coerenza religiosa. Paolo doveva essere rimasto abbastanza sconcertato della loro rapida apostasia.
Nei primi cinque versetti è praticamente racchiusa l'essenza del suo vangelo: Gesù Cristo, figlio di dio, è morto per volontà del padre, affinché agli uomini fosse risparmiata, grazie alla sua resurrezione, l'idea di dover disperare di fronte ai mali del mondo, il principale dei quali, in quel momento, era lo schiavismo.
Essere «riscattati» per Paolo non aveva altro significato che acquisire consapevolezza, attraverso la resurrezione del messia, di due cose: che sulla Terra la liberazione sociale e politica non è possibile e che essa lo sarà in modo completo e definitivo solo nell'aldilà. Era un «riscatto» teorico, spirituale, della coscienza, che si traduceva sul piano pratico nel vivere l'amore fraterno, l'assistenza ai bisognosi, la sopportazione delle sofferenze come prova da superare per la felicità ultraterrena.
Un ragionamento del genere difficilmente un giudeo, residente in Palestina, avrebbe potuto accettarlo, e anche uno residente all'estero, che avesse avuto dei legami con la patria, avrebbe sicuramente avuto delle difficoltà. L'unica condizione per poterlo condividere era che la resurrezione implicasse una parusia abbastanza imminente: cosa in cui aveva creduto, in effetti, lo stesso Paolo, all'inizio dei suoi viaggi missionari. Tuttavia, quanto più essa tardava, tanto più i giudei convertiti al cristianesimo si sentivano autorizzati ad avanzare obiezioni alla sua predicazione: proprio perché non potevano rinunciare così facilmente all'idea politica di «nazione».
Paolo dunque, meravigliandosi alquanto della disinvoltura con cui i cristiani della provincia galata sono passati dal suo vangelo a quello di altri predicatori, arriva a dire, per far capire la propria superiorità, una cosa incredibile, che evidentemente in quel momento nessuno avrebbe potuto smentire, e cioè che il suo vangelo era identico a quello di Cristo. Lui si sentiva un incaricato che rappresentava con pieni poteri il suo mandante. E di questa alta autorità del suo ufficio, i «fratelli» ch'erano con lui ne davano piena conferma.
La defezione galata
Quando fu scritta questa lettera? Secondo gli esegeti più accreditati, intorno al 57, durante il terzo viaggio, dopo l'arrivo ad Efeso. A quell'epoca l'unico apostolo in grado di contraddire Paolo era Giovanni, che probabilmente lo fece nell'Apocalisse, là dove parla di «falso profeta» (13,11 ss.).
Per chiunque avesse aderito al movimento nazareno sarebbe parsa un'assurdità sentire da Paolo che il suo vangelo era identico a quello di Gesù, non foss'altro che per una ragione: se davvero per il Cristo l'argomento della «resurrezione» fosse stato l'unico che contava, ai fini della «salvezza» del suo popolo e dell'intero genere umano, sarebbe stato sufficiente dimostrarlo con una morte naturale, senza alcun bisogno di farsi crocifiggere a Gerusalemme. Per quale ragione infatti il Cristo avrebbe dovuto comportarsi da politico quando il suo messaggio sarebbe stato soltanto religioso?
In ogni caso, mettersi a predicare, come faceva Paolo, che il Cristo era stato crocifisso per soddisfare la volontà di un dio che, per placare la sua ira nei confronti degli uomini schiavi del peccato, aveva bisogno del sangue di un innocente (e l'unico sangue dell'unico innocente possibile poteva essere soltanto quello del proprio figlio), era cosa in cui non ci poteva certo credere in virtù di un ragionamento logico (né etico, né tanto meno politico).
Da un lato Paolo dava di dio un'immagine veterotestamentaria (un dio geloso delle proprie e vendicativo, quando queste non vengono riconosciute), dall'altro offriva della vita di Gesù un'interpretazione del tutto simile a quella di analoghi miti pagani, in cui un eroe si sacrifica volontariamente per il bene degli uomini, per poi risorgere più forte di prima. La differenza qui stava nel fatto che il Cristo avrebbe fatto capire d'aver ragione solo alla fine dei tempi.
Conciliare queste due cose non deve essere stato facile per Paolo. Pagani ed ebrei dovevano accettare l'idea di un dio più «padrone» che «padre», più autoritario che democratico, e che il dio-figlio era più suddito che cittadino, e che gli uomini erano del tutto impotenti, incapaci di gestirsi, in grado di salvarsi solo attraverso la fede nella grazia e, con certezza, solo nell'aldilà.
Non senza una certa spavalderia egli chiede di essere scomunicato il giorno in cui dovesse essere lui stesso a insegnare ai Galati cose diverse da quelle già dette. È così convinto del proprio «vangelo» che chiede di scomunicare persino gli «angeli» che venissero a dire cose opposte alle sue. E si vanta di questa sicurezza mostrando di non essersi mai avvalso delle proprie capacità intellettuali per compiacersi gli uomini, per fare carriera, per diventare potente. Si sente così convinto di sé che non cerca neppure il «favore di dio» (v. 10), come in genere fanno i sacerdoti.
L'idea di «resurrezione» è sempre stata centrale nella sua predicazione: «se Cristo non è risorto, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede», scriverà all'incirca nello stesso periodo ai Corinti nella prima lettera (15,14), quasi dando per scontato che, se Cristo non era risorto, sarebbe anche stato inutile credere in un dio onnipotente.
Leggendo anche solo questi pochi versetti è difficile non pensare che tutto il cristianesimo altro non sia stato che un'invenzione di Paolo, sulla scia delle prime mistificazioni operate da Pietro e confermate dal Giacomo fratello di Gesù. È infatti del tutto tautologico sostenere che la verità del proprio vangelo è data da un'interpretazione mistica della tomba vuota.
L'autodifesa di Paolo
Ciò che rende Paolo fiero di sé è la sua stessa conversione, che da persecutore acerrimo dei cristiani lo fece diventare loro strenuo difensore. Egli è convinto, e lo scrive espressamente in questa lettera, che di fronte a uno che ha vissuto una vicenda del genere, non si può dubitare di quel che dice. Il fatto ch'egli si sia improvvisamente sacrificato a diventare «servo di Gesù», lui che dava ordini ai propri subordinati e che avrebbe potuto avere un destino molto diverso, dovrebbe essere considerato - a suo parere - un motivo sufficiente per credere nella fondatezza del suo vangelo.
Qui ovviamente Paolo sta mentendo almeno su un aspetto, quello secondo cui il suo vangelo l'avrebbe ricevuto direttamente «per rivelazione di Gesù Cristo» (v. 12). Certo, può essere vero ch'egli non sia stato persuaso da nessun apostolo a credere nella nuova religione, ma è anche vero ch'egli non poteva non sapere che i cristiani predicavano la «resurrezione» del messia e quindi la necessità di non aspettarne un altro che li liberasse dai romani. Non poteva non sapere che, secondo i seguaci di Pietro, o Israele sarebbe stata liberata dal Gesù redivivo o non l'avrebbe fatto nessun altro.
Se questa posizione non fosse apparsa disfattista e pericolosa per le sorti politiche d'Israele, Paolo non avrebbe avuto alcun motivo di perseguitarli. Sulla via di Damasco s'era semplicemente reso conto che l'aver contribuito a eliminare il Cristo, da parte del suo partito politico, quello fariseo, era stato un errore colossale, cui, in qualche modo, bisognava porre rimedio. Non potendolo però fare a nome del partito, aveva deciso di farlo a titolo personale, assumendosi tutte le conseguenze di questa storica decisione. E Paolo non sarà certo il primo fariseo che entrerà a far parte della nuova compagine cristiana. Si ricordi anzi ch'egli aveva avuto come maestro quel Gamaliele che s'era mostrato possibilista nei confronti dei nazareni, proprio come l'altro fariseo, citato nel vangelo di Giovanni, Nicodemo.
Paolo aveva soltanto aggiunto che la natura del Cristo era divina come quella di Jahvè, essendone l'unigenito figlio: una cosa, in verità, non da poco per un ebreo rigidamente monoteista. Pietro infatti non si sarebbe mai arrischiato a dirla, e quando deciderà di farlo, non si troverà più in Palestina.
Ma qui la cosa più interessante è un'altra. Mentre scrive la propria sintetica autobiografia, Paolo (la cui nascita a Tarso si può presumere sia avvenuta intorno al 5-10 d.C.) precisa per noi una cosa molto significativa. Dopo la conversione di Damasco (che risale agli anni 34-36), egli andò a Gerusalemme circa tre anni dopo, per visitare Pietro, presso cui rimase due settimane. Lo fece privatamente, temendo conseguenze spiacevoli su di sé, come già a Damasco, da dove era dovuto fuggire in maniera rocambolesca. Non dimentichiamo che a Gerusalemme lui era stato una persona pubblica, al servizio del sommo sacerdote quando imprigionava i cristiani: stando agli Atti (7,58), fu il principale mandante del linciaggio di Stefano.
Ebbene, in quel periodo egli, oltre a Pietro, non vide «nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore» (v. 19), che non era appartenuto alla ristretta cerchia degli «apostoli» del Cristo e che, secondo Flavio Giuseppe, verrà lapidato nel 62 dai giudei.
Ora perché Paolo dice questo? e perché sostiene, giurando davanti a dio, che quanto dice è la pura verità (v. 20)? Possibile che a pochi anni dalla morte del Cristo, a Gerusalemme fossero rimasti soltanto Pietro e Giacomo a guidare il movimento nazareno? Tutti gli altri apostoli se n'erano già andati? Il movimento s'era già dissolto in varie comunità, guidate dagli apostoli che non avevano accettato le tesi interpretative di Pietro e di Giacomo sulla fine del Cristo?
Paolo in sostanza fa capire che quando aveva iniziato a predicare agli ebrei-ellenisti e ai pagani di Siria e Cilicia l'idea di un messia figlio di dio morto e risorto, la comunità che a Gerusalemme seguiva Pietro e Giacomo era ridotta, rispetto al glorioso movimento nazareno, a ben poca cosa. Egli non avrebbe avuto bisogno di alcun mandato per rivolgersi ai pagani o per considerarli equivalenti agli ebrei. Semplicemente era arrivato in maniera autonoma a credere nelle stesse cose di Pietro e di Giacomo, traendone però delle conseguenze più radicali, più esplicite per il destino politico della propria nazione. Nel senso cioè che se il Cristo era risorto, doveva essere un dio, e se era un dio che non aveva voluto liberare Israele dai romani, significava che il suo messaggio non andava interpretato in senso politico ma solo in senso religioso, e che se andava inteso così, allora poteva essere rivolto anche ai pagani, che già credevano negli dèi che muoiono e risorgono e che non ambivano a fare delle rivoluzioni politiche contro Roma.
In sintesi, la differenza fondamentale tra Pietro e Paolo stava nel fatto che il primo, pur professando la tesi della resurrezione, continuava a credere in una parusia politica del Cristo, a vantaggio anzitutto degli ebrei d'Israele. Anche Paolo vi aveva creduto sino alla fine degli anni 40 (come attesta la I lettera ai Tessalonicesi), ma non l'aveva mai pensata come pura e semplice «restaurazione del regno davidico». Un messia, vero uomo e vero dio, che muore sulla croce romana per colpa dei giudei, che l'hanno tradito o non hanno comunque saputo difenderlo, e che risorge per virtù propria, quando tornerà tra i vivi, in maniera trionfalistica, non potrà farlo solo per i giudei, dovrà farlo per tutti. Secondo Paolo non avrebbe avuto senso rinchiudere entro angusti confini nazionali un avvenimento così prodigioso.
Se Gesù si era lasciato uccidere così impunemente e ignominiosamente, lui che, essendo dio, avrebbe potuto evitarlo senza problemi, significava che con la sua morte violenta voleva dimostrare che il primato della nazione giudaica era finito. Se fosse ritornato sulla terra per rivendicare i propri diritti politici, l'avrebbe fatto al cospetto di tutto il genere umano e in maniera definitiva.
Pietro non poteva arrivare a queste conclusioni, a meno che non vi fosse stato costretto, come sembra alludere quel passo del IV vangelo che dice: «quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi» (21,18). A chi si riferiva Giovanni con quel pronome indefinito? A Paolo?
Pur essendo anti-giudeo in quanto galileo, Pietro restava ancora troppo «ebreo». Il fatto che fosse rimasto a Gerusalemme ad attendere, insieme a Giacomo, il ritorno trionfale del messia, era il segno evidente che non aveva ancora capito la fine del primato storico-politico di Israele.
Certamente però al lettore «laico» di questa lettera non può essere sfuggito il fatto che Paolo, proprio mentre difendeva a spada tratta la propria autonoma posizione, finiva col tradire la causa religiosa della chiesa petrina, la quale sosteneva l'idea che le tesi della «morte necessaria» del Cristo e della sua «resurrezione» andavano considerate come le uniche interpretazioni possibili della tomba vuota, il cui significato stava non nel negare ma proprio nel riconfermare il primato d'Israele, in maniera tale però che i giudei avrebbero dovuto sentirsi indotti a riconoscere i galilei come dei partner politici alla pari, in attesa di avere una conferma della verità della nuova posizione petrina in virtù della parusia trionfale del Cristo. Il vangelo di Marco si conclude con le parole, rivolte alle donne: «andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro ch'egli vi precede in Galilea» (16,7).
È dunque stato un grave errore, da parte di Paolo, aver voluto far vedere la propria indipendenza dagli apostoli, asserendo che quando li vide per la prima volta, erano rimasti nella capitale giudaica soltanto Pietro e Giacomo fratello di Gesù: in tal modo egli lasciava intendere che sulle tesi di Pietro non c'era stato affatto quell'unanime consenso che poi gli Atti sbandiereranno a tutta la cristianità, specie nel racconto della Pentecoste.
L'incidente di Antiochia
A Gerusalemme Paolo ritorna dopo circa 14 anni dalla sua prima visita e dopo aver continuato a predicare ai pagani. Anche questa, come altre nella lettera, è un'affermazione che non trova un vero riscontro negli Atti e che quindi va considerata più attendibile di quanto non sarebbe stato il contrario.
Era accompagnato dall'ellenico Tito e dal levita Barnaba, l'uomo di fiducia della comunità di Gerusalemme ad Antiochia, che collaborò con Paolo sino alla separazione avvenuta all'inizio del secondo viaggio missionario, a causa di Marco, il futuro evangelista.
Senza dare alcuna spiegazione, Paolo scrive nella lettera (diversamente da come verrà poi detto negli Atti) che aveva esposto privatamente i successi della sua attività ai soli dirigenti della comunità giudaico-cristiana, nella speranza di essere accettato senza tanti problemi. E in effetti egli ottenne più di quanto sperato, tanto che le autorità non gli imposero di far circoncidere Tito né i nuovi adepti di origine pagana (da notare però che secondo At 16,3 lo stesso Paolo, per sentirsi agevolato nella predicazione ai giudei, aveva imposto a Timoteo di farsi circoncidere).
E comunque non è vero che le autorità cristiane non gli chiesero nulla in cambio del suo diritto a predicare senza ostacoli ai gentili in nome della chiesa ufficiale della capitale. Oltre alle due cose citate nella lettera: rispettare i confini delle aree dell'apostolato, evitando quindi di frequentare quelle ebraiche, e organizzare una colletta a favore dei poveri della chiesa di Gerusalemme, che doveva servire anche per far riconoscere ai gentili convertiti la preminenza spirituale (non giuridica) della chiesa-madre, negli Atti si parla anche di un decreto di portata universale, che imponeva ai cristiani di origine pagana di astenersi dalle carni degli animali immolati nei sacrifici e dalle unioni illegittime (fornicazione).
Tuttavia il problema è un altro. In questa pericope, scritta peraltro in maniera piuttosto infelice, c'è qualcosa che non convince: perché parlare privatamente dei propri successi alle autorità giudaico-cristiane, quando poi sarebbero state proprio queste ad autorizzarlo dal continuare ad evangelizzare i pagani? Davvero Paolo rivide a Gerusalemme, dopo 14 anni, Pietro, Giacomo e Giovanni? Rivide Giovanni che non aveva visto la volta precedente? uno delle tre «colonne» (2,9) della chiesa cristiana di Gerusalemme, che nel racconto anteriore a questo non era neppure stato citato?
Qui è impossibile non pensare a una successiva mano redazionale, il cui intento deve essere stato quello di far vedere che tra Pietro e Giovanni non vi era alcuna opposizione.
Peraltro Paolo scrive che il suo vangelo era, nella sostanza, analogo a quello di Pietro: la differenza stava soltanto negli aspetti formali, in quanto i destinatari non erano gli stessi. In realtà le cose non erano così semplici e lo documenta proprio l'incidente di Antiochia, che porterà i due a non frequentarsi più.
Paolo sembra qui considerare Pietro il più importante degli apostoli di Gesù, ma la mano redazionale ha dovuto metterlo al secondo posto, poiché quando Paolo andò a Gerusalemme per la seconda volta, Pietro probabilmente non c'era già più, essendo la comunità guidata da Giacomo, fratello di Gesù, ch'era sicuramente molto più «giudeo» di Pietro. Tant'è che nel racconto degli Atti, intitolato dalla chiesa col nome altisonante di Concilio di Gerusalemme, a Pietro viene fatto dire che non aveva intenzione di imporre a Paolo e ai suoi pagano-cristiani un «peso» (in riferimento anche alla circoncisione!) che neppure loro erano stati in grado di portare (15,10). Una frase del tutto impossibile in quel contesto, quanto meno contraddittoria con le disposizioni finali stabilite da Giacomo.
È quindi da presumere che nella lettera originaria di Paolo non si parlasse neppure di Pietro come «presente» nella città santa, ma soltanto come di un punto di riferimento fondamentale per la sua predicazione ai pagani, a motivo delle inedite tesi sulla «morte necessaria» del Cristo e della sua «resurrezione», che avevano aperto una breccia significativa nell'impianto politico-nazionalistico del giudaismo. Un punto di riferimento, tuttavia, remoto, in quanto già prima della stesura della lettera ai Galati, ovvero subito dopo il secondo viaggio paolino a Gerusalemme, i rapporti tra i due si erano guastati.
Pur di fare un favore ai destinatari della lettera, facendo vedere ch'egli si sentiva più «pagano» che «ebreo», egli vuole ricordare il cosiddetto «incidente di Antiochia», che gli Atti collegano in maniera causale al suddetto Concilio (avvenuto non più tardi del 50) e che invece Paolo considera successivo a quell'evento.
Egli in sostanza aveva accusato pubblicamente Pietro di tenere una condotta ambigua, da ipocrita, sulla questione della comunanza di mensa, nei confronti dei cristiani di origine pagana, per timore d'essere malvisto dai giudeo-cristiani, capeggiati da Giacomo. Dopo quell'incidente non si saprà più nulla con sicurezza di Pietro. Di certo non tornerà più a Gerusalemme e Paolo non metterà più piede ad Antiochia.
La questione della legge
A partire da 2,15 si può constatare uno stacco abbastanza netto con quanto scritto fin qui. I vv. 15-21 sono una sorta d'introduzione molto sintetica, che anticipa una lunga lezione cattedratica che appesantisce notevolmente il carattere brioso della lettera e che in sostanza non aggiunge nulla di più a quanto già scritto nella lettera ai Romani (scritta all'incirca nello stesso periodo), tanto che vi è da supporre che questa parte sia stata interpolata da qualche discepolo in vena di esibire la propria erudizione.
La tesi di fondo di questo nuovo discorso si può ridurre ai seguenti termini: gli ebrei erano migliori dei pagani, poiché conducevano una vita moralmente sana in virtù della legge mosaica, per quanto fossero stati anche loro rovinati dalla corruzione dell'alto clero e dal collaborazionismo con le forze straniere occupanti. Siccome non sono stati capaci di riconoscere il messia che avrebbe potuto liberarli dai romani, hanno perso il diritto a considerarsi migliori degli altri popoli, tanto più che il messia lasciato crocifiggere non era un uomo comune ma un dio. Ora, poiché questo messia è risorto, e non poteva non esserlo, essendo un dio, e poiché, pur essendo risorto, egli non è tornato a liberare il suo popolo dall'oppressione romana, gli ebrei più onesti e realisti hanno dedotto che il primato d'Israele era finito, sia nel senso che non sarebbe stata possibile una liberazione politico-nazionale conservando le tradizioni ebraiche, sia nel senso che anche sul piano etico chiunque avrebbe potuto avere la medesima fede nel Cristo risorto, unigenito figlio di dio, il quale s'era lasciato crocifiggere appunto per insegnare agli ebrei che non avevano alcuna speranza di liberarsi da soli dell'oppressione straniera, ed egli non era tornato a liberarli proprio per insegnare loro che dopo il peccato originale l'unica speranza di sentirsi liberi poteva realizzarsi solo nell'aldilà: la sua resurrezione era appunto servita per dare conferma di questa verità. Dunque se gli ebrei non possono liberarsi politicamente, non possono neppure pretendere di sentirsi diversi dai pagani sul piano etico, né, tanto meno, su quello dell'adempimento delle prescrizioni legali.
Certo, il fallimento dell'insurrezione nazionale non stava a significare - secondo Paolo - che d'ora in avanti gli ebrei erano autorizzati a comportarsi come i pagani peccatori, le cui leggi non sono mai state severe come quelle ebraiche. Semplicemente voleva dire che ora la nuova etica ebraica poteva essere vissuta anche dai pagani, nella comune fede in Cristo risorto, rinunciando a qualunque velleità di liberazione politico-sociale.
È in questo senso che Paolo nega agli ebrei la possibilità di considerarsi migliori limitandosi a osservare i precetti della Torah. Anche perché tutti i loro precetti possono essere riassunti in uno solo, alla portata anche dei pagani, se questi sono convinti che il «regolamento dei conti» verrà fatto, senza ombra di dubbio, alla fine dei tempi: «ama il prossimo tuo come te stesso».
La nuova fede cristiana dovrà essere una sorta di etica religiosa, conforme ai valori umani universali, del tutto indifferente al problema di realizzare una liberazione sociale contro lo sfruttamento degli schiavi o una liberazione politica contro l'autoritarismo degli imperatori. Con la sua morte e resurrezione Cristo aveva semplicemente insegnato che su questa terra non c'è alcuna speranza d'essere liberi e che tutto dovrà compiersi nel regno dei cieli. Per questo bisognava aver «fede nella grazia».
Il cristianesimo di Paolo, per quanto paradossale possa sembrare, alla luce di ciò ch'egli dovette subire a causa del suo frenetico apostolato, è un cristianesimo a favore della rassegnazione politica, della rinuncia a combattere. È come s'egli avesse sublimato il fallimento della propria esperienza politica con un attivismo indomito a favore di una nuova esperienza religiosa. Proprio lui e, prima di lui, Pietro sono stati i principali responsabili del tradimento del messaggio di Gesù. Un tradimento, per alcuni versi, anche più grave di quello di Giuda, poiché questi aveva tradito una certa idea della politica, opponendone un'altra, di cui poi si pentì; quelli invece avevano attribuito al Cristo delle idee religiose che lui non aveva mai avuto: lo avevano usato per diffondere il loro idealismo mistico e non se n'erano mai pentiti.
Si badi, in astratto Paolo non aveva torto: non solo una liberazione politica, ma neppure una libertà etica può mai essere il risultato di una mera applicazione della legge. Indubbiamente i giudei peccavano di presunzione quando attribuivano al rispetto rigoroso della loro normativa la quintessenza della soddisfazione personale di un credente.
A dir il vero però i farisei non si limitavano a questo. Sarebbe far loro un torto considerarli come il partito più tradizionalista, unicamente interessato alle questioni della legalità, formale o sostanziale che fosse. Nelle fonti evangeliche risulta sufficientemente chiaro che questo partito non era solo avverso alla corruzione del clero del Tempio, ma anche al dominio romano, e per opporsi a quest'ultimo aveva pagato, prima della nascita del movimento nazareno, prezzi molto salati.
Ma il punto è un altro. Paolo non sta dicendo ai Galati che la politica dei farisei era stata inefficace contro Roma, non sta proponendo un'alternativa alla politica di quello che un tempo era stato il suo partito (come fece Gesù nei confronti del Battista), ma sta sostenendo che il rispetto scrupoloso della legge mosaica non serve assolutamente a nulla, proprio perché non serve a nulla lottare per una liberazione d'Israele.
Cioè il problema per lui non è più quello di porre una diversa strategia insurrezionale, bensì quello di come trasformare la battaglia politica contro Roma e i suoi collaborazionisti ebrei in una semplice ancorché radicale battaglia religiosa tra ortodossia (giudaica) ed eresia (cristiana), facendo diventare quest'ultima la nuova religione del presente e del futuro, in virtù della quale i cristiani di origine ebraica (quelli soprattutto residenti al di fuori della Palestina) si sarebbe avvalsi dell'aiuto dei gentili per propagandare una fede comune nel Cristo risorto.
I contenuti della sua dottrina Paolo non avrebbe mai potuto divulgarli entro Israele: l'avrebbero fatto immediatamente fuori, come lui aveva fatto con Stefano. Avrebbe avuto contro non solo gli oppositori al dominio romano ma anche i collaborazionisti fermamente vincolati alle tradizioni ebraiche. Al massimo avrebbe potuto avere con sé gli erodiani, che rispettavano le tradizioni ebraiche solo per pura convenienza e che forse sarebbero stati anche disposti a credere nella teoria della resurrezione di Cristo, avendo già detto, quando questi era ancora in vita e operante in Galilea, ch'era «il Battista redivivo» (Mc 6,16), da loro decapitato qualche anno prima.
Un ebreo ortodosso non avrebbe accettato i contenuti idealistici e spiritualistici di Paolo neppure dopo la catastrofe del 70, proprio perché per accettarli avrebbe dovuto comunque rinunciare al proprio ebraismo (un esempio evidente di questa rinuncia lo si ritrova nel racconto lucano dei discepoli di Emmaus).
Quando predicava agli ellenisti, Paolo si differenziava dal paganesimo solo per la sua condotta morale, la cui intransigenza era derivata dall'ebraismo. È vero che sul piano dottrinale, egli, a differenza dei gentili, sosteneva tesi monoteistiche, ma è anche vero che fu proprio lui a inventarsi, su due piedi, la trasformazione del monoteismo giudaico nel diteismo cristiano, né disdegnò le ipotesi più immaginifiche sulla parusia finale e il giudizio universale. La sua stessa conversione viene raccontata nella maniera più mistica possibile. Evidentemente egli conosceva bene le debolezze dei suoi interlocutori pagani, disposti com'erano a lasciarsi abbacinare da racconti in cui il mito avesse una parte preponderante sulla realtà.
Dopo il fallimento politico del movimento nazareno e le tesi mistico-revisioniste di Pietro, uno come Paolo, emerso dagli ambienti ellenistici dell'ebraismo, appariva, in un certo senso, come una inevitabile conseguenza. Non a caso sul versante opposto, quello decisamente rifiutato dai cristiani, si formò la rivolta giudaica capeggiata dagli zeloti. La sconfitta dello zelotismo tornò ovviamente a favore delle tesi magico-teologiche del petro-paolinismo, benché agli occhi dello Stato romano fosse ancora prematuro fare differenza tra «giudei» e «cristiani». Ed è indubbio che quella sconfitta rappresentò anche l'ultima seria resistenza al dominio romano prima dell'ingresso tumultuoso delle cosiddette popolazioni «barbariche».
Certo, qualche esegeta potrà sempre dire che, per quanto il messaggio originario del Cristo sia stato vergognosamente tradito non solo da Giuda, ma anche da Pietro e da Paolo, resta il fatto che sulla base di questo tradimento è comunque nata una religione che ha fatto la storia, che è risultata più universale dell'ebraismo e meno superstiziosa del paganesimo, per quanto taluni risvolti «politici» del cattolicesimo-romano il genere umano se li sarebbe risparmiati volentieri.
Evidentemente la carica democratica del movimento nazareno, che pur fallì sul piano rivoluzionario, doveva essere stata così grande che risultava impossibile prescinderne del tutto: qualcosa andava, in qualche modo, salvaguardato. Sotto questo aspetto, e considerando anche che per fare ciò i cristiani dovettero comunque subire delle persecuzioni, forse si potrebbe anche attenuare l'accusa di tradimento, anche perché la storia non è così generosa nell'offrire ai suoi lettori esempi di esplicita lotta rivoluzionaria. Solo in casi particolari gli uomini manifestano con coraggio l'intenzione di dire basta a violenze e soprusi.
Ecco perché bisogna riconoscere che i primissimi cristiani, e Paolo in particolare, rappresentano dei casi davvero singolari, poiché arrivarono ad accettare pesanti restrizioni alla loro libertà per aver predicato non delle teorie rivoluzionarie (anche se culturalmente innovative), ma delle teorie che politicamente erano molto conservatrici, con cui non solo allora ma anche per molti secoli dopo si sarebbe cercato di dissuadere gli oppressi dal compiere qualunque tipo di rivolta.
Non dimentichiamo che tutta l'opposizione cristiana alla legge ebraica aveva come scopo principale quello di demolire l'istanza politica a una liberazione nazionale, non aveva solo lo scopo di far vedere che gli ebrei schiavizzati da Roma s'illudevano di poter continuare a restare liberi semplicemente osservando i loro precetti.
Per gli ebrei la legge aveva un valore politico-nazionale e, nel contempo, un valore simbolico mondiale. Quando una religione s'afferma in un determinato territorio, è giocoforza che i poteri dominanti elaborino delle leggi per tutelarla. Questo a prescindere dal fatto che in Israele le classi egemoni avevano aggiunto alla tradizionale legge mosaica tanti di quei precetti da renderla un peso insopportabile, e a prescindere anche dal fatto che la religione qua talis viene sempre usata per tenere soggette le masse, che sia o no fusa con la stessa legge.
Difficilmente un ebreo avrebbe potuto capire che per affermare l'idea dell'amore universale si doveva abolire la legge tout-court, non foss'altro che per una ragione: quell'idea era già contenuta nella stessa legge. I principi «ama il prossimo tuo come stesso» o «non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te», non sono certo di origine cristiana.
Per poter arrivare a una soluzione così drastica e, se vogliamo, così idealistica, l'ebreo avrebbe prima voluto veder affermato l'amore a livello di rapporti sociali, nella consapevolezza che, proprio la realizzazione di un obiettivo del genere, così impegnativo, avrebbe richiesto un tempo enorme, nel corso del quale sarebbe stato assurdo fare a meno della legge. In tal senso va considerata del tutto utopistica la posizione paolina e se Israele non avesse perso la partita con l'impero romano, essa probabilmente avrebbe fatto la fine di una qualunque filosofia stoicistica.
Il concetto filosofico di «amore universale» non era mai stato predicato dal Cristo, proprio perché con esso si sarebbe finiti col dover amare persino i propri oppressori, rinunciando quindi a qualunque insurrezione. Nel suo programma politico le idee di libertà e di giustizia risultavano sicuramente molto più pregnanti ed efficaci.
In sostanza dall'esperienza umana e politica del Cristo si presero soltanto quelle cose che potevano essere rielaborate in chiave religiosa, ovvero si riformularono in chiave mistica quegli aspetti chiaramente orientati verso una soluzione non religiosa del problema della liberazione nazionale. Ci sono voluti 18 secoli prima che si riuscissero a porre le basi per un ripensamento critico, sia sul versante umanistico che su quello politico, del tradimento petro-paolino.
L'ideologia dell'amore
Quello che, dell'insegnamento di Paolo, doveva aver maggiormente tratto in inganno le popolazioni elleniche era stata indubbiamente la tesi secondo cui il Cristo, ch'era dio, s'era lasciato crocifiggere perché «amava gli uomini» e voleva sottrarli all'ira divina conseguente al peccato d'origine. Gli uomini cioè avevano bisogno di sapere che, pur ereditando le conseguenze di quel peccato, potevano continuare a sperare in una sua sconfitta definitiva, per poter tornare ad essere quello ch'erano stati un tempo, anteriore allo schiavismo.
Era impossibile che il sacrificio personale di un uomo che aveva dimostrato d'essere dio (per il suo popolo) risorgendo dopo morto, non colpisse la fantasia della gente semplice, bisognosa di consolazione, al fine di sopportare meglio le frustrazioni della vita reale. Il cristianesimo mai avrebbe potuto avere il successo che ebbe, se non avesse mistificato degli eventi realmente accaduti, ovvero se non avesse operato delle falsificazioni su cose che qualcuno, in qualche modo, doveva aver visto coi propri occhi. È assurdo pensare che una dottrina così mistica avrebbe potuto avere un successo così clamoroso se fosse stata unicamente partorita dalla mente esaltata di qualche fanatico visionario.
Chi sostiene una teoria del genere, mostra di tenere in scarsa considerazione gli esseri umani, che generalmente non sono avvezzi a farsi prendere in giro oltre un certo limite di tempo, oltre un certo grado d'intensità. Il cristianesimo non è stato un fenomeno di autosuggestione collettiva, di plagio mentale da parte di leaders religiosi senza scrupoli: sarebbe un'interpretazione semplicistica.
Indubbiamente i fenomeni mistici, magici e superstiziosi appartengono anche al cristianesimo, come a qualunque altra religione, ma se si fosse trattato solo di questo, difficilmente riusciremmo a spiegarci la sua durata nel tempo, il suo successo universale. In realtà il cristianesimo è stato la mistificazione di un evento reale, la cui importanza doveva in qualche modo aver notevolmente impressionato i suoi testimoni oculari.
La mistificazione ebbe successo proprio perché si seppe abilmente giocare sull'ambiguità delle parole, come solo dei grandi intellettuali riescono a fare, e indubbiamente gli ebrei sanno anche essere dei grandi intellettuali. Paolo, p.es., parlando di «sacrificio del Cristo per amore degli uomini», doveva essere consapevole di dire una cosa che poteva essere interpretata in modi assolutamente divergenti e che, nonostante questo, il suo doveva apparire come l'unico giusto.
Infatti, dire che un dio fattosi uomo s'era lasciato uccidere per adempiere alla volontà del padre, il quale voleva riconciliarsi con gli uomini, educandoli a credere nella salvezza ultraterrena, era una cosa. Dire invece che un leader politico aveva preferito sacrificare la propria vita piuttosto che compromettere quella dei propri seguaci, nella speranza che la rivoluzione antiromana si sarebbe ugualmente fatta, così come lui l'aveva progettata, era tutt'altra cosa. L'idea di «sacrificio personale» venne usata dai cristiani non per confermare la necessità di un progetto insurrezionale, ma per negargli qualunque legittimità.
Semmai dovremmo chiederci che fine fecero quanti, già tra gli apostoli, non accettarono queste mistificazioni. Forse un giorno ce lo dirà il ritrovamento del vangelo originario di Giovanni o quello dell'autentica Apocalisse o di altri testi ancora, di cui non sappiamo nulla. Noi al momento possiamo soltanto constatare che l'interpretazione che i vangeli danno della Sindone è troppo mistica per essere vera: se la Sindone è vera, indubbiamente i vangeli mentono. Nessun romano aveva mai trattato un ribelle in quelle condizioni. Dovevano esserci dei presupposti molto particolari per poterlo fare, di cui almeno tre essenziali: 1. che l'insurrezione fosse imminente, 2. che i romani non avessero alcuna possibilità di vittoria, 3. che il leader degli insorti avesse un'enorme popolarità. Neppure quando vi fu l'inaspettato tradimento di Giuda, le autorità erano sicure di poter mandare il Cristo al patibolo, almeno non senza conseguenze per la loro incolumità.
L'invenzione dello Spirito e il mito di Abramo
Il capitolo 3 introduce improvvisamente un elemento di cui non s'era parlato in precedenza: lo spirito. In cinque versetti la parola spirito viene scritta tre volte e ogni volta si sostiene che lo spirito era stato dato ai Galati dallo stesso Paolo, tramite la predicazione del suo vangelo.
Se non credessimo che l'autoesaltazione di Paolo poteva arrivare anche a delle pretese del genere, saremmo indotti a credere che qui si sia in presenza di un'aggiunta da parte di qualche suo discepolo di origine ellenistica, con vaghe tendenze autoritarie: un discepolo in grado di avere cognizione di un fattore ecclesiale alquanto mistico, che la comunità post-pasquale elaborò in maniera compiuta soltanto alla fine del I secolo.
Nel vangelo di Giovanni lo spirito appartiene a dio-padre e può essere dispensato solo dal Cristo. In questi versetti invece non sembra che Paolo parli di sé come «seguace di Cristo risorto» ma come suo «sostituto», tant'è che nell'ultimo versetto non si ha ritegno nell'affermare che nelle comunità da lui fondate, egli era in grado di compiere «miracoli» come Gesù Cristo.
Sotto questo aspetto pare più autentico il v. 14, ove Paolo sostiene che i pagani, per mezzo della fede, potevano ricevere dal Cristo lo spirito promesso. Solo che questo versetto appartiene a una sequela di versetti basati su interpretazioni del tutto arbitrarie dell'Antico Testamento, cui i cristiani di origine ellenistica sarebbero stati poco interessati. Il che lascia pensare che la lettera sia stata effettivamente manomessa da redattori cristiani di origine ebraica.
In effetti, tutta la fantasiosa reinterpretazione del ruolo storico di Abramo sembra più che altro essere rivolta a un interlocutore semita, da tempo abituato a confrontarsi con la cultura ellenistica. Immaginarsi infatti un Cristo prefigurato addirittura da Abramo poteva venire in mente solo a un ebreo che avesse già messo in crisi le fondamenta del proprio ebraismo.
Qui l'autore dell'interpolazione si serve di una mitologizzazione della figura di Abramo per giustificarne un'altra, quella del Cristo risorto. E non fa che riprendere quanto Paolo aveva già scritto in Rm 4. Solo che una differenza fondamentale c'è. Nella lettera ai Romani Paolo considerava la fede di Abramo (quella contro ogni ragione) come un modello della fede cristiana, un modello fattibilissimo, in quanto Abramo la ebbe da incirconciso, e quindi da pagano, anche se poi la circoncisione servì come «sigillo della giustizia divina ottenuta per la fede» (Rm 4,11), sicché, in tal modo, Abramo poteva legittimamente essere considerato padre sia degli ebrei che dei pagani.
Ma nella lettera ai Galati non ci si limita a una generica identificazione del tipo di atteggiamento religioso che gli uomini devono avere nei confronti della divinità, non ci si limita a sostenere che la fede nei confronti di Jahvè doveva diventare la stessa nei confronti di Cristo risorto; quello che qui si aggiunge è cosa che nessun ebreo avrebbe mai potuto accettare restando ebreo: il fatto cioè che tutto quanto era stato promesso ad Abramo aveva come scopo fondamentale quello di arrivare a credere in Gesù Cristo.
Qui si pone un legame diretto tra ebraismo e cristianesimo, non semplicemente una simbolica equiparazione: l'uno è inveramento dell'altro. Cioè il cristianesimo porterebbe a compimento la promessa che Jahvè aveva fatto al suo popolo di avere una terra priva di schiavitù, con l'aggiunta però che questa promessa verrà mantenuta solo nel regno dei cieli. Da una promessa concreta, materiale e in fondo politica, gli ebrei sarebbero dovuti passare a una promessa del tutto spirituale. La «terra promessa» andava reinterpretata come «spirito promesso» (v. 14), quello spirito che rende tutti «uguali»: giudei e greci, schiavi e liberi, maschi e femmine (3,28). L'uguaglianza non ha più bisogno d'essere sociale, è sufficiente che sia religiosa.
Qui Paolo, o comunque i suoi manipolatori, usano in maniera strumentale la figura di Abramo per giustificare il loro cristianesimo mitologico. Cioè non si limitano a considerare la legge mosaica come insufficiente per ottenere la liberazione politica e la libertà etica, ma ritengono che la fede di Abramo fosse superiore alla stessa legge mosaica, proprio perché più somigliante a quella che deve avere il cristiano quando crede nella resurrezione di Cristo. Abramo diventa il mito più utile per credere nel mito di Cristo.
Insomma non è da escludere che tutto il capitolo 3 sia stato aggiunto a questa lettera. A partire dal capitolo successivo infatti torna improvvisamente il tono colloquiale, quello con cui Paolo spera di convincere i Galati a non lasciarsi sedurre dalla predicazione di nuovi cristiani di origine giudaica, i quali esigono il rispetto di alcuni elementi fondamentali della loro religione, tra cui appunto la circoncisione.
Il cristianesimo fra libertà e schiavitù
Nel cap. 4 della lettera Paolo sembra rivolgersi non tanto ai cristiani di origine pagana quanto a quelli di origine ebraica, in una maniera stranamente confusa. Infatti scrive: «finché l'erede [che qui supponiamo sia l'ebreo] è minorenne, non differisce in nulla dal servo [che qui supponiamo sia il pagano], benché sia padrone di tutto» (v. 1). «Così anche noi [ebrei], quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo» (v. 3), nel senso che gli eredi della promessa fatta ad Abramo non erano padroni di nulla, poiché le contraddizioni antagonistiche lo impedivano.
Ma poi venne il Cristo - prosegue Paolo - «per riscattare quelli [gli ebrei] ch'erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione [a figli]» (v. 5), nel senso che quanto gli ebrei non avevano ottenuto attraverso la legge, nonostante la promessa, l'hanno finalmente ottenuto con la resurrezione di Cristo, che rimanda tutto all'aldilà.
Questa cosa però vale anche per i pagani, che non sono più «servi ma figli» (v. 7) e quindi co-eredi della promessa di liberazione, fatta questa volta dallo stesso Cristo risorto. Ora, come possono i pagani diventare «figli» non avendo mai conosciuto neppure il vero dio? Paolo risponde a questa domanda dicendo, nella maniera più mistica possibile, che «dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei cuori di tutti gli uomini che grida: 'Abbà' [che in greco significa 'Padre']» (v. 6).
Questo è un punto-chiave della lettera. L'incontro tra pagani ed ebrei non avviene sulla base di motivazioni di riscatto socio-politico, ma su questioni eminentemente religiose. È come se Paolo avesse detto che dio aveva voluto il fallimento dell'ebraismo politico-nazionalistico affinché si creasse l'occasione di un'intesa, sul piano religioso, con la disperazione degli oppressi di origine pagana, che non solo non riuscivano - come gli ebrei - a liberarsi del dominio romano, ma non riuscivano neppure a trovare nella loro tradizionale religione alcun motivo di conforto.
Paolo, in sostanza, s'era convinto che l'ebraismo avrebbe potuto continuare a sussistere approfittando delle debolezze del paganesimo politeista e, nel contempo, spogliandosi di tutte quelle peculiarità semitiche che l'ellenismo non avrebbe mai potuto accettare (la prima delle quali era appunto la circoncisione). Era riuscito a compiere un'operazione politicamente revisionista e religiosamente cosmopolita, e ora nella lettera si dispera di aver lavorato invano coi suoi discepoli Galati. Mentre da un lato rivoluzionava le coscienze mistiche, dall'altro le inchiodava a un'esperienza concreta di schiavitù, facendo però credere che solo in tal modo si sarebbe potuta raggiungere la vera libertà.
Solo una persona particolarmente caparbia e intellettualmente dotata poteva riuscire in un'impresa del genere. Egli peraltro era in grado di passare dalle riflessioni teologiche più ardite ai toni colloquiali più toccanti, come quello che usa proprio nei vv. 12-20 di questo capitolo, in cui sembra voglia assumere il ruolo di un padre che chiede di riconciliarsi coi propri figli, riconoscendo loro dei meriti speciali per averlo assistito durante una sua grave indisposizione: «mi accoglieste come un angelo di dio, come Cristo Gesù stesso» (v. 14); «vi sareste cavati gli occhi per me» (v. 15).
Dal v. 21 al v. 31 di nuovo subentra una certa confusione. A chi si rivolge ora Paolo? Da ciò che scrive non sembra esservi dubbio: ai cristiani di origine giudaica che vogliono conservare dell'ebraismo gli elementi fondamentali. Ma quanti destinatari ha avuto questa lettera? Qui è evidente che più mani sono intervenute, in fasi successive, alla sua stesura.
Ora il confronto che viene posto non è più tra Abramo e Cristo, ma tra Sara e Agar, le due mogli di Abramo. Identica è però la lettura del tutto strumentale dell'Antico Testamento. Infatti la discendenza di Agar viene ritenuta «schiava», come schiavi sono gli ebrei che in Israele sono dominati da Roma. Viceversa la discendenza di Sara è «libera», essendo figlia della «Gerusalemme celeste» (v. 26), quella della fine dei tempi. E se anche ora i cristiani vengono perseguitati dai giudei (dai figli di Agar), alla fine dei tempi saranno soltanto loro a ricevere il dono della libertà ch'era stato promesso: «noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera» (v. 31).
Come si può notare, un'interpretazione della vicenda abramitica del tutto fantasiosa, che un giudeo mai avrebbe potuto accettare e che un pagano difficilmente avrebbe potuto capire. Qui si ha l'impressione che questa parte di testo sia stata scritta per ebreo-cristiani che di ebraico ormai non avevano più nulla, salvo il desiderio di reinterpretare le parti salienti dell'Antico Testamento per giustificare meglio la loro transizione al cristianesimo.
Praticamente è solo al capitolo 5 che si comprende che l'intento della lettera era quello d'impedire che i nuovi cristiani di origine ebraica inducessero i Galati (di origine ellenica) a farsi circoncidere. Questi ebreo-cristiani presumibilmente erano partiti da Israele con l'intenzione di far valere l'aspetto che consideravano più distintivo della loro identità, per poi probabilmente arrivare a proporre nuove condizioni di appartenenza al cristianesimo (p.es. il rispetto di un certo calendario astronomico, come si evince da 4,10).
Probabilmente questi ebreo-cristiani ritenevano ancora possibile la liberazione politica della Palestina. Paolo invece li paragona a pedanti esecutori del rispetto formale della legge, incapaci di capire che la vera salvezza si ottiene soltanto grazie alla «fede che opera per mezzo dell'amore» (5,6). Ed è sul valore dell'amore che si chiude la lettera.
La religione dell'amore
Paolo sembra rendersi conto che se non può tener testa ai giudei sul piano della speculazione teologica (anche perché non è in grado, in quel momento, di raggiungere i Galati), e se rischiano di non bastare i suoi rapporti di fiducia con le persone ch'egli aveva in un primo tempo convertite alla sua nuova ideologia religiosa, forse una speranza può ancora averla se punta il dito su una questione che inevitabilmente tocca i sentimenti e la coscienza di tutti: l'amore fraterno.
Il pezzo forte di questa lettera non sono certo le astruse speculazioni teologiche e neppure la sintetica autobiografia, per quanto scritta con molta intensità, ma sono queste riflessioni sull'amore, intrecciate a un'espressività esistenziale di tutto rilievo. È qui che Paolo offre il meglio di sé.
Essere «liberi» per lui significa vivere nell'amore fraterno, «poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: Ama il prossimo tuo come te stesso» (5,14). Il che, in sostanza, per lui voleva dire che bisognava mettere alla prova gli «intrusi» sul piano concreto dell'amore reciproco.
«Amore» infatti significa «aiutarsi» ma anche «sacrificarsi», rinunciare ai desideri della «carne», che non riguardano solo la sessualità, ma anche l'immoralità in senso lato, le superstizioni..., fino alle ambizioni di potere. Paolo sta praticamente dicendo ai suoi adepti che i migliori di loro si riconoscono dal fatto che agiscono in umiltà, senza ambire a pubblici riconoscimenti, senza dividere ciò che è già unito.
Sotto questo aspetto, anche i cristiani di origine pagana sono in grado di smascherare le trame degli infiltrati di origine giudaica. Se c'è «amore reciproco», ci sarà anche la preoccupazione di evitare divisioni per motivi che ormai non hanno più alcun vero significato. I Galati devono soltanto stare attenti a non approfittare della libertà spirituale che hanno ottenuto per compiere cose contrarie alla dignità umana.
Quanto ai giudeo-cristiani che vogliono imporre loro la circoncisione, è facile smascherarli: lo fanno per evitare d'essere perseguitati dai giudei più ortodossi di loro. Infatti se fossero davvero giudei non accetterebbero di diventare cristiani e applicherebbero la legge per intero e non solo in una sua singola parte (la circoncisione), e se fossero davvero cristiani non chiederebbero di seguire un'usanza che per i pagani non ha alcun valore.
«Quello che importa - scrive Paolo - è essere una nuova creatura» (6,15). Una creatura che di politico non ha nulla: «io sono stato crocifisso per il mondo», proprio perché «il mondo, per me, è stato crocifisso» (6,14), nel senso che il mondo non ha alcuna possibilità di salvarsi da solo, per cui - fa ancora capire - è inutile insistere più di tanto nel cercare di convincere qualcuno a stare saldo nella propria fede: qualunque deviazione verrà pagata da inevitabili conseguenze. «Non vi ingannate; non ci si può beffare di dio; perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà» (6,7).
Il finale è mesto e sconsolato nei confronti di chi vuole tradire il suo messaggio, ma fermo e risoluto nei confronti di se stesso e delle scelte che ha già preso: «D'ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù» (6,17), cioè le sofferenze già subite, durante i suoi viaggi, per averlo predicato. Paolo in sostanza sta dicendo che non può scendere a compromessi sulle questioni essenziali della sua dottrina. Dunque più di così coi Galati non può fare.
Conclusione
Un personaggio straordinario, questo Paolo di Tarso, in grado di unire lo sfacelo della propria religione con quello di un'altra religione, del tutto opposta alla sua, dando vita a una terza religione, che ancora oggi, nella variante ortodossa, conserva aspetti di alta spiritualità e di grande coerenza con gli ideali originari.
È infatti questa variante del cristianesimo, e non tanto quella cattolico-romana, che ha legato la fede al potere politico più retrivo, né quella protestantica, che ha criticato il cattolicesimo solo per subordinare la fede alle esigenze della borghesia, che il socialismo democratico e l'umanesimo laico devono impegnarsi di più a superare.
(torna su)6) Lettera agli Efesini
La premessa della lettera agli Efesini (vv. 1-14), scritta - secondo la tradizione - da un Paolo incarcerato a Roma, è particolarmente pessimista, in quanto è tutta un elogio alla predestinazione.
È come se l'apostolo, consapevole della propria sconfitta come uomo politico, si voglia autoconvincere che tutto quanto sino a quel momento aveva fatto era stato in definitiva un successo solo dal punto di vista etico-religioso.
La premessa è una sorta di mini-trattato teologico in cui sono riassunti i temi fondamentali di tutta l'ideologia paolina: Cristo non era un liberatore politico ma un redentore morale, non agiva per liberare la Palestina dai romani e dai collaborazionisti ebrei, ma era venuto (dall'aldilà) per sconfiggere il peccato originale e quindi la morte, sua principale conseguenza, ovvero per riappacificare l'umanità col dio che l'aveva cacciata dall'eden proprio in seguito a quella colpa fatale.
Non tutti - spiega Paolo - hanno accettato questo messaggio di salvezza, evidentemente perché non erano predestinati da dio. Tuttavia chi lo è ha il compito morale di far capire agli altri il significato, l'importanza della missione del Cristo. Paolo ritiene di essere stato il primo ad avere capito adeguatamente, sino in fondo, sino alle conseguenze più radicali, tale missione, e ora gode del fatto che molti altri la pensano come lui.
Nel vv. 15-23 l'apostolo, che nel passato era stato un fariseo politicamente impegnato, non può limitarsi a dire che il Cristo si pose solo come redentore morale. La sua autorità è in realtà anche politica e materiale, solo che lo è in senso escatologico. Cristo dimostrerà di essere il più potente di tutti solo alla fine dei tempi. L'attesa della parusia imminente è decisamente scomparsa in questa enciclica.
Il trionfo politico delle idee religiose non è un compito del cristiano ma solo del Cristo. Compito del cristiano è quello di restare moralmente integro, irreprensibile e di attendere con serenità, forza e coraggio la fine dei tempi. Quindi suo compito non è semplicemente quello di rispettare la legge o di compiere opere di carità, poiché queste cose, senza un certo «atteggiamento interiore», non valgono nulla, non servono per diventare «cristiani» ma per restare «ebrei».
Qual è questo «atteggiamento interiore»? È quello della fede nella grazia divina. È dio che salva, l'uomo non può salvarsi da solo. Il cristiano deve soltanto accettare questa realtà. Il bene non può venire dagli uomini, che ne sono incapaci, ma solo da dio. Il bene del cristiano è la fede in dio attraverso la chiesa, che rappresenta Cristo in terra, ne è la sua «sposa».
Un discorso così astratto e generale, senza alcun riferimento a tradizioni o istituzioni ebraiche, poteva essere accettato anche dai pagani, previa ovviamente la fede nella resurrezione del Cristo, senza la quale tutto il resto è vano.
Con la sua teologia spiritualista Paolo realizza l'uguaglianza morale di tutti gli uomini della terra davanti a dio in Cristo. Gli uomini sono classificati in due grandi categorie: ebrei (che beneficiavano della legge, cioè della conoscenza del bene e del male) e pagani (moralmente inferiori agli ebrei perché con leggi eticamente meno rigorose, meno esigenti, con principi di vita meno umanitari di quelli ebraici).
Questo ovviamente per Paolo significa rinunciare a qualunque forma di liberazione politica nazionale. Non c'è più la nazione, c'è il mondo, perché non ci sono più i popoli ma solo la chiesa. Non c'è più la legge da rispettare ma l'amore da realizzare. Chi ama rispetta anche la legge, inevitabilmente.
Gli ebrei non devono difendersi dai pagani come facevano prima, quando temevano che un qualunque contatto con un «non ebreo» poteva «contaminarli»; non devono combattere i pagani quando questi sono oppressori, ma, una volta spogliatisi della loro ebraicità, devono diventare come i pagani convertiti, uomini nuovi, cioè cristiani.
I principi morali che i cristiani devono vivere sono quelli di sempre, affermati anche dalle migliori filosofie di vita pagane ed ebraiche, anche se vissute senza la consapevolezza che la liberazione è già compiuta nel Cristo risorto. Quindi umiltà, mansuetudine, pazienza, reciproca sopportazione e sottomissione, amore, pace, unità, verità nella carità, accettazione benevola delle cariche dirigenziali e amministrative, come volute da Cristo stesso; le mogli devono stare sottomesse ai mariti, che però devono amarle e non trattarle da serve; i figli devono stare sottomessi ai genitori, che però devono allevarli nell'educazione; gli schiavi devono stare sottomessi ai padroni, in tutta semplicità, come «servi di Cristo», anche perché di fronte a Cristo conta poco essere libero o schiavo: ognuno riceverà sulla base del bene che avrà fatto. Quindi anche ai padroni conviene trattare bene i loro schiavi, «mettendo da parte le minacce» (6,9).
Dopo aver parlato degli schiavi, Paolo deve per forza concludere che se anche tutti questi valori e principi non si realizzano, resta comunque il fatto che la battaglia da intraprendere non è politica ma solo religiosa (6,12), non è terrena ma celeste, non è materiale ma spirituale. Su questo bisogna essere chiari, anche a costo di finire in galera come lui.10
*
Tecnicamente bisogna dire alcune cose sulla lettera.
È da escludere che Efeso sia l'unica destinataria della lettera, in quanto questa si presenta come un trattato dottrinale e, nello stesso tempo, in maniera distaccata dalla vita concreta di una comunità specifica, al punto che si ha l'impressione che il suo autore non conosca i lettori o almeno non abbia di loro una conoscenza diretta (eppure Paolo aveva lavorato per tre anni a Efeso e proprio qui verrà fatta la raccolta delle sue lettere).
Gli esegeti più accreditati sono convinti che la lettera sia stata pesantemente manomessa da discepoli di Paolo, successivamente alla sua morte, o che addirittura tali discepoli l'abbiano prodotta autonomamente, sulla base del corpus paolino. Le critiche relative alla sua autenticità sono iniziate nel 1826 con De Wette e con Schleiermacher nel 1829. L'osservazione più importante è quella che rileva come l'appellativo di «apostoli» venga usato come una categoria già tramontata, cui lo stesso autore della lettera non apparterrebbe.
(torna su)7) Lettera ai Filippesi
Nella lettera ai Filippesi,11 scritta per ringraziare la comunità d'averlo aiutato materialmente, Paolo esordisce vantandosi d'aver diffuso il vangelo ovunque, anche a prezzo del carcere,12 e che anzi, proprio in virtù delle offese subite, s'è notevolmente ampliata la conoscenza della sua teoria fondamentale, quella del Cristo risorto, al punto ch'essa viene propagandata anche da chi cristiano non è, semplicemente per sfruttare un argomento ormai divenuto di moda (il che probabilmente doveva aver creato una certa confusione tra la gente, un certo imbarazzo tra le comunità cristiane).
Tuttavia Paolo sostiene d'essere del tutto indifferente all'uso strumentale che fanno delle sue idee, le quali evidentemente suscitavano un certo interesse. Sembra di sentire un anchorman dei media contemporanei: «dite quello che vi pare, purché lo diciate».
Solo che qui si ha a che fare con un apostolo seguace di un'idea teologica ambiziosa, diffusa come se fosse un'ideologia politica; ed è un individuo convinto che le persecuzioni, le torture, le minacce di morte, le prigionie e tutte le calunnie che possono offenderlo, non fanno che accrescere il suo prestigio di predicatore.
Un predicatore fermissimo nei suoi propositi, inamovibile nei suoi principi. «Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (1,21). Non c'è da scherzare. Paolo non sta predicando qualcosa per acquisire un potere, politico o economico, ma anzitutto per diffondere le proprie idee, per le quali non cerca compromessi con le autorità costituite.
Ed è talmente convinto d'essere nel giusto che è disposto anche a morire di morte violenta, anzi è convinto che una morte del genere agevolerebbe di molto la diffusione del suo vangelo. Sa bene infatti che il martirio uccide le persone ma fortifica le idee, crea dei miti che durano nel tempo.
In tal senso mostra di essere un po' travagliato: non sa se sia già giunto il momento di spingersi nella predicazione sino al punto di dover accettare il martirio, o se sia meglio attendere questo momento, preoccupandosi di sostenere ancora le comunità create, aiutandole nelle loro difficoltà di crescita.
Se dipendesse esclusivamente da lui, non avrebbe dubbi sulla strada da prendere, visto che è impossibile parlare di «liberazione politica», e che anzi forse proprio il martirio potrebbe rappresentare il modo migliore di fare politica senza farla. In un'epoca di dittatura imperiale è facile dimostrare la giustezza delle proprie idee, accettando serenamente il sacrificio della vita. Il martire ha sempre ragione, almeno in apparenza.
Tuttavia Paolo non vuole cercare una fine a tutti i costi. Sa bene che «se anche desse il proprio corpo a bruciare ma non avesse la carità sarebbe un bronzo che risuona» (1 Cor 13,1 ss.). Soprattutto non vuol farlo contro le esigenze delle comunità che ha fondato e che potrebbero ancora aver bisogno di lui.
Inoltre vuole evitare il rischio che uno cerchi il martirio facendo di questo un motivo di vanto personale. Ciò sarebbe in contraddizione col modello di Cristo ch'egli da tempo è andato predicando, di tipo kenotico, cioè quello secondo cui un uomo, pur essendo dio, s'è comportato come «umile servo», accettando persino di morire per gli uomini.
A dir il vero qui Paolo non spiega il perché di questo abbassamento esistenziale del Cristo. Nella lettera ai Romani aveva detto che il motivo stava nella maledizione conseguente al peccato originale, in cui tutta l'umanità era piombata, senza poterne più uscire.
Qui invece il motivo sembra essere più etico che teologico: Cristo è morto in croce semplicemente per insegnare agli uomini il valore dell'umiltà, della modestia, un valore che, se venisse accolto dal mondo intero - fa capire Paolo -, non esisterebbero più dittature, guerre, oppressioni...
L'umiltà è infatti un valore etico universale, che tutti dovrebbero imparare, «in cielo, in terra e sotto terra» (2,10), appunto sul modello del Cristo, che pur essendo dio ha accettato di morire in croce.
Paolo ovviamente non può rendersi conto di quanto sia politicamente astratto questo discorso, non può sapere che un discorso di alto contenuto etico può risultare del tutto insufficiente sul piano politico; non può sapere che quando gli imperatori romani, tre secoli dopo, cominceranno ad accettare le sue teorie etico-religiose, l'oppressione indosserà la veste politica proprio della sua teologia.
Per ora l'umiltà del Cristo risorto è il suo modello di vita ed egli, che non ha mai rinunciato completamente alla politica, vorrebbe che tutti, anche i potenti, riconoscessero questo ideale di vita: «nel nome di Gesù ogni ginocchio si deve piegare... ogni lingua deve proclamare che è il Signore» (2,10 s.). L'ideale politico di Paolo non è la liberazione degli oppressi, ma che tutti confessino che Gesù è il figlio di dio: il resto verrà da sé.
Paolo è un uomo politicamente pessimista: gli uomini - scrive - sono «perversi e malvagi» (2,15). Si salvano soltanto i suoi seguaci, che devono limitarsi a resistere all'assedio dell'oppressione, sino a «quando Cristo verrà» (2,16). L'idea di resurrezione implica necessariamente quella di parusia trionfale, di giudizio universale ecc.
E tra i suoi seguaci Paolo, in maniera un po' sorprendente, annovera il solo Timoteo come il più fidato: «nessuno come lui condivide il mio modo di vedere» (2,20); «tutti gli altri purtroppo cercano i propri interessi» (2,21). Poi cita anche, benevolmente, Epafrodito, incaricato dagli stessi Filippesi di portargli alcuni aiuti economici.
Nella seconda parte della lettera Paolo mette in guardia la comunità dall'ascoltare quegli israeliti, definiti col termine forte di «cani»13, che pur dicendosi «cristiani», «minacciano la fede col legalismo della circoncisione» (3,2), impedendo così ch'essa si diffonda agevolmente tra i pagani. Ancora evidentemente Paolo non vuole servirsi dello strumento della scomunica per togliere di mezzo questi «falsi missionari», e preferisce affidarsi all'intelligenza dei suoi seguaci. D'altra parte in queste comunità ancora non esiste una gerarchia ecclesiastica vera e propria.
Quanto a lui, egli non riesce proprio a vedersi morire di vecchiaia. Conclude la lettera così come l'aveva iniziata: «non sono ancora arrivato al traguardo, non sono ancora perfetto» (3,12). Il traguardo che assicura la perfezione è per lui uno solo: il martirio.
È difficile non vedere in questa posizione un certo «fanatismo religioso», analogo a quello di talune frange dell’attuale fondamentalismo islamico, che vogliono riscattarsi dall'oppressione del mondo occidentale e di Israele. La differenza, di non poco conto, è che Paolo non voleva diventare martire in un'azione suicida, ma predicando senza sosta in tutto il mondo. E quando gli ebrei lo minacciavano di morte, egli, in quanto cittadino romano, s'appellava sempre ai tribunali dell'impero.
Voleva infatti che il martirio gli venisse dato dalle stesse autorità romane, in modo che servisse, agli occhi dei suoi seguaci più significativi, quelli cioè provenienti dal mondo pagano, come testimonianza eloquente della verità della sua missione. Di «eloquente» però in questa lettera, che è stata sicuramente scritta da più mani, c'è solo la chiusa, là dove scrive: «vi salutano tutti i fratelli che sono con me, specialmente quelli che lavorano alle dipendenze dell'imperatore romano» (4,21).
(torna su)8) Lettera a Filemone
Filemone, chi era costui? Pur essendo un illustre sconosciuto del Nuovo Testamento, non c'è stato nome che la storiografia ateistica di tutti i tempi abbia usato più del suo, allo scopo di dimostrare che il cristianesimo primitivo parteggiava per lo schiavismo o comunque non era in grado di fare alcunché di sostanziale per superarlo.
Oggetto della lettera di accompagnamento e di raccomandazione, dal contenuto molto personale (cosa che nell'antichità sollevò qualche dubbio sulla sua canonicità), è la fuga di uno schiavo di nome Onesimo dalla casa di Filemone, un facoltoso cristiano di Colosse, convertito alla fede da Paolo.
Quest'ultimo avrebbe incontrato per la prima volta Onesimo mentre era in prigione a Efeso (ma non si è certi di questa località) e con la lettera avrebbe invitato Filemone a perdonargli la fuga e, visto che lo schiavo nel frattempo si era cristianizzato, a riprenderlo addirittura come se fosse un «fratello», un «amico».
Da notare che esortazioni ad assumere atteggiamenti benevoli, tolleranti, rivolte sia agli schiavi che agli schiavisti, erano già state fatte da Paolo in due lettere precedenti: Col 3,22-4,1 e Ef 6,5-9.
Nel saluto iniziale Filemone non viene considerato come un «compagno di lotta», al pari del figlio Archippo, che addirittura era responsabile della comunità colossese, ma semplicemente come un «compagno di lavoro» (v. 1), cioè un «cooperatore», un collaboratore esterno, che metteva a disposizione la sua abitazione, le sue risorse ma non il suo tempo o la sua persona.
Filemone, la cui moglie era probabilmente la stessa Affia che Paolo qualifica come «sorella», è un buon uomo, un grande lavoratore, uno - diremmo oggi - che s'è fatto da sé, uno che non s'accontenta di quel che ha, ma vuole espandere la propria attività e, per tale ragione, ha bisogno di schiavi che lavorino per lui (benché qui si parli soltanto di uno di loro).
Ma se era così «buono», così «cristiano», perché Onesimo era scappato? Dalla lettera non si capisce. Paolo si limita a dire d'averlo incontrato in prigione e di averlo convertito. Forse Onesimo aveva pensato che stare presso colui che aveva convertito al cristianesimo il suo padrone gli avrebbe dato qualche sicurezza in più: in fondo il diritto di asilo veniva offerto anche da certi templi famosi, come p.es. quello efesino di Artemide.
Una cosa sola di Onesimo si sa con certezza: prima era fuggito come schiavo pagano, ora chiede di ritornare come schiavo cristiano, nella speranza, visto che lo stesso Filemone è cristiano, di essere trattato assai meglio di uno schiavo.
Paolo fa diversi giri di parole, dicendo una cosa e poi il suo contrario, per cercare di convincere Filemone a riprenderselo.
Anzitutto gli fa notare che potrebbe ordinarglielo (moralmente s'intende), in quanto Filemone appartiene a una comunità il cui fondatore è stato lo stesso Paolo. Quindi un certo riconoscimento istituzionale glielo deve.
Tuttavia Paolo gli chiede di riprenderlo spontaneamente, in nome dell'amore, anche per rassicurare Onesimo sul suo destino di schiavo pentito. Se Filemone lo accetta liberamente, non avrà motivo di rammaricarsi di non aver proceduto per vie legali.
La terza motivazione della richiesta è quella di riprendere Onesimo come segno di benevolenza, di riconoscimento morale nei confronti di Paolo, «vecchio e prigioniero» (v. 9).
La quarta è la motivazione economica, detta in tono ironico: Onesimo, che significa «vantaggioso», può tornare di nuovo «utile» al suo proprietario, e questa volta per sempre. «Si è allontanato per breve tempo, affinché tu lo riavessi per sempre» (v. 15), gli dice appellandosi a misteriose quanto divine leggi della provvidenza.
La quinta è ideologica: tra schiavo e schiavista non vi possono più essere contrasti culturali, religiosi, avendo entrambi la stessa fede cristiana. Anzi, proprio per il fatto d'essersi convertito e d'aver accettato di collaborare con Paolo, Onesimo viene considerato come una sorta di «discepolo», sicché con la sua reintegrazione nella precedente attività lavorativa non si può ora non tener conto di questa novità.
Onesimo è diventato cristiano come Filemone, cioè uno schiavo è diventato cristiano dopo il suo schiavista: è un successo incredibile per il cristianesimo paolino. Se non fosse stato in carcere, probabilmente Paolo l'avrebbe tenuto con sé, utilizzandolo come esempio paradigmatico della capacità persuasiva della nuova concezione di vita, a questo punto fruibile non solo dai ceti benestanti ma anche da quelli meno abbienti, anzi addirittura dagli schiavi.
Paolo arriva persino a proporre una soluzione finanziaria, secondo cui se Onesimo ha rubato qualcosa, sarà lui stesso a risarcire la perdita (il «se» dubitativo qui è un po' pleonastico, poiché come minimo Onesimo era venuto meno a una prestazione gratuita di manodopera, cui per legge era tenuto); poi però Paolo, rendendosi conto della esagerazione appena detta, fa capire, senza tanti giri di parole, che Filemone gli deve la sua stessa vita, essendo divenuto «cristiano» proprio grazie a lui. Come se il suo cristianesimo l'avesse salvato da sicura morte spirituale!
Da un lato lo supplica, dall'altro pretende di sapere che non rifiuterà il favore (quello di riprendesi Onesimo senza punirlo), anche perché gli prospetta l'esigenza di dover ospitare lui stesso, prossimo a uscire dal carcere. Sembra qui di assistere, in anteprima, a quella prassi, così tipica nella chiesa cattolica, nonché di tante organizzazioni di potere, basata sui «favori personali e reciproci», che non si possono negare proprio esiste un vincolo di dipendenza gerarchica.
La procedura altalenante delle motivazioni ha fatto pensare non pochi critici a successive manipolazioni della missiva: a frasi toccanti, infatti, quasi commoventi ne seguono altre, stranamente, di velata minaccia, di pseudo ricatti morali. Evidentemente Paolo, che qui sembra arrampicarsi sugli specchi pur di veder esaudita la propria richiesta, temeva che due righe non sarebbero bastate per impedire delle ritorsioni a carico di Onesimo, che quella volta peraltro cadevano puntuali sulla testa degli schiavi fuggitivi.
Proprio nel periodo in cui Paolo scriveva il biglietto a Filemone, a Roma, stando al racconto di Tacito (Annali, 14, 43), il prefetto Pedanio era stato assassinato da uno dei suoi schiavi e il colpevole era stato scoperto; ma la legge dichiarava tutta la famiglia degli schiavi responsabile del delitto e così tutti i 400 schiavi di Pedanio, uomini, donne e bambini, furono crocifissi per colpa di uno solo di essi.
In ogni caso, a parte il suo valore indiscutibilmente umanitario, la lettera paolina ha l'apparenza di una vera e propria favola, dove tutti alla fine vivranno felici e contenti.
Da un lato viene chiesto a Filemone d'essere spontaneo e di riprendersi con convinzione e piena libertà il suo schiavo, accettandone altresì la sua conversione.
Dall'altro viene chiesto a Onesimo di ritornare spontaneamente dal suo padrone a fare di nuovo lo schiavo, nella convinzione che, divenuto ora cristiano, sarebbe stato trattato meglio. Indirettamente quindi Paolo fa capire al lettore che Filemone, pur essendo cristiano, non si sentiva in dovere di trattare umanamente gli schiavi di religione pagana.
Paolo insomma presenta Onesimo come un ottimo elemento, sia come uomo che come credente (lo dice testualmente al v. 16), eppure gli chiede di tornare a fare lo schiavo, benché nel contempo preghi Filemone di non considerarlo più come uno schiavo, appunto perché ora, essendosi convertito, è pari a un «fratello» nella fede. E infatti ritroviamo Onesimo a fianco di Tichico in Col 4,9, presso la comunità di Colosse, da dove era partito per andare a trovare Paolo una seconda volta.
Dunque Filemone cosa avrebbe dovuto fare? Liberare Onesimo dalla schiavitù? Considerarlo come un amico, un collaboratore domestico, un socio in affari, come se fosse lo stesso Paolo in persona? Filemone accetterà forse i buoni consigli, le perorazioni, i suggerimenti di Paolo, facendo un'eccezione alla regola della schiavitù e permettendo così a Paolo di trasformare un caso eccezionale in una regola universale?
Paolo offre qui un chiaro esempio di cosa voglia dire realizzare dei rapporti personali col potere (qui non di tipo politico ma solo sociale), soprassedendo ai rapporti oggettivi di sfruttamento economico. Per lui la schiavitù è solo una questione interiore, di coscienza, e non (anche) uno stato fisico, una condizione materiale di esistenza.
È fuor di dubbio tuttavia che il tentativo paolino di cristianizzare i rapporti tra padroni e schiavi contribuirà in qualche maniera al superamento del rapporto mercificato tra i due soggetti in una forma di dipendenza più vicina al servaggio, in cui l'uno riconoscerà all'altro maggiore dignità umana, pur continuando a negargli la libertà personale. L'uguaglianza sociale, pratica, è infatti possibile, secondo il cristianesimo, solo in un ordine sovratemporale o soprannaturale.
Si può qui concludere facendo il richiamo di rito alle due lettere che Plinio il Giovane (Lettere, IX, 21 e 24) spedì, nel 106-7 d.C., all'amico Sabiniano, il quale, avendo anch'egli avuto un liberto fuggiasco, veniva pregato di riprenderlo senza infierire. Il liberto infatti, giovane e inesperto, era andato da Plinio per essere rimandato da lui al padrone con garanzia di tutela. Plinio accondiscese e nella seconda lettera ringraziò Sabiniano per la clemenza usata verso il fuggitivo.
Inutile qui dire che mentre nella lettera paolina è esplicita l'uguaglianza morale di fronte a dio del padrone col suo schiavo, in quelle di Plinio il perdono dell'offesa viene concesso partenalisticamente da un padre-padrone che non avrebbe mai considerato lo schiavo moralmente uguale a lui.
(torna su)9) Prima lettera a Timoteo
Informazioni su Timoteo
Timoteo, considerato come il migliore interprete del pensiero di Paolo, entra in scena, stando alle sole fonti del N.T., nel corso del secondo viaggio dell'apostolo. Era nato a Listra da padre pagano e da madre giudea, aveva ricevuto un'educazione ebraica sia dalla madre che dalla nonna, ed era stato convertito al cristianesimo forse da Paolo stesso, fin dal primo soggiorno dell'apostolo proprio a Listra, quindi già durante il primo viaggio.
Pur avendo un carattere timido e pur essendo molto giovane, Timoteo godeva già di larga stima tra i cristiani della Licaonia, perciò Paolo, ripassando da Listra, durante il suo secondo viaggio, decide di prenderselo come collaboratore e, fattolo circoncidere, perché potesse predicare liberamente tra le comunità ebraiche di quella regione, si dirige con lui alla volta delle province d'Asia e di Macedonia.
Timoteo condivide quindi con Paolo le fatiche della fondazione delle comunità di Filippi e di Tessalonica. Da qui egli raggiunge Berea, dove si trattiene anche al momento della partenza di Paolo, ma i due si ritrovano ben presto ad Atene, da dove poi Timoteo viene inviato, in compagnia di Sila, a Tessalonica, per rafforzare quella comunità, dopodiché raggiunge Paolo a Corinto.
Ritroviamo Timoteo nel terzo viaggio di Paolo, ad Efeso, e un anno più tardi di nuovo in Macedonia e a Corinto: qui egli è testimone della stesura della lettera ai Romani.
Nel viaggio di ritorno accompagna ancora Paolo, rivede la Macedonia, Troade e Mileto e probabilmente segue Paolo sino a Gerusalemme.
Qui però gli Atti lo perdono di vista: l'assenza si nota soprattutto durante i fatti che portano all'arresto di Paolo, alla prigionia di Cesarea e alla traversata del Mediterraneo verso Roma.
Tuttavia, nel corso della prigionia romana di Paolo ritroviamo Timoteo in sua compagnia.
Dalla I lettera si evince che Timoteo è a capo della comunità di Efeso (episcopo?). Paolo lo invita a recarsi a Roma, portandogli, prima dell'inverno (dell'anno 56-57), il suo mantello e i suoi libri e pergamene rimasti presso Carpo. Lo farà dopo essere stato liberato da una prigionia, di cui però non si sa nulla.
Stando agli apocrifi Timoteo assiste alla morte di Paolo, dopodiché torna ad Efeso, dove muore martire nel 97. Una certa esegesi vede in lui «l'angelo della chiesa di Efeso» che nell'Apocalisse (12,1-6) lotta contro i Nicolaiti.
I riferimenti biblici che lo riguardano, direttamente o indirettamente, sono i seguenti: oltre ovviamente alle due lettere, Atti 14,6-20; 16,1-3; 17,14-15; 18,5; 19,22; 20,4; 1-2 Tess 1,1; 1 Tess 3,2-6; Fil 1,1; Col 1,1; Rm 16,21; 1 Cor 4,17; 16,10-11; 2 Cor 1,1; Ebr 13,23, Filem 1.
*
Se il vero ebraismo fosse stato solo quello politico-rivoluzionario, volto a lottare contro Roma, la predicazione di Paolo non avrebbe probabilmente avuto molto successo.
Il fatto è che l'ebraismo era molto composito e là dove non si poneva in modo rivoluzionario, era ormai il fantasma di se stesso, soprattutto quando pretendeva di parlare di «liberazione» semplicemente restando legato alla «tradizione», anzi, se possibile, facendo di questa tradizione un qualcosa di assolutamente invivibile (com'era il caso della posizione farisaica).
Nella prima lettera a Timoteo (una delle tre dette, a partire dal XVIII sec., «Pastorali», perché indirizzate a responsabili di comunità), Paolo, che scrive dalla Macedonia, lo dice subito al suo discepolo prediletto: «Ti raccomandai di rimanere in Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili...» (1,3 s.).
Paolo si riferisce chiaramente ai cristiani di origine ebraica della comunità di Efeso, ma non è da escludere che, stigmatizzando un certo comportamento pseudo-intellettuale, cavilloso e pedante, egli considerasse negativamente anche molti contenuti della vecchia predicazione ebraica, qui paragonati ai miti e alle leggende del paganesimo, o a certe assurdità della neonata filosofia gnostica, ch'egli, o un successivo redattore, rigetta completamente (6,20).
Egli si vantava di predicare una dottrina molto diversa da quelle di origine pagana ed ebraica, eppure noi sappiamo che buona parte dei temi paolini si ritrovano sia nel paganesimo che nell'ebraismo (vedi p.es. i cataloghi di doveri e di vizi elencati in questa lettera, coincidenti per buona parte con analoghe enumerazioni in uso presso i filosofi ellenistici). Dunque dove stava la sua originalità?
Stava nella sintesi, cioè nella capacità sincretica di unire le due culture fondandone una nuova: una cultura favorevole sia all'uguaglianza morale degli uomini di fronte a dio che alla separazione di Stato e chiesa; una cultura che sosteneva la resurrezione del figlio di dio e quindi la rinuncia al politeismo, a ogni altro monoteismo che non fosse quello cristiano e soprattutto a qualunque forma di divinizzazione imperiale; una cultura che predicava la redenzione dei peccati, mettendo l'amore al primo posto nella scala dei valori della comunità.
A Timoteo chiede espressamente di non far nulla per cambiare la situazione esistente, ma semplicemente di dimostrare ai potenti che la comunità cristiana è un'associazione religiosa, non politica, una comunità che vuole vivere in pace con tutti, pur in presenza dello schiavismo e dei conflitti sociali (2,1 s.).
Cristo è morto per salvare tutti - ribadisce Paolo a Timoteo - e quando verrà la fine dei tempi (parusia) gli uomini saranno tutti salvati. Infatti, se Cristo, che era «dio», non è riuscito a compiere la liberazione del suo paese dal dominio straniero e dal collaborazionismo interno, significa che non era questo il suo obiettivo. La liberazione dalle ingiustizie, dalla oppressione è un obiettivo non di questo tempo, non di questo mondo.
Rinunciando alla liberazione politica, terrena, materiale, sociale..., Paolo si è sentito costretto a elaborare una teoria che, per essere convincente, doveva apparire di grande spessore etico-religioso.
Ed eccola formulata nella maniera più sintetica possibile: «uno solo è Dio e uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini: l'uomo Gesù Cristo. Egli ha dato la sua vita come prezzo del riscatto di tutti noi. A questo modo, nel tempo stabilito, egli ha dato la prova che Dio vuol salvare tutti gli uomini» (2,5 ss.).
Qui non ci sono tanti «se» e tanti «ma». Tutti i politeismi e tutti i monoteismi diversi dal cristianesimo sono falsi; tutti i mediatori assoluti tra dio e gli uomini, che non siano Gesù Cristo, sono falsi. Paolo stesso non si concepisce come «mediatore», ma come «messaggero» e «apostolo».
La frase centrale di tutta la teologia paolina è la seguente: «Cristo ha dato la sua vita come prezzo del riscatto degli uomini» (2,6). Gli uomini infatti erano condannati al male, avendo rotto la comunione con dio sin dai tempi del peccato originale: una rottura, questa, nei cui confronti tutta l'umanità non ha mai saputo porre rimedio, a testimonianza del fatto che quella colpa primordiale ha provocato guasti irreparabili relativamente alla capacità umana di compiere il bene.
Cioè in sostanza Paolo vuol dire che gli uomini non sono in grado di eliminare lo schiavismo imperante, l'oppressione delle minoranze, delle etnie, delle popolazioni da parte dei potentati economici e politici. L'umanità non è più capace da sola di tornare al periodo d'oro del comunismo primitivo.
Dio dunque è stato indotto a mandare sulla terra il figlio per far comprendere agli uomini che tutte le loro sofferenze sono soltanto temporanee, una sorta di prova da superare con pazienza, nell'attesa della loro risoluzione finale.
La liberazione non è di questo mondo, ma soltanto la consapevolezza d'una salvezza generale, universale, nell'aldilà. Con l'autosacrificio di Cristo gli uomini possono convincersi che la punizione conseguente al peccato d'origine non è definitiva, non è irrimediabile. Esiste ancora una speranza, seppure ultraterrena.
Qui Paolo parla di «Cristo uomo», ma è evidente ch'egli intende un uomo-dio, una natura divino-umana in senso proprio, e non semplicemente figurato (si è «manifestato come uomo», 3,16, ma era molto più di un uomo, altrimenti la resurrezione - che Paolo ha sempre considerato come un fatto incontrovertibile - non sarebbe stata possibile). Infatti solo lui è «mediatore» tra dio e gli uomini.
Cristo non si è sacrificato semplicemente per dare una speranza di vita al concetto di «bene», cioè per dimostrare che pur in mezzo a tanti orrori è sempre possibile un gesto di grande bontà. Cristo non è semplicemente un giusto che accetta il martirio, per insegnare agli uomini dei valori positivi, umani.
Nella teologia di Paolo Cristo si è sacrificato per dare a tutti gli uomini la certezza della loro salvezza, una salvezza che, beninteso, sino alla fine dei tempi resterà meramente interiore, come una sorta di consapevolezza morale e intellettuale da difendere contro lo scetticismo aprioristico e l'indifferenza per le sorti dell'umanità, e che al momento della parusia si esplicherà in tutta la sua evidenza concreta.
Quando ciò avverrà non è possibile saperlo. Come nessuno ha potuto sapere in anticipo il momento dell'arrivo del «mediatore», così «al tempo stabilito la sua apparizione [epifania] sarà decisa da Dio» (6,15).
Gli uomini non possono far nulla nei confronti del tempo; possono solo attendere con pazienza che tutto si compia. Il modo in cui devono vivere è quello in un certo senso della rassegnazione, ma non alla maniera stoica, cioè individualistica, distaccata dai problemi della vita; la rassegnazione cristiana è «comunitaria», in quanto basata sull'amore reciproco nella comune attesa: è una rassegnazione nei confronti della terra, mista a una speranza nei confronti del cielo.
Stranamente qui Paolo pone alle donne un compito di maggiore «passività» rispetto agli uomini (2,9-15), come se le donne fossero maggiormente responsabili dei mali del mondo. Un uomo come lui, che ha rotto tutte le barriere ideologiche tra paganesimo ed ebraismo, si formalizza di fronte a quelle di genere e fa professione di aperto maschilismo giudaico. Ma è molto probabile che qui si tratti di aggiunte redazionali successive da parte di certi ambienti clericali o misogini. Anche perché la proibizione alla donna di prendere la parola a qualunque titolo, in luoghi pubblici, è palesemente in contraddizione con lo spirito egualitario dei sessi presente nei vangeli; lo stesso Paolo, nella lettera ai Romani, fa risalire ad Adamo lo stato di colpevolezza dell'umanità (5,12).
Infatti se si toglie tutto il brano e si collega 2,7 a 3,1 il testo non perde di coerenza, anzi ne guadagna. Infatti al cap. 3 Paolo dice che «se qualcuno desidera avere un compito di pastore nella comunità, desidera una cosa seria» (3,1), cioè deve avere tutte quelle qualità morali che lo rendono moralmente irreprensibile e capace anche di «insegnare». Queste qualità devono poter essere riscontrate nel modo come si vivono i legami familiari e devono poter essere riconosciute anche da chi non è cristiano. Non dice che queste qualità possono averle solo gli uomini.
Stesso discorso vale per i diaconi, che si pongono al servizio dei pastori. Parlando di questa categoria di «funzionari», Paolo dà per scontato che possano essere di entrambi i sessi. Peraltro in 3,11 egli si riferisce chiaramente alle «diaconesse».
Paolo chiede semplicemente, oltre alle consuete virtù morali, che i responsabili di comunità (vescovi, presbiteri, diaconi) abbiano «una sola moglie» (3,2.12), poiché evidentemente vi erano casi di poligamia nelle primitive comunità cristiane (è da presumere negli strati sociali più elevati di provenienza pagana). A tale proposito va esclusa a priori l'interpretazione di quegli esegeti cattolici che qui vedono il divieto di risposarsi dopo la vedovanza, al fine di giustificare la successiva disposizione medievale sull'obbligatorietà del celibato per il clero.
Il contrario dei buoni pastori e dei buoni diaconi sono i «maestri d'inganno» (4,1), che insegnano un'etica fine a se stessa, il sacrificio per il sacrificio: vietando p.es. il matrimonio o certi cibi (4,3). Paolo condanna qui le pratiche ascetiche individualistiche, i falsi rigorismi morali, gli eccessi di privazione con cui qualcuno s'illude di potersi salvare, di poter essere diverso dagli altri. In realtà - egli precisa con grande buon senso - «tutto ciò che è stato creato da Dio è buono: non c'è niente da scartare» (4,4).
Cioè il male non viene dalle cose in sé, ma dall'uso che se ne fa e se, mentre le si usa, si «ringrazia Dio» (4,5), l'atteggiamento sarà sicuramente migliore di quello che condanna talune cose solo per timore che se ne possa abusare. Insomma contro lo schematismo meglio la flessibilità, contro il massimalismo meglio la dialettica.
Paolo stesso, quando fece circoncidere Timoteo perché potesse predicare liberamente presso i propri connazionali giudei, fu accusato di opportunismo, essendo un punto forte delle sue tesi proprio l'inutilità della circoncisione ai fini della salvezza personale. In realtà si trattava di un semplice compromesso, cui Paolo si sentiva costretto proprio a motivo del fatto che nella fase iniziale della sua predicazione egli non aveva ancora rotto definitivamente i ponti col giudaismo, e nel confronto dialettico con queste comunità inevitabilmente egli si sentiva in una posizione del tutto minoritaria.
«Ringraziare Dio» vuol dire «amarlo» (4,8). «Allenare il corpo serve a poco; amare Dio, invece, serve a tutto» (ib.). Se alla parola «dio» sostituissimo, a seconda dei casi, la parola «natura», «uomo», «oppresso», «comunità», le espressioni di Paolo potrebbero trovare un loro senso anche per l'oggi. In fondo egli predicava la fiducia in una forma d'esistenza che avrebbe dovuto essere migliore di quella dominante nella società del suo tempo, basata sullo schiavismo.
Il fatto che oggi diciamo che quella fiducia era mal riposta, in quanto l'esistenza religiosa non è stata in grado di risolvere alcun problema della società schiavile, non deve farci dimenticare che a questa convinzione siamo arrivati dopo secoli di progresso intellettuale e morale, attraverso i quali si è finalmente capito, grazie soprattutto al socialismo, che la «liberazione sociale» non va relegata a una dimensione ultraterrena.
C'è da dire che Paolo aveva inventato un'originale sintesi di paganesimo ed ebraismo: non poteva certo immaginare che una così alta teoria etico-religiosa sarebbe stata strumentalizzata per i peggiori abusi della storia.
Se in questa lettera avesse parlato come Socrate o come Seneca, ognuno di noi avrebbe potuto facilmente riconoscersi nelle sue parole; qui tuttavia abbiamo a che fare non tanto con un filosofo isolato, individualista, ma con il capo di un movimento popolare, che aveva saputo dare alla propria predicazione un taglio «sociale», per quanto illusorio oggi ci possa sembrare nelle sue finalità.
Basta leggersi le raccomandazioni che rivolge a Timoteo circa il comportamento da tenere nei confronti delle «vedove» (5,3 ss.): sono altamente umanitarie, non sempre riscontrabili, persino oggi, negli ambienti cristiani e non cristiani. «I figli o nipoti bisogna che imparino a mettere in pratica la loro fede prima di tutto verso le persone della propria famiglia» (5,4). «Se qualcuno non si prende cura dei suoi parenti, specialmente di quelli della sua famiglia, costui ha già tradito la sua fede ed è peggiore di uno che non crede» (5,8). La comunità avrebbe aiutato - qui si anticipa una sorta di «previdenza sociale» - le vedove assolutamente sole e oltre i 60 anni.
Relativamente ai responsabili di comunità, si ha l'impressione che Paolo voglia lasciar credere che possa esistere un mestiere da «intellettuale» separato da quello «manuale». «I responsabili che governano bene la comunità meritano doppia ricompensa, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento» (5,17). O qui si tratta di categorie di persone «anziane», ovviamente con funzioni ecclesiali, che da giovani avevano già svolto lavori manuali, oppure è dubbio che Paolo possa aver detto una cosa del genere.
Certamente lui si sentiva un «professionista» della predicazione e dell'insegnamento, ma non considerò mai questo come una condizione per pretendere privilegi da parte della comunità: infatti non s'è mai sottratto ai lavori manuali e disse esplicitamente che «chi non lavorava non aveva il diritto di mangiare» (2 Ts 3,10).
Tuttavia è fuor di dubbio che all'interno di una comunità è la comunità stessa che decide, unanimemente, come regolarsi nei confronti dei propri responsabili. Se Paolo parla di «doppia ricompensa», cioè di un particolare salario, significa o che i responsabili si erano lamentati di non avere sufficienti mezzi per predicare e insegnare, o che qualcuno aveva messo in dubbio la loro onestà o la loro utilità sociale per la comunità. Se è vera la seconda ipotesi, allora si spiega il motivo per cui Paolo chieda a Timoteo di «non ascoltare accuse contro un responsabile se non sono confermate da due o tre testimoni» (5,19).
La collegialità, nelle decisioni, è fondamentale quando si vive un'esperienza comunitaria. In ogni caso - prosegue Paolo - se davvero «qualcuno ha commesso una colpa, rimproveralo pubblicamente, in modo che anche gli altri ne abbiano timore... senza fare preferenze per nessuno» (5,20-21). Per «colpa» qui si deve intendere qualcosa di grave, di compromettente il sereno andamento della comunità. Colpe del genere, se non si vogliono spezzare i legami comunitari, vanno individuate in tempo, pubblicamente biasimate e chi le ha compiute deve essere disposto a fare autocritica.
Per cercare di evitare il più possibile tali incresciosi incidenti, è bene - dice Paolo - che i più responsabili o addirittura il leader della comunità - in questo caso lo stesso Timoteo - non abbia «fretta quando sceglie qualcuno per un incarico nella comunità» (5,22). La scelta dei leader giusti è la cosa più difficile, anche perché se «i peccati di certe persone si vedono chiaramente anche prima che siano condannate; i peccati di altre persone si scoprono soltanto dopo» (5,24).
Da notare che gli esegeti14 avversi all'autenticità delle tre lettere Pastorali si avvalgono del fatto ch'esse conoscono chiaramente la distinzione delle mansioni all'interno della comunità (episcopo - presbiteri - diaconi - vedove), in maniera del tutto inedita rispetto alle altre lettere e agli Atti, e ne concludono che le Pastorali non possono essere più antiche del II sec. e il loro scopo era proprio quello di appoggiare l'istituzione dell'episcopato monarchico contro la direzione collegiale dei presbiteri.
In questa obiezione ci può essere sicuramente un fondo di verità, anche a motivo del carattere frammentario dello stile delle lettere, che lascia presumere ulteriori interventi redazionali, ben visibili peraltro là dove dei circa 850 vocaboli usati nelle Pastorali, ben 130 sono del tutto sconosciuti alle altre lettere, e altri 170 sono hapax legomena, cioè nomi composti, i cui singoli elementi si trovano in tutto il N.T.
Tuttavia dalle Pastorali non si evince in maniera chiara che una direzione collegiale della comunità stava per essere sostituita da una verticistica e burocratica, meno che mai che la presunta monarchia episcopale avesse un carattere di rigida assolutezza.
Il concetto di «gerarchia» di per sé non costituisce un problema per la democrazia, se le cariche sono oggetto di approvazione collegiale. E nelle Pastorali non appare affatto che i dirigenti delle comunità paoline fossero persone «intoccabili». Anche quando, nel II sec., con Ignazio di Antiochia, noi vediamo una chiara distinzione dei tre gradi gerarchici (diaconi, presbiteri e vescovo), che lascia appunto supporre la presenza di un episcopato monarchico, quest'ultimo restava sempre soggetto a una disciplina del tutto collegiale nell'ambito dei sinodi e dei concili, ecumenici e non, almeno sino a quando non si vorrà affermare, in ambito cattolico-romano, la superiorità del papato sul concilio.
Quanto agli schiavi, Paolo ribadisce le sue note posizioni (cfr lettera a Filemone). «Quelli che si trovano a essere schiavi siano molto rispettosi verso i loro padroni [cioè non cerchino di opporvisi con la forza o di fuggire], perché nessuno possa bestemmiare il nome di Dio e parlar male della nostra fede» [dicendo cioè che gli schiavi cristiani sono più «ribelli» di quelli non cristiani]. «E se i padroni sono cristiani» [quindi l'obbedienza al padrone è dovuta a prescindere dalla fede di quest'ultimo], non possono loro mancare di rispetto, per il semplice fatto che sono fratelli nella fede» [cioè uno schiavo non deve approfittare della fede cristiana del proprio padrone per obbedirgli di meno]. «Anzi devono servirli ancor meglio, proprio perché compiono un servizio verso persone credenti e amate da Dio».
Così traduce, sbrigativamente, le ultime parole La Bibbia in lingua corrente (traduzione interconfessionale). In realtà la Bibbia di Gerusalemme dice: «perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi». Il che procura non pochi problemi interpretativi.15 Infatti, se chi elargisce i servizi sono gli schiavi, come in genere è, quelli che sono «fedeli e amati» dalla comunità devono per forza essere gli schiavisti cristiani. Sicché lo schiavo cristiano, se rispetta i propri padroni cristiani, rende un servizio ancora più grande alla comunità dei fedeli.
Qui non viene detto che uno schiavista cristiano che maltratta uno schiavo cristiano, non può dirsi propriamente «cristiano», o che lo schiavo cristiano è tenuto ad obbedire allo schiavista solo a condizione che questi sia davvero «cristiano», ma addirittura che uno schiavo cristiano deve prestare servizio con ancora più convinzione se il suo padrone è cristiano come lui, a prescindere dal fatto che nella pratica quest'ultimo lo sia veramente.
È incredibile che Paolo abbia scritto una cosa del genere. Anche perché nella Lettera a Filemone la posizione era molto più sfumata ed equilibrata. Sarebbe stato sufficiente scrivere che i padroni sono «credenti», senza bisogno di aggiungere che sono anche «amati» da dio. In 1Cor 7,21 veniva addirittura scritto: «Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventar libero, è meglio valerti dell'opportunità». In Ef 6,9 è chiesto esplicitamente agli schiavisti cristiani di non usare «minacce» nei confronti dei loro schiavi, specie se questi sono cristiani. Addirittura in Col 4,1, ricordando agli schiavisti che anche loro hanno «un padrone nel cielo», si chiede di dare agli schiavi «ciò che è giusto ed equo».
Viceversa Paolo nella lettera a Timoteo avrebbe chiesto a quest'ultimo di «insegnare e raccomandare» (6,2) che, dovendo scegliere tra il proprio interesse materiale (la libertà fisica) e quello spirituale (la libertà interiore), lo schiavo avrebbe dovuto preferire il secondo, in quanto la sua liberazione fisica sarebbe stata inutile: lo schiavista non avrebbe avuto bisogno di concederla proprio perché lo schiavo non avrebbe avuto bisogno di chiederla né, tanto meno, di pretenderla.
In nome di un idealismo assoluto ante litteram Paolo stava praticamente dicendo a Timoteo che lo schiavo e lo schiavista cristiani erano due persone interiormente libere, pur nella diversità dei ruoli sociali.
Poiché tuttavia qualcuno deve essersi accorto che, messe così, le «raccomandazioni» apparivano troppo penalizzanti per la sorte dello schiavo, per quanto cristiano fosse, s'è dovuto aggiungere una sorta di «codice per i ricchi», al fine di controbilanciare quello per gli schiavi.
Infatti se uno schiavo vuol diventare cristiano, non c'è problema: non sarà certo il cristianesimo paolino a liberarlo socialmente. Ma se vuole diventarlo uno schiavista, è bene che costui sappia alcune cose fondamentali circa il concetto di «ricchezza», altrimenti l'uguaglianza morale di fronte a dio, di schiavo e schiavista, rischia di trasformarsi in un'imperdonabile ingenuità, in un'insopportabile astrazione.
«Certo, la pietà [qui intesa come «religione»] è un grande guadagno, congiunta però a moderazione! Infatti non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori» (6, 6-11).
Qui non viene detto espressamente ma appare chiaro: 1. che al tempo della stesura di questa lettera vi erano già state conversioni e defezioni dalla fede cristiana da parte di esponenti di alto rango; 2. che la conversione di uno schiavista, che tale voleva restare, doveva essere guardata quanto meno con una certa perplessità.
A questo punto è impossibile non fare un paragone col racconto evangelico di quell'uomo ricco che chiese a Gesù cosa doveva fare per avere la vita eterna (Mc 10,17 ss.), ricevendo, per tutta risposta, l'invito a seguirlo come discepolo previa la vendita di tutti i propri beni. Cristo aveva bisogno di seguaci per fare la rivoluzione antiromana; Paolo si accontenta di seguaci che manifestino un minimo di onestà morale e intellettuale.
Qualche altro redattore si deve essere accorto che anche le parole di Paolo sulle ricchezze non erano sufficienti, per cui s'è sentito in dovere di aggiungerne altre, le quali però, ancora una volta, non fanno che ribadire i noti concetti moralistici della teologia paolina: «Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere; di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere generosi, mettendosi così da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (6,17 ss.).
Qui le parole sembrano rivolgersi ai ricchi già divenuti cristiani e che naturalmente volevano restare «ricchi». D'altra parte perché avrebbero dovuto rinunciare alle loro ricchezze, visto che «dio dà tutto in abbondanza» anche a chi non possiede altro che la fede?
(torna su)10) Seconda lettera a Timoteo
Stando alla tradizione la seconda lettera a Timoteo fu scritta da Paolo durante il secondo processo a Roma. La chiesa ha considerato questa lettera una sorta di «testamento spirituale», in quanto è l'ultima di Paolo, che prevede la sua fine imminente.
È rivolta al suo discepolo prediletto, cui Paolo riconosce sì la fede, ma, chissà perché, non può fare a meno di ricordargli ch'essa fu un po' tardiva, visto che prima di lui si convertirono la nonna Loide e la madre Eunice (1,5). Addirittura, dicendo «ne sono certo», Paolo lascia trapelare qualche dubbio sulla continuità della fede di Timoteo.
È una strana ouverture, questa di Paolo: sembra che tra i due siano passati molti anni in cui non si sono né visti né tenuti in contatto, al punto che Paolo sembra costretto a dirgli: «ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani» (1,6). Eppure tra la prima e la seconda lettera la critica sostiene non essere trascorso più di un anno.
Il verbo «ravvivare» sta a significare che Paolo non solo «temeva» ma «sapeva» bene che Timoteo non aveva più la fede di una volta, quella di quando Paolo svolgeva a pieno ritmo il suo apostolato. Infatti lo invita a non avere «uno spirito di timidezza» (1,7) e a «non vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore nostro» (1,8). Non deve vergognarsi neppure di Paolo, ora che è «in carcere per Cristo» (ib.).
Evidentemente Timoteo aveva avuto delle perplessità di fronte alle persecuzioni subite da Paolo. Questa seconda lettera è stata scritta più per sollecitare Timoteo a riprendere il cammino di un tempo, che per fare un testamento spirituale. E forse le successive manipolazioni stanno a indicare una prevalenza della tendenza giudaica in seno alla comunità cristiana di Efeso dopo la morte di Timoteo.
Per convincerlo a riacquistare fiducia in se stesso, Paolo gli ricorda, in maniera molto esplicita, come mai finora aveva fatto, che il vangelo secondo cui il Cristo ha salvato l'umanità a titolo gratuito, «non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia...», vincendo la morte, è il suo proprio vangelo, quello che solo lui ha capito per primo e di cui s'è fatto «araldo, apostolo e maestro» (1,9-11), tant'è che il suo discepolo prediletto non è nessuno degli apostoli o della loro cerchia e neppure nessuno del movimento nazareno, ma è Timoteo, un giovane per metà ebreo e per metà pagano.
Più avanti dirà a chiare lettere che «Gesù Cristo... è risorto dai morti, secondo il mio vangelo...» (2,8). Il che in sostanza voleva dire che l'interpretazione ch'egli aveva dato della tomba vuota si discostava da quella degli altri apostoli o comunque che solo lui aveva portato la tesi della resurrezione (di origine petrina) alle sue conseguenze più radicali, rompendo definitivamente i ponti con le tradizioni ebraiche del messianismo politico-nazionale.
E che questo suo vangelo sia vero lo dimostra il fatto - secondo Paolo - ch'esso è «causa dei mali» di cui egli soffre (1,12). Paolo dunque lo invita a soffrire insieme a lui, al fine di riacquistare fiducia in se stesso. Se si è perseguitati, sicuramente si è nel giusto, a condizione ovviamente di non aver compiuto nulla contro la legge.
Paolo infatti dice di soffrire «fino a portare le catene come un malfattore» (2,9), pur non avendo fatto altro che predicare la pace e l'amore universali. Da queste poche parole si arguisce ch'egli non si trovava nella condizione della custodia militaris, in una casa presa in affitto, come la prima volta (At 28,30), ma in quella della custodia publica, insieme ai delinquenti comuni.
La predicazione ha procurato a lui molte sofferenze: «tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati» (2,11 s.).
Stupisce che qui Paolo ricordi a Timoteo solo le persecuzioni occorsegli durante il primo viaggio missionario, cui il racconto degli Atti non associa la presenza diretta di Timoteo. Tuttavia qui Paolo vuol semplicemente dire che non essendo Timoteo un «perseguitato», la sua fede non è ancora sufficientemente sicura, combattiva, o non lo è più come un tempo.
La persecuzione, il martirio vengono spesso considerati da Paolo, specialmente nel suo ultimo periodo, come un indizio sicuro della verità della propria missione. In tal senso non si può non attribuirgli una certa dose di fanatismo ideologico (nel suo caso, di tipo «religioso»).
Egli dunque si sente in dovere di «scongiurare» Timoteo di annunciare la parola, di insistere in ogni occasione, opportuna e non opportuna, di ammonire, di rimproverare, di esortare con ogni magnanimità e dottrina (3,1 ss.). Secondo Paolo è proprio questa attività pubblica di incessante predicazione che il «mondo» non riesce a tollerare. «Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole» (4,3 s.).
Paolo qui sembra ricordare il dibattito che ebbe presso l'Acropoli ateniese, cui Timoteo fu testimone. Tutta la filosofia pagana viene paragonata alle «favole». Non ha il minimo dubbio che la sua interpretazione della tomba vuota sia l'unica possibile.
Egli è quasi convinto di dover morire, o forse addirittura lo desidera quando usa il termine sacrificale di «libagione», nella certezza di poter ottenere «la corona di giustizia» (4,8) dalle mani dello stesso Cristo.
Le ultime disposizioni però paiono in contrasto con la certezza di una morte imminente: chiede a Timoteo che lo raggiunga insieme a Marco (con cui aveva duramente litigato dopo l'incidente della Panfilia, in At 15,37 ss.), perché gli sarà utile «per il ministero» (4,11); gli chiede anche di portargli «il mantello» (4,13), per l'inverno imminente, e «i libri, soprattutto le pergamene» (ib.). Come noto infatti era stato arrestato a Troade, da dove era stato subito trasferito a Roma. Qui è come se non potesse escludere a priori, come già ad Antiochia, Iconio, Listri, una sua insperata liberazione.
Si lamenta che nella sua «prima difesa in tribunale» era stato abbandonato da tutti (4,16), ma chi siano questi «tutti» non si sa: discepoli o gente influente che avrebbero potuto aiutarlo? Noi in realtà non sappiamo nulla di certo sulla fine di Paolo. Se fosse davvero morto martire, perché Luca o un redattore successivo non ne ha parlato negli Atti? Nulla ci impedisce di credere che il biennio di prigionia romana si sia concluso con una sentenza a lui favorevole.
Paolo non incitava gli schiavi alla ribellione, non si opponeva all'esosità fiscale dello Stato, rispettava le leggi romane, e ai suoi tempi il culto divino da attribuire all'imperatore non era così tassativo, meno che mai per un ebreo. È solo sotto Domiziano (81-96) che la divinizzazione dell'imperatore diventa una pietra di paragone della lealtà civile e del patriottismo, nel senso che il crimine di «ateismo» (e i cristiani apparivano «atei» agli occhi dei politeisti) equivaleva a quello di «lesa maestà». Fino ad allora parlare di «unico dio» (1 Tm 1,17; 6,15) aveva più un senso critico nei confronti del politeismo pagano e del monoteismo giudaico che non verso il culto imperiale, per quanto già con Svetonio e Tacito si cominci ad assimilare l'appartenenza al cristianesimo (che non veniva ancora distinto dall’ebraismo) a un delitto (superstitio malefica).
Dunque quale ebreo avrebbe potuto accusarlo in un tribunale romano della capitale dell'impero, in cui i reati di opinione per motivi religiosi erano in quel momento praticamente inesistenti? Paolo non era stato forse sempre prosciolto da tutte le accuse nei tribunali romani proprio perché non si vedeva in lui alcuna «colpa» in senso giuridico? È anche probabile ch’egli sia stato liberato perché non si presentarono i sostenitori dell'accusa nel tempo previsto. Sicché i suoi progetti di fare un viaggio in Spagna (Rm 15,24) avrebbero anche potuto realizzarsi, come lasciano credere Clemente Romano (1 Clem. 5,4-7) e il Frammento del Muratori (r. 38 s.). Ma se il viaggio in Spagna fosse stato fatto tra il primo e il secondo processo romano, perché non parlarne?
Probabilmente il martirio di Paolo non è stato descritto nel N.T. proprio perché egli morì di vecchiaia o in maniera accidentale o di malattia. Noi sappiamo soltanto che l'ultimo Paolo a nostra conoscenza era molto amareggiato: si sentiva abbandonato, deluso. Solo Luca, che contribuì quasi sicuramente alla stesura della seconda lettera a Timoteo, era rimasto al suo fianco (4,11). Stando comunque alla tradizione, egli fu decapitato nel 67 d.C. presso le Tre Fontane (Aquae Salviae) della capitale, non molto tempo dopo l'esecuzione di Pietro.
(torna su)11) Lettera a Tito
Nell'esordio di saluto e di autopresentazione Paolo non fa tanti giri di parole: la promessa della vita eterna, che dio ha fatto «prima di tutti i secoli» (1,2), è stata rivelata a lui «per ordine» di Gesù Cristo.
Il messaggio è chiaro: il vangelo di Paolo è «religioso» non «politico», è un vangelo inedito, senza precedenti storici, è un vangelo che va predicato attivamente, non basta ascoltarlo o viverlo privatamente, a livello di mera coscienza personale, è insomma un vangelo «politico» il cui contenuto è «teologico», cioè è un vangelo apparentemente rivoluzionario e sostanzialmente conservatore, culturalmente innovativo e politicamente moderato.
Tito, figlio di greci, non è che un discepolo di Paolo, come Timoteo: un discepolo che deve eseguire degli ordini precisi a Creta, organizzando la vita della comunità qui costituita dallo stesso Paolo.
Gli «anziani» o «vescovi», per poter dirigere questa comunità, devono essere moralmente irreprensibili, giuridicamente monogami, con figli docili e ben educati. La gestione della comunità è collegiale, in quanto nella lettera si parla di «anziani» al plurale, con funzioni democratiche, e non di «vescovo» al singolare, con funzioni monarchiche. Quando Paolo parla di «vescovo» al singolare, intende semplicemente il tipo-ideale di «anziano». Più anziani, tra loro giuridicamente uguali, devono gestire insieme la comunità.
Queste persone devono essere il contrario di molti di quelli che si trovano tra gli ebrei (i cristiani di origine ebraica), che sono ribelli, ciarloni, seduttori delle menti, disonesti (1,10 s.). Paolo vuol dare fiducia agli elementi provenienti dal mondo pagano.
Le teorie dei giudeo-cristiani vengono paragonate, senza mezzi termini, a delle «favole» (1,14): «questioni stolte, genealogie, contese, dispute intorno alla legge», tutte cose settarie e quindi inutili. Gli ebreo-cristiani non riescono a diventare «cristiani» sino in fondo, perché restano troppo «giudei».
La loro stessa condotta di vita viene considerata falsa e ipocrita da Paolo, in quanto del tutto contraddittoria anche ai migliori principi professati, il primo dei quali è il monoteismo: «professano di conoscere Dio ma lo rinnegano coi fatti» (1,16). Il suo vangelo invece - dice Paolo - è più coerente: parla di redenzione non di liberazione, di salvezza morale non politica, di speranza ultraterrena non storica.
Ecco perché agli schiavi (e non semplicemente ai «servi», come vogliono molte traduzioni italiane) va detto, con fermezza e in tutta tranquillità, che devono stare «sottomessi ai loro padroni», devono addirittura «compiacerli in ogni cosa», non devono mai «contraddirli» né «derubarli», ma anzi devono «mostrare sempre lealtà perfetta» (2,9 s.).
Più chiaro di così non si può. Paolo non chiede agli schiavisti neppure un minimo di reciprocità nei confronti dei loro schiavi, che pur sono cristiani come loro, per quanto qui sembra ch'egli voglia rivolgersi unicamente a schiavi cristiani soggetti a schiavisti pagani.
Gli schiavi non devono mai ribellarsi, semplicemente perché non ne hanno bisogno: «la grazie salvifica di Dio s'è manifestata per tutti gli uomini» (2,11), quindi anche per loro. Ribellarsi vuol dire essere «empi», cioè atei, avere «desideri terreni», cioè materiali, sociali, politici.
Viceversa uno schiavo veramente cristiano deve limitarsi ad aspettare «la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù» (2,13). («Grande Dio» era un'espressione che nel mondo romano si attribuiva solo all'imperatore, la cui apparizione era attesa in quanto procurava benefici). Cioè la libertà esteriore, sociale, politica viene rimandata a un futuro glorioso del Cristo risorto (parusia), del tutto indipendente dalla volontà degli uomini.
D'altra parte l'obbedienza non è dovuta solo agli schiavi, ma anche a tutti i cittadini liberi della stessa comunità cristiana. Anche loro devono stare «sottomessi» (3,1): in questo caso «ai magistrati e alle autorità». Bisogna obbedire sia al potere politico che a quello amministrativo. Paolo è convinto che se i cristiani si dimostrano leali nei confronti delle istituzioni, nessuno potrà far loro del male.
I cristiani devono guadagnarsi la fiducia delle istituzioni, mostrandosi ligi ai loro doveri di cittadini, evitando accuratamente di fare delle contraddizioni sociali un motivo per opporsi alle istituzioni. I cristiani devono essere conformisti, diplomatici, moderati, devono limitarsi ad agire dietro le quinte, «mostrando grande dolcezza verso tutti gli uomini» (3,2). Se proprio sono capaci di sfruttare le contraddizioni sociali per rivendicare un potere personale, utile alla comunità, lo facciano con grande circospezione e avvedutezza.
*
Paolo fa capire a Tito o alla comunità cretese ch'egli rappresenta che di fronte al fatto della resurrezione vengono meno tutte le motivazioni che possono rendere significativa una morte in croce. Cioè se anche fossero stati crocifissi mille ebrei nello stesso giorno in cui è stato crocifisso il Cristo, non essendo nessuno di loro risorto, il loro sacrificio è nulla a confronto di quello, apparentemente analogo, subito dal Cristo, proprio perché questi, risorgendo da morte, ha dimostrato che il suo sacrificio avrebbe potuto tranquillamente evitarlo, e il fatto invece di averlo accettato ci deve far riflettere non tanto sulle motivazioni «umane» del gesto, quanto su quelle «divine», poiché queste vanno sicuramente al di là dell'uomo-Gesù, del Cristo come individuo, riguardando piuttosto una sorta di «eterno piano divino», una soteriologia in cui più che la crocifissione, riveste un ruolo centrale la resurrezione, in quanto se la crocifissione può dimostrare la grandezza «umana» del Cristo, la resurrezione ne dimostra l'assoluta superiorità «divina», al punto che si potrebbe addirittura sostenere che avrebbe potuto esserci resurrezione anche senza crocifissione, nel senso che se anche il Cristo avesse avuto a che fare con una popolazione disposta ad ascoltare il suo messaggio, disposta cioè a lasciarlo morire in maniera naturale e non violenta, noi avremmo comunque dovuto sperimentare la sua vittoria sulla morte. Questo perché mentre la crocifissione va considerata come una possibilità umana, la resurrezione va invece considerata come una necessità divina.
Ciò che in ultima istanza dà sicurezza agli uomini non è il fatto che un innocente accetti di morire in croce, che un uomo si sacrifichi per il bene della sua gente, per risparmiare alla sua gente inutili sofferenze, che un uomo accetti di sacrificarsi per dare il buon esempio, per dimostrare d'avere coraggio e di non temere né il male né le sofferenze; ciò che dà sicurezza non è neppure, se vogliamo, l'idea teologica e giuridica secondo cui la crocifissione è servita per riconciliare dio con gli uomini, per sanare la situazione che s'era creata in seguito al peccato d'origine, come dice espressamente Paolo nella lettera ai Romani.
Ciò che dà sicurezza è che tutto questo è stato vissuto per un fine superiore, un fine che se anche gli uomini stentano a capire, è sicuramente un fine di bene, voluto dalla prescienza divina, entro la quale veniva esclusa a priori l'idea di poter abbandonare gli uomini alle conseguenze devastanti del peccato originale, la rottura della comunione con dio (che è poi quella col comunismo primitivo).
Il sacrificio di Cristo è stato grande perché in un certo senso voluto da dio, è stato necessario per far capire agli uomini, attraverso la sofferenza, in quali bassezze erano arrivati, la profondità del loro male.
Il fatto che il Cristo sia risorto e che abbia fatto capire ai suoi discepoli ch'era risorto, deve farci credere ch'egli, nonostante la crocifissione, ci ha perdonati, anche perché questa era prevista nel piano divino. Se lui ch'era dio non ha potuto impedirla, è stato perché non ha voluto, e non ha voluto perché sapeva ch'essa rientrava nella volontà divina. Il Cristo ha pagato il prezzo del proprio desiderio di creare l'umanità, cioè di creare un essere umano che fosse a immagine e somiglianza della divinità. Con la crocifissione il figlio ha saldato il debito nei confronti del proprio padre e ha fatto saldare agli uomini il debito che avevano contratto nei confronti di dio.
Paolo, con questa sua teologia mistica e trascendentale, giustifica ogni cosa; in nome di questo ideale supremo di redenzione cosmica, di ricapitolazione universale di tutte le cose in Cristo (palingenesi) giustifica la croce, la sconfitta di Israele, la spoliticizzazione del vangelo, il tradimento degli apostoli, la trasformazione dell'immagine di Cristo da liberatore a redentore.
Paolo è il principale responsabile della mistificazione che il cristianesimo primitivo ha operato al vero vangelo di Cristo, il cui scopo principale non era quello di far credere in un'esistenza metafisica, sovrumana, ultraterrena, ma quello di far credere ancora possibile un ritorno all'esperienza, tutta terrena, umana, materiale, del comunismo primitivo, poiché dio non è altro che questo comunismo e tutto quello che di religioso è stato detto intorno a questo comunismo è fuorviante.
(torna su)12) Prima lettera ai Corinzi
L'ampiezza della corrispondenza epistolare tra Paolo e i Corinzi si spiega col fatto ch'era stato proprio lui in persona ad aver fondato in questa città la prima comunità cristiana, di cui andava particolarmente fiero.
Prima che venisse rasa al suolo dal console Lucio Mummio, nel 146 a.C., Corinto era stato un centro commerciale di prim'ordine, favorendo notevolmente gli scambi tra Europa ed Asia. E forse per questo era anche particolarmente corrotta, tanto che allora, quando si usava l'espressione «fanciulla corinzia», s'intendeva in sostanza una meretrice.
Nel santuario dedicato ad Afrodite Pandemos si esercitava, come rito religioso, la sacra prostituzione. Fu proprio Giulio Cesare che ne ordinò la ricostruzione nel 44 a.C., chiamando, per popolarla di nuovo, molti coloni italici, sia veterani che liberti, giudicati con disprezzo dai greci.
Nel 27 a.C. l'imperatore Ottaviano la fece capitale della nuova provincia senatoriale dell'Acaia, promettendole di risplendere come un tempo.
Gli schiavi erano numerosissimi, gli ebrei avevano una loro importante sinagoga e l'elemento greco era, in rapporto al totale degli abitanti (circa mezzo milione), meno significativo rispetto ad altre grandi città. Corinto era la meno greca delle città greche.
I filosofi più rinomati erano i Cinici, mentre sul piano religioso vigeva il più ampio cosmopolitismo, benché la dea preferita restasse Afrodite, i cui riti erano sicuramente licenziosi.
Paolo vi giunse dopo lo smacco subito all'Areopago ateniese, cioè alla fine del secondo viaggio missionario, tra la primavera e l'estate del 51 d.C. Atene era stata l'unica città da cui Paolo s'era volontariamente allontanato senza esserne stato scacciato, e quando giunse a Corinto era solo e privo di mezzi di sussistenza. Per sua fortuna aveva incontrato due coniugi ebrei, Aquila e Priscilla, a quel tempo già cristiani, appena profughi da Roma a causa dell'editto d'espulsione di tutti gli ebrei, emanato dall'imperatore Claudio. Siccome Paolo faceva il loro stesso mestiere di fabbricante di tende, poté ottenere l'agognata ospitalità.
Appena sistematosi economicamente, iniziò a predicare, partendo, come al solito, dalla sinagoga, raggiunto, nel frattempo, da Sila e Timoteo, che si trovavano in Macedonia. Anche loro lo aiutavano finanziariamente.
Poiché i giudei, in genere, rifiutavano le sue assurdità relative alla resurrezione del messia figlio di dio, crocifisso per redimere, agli occhi del dio-padre, l'umanità peccatrice sin dai tempi del peccato originale, egli iniziò a frequentare un certo Tizio Giusto (pagano affiliato al giudaismo), la cui casa era attigua alla sinagoga. Nel frattempo s'era convertito anche Crispo, un archisinagogo, con tutta la famiglia.
Rendendosi conto dell'oggettiva difficoltà, Paolo non cercava un'intesa vera e propria con gli ebrei ma più che altro un pretesto che gli permettesse di svolgere il ruolo della vittima espulsa dalla sinagoga e osteggiata in mille modi; dopodiché gli era relativamente facile trovare dei seguaci tra i pagani, anche se in diciotto mesi di inteso lavoro propagandistico non ebbe forse il successo sperato in questa città.
I Corinzi infatti erano abituati a uno stile di vita tutt'altro che morigerato. Impressionante è l'elenco di «peccati» ch'egli delinea in 6,9 ss.: fornicazione, idolatria, adulterio, ogni specie di vizio sessuale, ladrocinio, cupidigia, ubriachezza, oltraggio ecc.
Furono proprio i giudei della città, aiutati da altre persone pagane, a denunciarlo al proconsole dell'Acaia Gallione, fratello del filosofo Seneca e, come questi, costretto in seguito a suicidarsi da Nerone perché coinvolto nella congiura dei Pisoni. L'accusa era quella secondo cui egli, nelle città pagane, predicava l'assoluto monoteismo (anche gli ebrei ovviamente erano monoteisti, ma era loro interdetto il proselitismo).
Tuttavia il proconsole cacciò i giudei dal tribunale, in quanto, secondo lui, si trattava di questioni meramente religiose, nelle quali non sarebbe voluto entrare. Gallione conosceva bene gli ebrei e quando vide, in quel frangente, che alcuni greci stavano malmenando, per ritorsione, un altro sinagogo, di nome Sostene, forse a capo del procedimento giudiziario a carico di Paolo, fece finta di nulla.
Nei momenti a lui più sfavorevoli, Paolo era abilissimo nel mettere gli uni contro gli altri. Infatti ne approfittò subito per continuare a predicare per ancora molti giorni, finché, dopo aver sciolto un voto col rito ebraico del nazireato (Num 6,2-21), salpò, agli inizi del 53, con Aquila e Priscilla, verso le coste della Siria.
I
L'occasione dell'epistola furono, guarda caso, le sregolatezze sessuali di Corinto, nel senso che molti cristiani volevano le stesse libertà che avevano prima, quand'erano pagani. La prima lettera, andata perduta, venne scritta da Efeso, durante il terzo viaggio missionario, tra il 56 e il 57. Quella che oggi si chiama «prima lettera ai Corinti» è in realtà la seconda e da essa si può facilmente arguire che la precedente non aveva conseguito alcun effetto, anzi, la situazione era andata peggiorando: si stavano persino formando delle scissioni, i cui leader dicevano di parteggiare per Paolo o per Apollo o addirittura per Pietro (Apollo era oriundo di Alessandria, seguace di Filone, sincretista e allegorista, in quanto tendeva a conciliare Mosè con Platone).
Da Corinto gli arrivò una missione ufficiale che gli propose di risolvere alcuni complessi casi di coscienza (troppi in verità per una singola lettera), come il rapporto tra matrimonio e verginità, l'uso delle carni immolate agli dèi, l'ordine da seguire nelle riunioni liturgiche, l'uso equo dei carismi, la questione della resurrezione dei morti e anche il fatto che sempre più spesso si pretendeva di risolvere litigi e controversie di natura economica attraverso i tribunali, dando così scandalo a quelli di fede pagana.
La lettera è piena di questi numerosi e controversi problemi e il suo autore (chiunque sia stato) ha cercato di affrontarli senza alcuna vera sistematicità, per quanto essa resti una delle più ricche di temi e spunti dottrinali e disciplinari. Gli esegeti danno per scontato che a una prima stesura originaria siano seguite interpolazioni di non poco conto, la cui conformità all'ortodossia paolina viene ovviamente sostenuta solo dai più confessionali.
II
Di tutti i problemi comunitari, quello che maggiormente sembra preoccupare Paolo è la tendenza a formare delle scissioni politico-religiose. I partiti in questione sarebbero tre: il più forte è ovviamente quello che si rifà a lui medesimo; il secondo preferisce come leader Apollo o Apollonio (anche lui presente per un certo tempo nella città); il terzo, evidentemente di origine ebraica, si rifaceva a Pietro (qui chiamato Cefa, col suo soprannome aramaico).
Questo terzo partito è molto strano: se i suoi adepti volevano dimostrare che Pietro era superiore a Paolo, la differenza doveva stare semplicemente nel fatto che Pietro riteneva ancora imminente una parusia «politica» del Cristo «ebreo», a favore della Palestina oppressa da Roma. Quindi verrebbe quasi da presumere che nel momento in cui questa lettera venne scritta Pietro risiedesse ancora a Gerusalemme o non avesse comunque appoggiato in toto la teologia mistica di Paolo, che peraltro la comunità ebraico-cristiana di Gerusalemme (guidata da Giacomo il Minore) considerava valida solo se riferita ai pagani. Resta però il fatto che nessun documento del Nuovo Testamento ricorda una presenza di Pietro a Corinto. Anzi, è da presumere che già al momento della stesura di questa lettera, la figura di Pietro fosse del tutto ininfluente sia dentro che fuori della Palestina.
Si badi, anche Paolo riteneva imminente la parusia cristica, tant'è che in questa lettera si rivolge ai Corinzi come se stessero aspettando «la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo» (1,7), ma il suo concetto di Cristo non aveva più alcun connotato «ebraico» o «nazionalistico».
Assurdamente gli esegeti cattolici han voluto vedere in questo partito filo-petrino la conferma di un particolare «primato» del discepolo galileo rispetto al collegio apostolico. Noi non sappiamo quasi nulla di quel che avvenne di tale collegio dopo la morte del Cristo: di certo Pietro assunse un ruolo di comando, non condiviso dai fratelli Zebedeo, e non meno certamente la pretesa all'apostolato da parte di Paolo si avvalse di una piena libertà d'iniziativa al di fuori della Palestina. Peraltro molti commentatori antichi di questa epistola consideravano del tutto fittizi i nomi dei leader dei tre partiti, in quanto si voleva evitare di citare quelli veri.
Paolo comunque rifiuta d'essere considerato leader di una fazione religiosa, anzi, nel preambolo della lettera aveva dichiarato d'essere apostolo «per volontà di Dio», non per un mandato da parte di qualche altro stretto discepolo del Cristo. Lui si sentiva del tutto indipendente dai Dodici e quando si presentava al loro cospetto per giustificare il proprio operato «anti-ebraico», era solo perché a Gerusalemme arrivavano continue denunce da parte dei cristiani di origine giudaica che lui incontrava nella diaspora. Questo poi senza considerare che lui a Gerusalemme non vide altri che Pietro, Giacomo il Minore e forse, ma è molto dubbio, Giovanni.
Qui stranamente ritiene che la pratica del battesimo uno poteva usarla anche per ottenere seguaci alla propria causa, ma, in tal senso, lui si vanta, essendo restio a usarla in questa maniera, di non aver battezzato nessuno a Corinto, ad eccezione di tre persone: l’archisinagogo Crispo, Gaio, presso cui alloggiava, e Stefana, ch'era stata inviata dalla comunità di Corinto a Efeso. Per lui era molto più importante predicare che battezzare, anche perché il battesimo era alla portata di chiunque (ancora non esisteva una casta sacerdotale ad hoc), mentre per predicare occorreva essere di provata virtù.
III
Nonostante le manipolazioni in più punti, la lettera può essere divisa in due ampie parti. Nella prima si condannano le divisioni interne. Paolo sostiene che la forza del «suo» vangelo sta nel fatto che ha una propria coerenza interna di tipo teologico e cristologico e non sa che farsene di altre scienze umane, proprio perché nessuna di queste, nonostante gli alti livelli della loro sapienza, è in grado di non scandalizzarsi di fronte alla croce e alla resurrezione, che sono l'unica fonte di salvezza del credente cristiano. Su questo è tassativo, anche perché lo smacco di Atene ancora gli brucia: nessuna scienza o filosofia è mai arrivata e mai arriverà a comprendere i misteri di dio. È quindi inutile dividersi su questioni meramente interpretative circa le fonti della salvezza: la verità è già data, bisogna solo accoglierla.
Che questa verità non dipenda dalla saggezza di nessuno, è dimostrato anche dal fatto che i migliori cristiani sono quelli che, agli occhi del mondo, non contano nulla: gente semplice che sa mettere in pratica le regole dell'amore fraterno. La saggezza che hanno i cristiani non può essere comunicata da nessuna «teoria umana», proprio perché si basa su un fatto che «umano» in senso stretto non può essere: Cristo risorto. Un fatto in cui è normale che non tutti riescano a credere, ma solo quelli a cui viene concesso dallo spirito. Pertanto chi crede non può dividersi, essendo già «diviso» da chi non crede.
Se il mondo fosse stato davvero saggio - ribadisce a più riprese Paolo - non avrebbe giustiziato il Cristo. Ancora oggi - e qui si esprime in maniera molto efficace - i giudei chiedono «miracoli» e i gentili «sapienza»; invece i cristiani predicano «Cristo crocifisso», scandalo per gli uni e stoltezza per gli altri (1,22 ss.).
L'osservazione, in teoria, era giusta, anche se egli fa passare i giudei per creduloni, superstiziosi e rozzi materialisti, e i pagani per intellettuali oziosi, vuoti e retorici. Ma è comunque sbagliata la conclusione operativa. È infatti molto limitativo sostenere che, siccome Cristo è stato ingiustamente giustiziato, allora non ha più senso lottare per cambiare il mondo. Una conclusione del genere è infantile, da adolescente ferito nel proprio idealismo (che poi diventa, in casi del genere, «amor proprio»), il quale adolescente, ad un certo punto, poiché vuole comunque emergere, sceglie la strada estrema di proporre una soluzione «oltremondana» ai problemi dell'umanità (come ancora oggi fanno i seguaci delle sette millenaristiche, p.es. i geovisti).
Il principale torto di Paolo è stato proprio quello di predicare non tanto il «Cristo crocifisso» quanto piuttosto il «Cristo risorto». Sarebbe stato sufficiente dire che quando un popolo così etico come l'ebraico non ha saputo riconoscere il leader politico più giusto che abbia mai avuto, eliminandolo addirittura con la collaborazione del nemico in patria, diventa del tutto normale ritenere che gli ebrei, proprio in quanto ebrei, non possano pretendere più alcuna superiorità morale rispetto ai pagani. Sarebbe cioè stato assolutamente giusto sostenere che di fronte a «Cristo crocifisso» tutti gli uomini erano improvvisamente diventati uguali e che non aveva più senso distinguerli per etnia o nazionalità o tradizione storica, in quanto il messaggio ch'egli aveva proposto, essendo stato rifiutato sia dagli ebrei (cui principalmente si rivolgeva) che dai pagani, ora poteva essere rivolto a chiunque lottasse contro i soprusi dei poteri dominanti, contro le ingiustizie sociali, indipendentemente dal fatto che si fosse greci o barbari, liberi o schiavi, uomini o donne.
Se Paolo si fosse limitato a predicare ciò che il Cristo effettivamente disse, di cui egli avrebbe dovuto informarsi frequentando assiduamente i discepoli nazareni della prima ora, invece di iniziare subito a predicare a destra e a manca il «suo personale vangelo», quello secondo cui la cosa più importante della vita di Cristo era stata nientedimeno che la sua «morte», interpretata da Pietro come «resurrezione» e reinterpretata da lui stesso come prova suprema dell'«esclusiva figliolanza divina del Cristo», egli, molto probabilmente, avrebbe avuto uguale successo, non si sarebbe attirato l'odio feroce di tutti quegli ebrei che ancora ritenevano possibile una liberazione della Palestina dai romani, avrebbe anzi evitato di accendere ingiustificati odi antisemitici, e infine agli schiavi e oppressi di tutto l'impero romano avrebbe dato un'effettiva speranza di liberazione su questa terra e non nei cieli.
Anche perché, in definitiva, che cosa prometteva Paolo agli oppressi di tutto l'impero? Una liberazione definitiva solo nell'aldilà. E come si sarebbe dovuta realizzare questa liberazione? Nello stesso modo in cui sulla terra s'era imposta la schiavitù, cioè con la forza. Per lui il ritorno di Cristo sarebbe stato «trionfale», contro tutti i nemici della fede, e il giudizio universale avrebbe avuto un carattere di categoricità, in modo da rendere la verità un'evidenza.
Al cap. 7,21-22 è molto eloquente quanto scrive. Parafrasandolo è come se dicesse: «Sei divenuto cristiano mentre eri schiavo? Bene, non hai bisogno di diventare libero. Hai possibilità di affrancarti dalla schiavitù? E a che ti serve, visto che siamo tutti schiavi di Cristo? Anzi, approfitta della tua condizione, mostrando al tuo padrone che, pur potendo diventare libero, preferisci continuare a lavorare al suo servizio, e vedrai che quello ti terrà in grande considerazione. Se eri schiavo e sei diventato cristiano, sei già libero. Sei un libero affrancato dal Signore! Sei più libero del tuo padrone non credente. Saresti uno stupido a non capire che se ora, in quanto cristiano, accetti di restare schiavo, potrai più facilmente convertire il tuo padrone».
In sostanza, quanto più Paolo rinunciava a combattere politicamente la schiavitù, tanto più rendeva la liberazione ultraterrena una nuova forma di schiavitù. Il Cristo si sarebbe imposto, col consenso del padre, in virtù della sua potenza divina e scienza infusa, e chi non si fosse pentito sarebbe stato condannato per l'eternità.
Una tale concezione della libertà poteva appartenere solo a una persona molto immatura, ancorché condizionata da tempi storici alquanto drammatici (quali quelli della transizione dalla repubblica all'impero romano, dove la militarizzazione giocò un ruolo di primissimo piano), cioè solo a una persona che aveva metabolizzato molto male la propria sconfitta politica e che s'immaginava il futuro (immediato) come una gigantesca vendetta apocalittica contro ogni avversario che colpevolmente non si voleva riconoscere in un bene ipostatizzato.
In tal senso peraltro appare piuttosto ridicolo che Paolo dica ai Corinzi di non potersi permettere l'affronto di cose più elevate, essendo ancora scarsa la loro maturità teologica. In effetti l'unica sua lettera cristologicamente più profonda di questa resta quella scritta ai Romani, dove però l'esegeta laico ha a che fare soltanto con ulteriori speculazioni metafisiche.
IV
Paolo fa capire ai Corinzi che è assurdo dividersi «politicamente» (in senso religioso), quando poi sul piano «etico» si è disposti a tollerare abusi sessuali a non finire, p.es. che un cristiano pubblicamente conviva con la moglie del proprio padre (matrigna), rimasta vedova o separata. Persino il diritto romano (cui però in quel momento Corinto non era tenuta) vietava unioni del genere. Egli non poté fare altro che scomunicarlo.
Quando c'erano di mezzo le questioni sessuali, Paolo, nonostante le sue assurdità teologiche, riusciva sempre ad avere la meglio, proprio perché la sua eticità, di provenienza giudaica, era di molto superiore a quella pagana, dove gli aspetti della vita sessuale ed economica avevano prevalenza su tutto. Più e più volte dovette infatti scontrarsi con comportamenti che lo disgustavano, essendo considerati molto riprovevoli nel mondo ebraico.
E chiunque può facilmente rendersi conto che quando uno dimostra di avere una concezione superiore dell'etica, gli diventa poi relativamente facile trasmettere, nella propria predicazione, delle idee fantasiose di tipo mistico.
Tuttavia egli si rendeva anche conto che in una situazione dove l'elemento pagano era così nettamente maggioritario, più che dare «ordini» in materia di comportamento sessuale, era meglio limitarsi a dei «consigli». Egli certamente non poteva tollerare la prostituzione, la sodomia, l'omosessualità, l'adulterio ecc., ma non poteva imporre la continenza o l'astinenza. Si limitava semplicemente a dire che piuttosto che lasciarsi schiavizzare dalle proprie passioni, era meglio sposarsi. La motivazione fondamentale che usava per motivare la sua preferenza per la castità era relativa alle grandi difficoltà che caratterizzavano il suo tempo, e quindi al fatto che fosse meglio affrontarle come se da un momento all'altro dovesse accadere qualcosa di catastrofico.
Paolo aveva una concezione apocalittica dell'esistenza e si sentiva in dovere di trasmetterla ai suoi interlocutori, che sicuramente non potevano negare che le sue preoccupazioni fossero fondate. Ecco perché diceva che bisognava vivere come se non si possedesse nulla (dal corpo del proprio partner ai beni materiali).
In tal senso gli apparivano assurdi i ricorsi presso i tribunali pagani per dirimere controversie connesse alla proprietà. Per convincere i Corinzi a dimostrare la loro superiorità etica rispetto ai pagani li invita a riflettere sulla seguente linea di condotta: «è meglio subire l'ingiustizia che farla» (6,7).
In questa prima parte dell'epistola, l'unica cui è possibile attribuire con certezza una paternità paolina, la conclusione è pertinente a quanto fin qui detto: se i cristiani, in virtù di una conoscenza teologica superiore, pensano di potersi comportare liberamente, si sbagliano, poiché qualunque violazione dell'etica, soprattutto per motivazioni di ordine sessuale, li farà inevitabilmente ripiombare nella schiavitù della carne.
V
Nella seconda parte della lettera, quella più manipolata, Paolo entra nello specifico dei problemi che gli sono stati posti.
Il primo è quello dei rapporti tra verginità e matrimonio. In generale Paolo sostiene una sorta di primato dello stato verginale su quello matrimoniale, ma si guarda bene dal pretenderlo. La sua indicazione di massima, contestuale alla crisi sistemica del suo tempo, era la seguente: ognuno rimanga nella condizione in cui si trovava al momento di ricevere il vangelo, compresi gli schiavi, tanto i tempi della sofferenza sono brevi ed è insensato aggiungere nuove tribolazioni a quelle già esistenti; si tratta solo di avere un po' di pazienza e di controllare le spinte passionali; chi proprio si vuol sposare perché non resiste e rischia comportamenti indegni, lo faccia, ma senza pensare al divorzio in caso di crisi matrimoniale.
L'unico divorzio possibile (infatti i cattolici, forzando la lettura dei testi, parlano di «privilegio paolino») è quello tra due infedeli di cui solo uno diventi cristiano: in tal caso può essere chiesto dal coniuge rimasto pagano, il quale permette automaticamente all'altro di risposarsi.
Anche la vedova, se voleva, poteva risposarsi, ma lui lo sconsigliava. Paolo voleva che i cristiani fossero come lui, pronti a sacrificarsi per un ideale, anche negli aspetti più intimi della sessualità, disposti a viaggiare per il mondo, diffondendo l'idea del Cristo risorto. Non si rendeva conto di chiedere l'impossibile, la disponibilità a una vita eccezionale, sempre nell'occhio del ciclone. Parlava come se ci fosse una guerra in corso, come se una catastrofe di qualsivoglia natura fosse imminente.
È evidente che in una situazione del genere, che sicuramente in parte corrispondeva alla realtà (il passaggio dalla Repubblica all'Impero fu certamente traumatico), non avere incombenze con gravidanze o figli molto piccoli, sarebbe stato meglio. Ma difficilmente su questa strada avrebbe potuto trovare molti seguaci.
Paolo non chiedeva di vivere una vita normale ma una vita agitata, in cui fosse sempre possibile essere malmenati, dileggiati, denunciati, incarcerati, minacciati di morte... Da quando aveva iniziato a predicare, la sua «vita normale» era sempre stata questa.
Essendo uno sradicato dalla sua terra d'origine, privo di un reale appoggio sociale in Israele, dove era malvisto non solo dai giudei ortodossi ma anche dagli stessi cristiani che non amavano essere messi sullo stesso piano dei pagani, Paolo doveva per forza nelle sue lettere parlare spesso di se stesso, delle grandi sofferenze che pativa, delle gravi difficoltà che incontrava nei suoi viaggi, delle regole ferree che si dava. Qui in effetti si ha a che fare con una persona molto dotata sul piano intellettuale, incredibilmente determinata nell'azione, disposta a qualunque sacrificio e fanaticamente convinta delle proprie idee. Il capitolo 9 è interamente autobiografico.
Paolo era più che convinto di vedere le cose con maggiore lungimiranza rispetto ai seguaci degli apostoli Pietro e Giacomo il Minore. Tuttavia, siccome non aveva un seguito come loro, doveva per forza avvalersi delle proprie capacità, della propria esperienza, per dimostrare l'assoluta verità di quanto andava propagandando nei territori della diaspora ebraica. P.es. egli si è fregiato del titolo di «apostolo» abusivamente, dicendo d'aver avuto una rivelazione direttamente da Cristo: s'inventava le cose sfruttando la creduloneria popolare. In realtà dovette ottenere il consenso da parte della comunità di Gerusalemme per poter predicare come inviato speciale («apostolo») presso i pagani.
In questa lettera è costretto a ricordare che per alcuni lui continua a restare un «non apostolo» (9,2), ma si difende da questa accusa mostrando le tante comunità che ha fondato, tra cui appunto Corinto. Inoltre spera di ammorbidire le ritrosie dei cristiani di Gerusalemme organizzando per loro una grande colletta di aiuti economici.
Molto astutamente, rendendosi conto di non poter esibire i privilegi degli altri apostoli, ne approfitta per vantarsi di non averli. E così ci tiene ad affermare d'aver sempre lavorato manualmente, di aver rinunciato a legarsi con una donna, di non aver voluto fare differenze di onore o di dignità tra ebrei e pagani, tra ricchi e poveri, e di aver sempre rifiutato cariche prestigiose.
Era poi abbastanza intelligente per capire che se anche i Corinzi preferivano non imitarlo, non era il caso di prendersela. Non ne avrebbe fatto un dramma. Semmai è stata la teologia cattolica che, forzando la lettura di talune espressioni di questa epistola e di alcuni vangeli, ha ritenuto doveroso imporre l'indissolubilità del matrimonio, senza rendersi conto che tutti i consigli che, in materia sessuale, dava Paolo erano dettati dalla percezione di una contingenza storica molto precaria, segnata da una forte provvisorietà; e, nonostante questo, egli si sforzava di tener conto delle umane debolezze, per cui non rifuggiva dall'uso del buon senso. Paolo non avrebbe mai accettato che in caso di adulterio da parte di un coniuge, l'altro avrebbe dovuto continuare ad amarlo o a fingere di farlo, per salvare le apparenze, solo perché il matrimonio sottostava al vincolo dell'indissolubilità.
VI
L'altro argomento che affronta riguarda le carni immolate agli idoli. Paolo sostiene che pur essendo i cristiani liberi di mangiarne non perché credono in qualche idolo, ma proprio perché non vi credono, non devono tuttavia farlo in presenza di chi ritiene, in coscienza, che ciò non debba essere fatto. Lui stesso - dice - avrebbe potuto pretendere d'essere economicamente mantenuto dalle comunità personalmente fondate, eppure, per non dare adito a chiacchiere e malintesi, si era sempre rifiutato di farlo.
Questo per dire che chi beneficia di certi diritti, non deve vantarsene come fossero suoi esclusivi privilegi. Naturalmente un cristiano che mangia carne aderendo espressamente a riti religiosi favorevoli al paganesimo, diventa eo ipso un idolatra. È come se oggi un cattolico si leggesse il Capitale di Marx per poter partecipare attivamente alle riunioni di una sezione comunista: al massimo potrebbe leggerlo privatamente, oppure allo scopo di contestarlo pubblicamente.
Naturalmente il ragionamento da fare è più complesso. Paolo aveva a che fare con cristiani provenienti dal mondo pagano, che prima di credere nel monoteismo da lui predicato, erano stati politeisti. Quando credevano negli idoli, a questi facevano sacrifici. Ora, una volta divenuti cristiani, e avendo quindi dichiarato apertamente il proprio monoteismo, si chiedevano se si facesse peccato a mangiare i cibi offerti agli idoli.
Paolo sostiene di no, proprio in quanto tutti i cristiani sanno che gli idoli son falsi (non si acquista nulla mangiando carni idolatriche - dice - né si perde qualcosa non facendolo); e tuttavia se qualcuno si scandalizza, è meglio astenersene, perché più importante della certezza dell'inesistenza degli dèi, è la carità (in questo caso la «delicatezza») di non scandalizzare chi, in virtù di questa certezza, pretende un comportamento assolutamente coerente.
Avendo smesso da tempo di fare il «fariseo», Paolo considerava «puri» tutti i cibi e non si formalizzava più sulle regole alimentari, così come riteneva inutile credere nel primato storico di Israele, nella sacralità del Tempio di Gerusalemme, nel valore sociale delle sinagoghe, nei precetti del sabato e della circoncisione. Nondimeno temeva di scandalizzare i semplici e, dall'alto delle sue convinzioni religiose, si abbassava ad accettare compromessi per amor di pace.
Le riflessioni che fa non sono banali e, se si vuole, possono essere utilizzate anche in chiave laica. Quando scrive che se è vero che tutto è «lecito» (in quanto non ha senso formalizzarsi su cose ritenute superate), è anche vero però che non tutto è «utile» o edificante, proprio perché non è mai identica la percezione che si ha della verità delle cose. Chi è ingenuo non merita d'essere scandalizzato e, in ogni caso, la carità è superiore alla scienza.
«Se dunque qualcuno non credente - scrive Paolo - vi invita [a pranzo] e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse: «È carne immolata al sacrificio», astenetevi dal mangiarne, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza; della coscienza, dico, non tua ma dell'altro [di chi ti ha avvertito]. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui?» (10,27 ss.).
Parole potenti queste, ma un caso analogo l'aveva già vissuto Cristo, quando accettò di pranzare col collaborazionista Levi, che estorceva tasse ai galilei a favore di Roma: mangiando dei cibi acquistati con quei soldi sporchi permise a Levi di fargli capire che, a certe condizioni, avrebbe anche potuto accettare la sua conversione alla causa rivoluzionaria, e lui smise di fare l'esattore.
VII
Il resto della lettera (specie nei capitoli 12, 13 e 14) va considerato spurio, cioè interpolato da qualche discepolo, oppure aggiunto da altre lettere, paoline e non. Ci riferiamo all'istituzione dell'eucaristia, ai comportamenti delle donne cristiane, all'uso dei carismi (e quindi al ruolo dello spirito santo) e, infine, al significato della resurrezione dei corpi.
A. L'istituzione dell'eucarestia
Molto si è discusso sulle parole di Paolo relative all'eucaristia (11,23 ss.). È difficile pensare che queste parole siano state scritte da lui, proprio perché a Paolo interessava anzitutto predicare, non svolgere ruoli di tipo sacerdotale. Probabilmente l'unico rito che praticava, di tanto in tanto, era quello del battesimo.
La cosiddetta «cena eucaristica» proviene dal vangelo di Marco e probabilmente è stata introdotta, nelle prime comunità cristiane, dai battisti che avevano accettato la tesi petrina della resurrezione del Cristo. Quindi è probabile che quel racconto sia stato aggiunto successivamente in questa lettera, anche perché viene spiegato ai Corinzi come svolgere il rito, quando, stando al contesto, avrebbe già dovuto saperlo.
È noto, negli ambienti laici, che Cristo non ha istituito alcun sacramento, tanto meno il memoriale della propria morte la sera in cui avrebbe dovuto inaugurarsi l'insurrezione nazionale. Questo per dire che se i Corinzi facevano pasti in comune, questi al massimo avevano un contenuto simbolico, non sacramentale, di commemorazione della morte di Gesù.
Nell'epistola Paolo non si oppone affatto a questi conviti, dove, a quanto sembra, si discuteva anche molto animatamente. Si oppone però al fatto che i poveri, che forse giungevano tardi alle cene, venivano mortificati dal fatto che chi arrivava prima (i ceti benestanti) sottraevano loro una parte di cibo. Ecco perché invita ciascuno a mangiare a casa propria, oppure, se proprio volevano continuare a farlo insieme, ad attendere l'arrivo degli ultimi, mangiando tutti insieme.
Nella pericope l'interpolatore critica i Corinzi di praticare l'eucaristia in maniera indegna (una specie di baccanale) e presume di dimostrarlo dicendo che tra loro vi erano molti ammalati, di cui non pochi erano morti (11,30), come se dio li avesse puniti! È dunque probabile che ad un certo punto (non sappiamo quando) il rito vero e proprio dell'eucaristia sia stato separato da quello dell'agape serale (settimanale), proprio per gli abusi che in quest'ultima si verificavano. Si volle dare al rito un contenuto sacramentale, per renderlo più importante di quello dell'agape, che scomparve del tutto.
B. Il ruolo della donna
Che questa lettera abbia subito pesanti rimaneggiamenti lo si nota non solo nella parte dedicata alla storia d'Israele (10,1-13), che i Corinzi di origine pagana avrebbero avuto difficoltà a capire, ma anche e soprattutto in quelle regole che vengono poste circa il comportamento che le donne dovevano tenere (con riguardo persino al loro abbigliamento) nelle assemblee, liturgiche e non. Se qui è ravvisabile un'influenza che rivela la sua origine ebraica, bisogna però dire che storicamente essa venne fatta propria dagli ambienti maschilisti del cristianesimo di origine pagana.
Prendendo a pretesto la questione del velo che le donne si devono mettere sul capo durante le funzioni liturgiche per dimostrare la loro dipendenza dagli uomini, qui l'interpolatore dice cose molto mortificanti per il genere femminile, che Paolo si sarebbe sicuramente risparmiato, visto che usufruiva continuamente di assistenza anche da parte di donne da lui convertite. Sono cose peraltro in netto contrasto persino col racconto originario del Genesi, quello in cui uomo e donna venivano posti su un piano di parità.
È quanto meno «sessista» la frase secondo lui «l'uomo è a immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo» (11,7), per non parlare dell'altra: «come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge» (14,34). Peraltro Paolo, in quanto ebreo, non avrebbe mai posto una domanda del genere: «Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli?» (11,14). Qui deve essere intervenuta una mano redazionale pagana (abituata a vedere uomini ben rasati e coi capelli corti) e sicuramente molto clericale.
Ma è assurdo anche che l'interpolatore dica che i Corinzi devono conservare le disposizioni sull'abbigliamento femminile che Paolo aveva preteso sin dall'inizio: cosa che, se davvero avesse fatto, non avrebbe mai avuto alcun seguace fra quanti consideravano del tutto naturale che le donne decidessero autonomamente se mettersi o meno un velo in testa durante i riti religiosi (in realtà nei riti pagani non era inconsueto che le donne usassero un velo sul capo, ma non associavano questo comportamento al timore di sentirsi accusate di atteggiamenti eticamente sconvenienti).
Peraltro il fatto stesso che il redattore dica di «lodare» i Corinzi (11,2), poiché in ogni cosa si ricordano di Paolo e delle tradizioni che ha trasmesso loro, è indicativo dell'interpolazione: qui la lode è servita per far passare un'idea discriminatoria nei confronti delle donne. La lettera stessa fu scritta non per «lodare» ma per «biasimare»; infatti in 11,17 è scritto: «non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio».
È quindi evidente che al momento di scrivere queste aggiunte Paolo era già morto, anche se, avendo egli privato le sue comunità di qualunque obiettivo politico rivoluzionario, i suoi seguaci, per continuare a tenerle in piedi, si trovarono costretti a irreggimentarle sul piano etico, specie nei momenti di maggior crisi. Questo perché i fedeli provenivano da ambienti dove la regola era l'antagonismo sociale.
C. La gestione dei carismi
Incredibile che in una lettera del genere sia stato dedicato così ampio spazio al problema più marginale di quelli affrontati: l'uso dei carismi; anche perché poco prima di parlarne Paolo aveva scritto: «Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta» (11,34b). Il che potrebbe anche autorizzarci a pensare che la lettera fosse quasi finita lì, proprio perché le cose più importanti erano già state dette.
La stragrande maggioranza delle riflessioni sul ruolo dello spirito santo sono tardive: non s'incontrano neppure nel vangelo di Marco, almeno non nel modo in cui ne parla Paolo in questa lettera. La teologia pneumatica è stata elaborata in ambienti gnostici divenuti cristiani grazie al paolinismo.
Presso i pagani si verificavano strani fenomeni psichici di estatismo mantico, di eccitazione coribantica e di frenesia mistica, che i teologi cristiani dovettero affrontare alla fine del I secolo, inquadrandoli sul piano ecclesiale.
Al massimo Paolo può aver dato delle indicazioni di massima su come regolarsi nell'attribuzione del merito a questo o quel credente, e per lui sicuramente venivano prima gli apostoli (che nella sua teologia non coincidevano strettamente coi «Dodici»), poi i profeti, infine i maestri (12,28): tutta gente che edificava semplicemente «parlando», senza usare miracoli e glossolalie, che a Paolo non interessavano affatto.
Qui piuttosto bisogna sottolineare che l'interpolatore ha voluto approfittare di questo argomento per ribadire il proprio disprezzo nei confronti delle donne, per le quali non solo veniva fatto obbligo di coprirsi il capo in chiesa, ma ora anche di tacere del tutto nelle assemblee (14,34 ss.). Non a caso quando si parla di queste cose, che difficilmente avrebbero potuto essere accettate da Paolo o dalle sue neonate comunità, si usa un tono molto perentorio (14,37), mentre negli aspetti autentici della lettera ci si limita a dare consigli, suggerimenti.
In ogni caso i discepoli di Paolo, col passare del tempo, furono fatalmente costretti a tollerare, nelle comunità cristiane di origine pagana, pratiche religiose che sarebbero state impensabili nel movimento nazareno di Gesù Cristo, come appunto la glossolalia e i vaticini profetici, che ancora oggi è possibile riscontrare in sette spiritualistiche come i pentecostali o i carismatici, o in talune comunità millenaristiche, apocalittiche.
Il mondo pagano in effetti era pieno di sibille e profetesse (sino alla fine del Cinquecento era addirittura opinione comune che avessero anche loro prevista la venuta di Cristo), ma nessuna di loro svolse mai un ruolo analogo a quello dei profeti veterotestamentari, ch'erano coraggiosi uomini politici il cui potere simbolico era assai temuto dai governi in carica, tanto che spesso pagavano con la morte le loro denunce. L'ultimo grande profeta fu appunto Giovanni Battista.
In At 19,6 viene detto che dopo aver battezzato a Efeso dodici pagani, Paolo vide che su di loro era sceso lo spirito santo e parlavano in lingue e profetavano. Questa sciocchezza, che nelle prime comunità post-pasquali serviva per distinguere i cristiani da quei discepoli del Battista che non avevano accettato il compromesso sull'idea di resurrezione del messia Gesù, negli Atti è già presente in 2,4, allorché Pietro vuol mostrare che la sua comunità era migliore di quella ebraica e persino di quella nazarena, ch'egli si accingeva a tradire con l'interpretazione distorta della tomba vuota.
Questa parte manipolata della lettera fa chiaramente capire che i discepoli di Paolo erano intenti a gestire delle comunità sempre più religiosamente alienate, al punto che sono qui costretti ad affermare che, al di sopra di ogni manifestazione cultuale, vi è sempre la carità, cioè l'amore fraterno.
D. L'idea di resurrezione
Di tutte le parti manipolate, sicuramente la più interessante è quella dedicata al tema della resurrezione. Paolo aveva fatto di questo argomento quello fondamentale di tutta la sua teologia politica, e voleva appunto considerarlo un tema «politico», ma con maggiore determinazione pratica e radicalità argomentativa rispetto alla posizione di Pietro, il quale, sino a quando rimase in Palestina, non volle favorire gli elementi di origine pagana.
Difficilmente Paolo si sarebbe legato le mani nel cercare di dare un'interpretazione la più possibile esatta, convincente, su un argomento per il quale, se si escludono tutte le mistificazioni, invenzioni e falsificazioni operate da Pietro e da altri apostoli, l'unica testimonianza di cui i traditori di Cristo potevano vantarsi (e per giunta evitarono di farlo, in quanto controproducente all'idea di rinunciare all'insurrezione nazionale) era la sindone. Paolo evitò persino di ricordare il fatto che gli apostoli trovarono una «tomba vuota» e preferì invece sostenere che il Cristo risorto fu visto da singoli apostoli e da intere collettività di discepoli.
Il cap. 15 presenta alcune parti che possono essere considerate autentiche di Paolo e altre chiaramente interpolate. Il tutto però risulta fuori contesto rispetto agli altri argomenti pratici affrontati, per cui è da presumere o che sia stato trattato in una lettera precedente andata perduta (anche perché, quando Paolo predicava usando la «resurrezione di Cristo» come argomento assolutamente fondamentale, era naturale per lui aspettarsi obiezioni e richieste di chiarimenti: cosa che i Corinzi avrebbero potuto e dovuto fare subito dopo averlo ascoltato per la prima volta), oppure il capitolo è frutto di una conversazione ch'egli ha tenuto con qualche suo discepolo (magari proprio con qualche intellettuale di Corinto), che poi s'è preoccupato di trascriverla in questa lettera. Infatti se eliminiamo tutto il capitolo e andiamo direttamente al successivo, la coerenza del testo rimane integra.
Il capitolo tuttavia è molto importante e merita d'essere esaminato, seppur brevemente. Che non possa appartenere del tutto a Paolo lo si nota già dalle prime righe, allorché viene detto ch'egli avrebbe trasmesso ai Corinti una tradizione già consolidata tra gli apostoli del Cristo, e cioè che questi subì croce, sepoltura e resurrezione «secondo le Scritture» (addirittura che «risorse dopo tre giorni», quando negli stessi vangeli appare chiaro che la scoperta della tomba vuota avvenne «il mattino presto del giorno dopo»).
Qui dunque siamo in presenza di un testo dottrinale, kerigmatico, probabilmente successivo a Paolo, che mal si addice a una lettera avente finalità di ordine pratico. Semmai ci si dovrebbe chiedere il motivo per cui, nella lettera in oggetto, la comunità primitiva avesse avuto bisogno di dettagliare un argomento che sin dall'inizio della predicazione paolina veniva dato per scontato, essendo il fulcro di tutta la sua cristologia.
Si può quindi presumere che dovettero esserci, sin dall'inizio della sua predicazione, delle contestazioni da parte di chi, sentendo parlare di resurrezione di un messia ebreo che sarebbe dovuto tornare, in veste gloriosa, per giudicare anche i non-ebrei, doveva invece constatare un ritardo inaccettabile di questa parusia trionfale, a fronte di una situazione socioeconomica sempre più oppressiva e insostenibile.
In effetti tutta la cristologia paolina poteva avere un certo successo negli strati sociali marginali solo a condizione che la parusia fosse stata non troppo lontana nel tempo; altrimenti si finiva coll'essere costretti ad ammettere che quella cristologia poteva andar bene solo ai ceti benestanti, che non si sarebbero posti tanti problemi sui ritardi dell'apocalisse.
Qui comunque il redattore afferma alcune cose sulle presunte «apparizioni» del Cristo che difficilmente Paolo avrebbe potuto sostenere senza timore d'essere smentito. Anzitutto il termine «apparizione» viene usato in senso fisico-materiale, quando in realtà più che intenderlo in senso metaforico non si sarebbe potuto: «apparve» cioè solo nel senso che Pietro fu il primo a «interpretare» la tomba vuota come «resurrezione»; tesi, questa, che venne poi accettata da un certo numero di apostoli e discepoli, i quali rinunciarono alla lotta armata.
All'inizio della sua predicazione Paolo non poteva sostenere cose del genere, ma, al massimo, che la tomba era stata trovata vuota. Persino nel vangelo originario di Marco, che è successivo al 70, ancora non si ha il coraggio di scrivere un racconto di «apparizione del risorto».
Quando i cristiani, ad un certo punto, hanno iniziato a scrivere di «Cristo redivivo», «riapparso ai suoi» in carne e ossa, evidentemente questi «suoi», cioè i primi ad averlo seguito personalmente, erano già tutti morti o avevano smesso di essere «nazareni» o non erano mai diventati «cristiani», stanchi di credere in qualcosa che non dava nessuna aspettativa concreta di liberazione. La seconda generazione di cristiani non aveva mai iniziato a credere nell'imminenza della parusia, nel senso che dava per scontato ch'essa avrebbe coinciso col giudizio universale della fine dei tempi.
In questa lettera la contestazione è molto precisa e pertinente alla mancata parusia: Cristo può anche essere resuscitato dai morti, ma, non essendo tornato, non è possibile esserne sicuri (la tomba vuota non è una prova sufficiente), né, tanto meno, si può esserlo nei confronti della propria resurrezione finale. Quindi a che pro continuare a credere in una cosa che nel presente non è di alcuna utilità?
Ed è qui che il cristianesimo inizia davvero ad arrampicarsi sugli specchi e ad assumere un risvolto politicamente molto conservatore. Una cosa infatti era predicare un'interpretazione mistificata della tomba vuota nell'illusione di una parusia imminente; un'altra invece è quella di sostenere che se il Cristo non è risorto, allora tutto quello che lui ha fatto in vita è stato illusorio. «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini» (15,19).
La falsità più profonda del cristianesimo sta proprio in questo, che piuttosto che attribuire ai discepoli del Cristo il torto di non aver saputo proseguire il suo progetto di liberazione nazionale, si è preferito sostenere una cosa falsissima, e cioè che l'obiettivo principale del Cristo era quello di vincere la morte fisica (simbolo del peccato originale), al punto che se questa vittoria non fosse stata certa, tutto quanto venne fatto prima della croce andrebbe considerato illusorio.
Detto altrimenti: su questa terra non esiste un valido motivo per impegnarsi politicamente e umanamente, poiché, se il miglior popolo della storia, l'ebraico, non è stato capace di riconoscere il miglior messia che abbia mai avuto, cosa potranno mai fare i popoli pagani? Chi mai riuscirà a comportarsi meglio del Cristo, che è addirittura risorto da morte? L'unico motivo per cui valga davvero la pena vivere e morire è quello di sostenere, in nome di Cristo risorto, che la vita su questa terra non vale nulla rispetto a quella che si deve attendere nei cieli. Il cristiano deve vivere per morire, poiché morire significa rinascere a una vita sicuramente migliore.
Il tradimento del cristianesimo petro-paolino sta proprio in questo, che non solo si rifiutò di fare autocritica, ma si arrivò anche a ipotizzare che se la resurrezione non fosse stata il motivo fondamentale della venuta di Cristo, allora egli stesso sarebbe falso e dio non esisterebbe. Una volta interpretata la tomba vuota come «resurrezione», non è più possibile tirarsi indietro, se si vuole restare seguaci del Cristo, neppure di fronte alla mancata parusia imminente; anzi, bisogna con fermezza sostenere che se lui è risorto, chiunque dovrà esserlo e che il problema della liberazione definitiva va necessariamente rimandato al solo aldilà, cioè al momento dell'apocatastasi.
Se il Cristo non torna a risolvere il problema del male sulla terra, significa che il male su questa terra non può essere risolto. È esattamente così che il cristianesimo, da centro di predicazione delle illusioni, è diventato la principale fucina della rassegnazione mondiale. Dopo aver racchiuso tutto il senso della liberazione proposta dal Cristo nell'evento della tomba vuota, per il quale la liberazione politica dalla schiavitù sociale è stata fatta coincidere con la liberazione spirituale dalla morte fisica (segno della liberazione metafisica dal peccato d'origine), si è fatta di questa liberazione astratta, idealistica, la morte di ogni speranza terrena, rinchiudendo tutto il genere umano, sino alla fine dei tempi, nella stessa tomba che fu di Cristo, in attesa che solo lui torni ad aprirla. «Poiché se a causa di un uomo [Adamo] venne la morte, a causa di un uomo [Cristo] venne anche la resurrezione dei morti» (15,21). «Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo» (15,32).
Sono affermazioni, queste, davvero incredibili, che vanno ben oltre il cinismo di certi filosofi greci, e fa specie che la stragrande maggioranza degli esegeti confessionali non abbiano avuto dubbi nell'attribuirle a Paolo in persona. Come minimo, infatti, di fronte a chi gli contestava la tesi della resurrezione, Paolo avrebbe dovuto dire che «il bene va comunque compiuto proprio per cercare di stare bene». Compierlo non perché convinti della sua utilità, ma solo nella speranza di ricevere un premio ultraterreno, dovrebbe essere considerato indegno (perché utilitaristico) da parte di qualunque etica, laica o credente che sia. Con una filosofia di vita del genere Paolo avrebbe fatto un passo indietro persino rispetto alla legge mosaica.
La lettera viene conclusa con la richiesta di fare una colletta per la comunità di Gerusalemme, ma questo sarà argomento della lettera successiva.
(torna su)13) Seconda lettera ai Corinzi
Verso la fine del suo soggiorno efesino, Paolo aveva inviato a Corinto il discepolo Tito (in 1Cor 4,17 e 16,10 si parlava in realtà di Timoteo, il quale forse andò a Corinto senza ottenere risultati significativi), probabilmente per organizzare al meglio la racconta dei fondi da inviare alla comunità di Gerusalemme.
Paolo aveva bisogno di non rompere i rapporti con la chiesa-madre israelitica, che lo titolava a svolgere la sua missione tra i pagani (per quanto lui avesse iniziato autonomamente) e che, s'essa avesse visto buoni risultati, lo avrebbe difeso dai cristiani di origine ebraica, che spesso lo contestavano per il fatto di mettere sullo stesso piano giudei e gentili.
Terminata la missione a Corinto, Tito avrebbe dovuto recarsi nel luogo dove avevano convenuto d'incontrarsi: Troade. Tuttavia la rivolta degli argentieri (At 19,23 ss.) aveva costretto Paolo ad anticipare bruscamente la sua partenza da Efeso, per cui, arrivato a Troade, non poté trovare Tito, sicché preferì andargli incontro in Macedonia.
Ottenute notizie sulla situazione interna alla comunità corinzia, Paolo pensò, prima di recarsi a trovare i suoi amati e odiati discepoli (taciuti stranamente dagli Atti), di farsi precedere da questa lettera, una parte della quale fu dunque scritta in Macedonia, probabilmente a Filippi, tra il 57 e il 58.
Che cosa sia accaduto fra la prima e la seconda lettera non lo sappiamo: gli Atti non ne parlano e non potrebbero farlo, perché tendono sempre a minimizzare. Di certo avvenne qualcosa di molto spiacevole per Paolo, altrimenti risulterebbe poco chiaro il motivo per cui in questa lettera si respiri un clima di tensione quasi bellica. Si può forse presumere che l'incestuoso, scomunicato nella precedente lettera, l'abbia in qualche modo offeso gravemente (2,5-8; 7,12), benché lo stesso Paolo si limiti a pretendere un gesto riparatore da parte della comunità, in segno di obbedienza (2,5-11).
In verità ciò che lo preoccupava di più sembra essere l'atteggiamento dei cosiddetti «superapostoli» o «pseudo-apostoli», cioè di quei mestatori giudaizzanti che rischiavano di screditarlo in maniera irreparabile. Egli aveva assolutamente bisogno di recarsi a Corinto per sistemare faccende delicate, che riguardavano la sua stessa persona.
I
Anche questa epistola, come la precedente, contiene parti autentiche e parti manomesse o interpolate dai suoi discepoli. Le difficoltà più largamente riconosciute riguardano le tre seguenti pericopi: 6,14-7,1; cap. 9; cc. 10-13.
La prima interrompe, senza motivo, l'esortazione iniziata in 6,13 e proseguita in 7,2. La seconda è un doppione del cap. 8, salvo il contrasto tra la generosità dei Macedoni (per la colletta) e la tirchieria dei Corinzi, che pur sono più benestanti. La terza riflette circostanze fuori contesto rispetto al contenuto specifico della lettera.
Non pochi esegeti han ritenuto di vedere sintetizzate in questa epistola almeno cinque o sei lettere diverse. Si è anche pensato che i capitoli 10-13 siano stati scritti prima dei capitoli 1-9 e che rappresentino quella famosa lettera scritta «tra molte lacrime», di cui si parla in 2Cor 2,3 e che non ci è mai pervenuta.
Come in quella ai Galati anche in questa manca, nella parte iniziale, il consueto ringraziamento alla comunità destinataria. La missiva, di regola, viene suddivisa dagli esegeti in tre parti distinte: la prima è spiccatamente apologetica (1,12-7,16); la seconda è esortativa, in quanto dedicata alla preparazione della colletta (8,1-9,15), ch'era già stata avviata l'anno precedente; la terza è vivacemente polemica (10,1-13,10), difficilmente attribuibile a Paolo.
II
Gli avversari giudaizzanti lo accusavano d'incostanza nei propositi, in quanto aveva varie volte rimandato il viaggio a Corinto; di mancanza di sincerità e di maniere dispotiche nell'agire. Da quest'ultima accusa si difende dicendo che ogni credente, volendo, può diventare «apostolo», non essendo questo un ministero esclusivo di nessuno. Si diventa apostoli se si è pronti anche a morire per la verità.
Gli stessi avversari, anche se non ben chiariti, vengono sferzati in maniera minacciosa, ironica e sarcastica nella terza parte della lettera. A sua difesa (ma è già un suo discepolo che qui scrive) ricorda le innumerevoli e incredibili sofferenze che ha dovuto patire (bastonature, flagellazioni, naufragi...), molte di più di quelle raccontate negli Atti e in tutte le sue lettere; e riporta due eventi del tutto mistici, chiaramente inventati, come il rapimento al terzo cielo (di 14 anni prima) e il misterioso «pungolo nella carne» che gli avrebbe conficcato un demone per schiaffeggiarlo.
Su questa famosa spina le interpretazioni sono state, nei secoli, diversissime: epilessia, febbri maltesi, oftalmia acuta ecc. In realtà l'autore di questi ultimi capitoli ha soltanto voluto esagerare le cose, volendo far passare Paolo per un santo, per un cristiano assolutamente eccezionale. Forse è addirittura da escludere che questi passi avessero come destinatari i Corinzi, anche perché non sarebbe certo stato in questa maniera ch'egli avrebbe potuto superare quel momento di grave crisi.
I Corinzi erano di origine pagana e credevano, come tutti i pagani, in fenomeni sovrannaturali: non è da escludere che qualche suo discepolo, dopo la morte di Paolo, abbia inserito questi testi nell'epistola per attribuire all'apostolo, la cui autorità - diceva egli stesso - non proveniva da quella dei Dodici ma direttamente da Cristo risorto, apparsogli personalmente sulla via di Damasco, quegli elementi che potevano servire per beatificarlo e santificarlo.
In effetti, se si può anche credere che Paolo avesse un qualche, penoso, disturbo di tipo fisico o psico-somatico, di cui mise a conoscenza qualche suo discepolo, è però certamente da escludere che si potesse metterlo in relazione con un evento di tipo mistico, altrimenti saremmo costretti a ritenere Paolo un soggetto mentalmente disturbato. Una cosa infatti è sostenere posizioni mistiche per negare al Cristo una qualunque caratterizzazione politica; un'altra è fare di tali posizioni un attributo per favorire il culto della propria persona.
Peraltro la pericope del suddetto rapimento mistico (12,1-10) ricorda troppo da vicino la versione, non meno leggendaria, che la comunità primitiva volle dare circa la repentina conversione al cristianesimo petrino da parte dell'apostolo. Quando si cominciò a sostenere che Paolo in persona era stato oggetto di un intervento miracoloso da parte di Cristo risorto, non ci volle poi molto a rincarare questa tipologia d'interventi, mutandone solo qualche particolare di secondaria importanza. Gli stessi Atti degli apostoli non hanno avuto scrupoli nell'attribuire a lui e a Pietro straordinarie azioni terapiche a imitazione del Cristo taumaturgo.
III
La sofferenza per Paolo è sicuro segno di verità della propria fede. Esordisce così nella lettera e spera che su questo aspetto preliminare e fondamentale lo capiscano subito. Paolo e i suoi discepoli (in questo caso viene citato Timoteo) possono considerarsi superiori a qualunque credente di Corinto, proprio perché soffrono più di chiunque altro. E naturalmente ne approfitta per esibire l'esempio più eloquente di cui fino a quel momento poteva disporre: la rivolta degli argentieri di Efeso. Ma, poiché ne aveva già parlato in 1Cor 15,32, qui si limita a ribadire che in quel frangente quasi rischiava la vita.
Proprio per le tribolazioni patite (anche a favore della comunità corinzia), si meraviglia che venga accusato di non essere di parola, soltanto perché aveva promesso di andarli a trovare e non l'aveva fatto. Avrebbero dovuto anzi pensare che dovevano esserci gravi motivi. Ora infatti li spiega, seppur con ampi giri di parole che già fanno pensare a interventi redazionali successivi. Egli non era andato a trovarli perché era stato offeso amaramente da qualcuno, durante una sua breve visita, dopo aver scritto la prima lettera canonica giuntaci. È vero che aveva promesso che sarebbe tornato per restarvi più a lungo, ma un nuovo incidente, in cui l'autorità di Paolo era stata, questa volta, offesa nella persona di un suo rappresentante (2Cor 5,10; 7,12), l'aveva indotto a sostituire alla visita una severa lettera (2,3 s.), che, a quanto pare, aveva prodotto un effetto salutare (7,8-13).
In Macedonia aveva appreso da Tito che la crisi era stata risolta (nel senso che il colpevole era stato punito), ed era stato appunto allora che aveva preso a scrivere questa nuova lettera, raccomandandosi di non esagerare nelle punizioni, affinché il colpevole non si perdesse. Da Corinto poi si recherà a Gerusalemme, dove verrà arrestato dai giudei, pur sapendo egli benissimo che non vedevano l'ora di farlo.
Che Paolo considerasse i cristiani provenienti dal giudaismo come i nemici più pericolosi, è ben evidente, nella lettera, anche quando paragona Cristo a Mosè. I giudei, secondo lui, non riescono a vedere che il giudaismo è finito e continuano a restare legati alla legge mosaica, senza rendersi conto che anche il più piccolo cristiano è superiore a Mosè, come alla legge è superiore l'amore, e all'interpretazione letterale della legge la libertà dello spirito.
Tuttavia, per dimostrare questa superiorità, offre una lettura rovesciata di Es. 34,33 s., smentendo quella tradizionale secondo cui Mosè s'era coperto il volto perché troppo splendente rispetto alla pochezza di fede degli israeliti. Per Paolo invece egli se lo coprì per non mostrare la gloria effimera del suo volto. Il velo dunque viene interpretato negativamente e messo in relazione alla cecità dei giudei a lui contemporanei, che non sanno leggere l'evento-Cristo in chiave mistica.
È dubbio però che Paolo abbia potuto fare un ragionamento così contorto a un target di origine pagana. È anzi probabile che tutto il cap. 3 sia stato interpolato dallo stesso Timoteo. Le autentiche parole di Paolo sono sicuramente quelle riferite alla sofferenza, ch'egli metteva sempre in primo piano, per avvalorare la sua attività missionaria.
Anche in questa lettera infatti è abbastanza evidente ch'egli non vede l'ora di morire martire, sicché tutte le tribolazioni che patisce non fanno che rallegrarlo, in previsione di ciò che a Gerusalemme gli potrà accadere, avendo intenzione di consegnare di persona la colletta raccolta.
La morte è l'accesso a una dimensione ultraterrena, ch'egli s'immagina in una maniera di tipo «giuridico»: «Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male» (5,10). Difficile vedere in questa scena oltremondana qualcosa di molto diverso da ciò che p.es. avevano già detto gli egizi alcune migliaia di anni prima.
Tutta la teologia paolina è un connubio tra legalismo (o giuridicismo) e mistica: «Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe... Colui che non aveva conosciuto questo peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio» (5,19 ss.).
Cristo dunque come vittima sacrificale per le colpe degli uomini, affinché queste colpe, che gli uomini da soli non possono espiare, non finiscano per distruggere l'intero genere umano. Siamo riconciliati con dio per sua grazia, non per nostro merito; tuttavia noi, non essendo in grado di recuperare l'innocenza primordiale, siamo destinati all'autodistruzione, se non accettiamo con fede la grazia ricevuta. Che poi Cristo abbia accettato il proprio sacrificio per dovere o in libertà, non fa molta differenza: i fatti dimostrano che gli uomini non potevano che ucciderlo, essendo incapaci, da soli, di compiere qualunque vero bene.
Che in questa visione teologica della storia umana vi sia del paternalismo autoritario e insieme moralistico è molto evidente. Praticamente dio-padre non può distruggere l'umanità solo perché essa è stata voluta dal dio-figlio; però, per poterla perdonare di tutte le sue nefandezze, si sente in dovere di chiedere al figlio di pagare il prezzo d'averla voluta creare. E il figlio, che, nonostante tutto, non s'è pentito d'averla creata, accetta di sacrificarsi, nella speranza che gli uomini capiscano che dio-padre li ha perdonati.
Come si può notare, tra cristianesimo e mitologia pagana non vi è molta differenza.
IV
La seconda parte dell'epistola - come già detto - riguarda la questione dell'organizzazione della raccolta di fondi a favore della comunità di Gerusalemme. Probabilmente la colletta non aveva solo lo scopo di assistere i bisognosi della città santa (sotto questo aspetto sarebbe parso strano chiedere soldi a comunità, come quelle macedoni, che nella lettera vengono considerate molto povere), ma doveva anche servire a indurre soprattutto i giudeo-cristiani a considerare i pagano-cristiani al loro stesso livello. Lo stesso Paolo aveva bisogno di farsi accettare, senza riserve, dalla comunità gestita da Giacomo il Minore per avere ampie possibilità di manovra coi giudei della diaspora, da cui, di regola, partiva la sua predicazione.
Quindi era una colletta con finalità forse più politica che economica. Dimostrando che le sue comunità di origine pagana riconoscevano una sorta di primato d'onore a quella di Gerusalemme, Paolo avrebbe sicuramente potuto muoversi nell'ambito della diaspora con molta più facilità. Egli però sapeva bene che gli ebrei in generale, soprattutto quelli non simpatizzanti per il cristianesimo, condividevano assai poco i contenuti della sua predicazione, giudicati politicamente disfattisti, sicché egli non poteva non mettere in preventivo che, una volta giunto a destinazione, avrebbe potuto essere immediatamente denunciato. Col pretesto della colletta egli sembra voler andare incontro a un destino fatale.
In questa lettera dunque Paolo chiede che la raccolta di fondi venga organizzata da Tito (e forse anche da Timoteo), la cui onestà era unanimemente riconosciuta. A dir il vero qui parla di un «fratello» che «ha lode in tutte le chiese a motivo del vangelo... designato dalle stesse chiese come nostro compagno in quest'opera di carità... onde evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata» (8,18 ss.).
Molto strano il silenzio sul nome di questo delegato in una lettera che doveva rassicurare i Corinzi che la colletta si sarebbe compiuta rispettando i crismi della migliore onestà. Chi poteva essere un uomo così popolare se non Timoteo? Peraltro Paolo sembra parlare di un «terzo compagno» (anch'egli anonimo), disposto a unirsi agli altri due (8,22). Non è da escludere che tutto questo anonimato fosse una misura precauzionale, per non mettere a rischio l'incolumità di tali delegati nei confronti di possibili aggressori. A meno che non si sia voluto citare il nome di Timoteo perché, probabilmente, è il principale protagonista delle manipolazioni di questa lettera.
V
Nel cap. 8 (e nel suo duplicato aggiunto subito dopo) è delineato il modo che Paolo aveva di affrontare la questione economica della giustizia sociale.
Per convincere i Corinzi a non essere gretti nel dare, Paolo fa notare loro la generosità delle chiese macedoni, che sono più sofferenti e più povere di loro. Nella visione dell'apostolo (e ovviamente dei suoi discepoli) non c'è la volontà di affrontare in maniera oggettiva il bisogno, le contraddizioni sociali: semplicemente la munificenza doveva partire da una sorta di senso di colpa. Ecco perché fa notare ai Corinzi che le chiese macedoni avevano già dato «anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi» (8,3-4). In sostanza Paolo si serviva dei seguaci più ingenui per convincere quelli più sospettosi.
Ed è altresì verosimile che s'egli aveva bisogno di ricorrere a questi espedienti per convincere i Corinzi a essere più altruisti, significa ch'essi avevano poca intenzione di aiutare una comunità che faceva pesare su tutti la propria importanza e che considerava i cristiani d'origine pagana dei convertiti di seconda categoria. La cosa strana è che lo stesso Paolo, più avanti, ricorda ai Corinzi che l'anno prima erano stati proprio loro a proporre un'iniziativa del genere e li critica, seppur velatamente, di non aver concretizzato le loro intenzioni. Non è da escludere ch'essi avessero avuto l'idea della colletta per dimostrare che non si sentivano inferiori a quei cristiani d'origine giudaica che sul piano etico li guardavano con un certo distacco, e poi magari, col passar del tempo, s'erano pentiti d'averla avuta.
Paolo stuzzica la vanità dei Corinzi dicendo loro che son bravi in tutto, al fine d'indurli a esserlo anche «in quest'opera generosa» (8,7). Non vuole obbligarli a fare alcunché, anche perché sa che non ne avrebbe la forza, essendo un apostolo itinerante, non un dirigente in pianta stabile; vuole soltanto mettere alla prova «la sincerità del loro amore con la premura verso gli altri» (8,8). Sapeva bene che quando si chiede di fare elemosine, bisogna toccare per forza i sentimenti.
D'altra parte non chiede sacrifici molto onerosi: «la buona volontà riesce gradita secondo quello che uno possiede» (8,12), cioè in rapporto alle proprie sostanze. «Qui non si tratta di mettere in ristrettezze voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza» (8,13). L'uguaglianza appunto della carità fraterna, che non va a toccare i gangli vitali dei rapporti produttivi, ma soltanto i sentimenti, per una soluzione che ovviamente più che transitoria non poteva essere. Del tutto irrisolto, anche perché neppure sfiorato alla sua radice, restava infatti il problema dello sfruttamento del lavoro altrui, che in Israele, peraltro, si univa a quello dell'oppressione nazionale a causa della dominazione straniera.
L'uguaglianza che cerca Paolo è puramente morale, in quanto sul piano economico è contingente a una situazione di particolare necessità, che di lì a qualche tempo si sarebbe certamente ripresentata. Egli vuole indurre i Corinzi a essere generosi perché un giorno potrebbero esser loro stessi ad aver bisogno dell'aiuto altrui, senza poi considerare - aggiunge l'apostolo - che la concessione di un aiuto economico potrebbe essere ricambiata, da parte di chi lo riceve, con un aiuto di tipo extra-economico, come può essere p.es. quello morale o culturale o ecclesiale.
E Paolo sa bene quanto potrebbe servire, anzitutto alla sua predicazione, la decisione che la comunità di Gerusalemme potrebbe prendere di dargli carta bianca anche nei confronti degli ebrei della diaspora, non tanto per poterli convertire (anche per questo naturalmente), quanto piuttosto per essere relativamente sicuro che la loro opera spionistica, delatoria e intrigante non influisca sulla considerazione che a Gerusalemme hanno di lui.
Nel cap. 9, che, come già detto, è stato aggiunto, si fa notare che le chiese macedoni sono migliori, nella generosità, di quelle dell'Acaia, tra cui appunto va annoverata Corinto. E la cosa s'andava, a quanto pare, diffondendo, mettendo in imbarazzo tutti i promotori (tra cui gli stessi Corinzi) e gli organizzatori della colletta.
Sembra che dal cap. 8 al cap. 9 sia passato un certo tempo, in cui i Corinzi han potuto dar prova non della loro generosità bensì della loro «spilorceria» (9,5). Da notare che Paolo dirà più avanti, in 11,8 ss., d'essere stato, diversamente che in Acaia, economicamente mantenuto dalle chiese macedoni quando predicava da loro.
In ogni caso il cap. 9 non aggiunge elementi significativi alla concezione di giustizia sociale espressa in quello precedente. Semmai anzi si può ravvisare un tono minaccioso, soprattutto là dove si fa osservare che «chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà» (9,6), poiché «Dio ama chi dona con gioia» (9,7): ecco perché al dono i Corinzi avrebbero dovuto sentirsi tenuti, visto che già ora hanno «il necessario in tutto» (9,8).
Si può forse dire che mentre il cap. 8 è più incentrato su motivazioni di ordine etico per sollecitare a compiere la colletta, il cap. 9 invece preferisce le motivazioni di ordine religioso, nel senso che la colletta andava anzitutto fatta per ringraziare dio, cosa di cui i cristiani di Gerusalemme avrebbero preso atto con molto favore.
VI
Gli ultimi tre capitoli (10-13) potrebbero essere intitolati «Apologia di Paolo», ma è ostico considerarli come facenti parte della stessa lettera. I toni sono completamente diversi. Di certo vi è la mano di Paolo, ma devono per forza essere stati scritti in un momento diverso e qui aggiunti per fare di due una sola epistola. Anche perché sarebbe poco logico pensare che una comunità così importante come quella corinzia abbia ricevuto da Paolo, che viaggiava di continuo, solo due o tre lettere al massimo.
Al cap. 10 Paolo fa capire a chi l'accusava che la durezza delle sue missive era incoerente con la remissività della sua persona e, ch'egli, se volesse, potrebbe esser duro anche quando è presente in mezzo a loro, ma un atteggiamento del genere - spiega loro - s'addice più a un «politicante» che non a un predicatore di idee mistiche.
Paolo non vuole rivendicare un ruolo di comando, neppure sul piano amministrativo, in quanto la sua battaglia è soltanto di tipo «teologico» e, in tal senso, vorrebbe essere lasciato libero di annunciare al mondo che il Cristo crocifisso è risorto.
Nel cap. 11 ribadisce di non essere un «profano nella dottrina» (v. 6), cioè di non temere confronti sul piano delle Scritture e di avere argomenti più che sufficienti per contrastare chi propaganda una cristologia diversa dalla sua. Qui mostra di avercela in particolare con quei cristiani di origine giudaica, da lui definiti «superapostoli» (v. 5), venuti dalla Palestina, che evidentemente erano rimasti legati alle posizioni di Pietro e di Giacomo il Minore, o che forse, addirittura, riflettevano le posizioni rivoluzionarie dei fratelli Zebedeo. Essi, probabilmente, si facevano mantenere dalla stessa comunità di Corinto e da qui controllavano l'operato di Paolo, il quale non rimprovera loro nessun errore specifico, limitandosi a smascherare la loro vanità.
La comunità di Corinto apparteneva alla sfera d'azione di Paolo e lui qui non voleva intrusi. La sua idea infatti era quella di potersi servire di questi discepoli greci per andare a predicare a Roma e in Spagna. Ecco perché considera i cosiddetti «superapostoli» completamente «falsi» (v. 13), e lo dice con così grande sicurezza che non teme d'essere considerato «pazzo» (11,16).
Anzi è talmente infuriato che dice loro una cosa, che, per la sua importanza, meriterebbe d'essere ampiamente esaminata: «Voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate che vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, che vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna; come siamo stati deboli!» (11,19 ss.).
Quel «voi» sembra riferirsi esclusivamente ai cristiani giudaizzanti. Qui egli non sta parlando come «cristiano», ma come uno che si sta rivolgendo ai suoi compagni giudei d'un tempo, coi quali a Gerusalemme perseguitava i cristiani, che - secondo lui - avevano smesso di lottare contro Roma. Si sta riferendo all'incapacità che i farisei del suo partito avevano dimostrato di lottare uniti contro l'oppressione romana; sta condannando duramente l'illusione di poter continuare a restare «ebrei» nonostante il nemico in patria e la corruzione dei collaborazionisti. Quel che non sopportava più era l'idea di poter sostenere un primato d'Israele di fronte a un nemico che lo distruggeva quotidianamente.
È come se avesse detto che la sua cristologia mistica è stata una conseguenza della sconfitta politica dell'ebraismo tradizionale e nazionalistico, in cui lui stesso aveva tenacemente creduto. Ecco perché ora non si sente affatto in soggezione nei confronti di quei giudei che lo vogliono contestare per cose che in coscienza lui ha già largamente superato. Anzi, a causa delle sofferenze subite (qui ampiamente esagerate, non foss'altro perché aveva la cittadinanza romana), si sente di gran lunga migliore di loro: «Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese» (vv. 24-28).
Ora se si comporta o dice cose come se fosse pazzo, la colpa è degli stessi Corinzi - dice nel cap. 12 -, che invece di difenderlo, ascoltano i giudaizzanti, mostrandogli peraltro ingratitudine, in quanto lui non ha chiesto benefici economici a nessuno.
Questo capitolo in realtà è abbastanza squallido, poiché da un lato Paolo si vanta d'aver avuto visioni mistiche, estasi in cielo, prove di queste esperienze divine offerte da una misteriosa «spina nella carne» (12,7), e di aver compiuto anche «segni, prodigi e miracoli» (12,12); dall'altro si meraviglia che non credano più al suo vangelo, quando lui non è stato di peso a nessuno, non li ha sfruttati per mezzo di qualche suo delegato (12,16 s.).
Difficile pensare che argomentazioni così fantasiose e politicamente deboli siano venute fuori dalla penna di Paolo. Esse piuttosto denunciano una situazione critica nell'ambito della comunità corinzia, successiva forse alla morte dello stesso Paolo, probabilmente nell'imminenza della prima guerra giudaica antiromana.
Peraltro lo stesso capitolo, nella parte finale, sposta arbitrariamente l'oggetto dell'argomento dalla lotta ideologica tra Paolo e i giudaizzanti al rischio che Paolo, quando arriverà in città, si debba umiliare vedendo i Corinzi ancora alle prese con «impurità, fornicazione e dissolutezze» (v. 21). È un avvertimento dal sapore minaccioso, con cui si fa capire che se le conversioni al suo vangelo si mostravano ancora così instabili, si rischiava un'insanabile rottura.
Il cap. 13, l'ultimo, conferma l'intenzione dell'apostolo di recarsi a Corinto per chiarire definitivamente i suoi rapporti con quella comunità: «quando verrò di nuovo [e sarebbe stata la terza volta] non perdonerò più, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me» (vv. 2-3).
Pur con tutta la saggezza che a loro proveniva dalla imponente filosofia greca, i Corinzi non si rendevano conto - e Paolo qui glielo fa capire molto bene – che gli uomini non hanno «alcun potere contro la verità» (v. 8). Infatti l'unica cosa che si può fare è quella di trovare argomentazioni per difenderla.
(torna su)14) Lettera ai Colossesi
La lettera ai Colossesi precede di poco quella agli Efesini, in quanto entrambe furono affidate, per la consegna alle rispettive comunità, a Tichico, ed è almeno di cinque, sei anni successiva a quella indirizzata ai Romani.
Colosse (oggi Çürüsku) era una città della Frigia (nell'odierna Turchia) sulla riva sinistra del Lico, a sud-est di Laodicea, da cui distava circa 25 km. Fu proprio quest'ultima, fondata da Antioco III Teo (261-246 a.C.), ad assorbirne quasi totalmente i commerci, ch'erano molto floridi a motivo della posizione strategica nell'area geografica che univa la metropoli Efeso all'Eufrate.
Oggi di Colosse non restano che ruderi, anche perché la regione vulcanica è stata colpita più volte da gravi terremoti, uno dei quali, nel 60-62 d.C., la distrusse quasi completamente.
La comunità cristiana non era stata fondata personalmente da Paolo, ma da un certo Epafra, non prima del 54-55, il quale doveva essere in stretti rapporti con lui, poiché nella lettera Paolo scrive in maniera autorevole, come se la comunità fosse stata una propria creatura.
È molto probabile che Colosse venne evangelizzata, insieme a Laodicea, durante il triennio del terzo viaggio missionario che Paolo dedicò alla regione turca che allora si chiamava «Asia» (cfr At 19,1-20,1). Tuttavia Colosse non fu da lui visitata personalmente, proprio perché nella stessa lettera viene detto che i cristiani fino a quel momento non l'avevano mai visto (2,1).
Dunque Colosse fu evangelizzata da Epafra, che aveva ascoltato Paolo a Efeso, mentre parlava o nella sinagoga o nella scuola di Tiranno (cfr At 19,1-8; 19,9), e che, per questa ragione, aveva ricevuto da lui il titolo di «ministro di Cristo» (1,7).
La comunità doveva essere composta prevalentemente di pagani convertiti, come di regola era nelle comunità paoline. Che Paolo l'abbia visitata, tra la prima e la seconda prigionia, non è improbabile, visto che in 2Tim 4,20 dichiara d'essere stato a Mileto. Ma è non meno probabile che, dopo la morte di Paolo, Colosse sia passata sotto l'influsso dell'apostolo Giovanni, che politicamente gli era molto ostile, in quanto favorevole all'insurrezione anti-romana. Di questa comunità, tuttavia, non si saprà più nulla, se non che dalle sue rovine fu costruito, a 4 km di distanza, il villaggio Chonai (oggi Khonas).
Il motivo della lettera dipese da una relazione che Epafra fece a Paolo prigioniero sullo stato di quella comunità neo-convertita. Evidentemente Epafra sentiva di non avere sufficiente autorevolezza per risolvere i problemi riscontrati.
Di che problemi si trattassero, però, non è dato sapere con precisione. Considerando che gli eretici doceti, come Valentino e Marcione, abusarono della lettera a sostegno delle proprie tesi, si può pensare che la questione fondamentale fosse di natura cristologica. Anche perché proprio in questa lettera Paolo si spinge a fare considerazioni altamente metafisiche, seppur espresse in forma molto sintetica, sulla figura di «Cristo-Capo», che è insieme «pienezza» (pleroma) della divinità, dell'umanità redenta e dell'intero universo.
I
In questa lettera appare in maniera molto evidente che il semplice accostamento della parola «dio» alla persona di «Gesù Cristo» ha permesso a Paolo di ottenere due risultati, per lui molto rilevanti: togliere al paganesimo il proprio politeismo e all'ebraismo il proprio nazionalismo.
Paolo infatti quando usa la parola «dio» nella forma pagana, le dà un contenuto ebraico favorevole al monoteismo. Nel contempo però il «Gesù storico» lo riduce a un «Cristo teologico», facendogli perdere qualunque riferimento alle vicende politiche della Palestina.
Il cristiano diventa dunque, nella teo-logia e cristo-logia paoline, il pagano che rinuncia alla religione pagana o, più raramente, l'ebreo che rinuncia alla politica ebraica (più raramente perché era il pagano a essere più abituato a credere in miti e leggende, per cui gli era sicuramente molto più facile accettare una ulteriore «divinità» che muore e risorge, seppur questa volta con pretese di attendibilità storica. Quanto agli ebrei, certamente anch'essi credevano in miti e leggende, ma questi dovevano appartenere a una coscienza di popolo e non alla mente di qualche intellettuale fantasioso).
Il cristianesimo paolino era la negazione della vera storicità (umana e politica) del Cristo e, nel contempo, era la progressiva ateizzazione della religione pagana, che, prima di diventare cristiana, doveva arrivare a distruggere tutti i propri dèi, sostituendoli con uno solo, dio-padre, il cui figlio unigenito partecipa della sostanza divina, essendo risorto da morte certa (nella prima lettera ai Corinti Paolo parlerà anche dello «spirito» come di una «sostanza divina» distinta da dio-padre).
Non avrebbe avuto senso per Paolo andare a predicare, al di fuori della Palestina, l'ennesimo messia morto crocifisso per colpa dei romani imperialisti. Il fatto stesso di uscire da Israele come profugo, per andare a predicare in maniera pacifica e non per ottenere consensi di tipo politico, stava ad indicare che Paolo aveva smesso di credere nella possibilità di liberare la sua nazione dalla colonizzazione imposta da Roma.
Nel momento stesso in cui smette di perseguire i cristiani e inizia a predicare a loro favore, Paolo si sentiva politicamente sconfitto, tant'è che ribadisce subito ai Colossesi che la loro speranza potrà realizzarsi solo «nei cieli» (1,4). Il cristianesimo veniva predicato da Paolo non ai casi disperati, cioè ai ceti più marginali, che, non avendo nulla da perdere, potevano anche essere disposti a comportamenti eversivi, ma a quei ceti sociali relativamente benestanti (artigiani, commercianti, piccolo-borghesi) che da un lato temevano il peggioramento della loro condizione economica e, dall'altro, non avevano sufficiente coraggio per riscattarsi in maniera politica.
Paolo non avrebbe mai potuto avere dietro di sé un popolo pronto all'insurrezione, anche se ciò, nel periodo in cui lui predicava, sarebbe stato relativamente facile, tant'è che persino talune sue idee teologiche (uguaglianza di fronte a dio, esistenza di un unico dio, insussistenza della divinità degli imperatori, separazione di chiesa e stato...) apparivano rivoluzionarie. Il suo target preferito erano le famiglie, quando poteva le sinagoghe e, quando vi era costretto dalle circostanze, i tribunali.
Paolo è progressista quando predica un'idea cristologica per negare valore a qualunque divinità, ivi inclusi gli imperatori, che proprio allora iniziavano a compiacersi di un culto religioso rivolto alla loro persona (cui bisognava prestare sacrifici come a una statua raffigurante un dio) e che, in ogni caso, si fregiavano del titolo di «pontefice massimo», servendosi della religione come di un proprio strumento per regnare. Ma egli è anche conservatore quando usa la stessa cristologia per sostenere che attraverso la morte e resurrezione gli uomini sono stati riconciliati con dio e più di nulla hanno bisogno se non di credervi.
Paolo fa un'operazione intellettuale che è nel contempo culturalmente avanzata e politicamente reazionaria. Fa un passo avanti rispetto a Pietro, ancora legato alle tradizioni politiche dell'ebraismo esclusivista (la prima delle quali era il nazionalismo), ma fa due passi indietro rispetto a Cristo, che voleva liberare politicamente la nazione ebraica dall'oppressione di Roma, col concorso di tutte le forze sociali, culturali, etniche e tribali della regione.
II
Se, leggendo le lettere di Paolo, si portano alle estreme conseguenze le sue parole, com'egli fece in relazione alle due tesi di Pietro sulla «morte necessaria» del Cristo e sulla sua «resurrezione», si arriva alla conclusione che dio può anche non esistere.
Infatti, se tutto quello che Paolo ha detto di Cristo è vero, e cioè che «in lui tutte le cose furono create: quelle celesti e quelle terrene, le invisibili e le invisibili, siano troni o signorie, principati o potestà» (1,16), allora il fatto che esista o non esista dio è del tutto irrilevante per l'essere umano; nel miglior dei casi è un problema che riguarda solo il Cristo.
Cioè l'idea di dio potrebbe appunto essere soltanto un'idea, un'espressione linguistica indicante l'umana perfezione, quella che col tempo s'era andata perdendo e che il Cristo ha cercato di recuperare, pagando di persona. Nulla quindi vieta di pensare, indipendentemente da qualunque considerazione di tipo religioso, che il suo messaggio potrebbe anche essere stato, semplicemente, quello di far capire agli uomini che non possono rinunciare ad essere se stessi, cioè umani, e che se anche eliminano chi pone loro il problema, questo, inesorabilmente, si ripresenterà.
A quel tempo la «perfezione umana» veniva chiamata «dio»; oggi la possiamo chiamare «essere» o «essenza umana». Gli esseri umani devono soltanto riconciliarsi con loro stessi, devono porsi il compito di diventare quel che sono veramente, quel che erano in origine e che dovranno tornare ad essere in futuro. Non possono pensare di rimandare questo compito all'aldilà.
Se la speranza di essere se stessi non fosse realizzabile su questo pianeta, per quale motivo il Cristo si sarebbe lasciato crocifiggere? Perché non limitarsi a predicare come un filosofo che la salvezza non è di questo mondo? Per quale ragione occorreva necessariamente un sacrificio così cruento per riconciliare l'uomo con se stesso (o con dio, come diceva Paolo)? Possibile che dio abbia «desiderato» una morte così crudele e infamante? Perché far passare gli ebrei per un «popolo maledetto», incapace assolutamente di riconoscere il proprio bene e il bene di tutta l'umanità, quando a quel tempo se c'era un popolo che lottava per la propria liberazione nazionale, era proprio quello ebraico?
L'idea che Paolo aveva di un Cristo che deve versare il sangue per liberarci dal potere del male, il quale c'impedisce d'essere noi stessi (di riconciliarci con dio-padre, secondo la sua terminologia), è sicuramente un'idea che si ritrova in ogni religione sufficientemente evoluta, l'idea cioè di una «sofferenza che redime», che purifica; tuttavia questa è un'idea che resta appunto di tipo religioso, incapace di dare speranze sul piano pratico-politico. È un'idea che ricorda da vicino il rito solenne del giorno dell'Espiazione (Kippurim), quando, nel mondo ebraico, il sommo sacerdote, portando nel Santo dei Santi, il sangue delle vittime sacrificali, implorava da dio il perdono per i peccati di tutto il popolo d'Israele. E tutto finiva lì.
Si trattava appunto di un rito religioso, che non metteva in discussione il ruolo alienante della classe sacerdotale. Paolo non ha fatto altro che trasformare una simbologia religiosa, che nella sua patria doveva seguire un particolare cerimoniale, antico di secoli, in una teologia dal respiro universale, che per forza di cose, rispetto al giudaismo classico, doveva apparire come una sorta di «protestantizzazione».
L'inno cristologico (1,14-20) che riassume organicamente tutta la teologia paolina, e che è il tratto più dogmatico di tutta l'epistola, venne subito considerato, negli ambienti cristiani, di altissimo livello, al punto che qualche redattore se ne servì per scrivere buona parte del Prologo del quarto vangelo, facendo così chiaramente capire che i manipolatori di Giovanni provenivano da ambienti paolini.
III
La teologia di Paolo è una «teologia della morte», dove alla morte intesa come «disperazione sociale» (dovuta p.es. al fatto che si deve sottostare alla volontà di un conquistatore) si sostituisce la morte intesa come «riscatto morale», in quanto alla necessità di una «liberazione» si supplisce con l'idea di «resurrezione» di un cadavere, ritenuto, per questo motivo, sovrumano, in grado di sconfiggere qualunque nemico.
Il fatto che la carne «risorga» è, secondo Paolo, più che sufficiente per assicurare a chiunque la libertà, la soddisfazione di sé, l'autenticità del proprio essere, che è sinonimo di «verità della propria fede»: fede non nell'essere che è o che deve diventare nel presente, ma nell'essere che sarà nell'aldilà, poiché nel presente non è possibile alcuna vera liberazione.
Sotto questo aspetto «morire nella fede» è un grandissimo guadagno. La vita non vale nulla e non serve che a testimoniare la sua negazione, cioè il fatto che tutto è soggetto a morire.
Il cristiano non vede l'ora di morire, per poter dare della propria morte la testimonianza che la propria fede è vera. La sua vita è un'istigazione continua a compiere un delitto (anche se Paolo sostiene che se è bene che vi siano martiri, non è bene che vi siano persecutori), proprio perché il martirio è la conferma suprema della verità della propria fede. Il persecutore diventa l'ateo che non crede nell'aldilà o nelle verità della fede e che anzi aiuta il martire a rafforzarsi nel proprio convincimento. Il delitto viene fatto passare per «sacrificio espiatorio».
Paolo non può suicidarsi, poiché ciò sarebbe un atto evidente di disperazione. Il cristiano deve piuttosto trasformare la propria rassegnazione (a non poter realizzare il bene su questa terra) in un atto di eroismo, con cui dimostrare di non tenere in alcun conto i beni terreni, inclusa la propria vita.
Il suicidio va mascherato con un omicidio subdolamente provocato, artatamente indotto. Bisogna solo trovare un motivo sufficientemente valido, e Paolo lo trovò nell'asserzione secondo cui l'unico essere umano avente natura o proprietà divina è Gesù Cristo, per cui chiunque pretenda di porsi o proporsi nella stessa maniera è un truffatore, un anticristo, uno che non merita d'essere rispettato.
Questa dinamica dell'irrazionale si trova non solo nella teologia cristiana (cattolica o protestante che sia), ma anche in qualunque espressione religiosa della fede fanatica o fondamentalista, e persino in talune ideologie esclusiviste, totalitarie, tipiche di quelle dittature nelle loro fasi di inesorabile declino.
Nella teologia paolina la morte non viene più vista come un semplice momento di passaggio in cui una materia si trasforma in un'altra materia, ma viene caricata di un'enorme aspettativa di redenzione, proprio perché il credente si sente del tutto incapace di vivere la vita, di risolvere le contraddizioni sociali che la rendono insopportabile. La morte diventa il vero significato della vita, non la «morte-che-si-dà», ma la «morte-che-si-riceve».
Gli uomini che uccidono altri uomini sono quelli che non credono in un'altra vita; viceversa, gli uomini che si fanno uccidere, che vanno incontro volutamente al loro sacrificio, non fanno della morte un semplice passaggio da una vita a un'altra, ma ne fanno, se vissuta in questa maniera così «ideologizzata», il vero significato di tutta l'esistenza terrena, propria e altrui. Il problema non è più quello di come vivere al meglio la propria esistenza, ma quello di come vivere al meglio la propria morte manifestando la propria fede.
La politica cristiana raggiunge l'apice nella rinuncia volontaria a fare della propria vita un bene da valorizzare, da proteggere. La vita va odiata amando la propria morte, che introduce a una nuova vita, in cui non vi saranno gli effetti negativi del peccato d'origine.
Da notare che, di per sé, non è irrazionale l'idea di «sacrificio» come espiazione di una colpa personale o altrui; lo è però l'idea che nel sacrificio di sé fino al martirio possa racchiudersi tutta la vera liberazione umana. È irrazionale far credere al «mondo» che un certo modo di morire (da vittima sacrificale o da capro espiatorio) costituisca la suprema forma della verità della propria fede.
IV
In questa lettera non si parla solo di riconciliazione degli uomini con dio attraverso il sacrificio volontario del Cristo, ma anche di riconciliazione degli esseri umani con l'universo, cioè con la natura, come ulteriore effetto benefico di quel sacrificio.
Se togliamo la parola «dio», che è un'astrazione metafisica, sostituendola con la parola «uomo», il pensiero di Paolo viene ad assumere questa significativa trasformazione: l'uomo riconciliato con se stesso, si riconcilia anche con la natura. Cioè quando smetterà di considerare il prossimo come un nemico, anche la natura gli diverrà amica.
Oggi potremmo tranquillamente far nostro questo pensiero, in quanto il rapporto di grande sfruttamento nei confronti della natura è indubbio che sia nato col sorgere delle civiltà basate su rapporti sociali di tipo conflittuale. La natura ci è diventata «matrigna» nel momento stesso in cui l'uomo s'è trasformato in «lupo dell'uomo». Di qui l'esigenza (non naturale ma indotta da qualcuno) di trovare una mediazione astratta, una consolazione illusoria nei miti religiosi.
È altresì interessante notare che per Paolo l'intero universo è fatto per l'uomo: nessun'altra creatura, se non il Cristo, nel quale si ricapitola ogni cosa, può tenergli testa.
Basta poco per svolgere in maniera ateistica l'inno che Paolo dedica alle prerogative del Cristo (1,14-20). Infatti, là dove dice che «tutto fu creato per mezzo di lui e per lui, ed egli esiste prima di tutte le cose, e tutte le cose hanno consistenza in lui», non ci vuol molto per aggiungere che in realtà non esiste alcun dio e che nell'universo domina soltanto l'uomo, di cui il Cristo può essere considerato «prototipo», ovviamente in via del tutto ipotetica, e comunque solo per la parte maschile dell'umanità, poiché per quella femminile deve necessariamente esistere un prototipo equivalente, che la cultura maschilista delle civiltà antagonistiche ha progressivamente emarginato, se non addirittura rimosso.
Non può essere stato un caso che nel periodo storico antecedente alla formazione delle civiltà urbane, gli aspetti più significativi della comunità di villaggio attribuissero alla donna, proprio per la sua capacità riproduttiva, un'importanza decisiva per lo sviluppo del collettivo.
Una qualunque cultura ateistica che non mettesse il ruolo della donna sullo stesso piano di quello dell'uomo, non uscirebbe dalle secche della religione. Infatti in qualunque rappresentazione religiosa dell'aldilà, il ruolo maschile è prevalente, come lo è nelle civiltà che si danno delle rappresentazioni mistificate. Gli dèi, fra le altre cose, sono serviti anche per sottomettere la donna all'uomo. E dunque, se proprio si vuol fare della «metafisica», che si affermi con decisione che «in principio non vi è l'uno ma il due».
Cioè anche nel caso in cui si accettasse l'idea che il primato del Cristo-uomo nega qualunque riferimento a un'entità divina astratta, occorre però aggiungere che tale primato non gli è esclusivo, dovendo egli condividerlo, in maniera paritetica, con quello della donna, la quale, generalmente, nella tradizione cristiana più illuminata, veniva fatta coincidere, nell'analisi dei misteri cosiddetti «trinitari», con la figura dello «spirito», essendo questa parola, nella teologia ebraica, di genere femminile (ruah).
V
Prima di Paolo, in campo religioso, le alternative della fede erano solo due: o gli dèi venivano rappresentati attraverso statue, oggetti materiali, feticci, simboli di varia natura; oppure - come nel caso dell'ebraismo - non venivano rappresentati in alcun modo, poiché si pensava che qualunque rappresentazione fosse inadeguata, dato che si volevano applicare alla divinità due facoltà sovrumane come l'onniscienza e l'onnipotenza.
Con Paolo si forma in un certo senso un'originale sintesi: dio resta sì un qualcosa di «assoluto» (alla maniera ebraica), ma diventa pienamente visibile nel suo figlio unigenito, che ha dimostrato concretamente la propria divinità risorgendo per primo dalla morte, in attesa che tutti possano farlo il giorno del giudizio.
Ora, se si volesse proseguire questo ragionamento, si dovrebbe arrivare a superare lo stesso cristianesimo paolino: Cristo infatti, se davvero è risorto, non dimostra, solo per questo, l'esistenza di un dio; anzi, poiché quand'era in vita egli non fece nulla per dimostrare la propria divinità (e tutto ciò che nei vangeli presume di farlo, va considerato falso), gli uomini devono valutarlo per quello che di «umano» ha fatto. Nel caso in cui vi sia stato in lui qualcosa di «sovrumano», ciò va considerato alla portata dell'essenza umana in generale; in ogni caso il genere umano deve cercare di realizzare la propria umanità nell'ambito terreno in cui al momento è chiamato a vivere.
VI
In questa lettera vi è un punto in cui l'apostolo afferma di rallegrarsi delle proprie sofferenze, poiché in tal modo «supplisce», cioè «completa» quel che Cristo aveva personalmente sofferto (1,24): come se l'opera del Cristo fosse stata deficitaria di qualcosa. Che significano queste parole?
È molto semplice: Paolo qui non ha il mente il Cristo politico, il cui tentativo insurrezionale era fallito a causa del tradimento di Giuda e, successivamente, di Pietro, che fece della tomba vuota un pretesto metafisico per attendere passivamente la parusia trionfale di un messia redivivo. Paolo intende riferirsi al Cristo religioso, il cui messaggio, pur rivolto inizialmente agli ebrei, in realtà era destinato al mondo intero (cosa che, secondo Paolo, i suoi apostoli non riuscirono a comprendere, fermi com'erano alla convinzione che Israele potesse ancora fruire di un primato storico, cioè etico-politico, sulle altre nazioni pagane).
Paolo poteva così vantarsi d'essere stato il primo ad aver dato al cristianesimo un carattere universalista, una diffusione che andasse al di là di qualunque distinzione etnica, tribale, nazionale, linguistica, giuridica, sessuale, alimentare... Aveva perorato la causa della mondializzazione del cristianesimo proprio mentre negava al suo popolo il diritto di liberarsi politicamente dell'imperialismo romano. Cioè aveva dato per scontato che la Palestina non sarebbe mai riuscita a liberarsi dell'oppressione straniera e, per fortuna, fino al 70 nessuno gli credette, né gli ebrei ortodossi (giudei o galilei che fossero), né i cristiani di origine ebraica, anche se dopo la catastrofe del 70 (confermata dalla seconda del 135) gli ebreo-cristiani cominciarono a pensare che Paolo avesse ragione su tutti i fronti.
Paolo fu responsabile dell'idea secondo cui una liberazione politico-nazionale di Israele non sarebbe servita a diffondere in tutte le altre nazionalità oppresse dell'impero romano un'analoga istanza emancipativa. Questo è stato forse il suo peggiore errore di valutazione storica. Una cosa infatti è predicare che la tomba vuota implicava la sicura «resurrezione di un corpo»; un'altra che, in virtù di tale resurrezione, ci si dovesse attendere una più o meno imminente parusia trionfale del Cristo; un'altra ancora che, in assenza di tale parusia, il popolo ebraico dovesse rinunciare a qualunque resistenza armata nei confronti di Roma. Nella mistificazione interpretativa della tomba vuota, partita da Pietro, la comunità non fece che andare in crescendo.
Uno può anche avere idee bislacche su certi avvenimenti, di cui non riesce a spiegarsi completamente la dinamica, ma quando se ne serve per demotivare gli oppressi, non può pretendere, facendo leva sulle persecuzioni subite, d'essere creduto sulla propria buona fede. Paolo aveva finito col trasporre sul terreno del cosmopolitismo religioso la realizzazione mistificata di un'istanza politica che, pur trovando una battuta d'arresto con l'esecuzione del Cristo, non era affatto destinata a restare irrealizzata in Palestina.
Sotto questo aspetto l'analisi storico-politica ch'egli fa è completamente sbagliata. Egli infatti attribuisce alla decisione dei giudei di crocifiggere il Cristo la fine del primato d'Israele rispetto alle altre nazioni basate sull'antagonismo sociale, e quindi l'inizio dell'uguaglianza etico-religiosa dei pagani e degli ebrei di fronte a dio, di fronte al destino comune che li attende in nome di Cristo.
Così facendo, Paolo non teneva in alcuna considerazione il fatto che già nell'operato del Cristo s'era posto il problema del superamento del primato etnico dei giudei rispetto ad altre etnie palestinesi, come p.es. quella galilaica e quella samaritana. Non è affatto vero che l'idea di universalizzare la resistenza romana, prescindendo dalle differenze culturali, non fosse già presente nella propaganda politica del movimento nazareno.
Paolo poteva attribuirsi questo merito nei confronti degli apostoli che, dopo quel tragico venerdì di pasqua, aveva cominciato a tradire il messaggio di Cristo, ma non poteva certo attribuirselo nei confronti di chi non rispettava il sabato, le regole dietetiche, il primato del tempio, l'importanza delle sinagoghe, di chi frequentava malati e peccatori e di chi non aveva difficoltà a confrontarsi con elementi del mondo pagano.
Paolo in realtà, avendo rifiutato l'idea di liberare politicamente la propria nazione, agiva come uno sradicato, potendo contare unicamente sulla forza del proprio carattere, sulla propria abilità oratoria, sulla vana speranza che questo fosse sufficiente perché la comunità apostolica guidata prima da Pietro, poi da Giacomo, lo considerasse un proprio discepolo. Cosa che in effetti, e in parte, con Pietro avverrà, ma certamente non con Giacomo. Il suo vero successo Paolo l'otterrà soltanto dopo morto.
Di rilievo semmai nella sua predicazione è il fatto ch'egli non si comportava come un eccentrico filosofo o come un fondatore di scuole private per i figli dei ceti facoltosi: il suo scopo era quello di istituire una propria comunità di fede in ogni città che frequentava, sfruttando tutti i luoghi pubblici in cui potesse far ascoltare la propria voce (dalle sinagoghe all'agorà, dai tribunali al carcere). Nessun filosofo greco s'era mai comportato in questa maniera.
Oggi possiamo dire che probabilmente era un esaltato, con un'altissima considerazione delle proprie idee, disposto a rinunciare a qualunque forma di potere pur di vederle il più ampiamente diffuse. Eppure il suo cristianesimo, per quanto profonde siano le crepe, continua a reggersi in piedi.
VII
Cosa chiedeva Paolo ai pagano-cristiani di Colosse, seguaci della dottrina che lui stesso aveva elaborato per loro e per altri pagani come loro? Chiedeva di approfittare del fatto che la superiorità del giudeo rispetto al gentile non era stata sufficiente per riconoscere la verità offerta dal Cristo, sicché a partire dal momento della crocifissione (quasi a prescindere dalla tomba vuota, ma Paolo non arriverà mai a tenere le due cose separate) chiunque avrebbe potuto riconoscere quella verità: tutti si sarebbero trovati in fila sulla stessa linea di partenza. I pagani non avrebbero più dovuto sentirsi giudicati dagli ebrei per il fatto di non rispettare leggi, costumi, tradizioni con cui avrebbero potuto essere migliori di quelli che erano.
Che gli ebrei, di fronte al Cristo, si fossero comportati, nonostante la loro superiorità etica, nel peggior modo possibile, rientrava - secondo Paolo - in un mistero insondabile della divinità (1,26), rimasto nascosto per secoli, e che lui si vantava d'aver saputo coerentemente decifrare prima dei Dodici. A suo giudizio, tutto si ricapitolava in Cristo, incluse la scienza e la filosofia, il diritto e la politica, e le comunità da lui fondate non dovevano far altro che attendere con fiducia la «fine del mondo», il ritorno glorioso del creatore dell'universo, limitandosi ad agire rettamente, secondo le regole fondamentali della vita etico-religiosa, cioè senza fare torto a nessuno.
Paolo non chiedeva di diventare degli intellettuali, anzi, al contrario, supplicava di stare alla larga da qualunque filosofia e dai «vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana» (2,8). Per lui non solo tutto l'ebraismo era da buttare a mare (lo definisce «ombra delle cose future», 2,17), ma anche tutta la scienza e la filosofia del mondo pagano, quindi tutti i miti e le leggende. I suoi discepoli dovevano sentirsi liberi nei confronti di tutte le teologie e filosofie che non ponessero Gesù Cristo al centro della loro attenzione.
Non li stava invitando a comportarsi come volevano, ma semplicemente a non interessarsi di «cose mondane», futili, e che in ogni caso non potevano vantare maggiore serietà della sua «cristologia» solo perché esigevano di «mortificare i desideri e le passioni della carne» (2,20 ss.).
Quello che lui chiede non sono cose straordinarie, ma ciò che è alla portata di ogni uomo e che non va fatto per autogiustificarsi, in quanto, di fronte a dio, solo Cristo può giustificare l'uomo. I suoi discepoli dovevano provare «sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza» (3,12). Paolo chiedeva ai Colossesi di praticare quelle virtù che un tempo venivano chieste agli ebrei, i quali però le praticavano associandole a determinati usi e costumi che impedivano loro di avere relazioni coi pagani.
Paolo voleva trasformare i pagani in ebrei senza l'ebraismo, cioè in cristiani cosmopoliti, senza ambizioni nazionalistiche, rinunciando a qualunque caratterizzazione etnica, linguistica, sociologica, culturale, rituale, legalistica ecc. che li rendesse diversi dagli altri.
Le sue comunità non dovevano avere regole formali in virtù delle quali esse si sentissero migliori di altre comunità: la differenza tra pagano, ebreo e cristiano doveva vertere unicamente nel comportamento pratico, etico-religioso, ove il valore principale da realizzare era quello della «carità», dell'aiuto reciproco, dell'amore fraterno (3,14).
Paolo non aveva un progetto di trasformazione della società, non era interessato a lottare contro lo sfruttamento e l'oppressione in generale: il suo era soltanto un discorso di tipo etico-religioso. Infatti quando chiedeva alle mogli di stare «sottomesse» ai mariti, chiedeva a quest'ultimi di «amare» le loro mogli; quando chiedeva ai figli di «obbedire» ai genitori, chiedeva a quest'ultimi di non «esasperarli»; quando chiedeva agli schiavi di essere «docili» coi loro padroni, chiedeva a quest'ultimi di essere «equi» nei loro confronti.
Sul piano istituzionale Paolo voleva che le cose restassero sempre uguali: per lui non era un problema di ruoli, funzioni, gerarchie, ma solo di come far funzionare al meglio la società schiavista, in attesa della fine della storia, che ovviamente per lui restava imminente. L'idea di «resurrezione» da morte rendeva irrilevante qualunque altra cosa terrena: il cristiano non doveva temere più nulla, neppure la morte, che anzi sarebbe stata un guadagno.
Voleva far capire nella sua lettera che, nonostante non chiedesse nulla di straordinario, se non la necessità di credere nella resurrezione di un uomo ch'era anche dio, le istituzioni lo facevano soffrire in tutti i modi e gli impedivano di manifestarlo liberamente. La stessa cosa chiedeva ai Colossesi: «comportatevi saggiamente con quelli di fuori; approfittate di ogni occasione» (4,5). Cioè la predicazione, la divulgazione della cristologia mistica e dello stile di vita cristiano, dovevano far parte organica dei compiti di ogni comunità.
VIII
Leggendo le lettere di Paolo ci si stupisce che le istituzioni romane abbiano considerato il cristianesimo per tre secoli un nemico da abbattere. Che cosa vi poteva essere di così «eversivo» agli occhi delle autorità imperiali?
Due cose in realtà davano fastidio o facevano comunque sorgere dei sospetti sull'affidabilità di questo tipo di credenti e quindi sulla legittimità delle loro pratiche religiose.
In un mondo di politeisti, anzitutto, il monoteismo veniva considerato una sorta di ateismo, e questo, inevitabilmente, veniva associato a un comportamento cinico, amorale, persino crudele (i cristiani venivano accusati ingiustamente di tutte le nefandezze possibili) e sicuramente non patriottico. Finché il monoteismo restava circoscritto agli ebrei, ch'erano pochi, ben individuabili, che per giunta si autoescludevano, con tutti i loro usi e costumi particolari, dal contatto col mondo pagano (fatte salve le esigenze della quotidiana sopravvivenza), lo si poteva tollerare, seppur non senza un certo fastidio.
Ma se il monoteismo diventava patrimonio su vasta scala di elementi pagani, la cosa poteva risultare preoccupante. Le istituzioni statali e governative erano abituate a servirsi delle religioni come di uno strumento per regnare più efficacemente. Coi cristiani questo non era così semplice, poiché essi non accettavano di relativizzare il loro culto religioso, permettendo che fosse confuso con altri culti. Sarebbe stato impensabile per un cristiano ammettere l'esistenza del proprio dio insieme a quella di altri dèi, cui prestare sacrifici. In modo particolare non potevano ammettere, neanche in maniera simbolica, che l'imperatore potesse vantare delle prerogative religiose.
Quando, con Costantino, il cristianesimo verrà riconosciuto come una delle tante religioni, gli si concesse, contestualmente, il diritto di esercitare il proprio culto nella più assoluta autonomia. In tal modo il potere politico smetteva d'interferire nelle questioni religiose. Cosa però che di lì a poco lo stesso Costantino smentirà, volendo presiedere personalmente al concilio di Nicea (e quindi, lasciandosi, in questo, strumentalizzare dai cristiani), con cui si condannerà l'arianesimo.
Invece di risolvere la questione autonomamente, i cristiani si servirono per la prima volta del potere politico: allo Stato fu assegnata la facoltà di dirimere una questione tipicamente religiosa. La cosiddetta «chiesa costantiniana» aveva riprodotto il concetto romano di «Stato confessionale», sostituendo il cristianesimo al paganesimo, il monoteismo al politeismo, e del monoteismo aveva voluto imporre una determinata concezione della natura di Cristo. D'ora in avanti tutte le controversie sul monoteismo sarebbero state regolamentate non solo dalle istituzioni religiose (sinodi e concili), ma anche da quelle civili (i sovrani, le amministrazioni statali, gli ordini giudiziari, polizieschi e militari).
La «chiesa costantiniana» è stata una sorta di reciproca strumentalizzazione: lo Stato appoggiava un determinato articolo di fede allo scopo di ottenere un certo consenso politico. In una situazione del genere non aveva nemmeno più senso sostenere che il martirio rappresentava la suprema testimonianza della fede.
La seconda cosa che al tempo di Paolo non piaceva alle autorità romane era il fatto che, in presenza di forti crisi sociali, le comunità cristiane, esattamente come quelle ebraiche (che però praticavano l'usura nei confronti dei pagani), riuscivano a sopportare meglio le contraddizioni, facendo leva sull'assistenza ai bisognosi. Le situazioni di crisi, di malessere sociale venivano sfruttate dai cristiani per ottenere consensi, per ampliare i ranghi delle loro comunità. Per l'individualismo del mondo pagano questo era intollerabile, e costantemente si cercava di addebitare ai cristiani le cause dei mali sociali.
Il cristianesimo, in realtà, non riuscì mai a porre all'ordine del giorno il problema di come superare la prassi quotidiana dello sfruttamento del lavoro altrui. Dava semplicemente per scontato che di fronte a un servo obbediente il padrone avrebbe avuto meno motivi per sfruttarlo senza ritegno. Riduceva il rapporto oggettivo di oppressione economica a una questione soggettiva di comportamento morale.
La domanda che ora sorge spontanea è la seguente: Paolo si sarebbe riconosciuto nella chiesa di stato? Ponendo la resurrezione al centro della vita cristiana, molto probabilmente sì. Infatti è proprio questo concetto che impedisce di risolvere alla radice i conflitti sociali.
Per poter lottare contro la chiesa di stato Paolo avrebbe avuto di fronte a sé due alternative: o creare nuove comunità che contestassero la chiesa sul piano pratico, non ideologico; oppure creare nuove comunità in cui la contestazione alla chiesa non riguardasse solo gli aspetti pratici ma anche quelli ideologici. La prima alternativa fu scelta dai movimenti ereticali, la seconda dal socialismo scientifico.
(torna su)La domanda che a questo punto ci si pone è la seguente: si può davvero proseguire in maniera ateistica la teologia paolina? Si può davvero fare con la sua teologia quel che lui fece con la teologia ebraica e con la mitologia pagana? Sì, si può, ma solo a una condizione, che non si abbia timore di farlo, cioè che si voglia andare davvero sino in fondo.
Infatti, quando Paolo afferma che il Cristo è a immagine di dio, bisogna avere il coraggio di aggiungere che se questa immagine è perfetta (adeguata alle esigenze umane), è irrilevante o ininfluente per l'uomo (che s'interfaccia col Cristo), sapere se dio esiste davvero o no.
Paolo usa la parola «immagine» non solo per indicare un «figlio» che proviene da un «padre» (come «dipendenza originaria»), ma anche per indicare una certa identità di natura, una perfetta uguaglianza.
Una qualunque esegesi laica può sfruttare questa fondamentale debolezza logica della teologia cristiana (che per Paolo era invece un segno di forza, di originalità rispetto sia all'ebraismo che al paganesimo): quella di servirsi di una «persona storica» per dimostrare la fondatezza di un’«entità metafisica» (dio), trasformando inevitabilmente lo stesso Cristo in una «persona metastorica». Si può sfruttare questa debolezza per arrivare a sostenere, in maniera del tutto laica (o atea, che dir si voglia), che se l'uguaglianza tra «padre» e «figlio» è perfetta, allora può anche non esistere alcuna entità astratta chiamata «dio», o che, in ogni caso, essa risulta irrilevante per l'istanza umana di autenticità o di liberazione.
Se vogliamo considerare Cristo un «modello» per l'umanità, facciamolo restando nella storia. Se per la chiesa Cristo è «figlio», per noi è «padre» e se, incarnandosi, ha voluto dimostrare la propria «umanità», allora noi, come lui, abbiamo «natura divina». Dio insomma, come realtà separata dalla nostra umanità, non esiste.
In questa maniera, peraltro, potremmo fare a meno dell'altro aspetto, questa volta di tipo moralistico, che appartiene sempre alla teologia paolina, secondo cui il sacrificio cruento del Cristo ha riscattato agli occhi di dio un'umanità dannata a causa del peccato d'origine, un'umanità incapace di bene, che deve limitarsi ad attendere con fiducia la propria definitiva liberazione al momento del giudizio universale. Occorre liberarsi di questa forma di rassegnazione universale.
Da un lato quindi possiamo arrivare a conclusioni più ateistiche di quelle che Paolo aveva nei confronti del giudaismo e del paganesimo; dall'altro invece possiamo ipotizzare un percorso politico e un impegno umano finalizzati alla liberazione nel presente.
Paolo non s'è reso conto che, volendo dare al termine «immagine» una pregnanza così marcata (manifestare pienamente l'invisibile in maniera visibile) ha involontariamente offerto l'occasione agli esegeti laici di radicalizzare ulteriormente il suo pensiero, facendo dell'immagine non un «riflesso» di altro ma una «fonte» vera e propria.16
Solo adesso è possibile fare questo percorso. Infatti tutte le eresie cristologiche sviluppatesi dopo la morte di Paolo, sino all'iconoclastia, non hanno mai messo in dubbio l'esistenza di un dio-padre, essendosi limitate a definire la natura e l'identità del Cristo. Nei primi sette concili ecumenici l'ateismo si esprimeva unicamente negando al Cristo una piena natura divina; non si arrivò mai a sostenere che se si fosse affermata sino in fondo la sua natura umana, si sarebbe dovuti arrivare a negare l'esistenza a qualunque divinità. Quella volta gli eretici negavano la natura divina al Cristo per contestare il potere politico della chiesa e dello Stato cristiano (nel migliore dei casi preferivano uno Stato che tenesse la chiesa politicamente sottomessa e che permettesse un'ampia libertà di religione).
Oggi invece bisogna affermare la natura umana del Cristo per negare a qualunque «istituzione sovrumana» (chiesa o stato che sia) la pretesa d'essere indispensabile per il genere umano. Oggi l'ateismo non può servire soltanto a «negare dio», ma anche a eliminare dalla storia la pretesa che una qualunque struttura di potere possa comportarsi come una sorta di «divinità». Tutto quanto pretende, con l'uso della forza, una fede cieca, un delega in bianco dei poteri politici, una rinuncia all'autonomia gestionale delle proprie risorse territoriali, una rinuncia alla propria facoltà di scelta, alla propria libertà di coscienza, andrebbe abolito senza se e senza ma.
Se il Cristo è umano e tutte le cose sono state create da lui, non possiamo che rallegrarcene, poiché di fatto partecipiamo attivamente a questa creazione (come «genere umano», non come «credenti»), nella consapevolezza di poterlo fare autonomamente, utilizzando le nostre facoltà volitive e intellettive.
Ciò che ci preoccupa è semmai il fatto che, avendo eliminato tragicamente il prototipo di questa creazione, noi inevitabilmente rischiamo di compiere errori colossali e persino di autodistruggerci, in quanto, col passare dei secoli, pur essendoci state, di tanto in tanto, delle controtendenze, s'indebolisce la memoria degli aspetti che assicurano la vivibilità della nostra umanizzazione.
Il fatto stesso che i vari protagonisti del tentativo di recupero di questa memoria vengano sistematicamente eliminati, è indicativo della nostra impotenza nei confronti del bene, della nostra incapacità a individuare il meglio per la nostra specie. La fine che ci attende, se il trend non cambia, è tragica, come la decisione d'aver voluto eliminare la fonte della nostra umanizzazione.
Il destino che incombe su di noi sembra essere quello di farci provare dei desideri di identità impossibilitati a realizzarsi, dei desideri che vengono sistematicamente contraddetti da atteggiamenti che non fanno che peggiorare la nostra disumanizzazione. E, a quanto sembra, le catastrofi, cui periodicamente andiamo incontro (guerre mondiali, crolli di civiltà, devastazioni ambientali ecc.), non possiedono mai la forza risolutiva per farci cambiare rotta in maniera definitiva.
La storia sembra muoversi come una parabola dall'andamento sinuoso, a onde ricorrenti, senza fine, dove la distruzione è parte organica di ciò che si costruisce. Si raggiunge un picco nell'illusione che il progresso sia inarrestabile, invece poi si sprofonda nel baratro, da cui, con molta fatica, si cerca di risalire la china, ma solo per ripetere, seppure in forme diverse, gli stessi errori di prima. Sembra la maledizione di Sisifo. Paolo avrebbe detto: «Chi ci libererà da questo corpo di morte?».
(torna su)Appendici
Le lettere di Pietro
15.1) Pietro I
La prima lettera, una sorta di circolare per i cristiani di alcune regioni dell'attuale Turchia, già evangelizzate da Paolo, porta i saluti della comunità cristiana che vive a Roma. La seconda lettera, che diversi antichi non volevano fosse inclusa nel numero dei libri ispirati e che molti moderni dubitano fortemente sia di Pietro, dovrebbe essere stata scritta tra il 63-64 e il 67.
Nella prima Pietro ribadisce il principio fondamentale del «suo» vangelo (che qui appare identico a quello di Paolo): la speranza di una vita migliore è data ai cristiani dalla «resurrezione di Cristo» (1,3). Tant'è che l'«eredità», cioè la liberazione dalle contraddizioni sociali, è unicamente «conservata nei cieli» (1,4).
In questa verità bisogna credere per fede, nella convinzione che la fede si trasformerà in certezza, in evidenza concreta quando la «potenza di Dio» (1,5) si manifesterà chiaramente. E tale potenza è «prossima a rivelarsi negli ultimi tempi» (ib.) - chiaro riferimento escatologico alla imminente parusia trionfante del Cristo, che la generazione dei discepoli di Pietro era stata «educata» ad attendere con ansia.
Pietro infatti, pur non sapendo quando sarebbe avvenuta la parusia, deve necessariamente darla per scontata, perché sa di non poter parlare di «resurrezione» senza dover parlare, contestualmente, come sua inevitabile conseguenza, di ritorno glorioso del Cristo.
Il rischio di un clamoroso flop c'era: Pietro non poteva non esserne consapevole, anche se ad ogni ritardo, rispetto ai tempi previsti, si sarebbe sempre potuta trovare una qualche spiegazione plausibile. L'importante era far credere che la fede nella resurrezione era ben riposta, cioè non doveva apparire come la consolazione (amara) di un uomo sconfitto politicamente, di un perdente della storia.
Naturalmente di tutte le motivazioni con cui spiegare il ritardo della parusia, la più usata dagli apostoli Pietro e Paolo è sempre quella della «prova», nel senso che il ritardo dipende dal fatto che la fede dei cristiani va sottoposta a dure verifiche. E la durata di questo collaudo nessuno può preventivarla: l'importante è credervi come motivazione del «ritardo».
Peraltro la prova di cui parlano spesso Pietro e Paolo non è esattamente «individuale» bensì «collettiva»: si riferisce all'insieme della comunità cristiana, non al singolo credente. Sicché è poi facile sostenere che all'interno della comunità vi è sempre qualcuno la cui fede, inevitabilmente vissuta con forme diverse di convinzione o di intensità, non è stata ancora abbastanza torchiata.
Ai seguaci della comunità, destinatari di questa missiva, Pietro peraltro dice, lusingandoli, che han già una fede molto grande, in quanto «amano il Cristo pur senza averlo visto» (1,8), a differenza di tanti suoi (del Cristo e dello stesso Pietro) connazionali, che pur avendolo visto operare di persona, non gli credettero affatto.
La seconda grande consolazione, di cui la comunità dovrebbe beneficiare, Pietro la fa dipendere da un'interpretazione forzosa di quello che, secondo lui, era l'atteggiamento dei profeti veterotestamentari, i quali avrebbero capito, o intuito, prima di tutti gli altri, che un giorno sarebbe arrivato il Cristo.
Essi profetizzarono una cosa di cui però non poterono fruire, poiché la nascita del Cristo non era destinata a loro, ma alla generazione coeva agli apostoli e quindi agli stessi destinatari di questa missiva.
Se tali destinatari non sono di origine ebraica, debbono rallegrarsi ancora di più dell'atteggiamento che ebbero i profeti, poiché proprio ai cristiani è stato «rivelato» che la sofferenza e la gloria di Cristo (1,11) hanno come scopo ultimo il bene del mondo intero e non solo quello del popolo d'Israele.
Col che Pietro può ulteriormente forzare la sua esegesi biblica, facendo passare tutti i profeti per degli autentici «precursori» del Cristo, l'ultimo dei quali era stato il Battista, ben sapendo che sulla strada di tale esegesi non potrà incontrare oppositori tra i seguaci cristiani di origine pagana; e in fondo neppure tra quelli di origine ebraica, poiché un giudeo che l'avesse contestato su questa forzatura, di sicuro non avrebbe militato tra le fila cristiane o ne sarebbe presto uscito.
Posto questo, la prassi da seguire era molto semplice: se un cristiano concepisce la propria vita come un «pellegrinaggio» (1,17), in attesa della «parusia», non c'è ragione di conservare tutti quegli atteggiamenti tipici di chi considera invece prioritari i beni materiali, il benessere fisico, la sicurezza esteriore. I cristiani devono pensare anzitutto ad «amarsi» (1,22) e, nell'amore, devono provvedere a costruire «l'edificio spirituale» (2,5) della loro comunità, con cui farsi forza reciprocamente, contro l'incredulità altrui, giudaica nella fattispecie, cui si è peraltro «destinati» (2,8) dallo stesso dio, che è riuscito a fare del «non popolo» dei pagani (2,10) il vero «popolo di Dio» (ib.), una «stirpe eletta», un «sacerdozio regale», una «nazione santa» (2,9), insomma ciò che un tempo era patrimonio esclusivo degli ebrei.
Dalla negazione del popolo che aveva negato fiducia al Cristo, è nata una nuova positività, un nuovo popolo. Pietro ovviamente non può qui precisare (lo farebbe contro i suoi stessi interessi di «politico revisionista») che il nuovo popolo s'è formato sulla base di un'idea del tutto mistica e fantastica dell'operato di Cristo. Non può cioè spiegare ai suoi lettori che il primato concesso dagli apostoli al mondo pagano è stato pagato al prezzo di una cristiana spoliticizzazione del messaggio evangelico del Gesù liberatore nazionale.
Anche se in verità è costretto a dir loro delle cose molto precise sul piano politico, che naturalmente non possono avere nulla di eversivo:
- i cristiani devono sentirsi, ovunque vivano, degli «stranieri» e dei «pellegrini» (2,11), cioè non devono partecipare a battaglie politiche, non devono prendere posizioni per questa o quella idea politica; devono soltanto avere una condotta eticamente «irreprensibile» (2,12);
- i cristiani devono anzi stare «sottomessi a ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni» (2,13 s.).
Conformismo quindi assoluto, da esercitarsi a prescindere non solo dal tipo di funzione ricoperta dall'autorità (politica, amministrativa, militare), ma anche da qualsivoglia atteggiamento essa possa avere (tollerante, autoritario ecc.). Che sia buona o cattiva, l'autorità va rispettata, poiché «questa è la volontà di Dio» (2,15). Naturalmente qui Pietro dà per scontato che l'autorità non impedisca al cristiano di esercitare liberamente la propria fede.
D'altra parte - si sarà chiesto Pietro - che motivo avrebbe l'autorità romana a reprimere una fede che predica l'obbedienza assoluta alla volontà dei poteri costituiti?
Per di più l'obbedienza non deve essere solo «politica» ma anche «sociale». Gli schiavi infatti (qui molte Bibbie traducono col termine eufemistico di «domestici») devono stare «soggetti con profondo rispetto» ai loro padroni (2,18), «non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili» (ib.).
La convinzione di Pietro era quella secondo cui quanto maggiore fosse l'ossequio dimostrato nei confronti delle istituzioni, tanto minore sarebbe stata da parte di queste l'esigenza di usare metodi coercitivi.
Le ragioni della forza andavano vinte con la pazienza, la rassegnazione, la fede in un premio ultraterreno. Qui Pietro raggiunge le vette dello stoicismo pagano, alla cui filosofia aggiunge però la certezza del premio finale. «È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato?» (2,19 s.).
La sofferenza non è fine a se stessa, non va vissuta come distaccata rassegnazione: essa ha come scopo la salvezza personale, essendo uno strumento di redenzione. E che vada vissuta così lo dimostra anche il modello cui il cristiano deve ispirarsi costantemente: «anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme» (2,21).
Il Cristo di Pietro non è molto diverso dal Buddha di 500 anni prima. L'idea dominante, che deve convincere i cristiani ad obbedire agli schiavisti e alle autorità, è quella del «giusto sofferente», un’immagine che si ritrova anche in taluni importanti testi profetici. Se questa idea è riuscito a metterla in pratica uno che, essendo risorto, avrebbe potuto sicuramente dimostrare, prima ancora di morire, la superiorità del proprio senso di giustizia, significa che questa idea, secondo cui non c'è altro modo di affermare la giustizia sulla terra che quello di sopportare con pazienza le ingiustizie, può e deve essere messa in pratica da chiunque voglia dirsi «cristiano».
Lottare per affermare la giustizia sociale (la liberazione dalla schiavitù) o la giustizia politica (la liberazione dalla dittatura) non è cosa che il cristiano deve fare in quanto «cristiano». Ci vorranno secoli prima che s'arrivi a capire, nel mondo cattolico, che una lotta del genere il cristiano avrebbe potuto e dovuto condurla in quanto «cittadino».
La distinzione tra «cittadino» e «credente» veniva fatta anche nell'ambito del cristianesimo primitivo, ma in maniera più che altro formale, in quanto la sfera «civile» veniva completamente ricompresa in quella «religiosa»: un po' come ancora oggi avviene in molte comunità israelitiche e musulmane.
Occorrerà lo sviluppo del pensiero «laico», occorrerà la secolarizzazione dei costumi, la rivoluzione tecnico-scientifica e mercantile, prima che il cristiano cominci a sentirsi anzitutto «cittadino», nell'ambito della società civile, e «credente» solo a livello di coscienza personale.
Il che, in realtà, servirà a poco in relazione all'esigenza di realizzare una vera giustizia sociale, in quanto, messo di fronte alla necessità di compiere una rivoluzione politica a favore delle classi oppresse, il cristiano ha di fronte a sé poche alternative: o smette d'essere cristiano e diventa p.es. «socialista» o «comunista», oppure sceglie la strada della conservazione, della diplomazia, della moderazione e della non violenza ad oltranza.
L'ambiguità di una laicità vissuta in sede civile e politica, e di una religiosità vissuta a livello personale ed ecclesiale, è capace di reggersi in piedi fintantoché le circostanze non obbligano a prendere decisioni radicali, e quindi a schierarsi dalla parte dell'una o dell'altra forza in campo.
Pietro, o comunque l'autore di questa lettera, è responsabile della mistificazione di credere possibile che la salvezza personale possa essere affidata all'idea di dover sopportare ingiustamente le angherie di un sistema diviso in classi antagonistiche.
Peraltro, in questa sopportazione ad libitum le donne vivono situazioni assai peggiori rispetto a quelle degli uomini. Qui il comandamento dell'apostolo, misogino quanto mai, è ancor più categorico: infatti, per loro vale quanto già stabilito in via generale, con l'aggiunta che devono anche «stare sottomesse ai loro mariti» (3,1), siano essi credenti o meno. Questo perché non si dica che le donne cristiane, con la loro fede, contribuiscono all'aumento dei divorzi. Anzi al contrario, se i mariti non sono cristiani, devono essere conquistati «dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole» (ib.).
Certo, sarebbe apparso ben strano che, dopo aver detto agli uomini cristiani di obbedire sempre e comunque alle loro autorità, si arrivasse a sostenere che le donne della medesima fede potevano disobbedire ai loro mariti miscredenti. L'obbedienza è una virtù in sé, anche perché la legge, lo Stato non obbliga mai a compiere il male. Così la pensavano Paolo, Pietro e i loro seguaci. Il «male» non veniva mai considerato come anche «oggettivo», non proveniva mai dalle istituzioni, dalle strutture di potere, al massimo proveniva dalla società, cioè da coloro che assumevano ruoli anticristiani o ereticali, ivi inclusi i fanatici di altre religioni.
Tale feticismo nei confronti della legge, del diritto in generale, dello Stato, ovvero questo modo di considerare equidistanti o neutrali le istituzioni, viste al di sopra degli interessi di parte, caratterizzerà la cultura cristiana per molti secoli (quella cattolico-romana cercherà addirittura nell'arco di tutto il Medioevo di sottomettere il potere laico alle proprie esigenze di dominio universale) e verrà fatto proprio anche dalla cultura borghese e persino da molta cultura sedicente di «sinistra».
Sotto questo aspetto le persecuzioni anticristiane dei primi secoli poggiavano prevalentemente su un equivoco di fondo, cioè sulla convinzione, da parte delle istituzioni romane, che la negazione della divinità imperiale comportasse una slealtà nei confronti dello Stato, o che la rivendicazione etica di una certa autonomia della chiesa costituisse di per sé una minaccia alla legittimità e all'autorità dello Stato.
Certamente gli imperatori si servirono delle persecuzioni antireligiose (che non furono soltanto contro il cristianesimo) come valvola di sfogo per le contraddizioni irrisolte del sistema schiavistico; ed è altrettanto vero che alla gerarchia cristiana si opposero sempre i funzionari preposti al culto del paganesimo, dei quali il pontefice massimo era lo stesso imperatore, ma resta comunque singolare che gli imperatori abbiano impiegato più di tre secoli prima di capire che il cristianesimo era una religione politicamente del tutto innocua. Evidentemente a quel tempo bastava pochissimo per rischiare di apparire «fuorilegge».
La semplice idea di impedire ad ogni uomo, anche al più potente, di considerarsi alla stregua di una divinità, ovvero l'idea di contrapporre alla divinità dell'imperatore quella di un crocifisso di cui si diceva fosse risorto, era un motivo più che sufficiente per reputare i cristiani dei pericolosi sovversivi o quanto meno degli elementi di disturbo sociale, delle persone politicamente inaffidabili.
E pensare che proprio grazie al cristianesimo, a partire da Costantino, andrà affermandosi l'idea che l'imperatore cristiano è una sorta di «dio in terra», molto più «dio» di qualunque imperatore pagano, per quanto fosse moralmente costretto a ricevere la corona dalla stessa chiesa, la quale rappresentava concretamente, in solido, il «dio-Gesù», solo in virtù del quale s'era ottenuta la vera «rivelazione» del dio-padre, che nessuno ha mai visto, e che l'imperatore poteva rappresentare solo molto simbolicamente.
Tali digressioni storiche ci aiutano a capire il filo comune che lega le varie esperienze cristiane nei secoli. Infatti, anche se indubbiamente esistono sostanziali differenze di contenuto tra le principali confessioni cristiane che si sono col tempo venute formando (ortodossa, cattolica, protestante), su questa tendenza a non impegnarsi in maniera radicale nei confronti delle ingiustizie sociali gli atteggiamenti pratici sono sempre stati assai simili.
Quando si vedono, nella storia più recente, dei cristiani lottare a favore del socialismo, è perché in realtà essi hanno smesso d'essere politicamente «cristiani», ovvero la loro religiosità è stata circoscritta in ambiti talmente privati da risultare inincidente rispetto alle scelte compiute in sede politica o pubblica.
Vien quasi da pensare come impossibile che un uomo come Pietro, seguace di un rivoluzionario come Cristo, abbia potuto scrivere una lettera come questa, ovvero che essa sia stata scritta da qualcuno che ha potuto attribuirla a Pietro proprio perché questi non era più in grado di smentirlo, o perché fisicamente scomparso o perché irrimediabilmente compromesso col proprio «revisionismo ideologico».
Questo forse spiega il significato di quelle parole sibilline che uno dei racconti giovannei sul Cristo risorto mettono in bocca a quest'ultimo mentre sta parlando con Pietro: «quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi» (21,18). In pochissime righe viene forse sintetizzato il passaggio dal petrinismo al paolinismo.
Nella prima lettera vi sono addirittura delle ingenuità sul piano teologico, relative alla natura del Cristo, destinate a essere sfruttate da correnti ereticali contro il connubio di religione e potere politico. P.es. là dove Pietro scrive che il Cristo ha «ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze» (3,22) soltanto dopo la resurrezione, come se l'accettazione supina della croce avesse comportato una sorta di «premio di buona condotta», un riconoscimento politico (in quanto viene esercitato un potere) per l'aldilà.
Il che porterebbe a credere che il Cristo non aveva la stessa natura «divina» del dio-padre o che questi l'aveva per così dire «adottato» come figlio, in grado di sedere alla sua destra, soltanto dopo averlo visto soffrire in umile silenzio la condanna e i tormenti della croce.
Pietro riesce meglio quando si limita a fare un discorso meramente etico, non strettamente teologico. Accettare una sofferenza da patirsi ingiustamente è per lui la chiave della salvezza personale. Tutto il discorso più propriamente teologico si sovrappone a una filosofia di vita di carattere stoico, che acquista qui un preciso senso religioso-universale, in quanto persino i morti, a partire dal momento della resurrezione cristica, han cominciato a beneficiare della predicazione della «buona novella» (3,19.4,6).
D'altra parte bisognava trovare una qualche spiegazione alla scomparsa del cadavere, e una fu proprio questa: tutti devono essere giudicati in base alle loro opere o in base alla loro fede, nessuno dovrà poter accampare scuse appellandosi alla propria ignoranza. Ecco perché anche i morti, vissuti anteriormente alla venuta del Cristo, hanno il diritto di conoscere le verità ultime. «La fine di tutte le cose è vicina» (4,7).
Chi mai avrebbe potuto rimproverare a Pietro d'aver fallito clamorosamente le previsioni dopo la propria morte? Lui, ch'era stato contemporaneo del Cristo, si poteva permettere il lusso di dire che la fine era vicina; altri, dopo di lui, avrebbero dovuto, evidentemente, cercare nuove motivazioni per giustificare la richiesta della rassegnazione, della non resistenza al male. E costoro infatti dovranno aggiungere a questa lettera alcuni brani con cui legittimare le persecuzioni anticristiane volute dalle stesse autorità romane, che appaiono come se fossero accadute dopo l'invio della stessa.
Non sono infatti queste persecuzioni il motivo che l'hanno generata, altrimenti si sarebbe parlato subito di un fatto così grave. Esse anzi appaiono «strane» (4,12) alla comunità, in quanto contraddittorie alla natura impolitica del cristianesimo petrino e paolino.
Qui la motivazione redazionale, oltre a ripetere quanto già detto in precedenza, si articola seguendo un percorso differente: le persecuzioni contro i cristiani sono in realtà una premessa, un anticipo di ben altre repressioni, che non riguarderanno unicamente i cristiani, che non avranno per oggetto d'interesse il solo cristianesimo.
«È giunto infatti il momento di cominciare il giudizio dalla casa di Dio; e se prima incomincia da noi, quale sarà la fine di coloro che rifiutano di credere al vangelo di Dio?» (4,17). Cioè se le istituzioni eliminano la parte «sana» della società, quella che obbedisce senza discutere alle leggi, quella che paga tutte le tasse e che si mostra irreprensibile sul piano etico, salvo rivendicare un'autonomia di giudizio circa le pretese «divino-umane» da parte degli imperatori, cosa potrà mai accadere a quella parte di società che andrebbe ritenuta «malata»?
Purtroppo qui non viene data alcuna spiegazione storiografica o cronachistica di tali persecuzioni, ma soltanto una religiosa o, se si preferisce, metafisica.
(torna su)15.2) Pietro II
La seconda lettera è stata attribuita a Pietro, ma è assai dubbio che l'abbia scritta lui. Di sicuro non sono suoi i riferimenti alla «tenda del corpo» (1,13 s.), che ricordano troppo da vicino l'episodio, del tutto mitologico, di Gesù trasfigurato sul Tabor e della relativa proposta di Pietro di allestire su quel monte tre tende, per Gesù, Mosè ed Elia.
La differenza è che mentre nei sinottici la concezione della tenda è squisitamente ebraica, qui invece lo è molto meno, in quanto il redattore la paragona a qualcosa di simbolico che riguarda il destino di un singolo individuo, tant'è che al concetto di «tenda» (che sta ad indicare il carattere precario dell'esistenza) viene associato il concetto di «sacrificio» (fino alla morte violenta). E questo per «rivelazione» diretta da parte dello stesso Cristo (1,14). Siamo nel misticismo più assoluto. Kierkegaard parlerebbe di un «rapporto assoluto con l'assoluto», del tutto incomprensibile agli altri.
La seconda cosa che attesta quanto poco attendibile sia l'attribuzione a Pietro di questa lettera è il riferimento compiaciuto, sempre relativo al racconto della trasfigurazione, a quel momento in cui, in maniera ancor più mitologica, si descrive l'investitura «speciale» da parte del dio-padre nei confronti del proprio dio-figlio. È incredibile come qui l'autore della lettera non abbia ritegno a mentire, dicendo di aver sentito personalmente udire, lui insieme ai due fratelli Zebedeo, la voce di dio «scendere dal cielo» mentre erano con Gesù sul «santo monte» (1,18).
Proprio mentre garantisce di non stare a raccontare delle «favole artificiosamente inventate» (1,16), ne riproduce una più grande di tutte, tratta dai sinottici, assicurandone l'assoluta attendibilità, in quanto - lo ribadisce a chiare lettere - sia lui che gli altri due apostoli furono «testimoni oculari» (1,16) di quell'evento prodigioso.
A chi si rivolge l'autore di questa lettera nel mentre usa in maniera così spregiudicata il racconto della trasfigurazione, al fine di «dimostrare» la natura divina del Cristo e quindi la verità di tutta la predicazione apostolica?
Qui si ha la netta impressione che l'indirizzo riguardi alcuni gruppi di cristiani di origine giudaica, i quali - dice il redattore - «volgono la loro attenzione» alla parola dei profeti veterotestamentari (1,19).
Evidentemente tali credenti interpretavano le profezie in maniera difforme dall'esegesi ufficiale, che nelle sue grandi linee doveva già essersi formata. Pietro, o chi per lui, lo spiega a chiare lettere e con tono perentorio: «nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione» (1,20).
La dinamica di questa diatriba sembra essere facilmente intuibile: se qualcuno, all'interno della comunità, usa uno strumento aleatorio, come appunto le profezie, per cercare di dimostrare che Gesù non era il «Cristo» (promesso) o che non era di «natura divina», o che non era il «figlio unigenito» di dio-padre, ecc., costui si pone, stricto sensu, fuori della chiesa, e alle sue soggettive, parziali, non documentate argomentazioni vanno opposte quelle ufficiali, condivise dal gruppo degli «anziani», che sono poi le uniche fondate sulla tradizione apostolica, cioè sull'unica testimonianza oculare dei fatti oggetto di credenza, gli unici fatti a dover essere creduti come assolutamente fondati.
Forzando un po' la mano si potrebbe dire che qui l'autore è come se dicesse: «se qualcuno si vuol servire di favole (le profezie veterotestamentarie), avrà a che fare con l'opposizione di favole ancora più grandi, nei confronti delle quali qualcuno può asserire, in tutta sicurezza, d'essere stato diretto protagonista».
In tale querelle esegetica chi potrà vincere? La posta in gioco è alta e non è proprio il caso di scherzarci sopra. È vero, nessuno ha mai visto dio, ma sul monte galilaico i tre principali apostoli l'hanno ascoltato con le loro orecchie. Nessun profeta, per quanto ispirato fosse, riuscì ad avere la stessa esperienza di Pietro, Giacomo e Giovanni. L'unico forse fu Elia, quando fu rapito in un carro di fuoco, e l'altro forse fu Mosè, quando discese dal Sinai col volto raggiante, ma non a caso nel racconto del Tabor questi due personaggi vengono posti ai lati del messia trasfigurato.
Nessun profeta va considerato più grande del Cristo, anche perché di nessun profeta Jahvè disse ch'era suo «figlio prediletto», nel quale «s'è compiaciuto». E se anche si volessero considerare i profeti come «ispirati da dio» (perché in fondo per la chiesa cristiana lo sono), proprio questo impedisce di interpretare le loro parole come frutto di «volontà umana» (1,21).
Essi furono «mossi da Spirito Santo» e parlarono «da parte di Dio»: ciò significa che la giusta spiegazione del contenuto, del significato delle loro parole può essere data solo da chi ha avuto col Cristo, ch'era oggetto delle loro profezie, un'esperienza diretta e personale. Dice a tale proposito il vangelo di Luca: «molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono» (10,24).
Qui è evidente lo scontro, all'interno della comunità primitiva, tra opposte concezioni della divinità: una, ancora prevalentemente giudaica, che vorrebbe assegnare al Cristo un ruolo di minore importanza rispetto a quello stabilito da Pietro e Paolo, ponendolo sulla scia della tradizione profetica esilica e post-esilica; un'altra invece che vede nel Cristo il compimento di tutte le profezie, la fine del primato storico d'Israele e l'inizio di una cultura religiosa innovativa, capace di superare tutte quelle particolarità giudaiche che rendevano l'ebraismo una religione di nicchia, o quanto meno nazionalistica.
La seconda lettera attribuita a Pietro è rivolta a chi ha il compito di combattere l'eresia, cioè l'interpretazione eterodossa del vangelo di Pietro e soprattutto di Paolo. Qui si ha già a che fare con cristiani che, non molto tempo dopo la loro conversione, si ponevano in posizione critica, dubitativa, nei confronti della promessa di una imminente e trionfale parusia del Cristo, e facevano leva sulle loro pregresse competenze giudaiche.
Sotto questo aspetto è incredibile, in una lettera così breve, la mole di parole usate per condannare questi eretici. Praticamente tutto il secondo capitolo. La filippica prosegue anche nel capitolo successivo, con la differenza che qui si spiega il motivo scatenante delle rimostranze dei giudeo-cristiani.
Gli «schernitori beffardi» infatti - e a giusto titolo, si può aggiungere - si chiedono che fine abbia fatto «la promessa della sua venuta», quella per cui era stato chiesto loro di non fare nulla contro i romani, ché tanto ci avrebbe pensato la parusia vittoriosa del Cristo risorto. «Dal giorno in cui i nostri padri [cioè i cristiani della prima generazione] chiusero gli occhi [morirono], tutto rimane come al principio della creazione» [eufemismo per dire che non è cambiato nulla] (3,4). Nel senso che restano immutate le ingiustizie sociali, l'oppressione politica ecc. Era stato loro promesso come imminente il paradiso, chiedendo di attenderne passivamente la venuta, limitandosi cioè a un comportamento eticamente irreprensibile, ed ora ecco che la comunità soffre come e più di prima. Cosa non aveva funzionato?
I dubbi sono sempre la premessa di ogni eresia: siamo sicuri che gli apostoli avessero ragione? Siamo davvero sicuri che il Cristo avesse «natura divina»? E se fosse stato soltanto un semplice profeta, come tanti altri del passato giudaismo? E se il vero «messia» deve in realtà ancora arrivare? Le eresie nascono proprio dai dubbi irrisolti, dalle risposte mancate, dai fallimenti pratici di determinate teorie, e proprio sul diverso modo di vivere la «prassi» si verifica se le eresie poggiano su solide fondamenta o se sono soltanto un flatus vocis.
Gli eretici infatti devono qui fronteggiare un'obiezione decisiva, escogitata dal redattore dell'epistola, quella di fronte alla quale rischia d'impallidire ogni previsione umana, e cioè che «davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo» (3,8). Il discorso, posto in questi termini mistici, è praticamente chiuso. Lo stesso Cristo l'aveva detto nei vangeli: «Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre» (Mc 13,32).
Dunque perché insistere sulla pretesa di sapere con debito anticipo il momento esatto della felicità? Non è forse questa una richiesta irragionevole, infantile, presuntuosa, addirittura pretestuosa, in quanto usata per negare tradizioni acquisite? «Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa - pontifica l'anonimo redattore, facendosi quasi portavoce di dio stesso -, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (3,9).
In altre parole, perché chiedere «giustizia sociale», «democrazia politica», qui ed ora, quando, individualmente, non si è neppure capaci di «pentimento»? Prima di realizzare la giustizia sociale occorre la conversione morale individuale. Quando tutti saranno eticamente irreprensibili, verrà il Cristo a realizzare la giustizia sociale, la democrazia e tutta la felicità di cui si ha bisogno.
Questo modo di ragionare è davvero singolare. Tutti si devono «pentire» prima di poter fare qualcosa per il bene comune, per la collettività; ma quando tutti saranno moralmente «pentiti» delle loro colpe, la giustizia sociale non verrà forse da sé? Non ci sarà neppure bisogno di rivendicarla. Dunque che bisogno avremo di una «seconda venuta» del Cristo? O forse l'autore voleva dire - con artificio machiavellico - che la giustizia sociale è un mito puerile, in quanto non avverrà mai che tutti, proprio tutti gli uomini della terra saranno davvero «pentiti»?
Una diatriba del genere, anche se sapientemente mistificata dai vangeli, si verificò tra il Battista e il Cristo, allorquando quest'ultimo decise di cacciare i mercanti dal tempio. Perché il Battista non vi partecipò, inducendo così il Cristo a rompere definitivamente con questo movimento pre-politico? Il motivo è identico a questa lettera: Giovanni si limitava a predicare un battesimo di penitenza e di conversione personale. Senza questa preventiva conversione, egli era convinto che dopo la cacciata dei mercanti tutto sarebbe tornato come prima: ai precedenti mercanti e sacerdoti corrotti se ne sarebbero sostituiti altri, e così all'infinito.
Al che chiunque avrebbe potuto obiettare che chi aspetta il momento in cui tutti gli uomini sono «convertiti», non muoverà mai un dito contro le ingiustizie sociali. Non esiste un prima o un dopo, come non esiste un primato assoluto dell'etica sulla politica o di questa su quella. Le due sfere si muovono in parallelo e si influenzano reciprocamente. Gli uomini agiscono così come sono, per quello che sono, e si modificano strada facendo.
Perché spaventarli dicendo che «il giorno del Signore verrà come un ladro, ... e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta» (3,10)? Se davvero viene come un «ladro», perché attenderlo passivamente? Perché limitarsi alla «conversione personale» rifuggendo qualunque impegno socio-politico? Il fatto che non si sappia «il giorno e l'ora» dovrebbe essere vissuto non come un impedimento all'azione umana, ma, al contrario, come un suo incentivo.
Tutte queste raccomandazioni all'inerzia politica sembrano nascere dalla coscienza di uno che si sente completamente sconfitto, tant'è ch'egli arriva a dire che «il giorno e l'ora» della giustizia sociale, della democrazia politica coincideranno addirittura con la fine del mondo! Sicché la «santità della condotta (personale)» (3,11) serve soltanto ad affrontare quel fatidico «giorno», in cui «i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno» (3,12).
Dunque non c'è speranza su questa terra, non c'è futuro per il genere umano. Le colpe sono troppo grandi, non esisterà mai un pentimento di tutta l'umanità, e se anche potesse esserci, quand'esso avverrà, sarà soltanto il segnale che tutto sta per finire.
«E poi - insiste il redattore mistico, come se volesse rivelare chissà quale cosa -, secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (3,13). Una «terra nuova» non nel senso antico-giudaico relativo alla «terra promessa», cui si può giungere uscendo materialmente, fisicamente dalla schiavitù o da qualche forma di insopportabile cattività, ma nel senso cristiano (cosmico) di un «nuovo pianeta» (non astronomico ma metafisico), di una nuova dimensione ultraterrena, completamente diversa da quella attuale, sconvolta irrimediabilmente dai guasti dello schiavismo romano (erede a sua volta di quello egizio, greco ecc.).
L'autore conclude l'epistola facendo ben capire ch'egli si sente un discepolo di Paolo (3,15 s.), il quale è per lui un «carissimo fratello», dotato di grande «sapienza», e chi non comprende le sue lettere è «ignorante» e «instabile».
Il filo che tiene unite le due missive è ora evidente: nella prima s'era detto che il Cristo stava per arrivare in pompa magna, nella seconda si è costretti a dire che arriverà sì, ma nessuno sa quando.
Chiunque può evincere da sé che se anche l'autore di questa lettera non è stato Pietro, il fatto che abbia potuto fregiarsi del suo nome sta appunto a significare che ormai nella comunità si dava per assodato che tra Pietro e Paolo vi era piena sintonia di vedute sulle cose fondamentali del vivere cristiano.
D'altra parte noi sappiamo com'è avvenuto il passaggio delle consegne tra i due apostoli. Constatata la crocifissione e la tomba misteriosamente vuota, la primitiva comunità cristiana ad un certo punto prese a fidarsi della parola di Pietro, non vedendo alternative praticabili. Egli per primo formulò l'idea della «resurrezione», mentre l'apostolo Giovanni (che constatò la tomba vuota insieme a lui) si limitò, analizzando il reperto della sindone, a sostenere la versione della scomparsa misteriosa del cadavere.
La tesi della resurrezione non era un giudizio di fatto ma un giudizio di valore. E come tale esso non avvalorava semplicemente l'istanza spiritualista dei seguaci di un crocifisso, i cui ideali di vita dovevano continuare a esistere e a diffondersi, come se lui fosse ancora vivo, ma proponeva un'idea squisitamente mistico-religiosa, e cioè che il cadavere era scomparso perché fisicamente risorto, il che dimostrava che il crocifisso non era un uomo come gli altri, ma una sorta di extraterrestre dai poteri paranormali.
Il fatto di cronaca era uno solo: la tomba vuota, che poteva dare adito a varie interpretazioni. Pietro scelse quella più azzardata, quella meno concretamente verificabile e la propose ai Dodici, che però probabilmente non l'accettarono, se non obtorto collo.
Giovanni rappresentava la via di mezzo: no alla resurrezione esplicita, che avrebbe distolto le masse dal continuare il tentativo insurrezionale preparato dal Cristo, ma no neppure alla tesi del trafugamento del cadavere, priva di riscontri concreti.
La resurrezione esplicita poteva essere accettata qua talis solo col beneficio del dubbio, e non caso Pietro collegava strettamente ad essa un'altra tesi non meno indimostrabile: la parusia imminente del Cristo glorioso. Idea questa che schiacciava i nazareni su posizioni ancor più attendiste, certamente non rivoluzionarie.
Che gli apostoli abbiano avuto seri dubbi su queste elucubrazioni di Pietro è testimoniato dallo scetticismo di Tommaso, che molto probabilmente non rappresentava solo se stesso: egli era portavoce di un dissenso comune. Tant'è che negli Atti non si sa quasi nulla degli altri apostoli; lo stesso Giovanni sparisce presto di scena.
La tesi petrina della resurrezione era di tipo opportunistico, molto moderata, il cui valore transitorio non poteva essere che di breve durata, in attesa appunto di una sua conferma evidente da parte della parusia. In mancanza di questa avrebbe dovuto essere fatalmente abbandonata (e Pietro ben presto dovrà andarsene da Gerusalemme), poiché con essa in auge l'azione rivoluzionaria restava come paralizzata.
A questo punto però entra in scena Paolo, che salva la comunità dallo stato di abbandono e di attesa frustrante in cui si trovava. Solo che invece di rinunciare completamente all'idea di resurrezione, egli ne fa il suo cavallo di battaglia, portando alle estreme conseguenze il suo significato.
Infatti se il Cristo è risorto e il ritorno glorioso non è avvenuto subito, significa che il compito storico non è quello di liberare Israele dall'oppressione romana. La parusia ci sarà ma alla fine dei tempi, dei quali non sappiamo nulla di preciso, allorquando si tratterà di giudicare i vivi e i morti. Dunque non resta che la resurrezione, senza la quale ogni fede è vana.
In questo gioco di staffetta Pietro aveva consegnato a Paolo il suo testimone: a un'interpretazione falsata della tomba vuota Paolo s'era sentito in dovere di aggiungere una spiegazione ancora più falsata, affinché si rinunciasse definitivamente a qualunque istanza politico-rivoluzionaria. La tensione emotiva, così ben descritta nel racconto della conversione sulla strada di Damasco, aveva finalmente trovato la sua pace interiore.
(torna su)16) Quali differenze tra ebraismo e cristianesimo?
Per capire ciò che distingue il cristianesimo dall'ebraismo bisogna considerare che il cristianesimo, pur affermando d'essere superiore sia all'ebraismo che al paganesimo, in realtà si pone come una sintesi di entrambi. Il cristianesimo non è altro che un ebraismo paganizzato.
Il principale artefice di questa operazione culturale sincretica è stato Paolo di Tarso, un ebreo nato e cresciuto in una cittadina profondamente ellenizzata. Non è stato lui però a inventare l'idea di resurrezione di Gesù, bensì Pietro, quando si trovò di fronte alla tomba vuota, benché i farisei già fossero favorevoli a un'idea del genere, come risulta in At 23,6.
Infatti, basandosi su alcuni passi dell'Antico Testamento: p.es. Osea 6,1-3 ("Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza"); Giobbe 14,13-15 ("Se l'uomo che muore potesse rivivere, aspetterei tutti i giorni della mia milizia finché arrivi per me l'ora del cambio!"); la visione delle ossa dei morti da parte di Ezechiele 37,1-14; l'Inno di ringraziamento di Isaia 26,19 ("Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere..."); le resurrezioni operate dai profeti Elia ed Eliseo (1Re 17,17-24; 2Re 4,18-37), ecc. - i farisei erano già arrivati a una sorta di spiritualizzazione della loro fede religiosa, opponendosi, in questo ai sadducei, di idee più materialistiche.
Tale idea, tuttavia, proveniva soprattutto dal mondo pagano, con cui si caratterizzavano, metaforicamente, talune divinità (l'egiziano Horus, Attis di Frigia, Krishna in India, il greco Dionysus, il persiano Mithra, ecc.), tutte morte e risorte dopo tre giorni.
Cos'ha fatto di diverso il cristianesimo? Ha fatto qualcosa che ha suscitato una certa opposizione, anche molto violenta, da parte sia dell'ebraismo che del paganesimo. Ha detto che un uomo, chiamato Gesù, dopo essere stato crocifisso dai Romani, istigati dai Giudei, è resuscitato dal suo sepolcro, dimostrando così d'essere un dio.
Attorno a questa idea, che nel N.T. risulta essere risalente all'apostolo Pietro, ne sono state elaborate altre, tra cui le principali sono le seguenti: Gesù si proponeva come messia d'Israele, intenzionato a liberare tutta la Palestina dai Romani che l'occupavano e dalla casta sacerdotale collusa con loro. Non era riuscito nel suo intento mentre era vivo, ma l'avrebbe fatto, in tempi brevi, dopo morto, dimostrando così che senza di lui gli uomini non erano in grado di fare nulla di risolutivo. Questa era l'aspettativa del movimento nazareno, per la quale si abbandonò la strategia rivoluzionaria del proprio leader, attendendo passivamente che la liberazione nazionale venisse compiuta in maniera sovrannaturale.
Quando scoppiò la guerra contro Roma, nel 66, i cristiani probabilmente non vollero collaborare coi Giudei assassini del loro messia. Infatti le autorità giudaiche, dal giorno della morte di Gesù al 66, non avevano mai accettato di considerarlo come il messia atteso, né mai avevano condiviso l'idea di una sua parusia imminente e trionfale (che comunque non ci fu). Il motivo di questa mancata intesa era che le autorità religiose non credevano affatto ch'egli fosse un liberatore nazionale, né che fosse risorto. Non avevano alcuna intenzione di pentirsi di ciò che avevano fatto.
Senonché una persona autorevole, chiamata Saulo, appartenente al partito dei farisei, pur avendo perseguitato per un certo tempo i cristiani su mandato delle autorità di Gerusalemme, si pentì e cominciò a credere ch'essi avessero ragione. Anche lui, all'inizio, era convinto che, accettando l'idea di resurrezione formulata da Pietro, sarebbe stato del tutto normale considerare imminente la parusia del Cristo.
Man mano però che la parusia tardava, Saulo, che intanto aveva assunto il nome di Paolo, iniziò a elaborare alcune idee intorno alla persona di Gesù, estranee alla cultura petrina. Paolo cominciò a dire che il Cristo, a motivo della resurrezione, non andava considerata soltanto come un dio, ma, piuttosto, come l'unigenito Figlio di Dio, ch'era morto per riconciliare Dio col genere umano, il quale, da quando aveva compiuto il peccato originale, non era più capace di vivere secondo verità e giustizia.
Siccome il rischio era quello che Dio sterminasse l'intera umanità, come ai tempi di Noè, l'intervento del Figlio, per il quale l'universo e quindi lo stesso genere umano erano stati creati, sarebbe stato decisivo una volta per tutte. Il Cristo infatti dimostrò d'amare così tanto l'umanità da accettare perfino d'essere crocifisso, riuscendo così a placare l'ira del Padre.
Paolo cominciò a dire che tale sacrificio non valeva solo per gli ebrei, ma anche per i pagani, sicché non aveva senso definirsi come "popolo eletto" e di attendere un "messia liberatore". Questo perché tutto il genere umano andava salvato. Era inutile aspettarsi un liberatore politico-nazionale, poiché era già arrivato un redentore etico-religioso universale. Cristo sarebbe tornato solo alla fine dei tempi, per compiere il giudizio universale, dopo che la sua parola fosse stata diffusa su tutto il pianeta.
Fino a quando Gerusalemme non fu completamente distrutta dai Romani, le idee di Paolo non furono accettate dai cristiani, se non in misura ridotta, poiché non si voleva credere che un Cristo risorto non tornasse, in tempi brevi, a liberarli dall'oppressione romana e dalla casta sacerdotale corrotta, per cui non si voleva rinunciare alla cultura ebraica.
Tuttavia dopo il 70 le sue idee iniziarono a imporsi in tutto l'impero romano, soprattutto tra la gente di religione pagana. E dopo tre secoli di persecuzioni da parte dei Romani il cristianesimo paolino trionfò in maniera decisiva, fino al punto in cui, con l'imperatore Teodosio, divenne una religione di stato.
Qual è stata quindi la morale della favola? L'imperialismo romano, ch'era riuscito a impedire all'ebraismo di rivendicare una propria indipendenza nazionale, si troverà a dover rinunciare al proprio paganesimo proprio a causa di una corrente religiosa uscita dallo stesso ebraismo. Tale corrente, chiamata cristianesimo, quando vorrà imporsi come religione di Stato in tutto l'impero, finirà col corrompersi in maniera irreparabile, inducendo sempre più gli uomini a rinunciare a qualunque religione.
(torna su)17) La religione ebraica e Roma
Che per i Romani le concezioni religiose degli ebrei non avessero alcun interesse è vero sino a un certo punto.
Diciamo che, in via del tutto generale, i Romani concepivano soltanto i rapporti di forza da regolamentarsi attraverso il diritto. I rapporti di forza si basavano anzitutto sulla proprietà privata di terra e schiavi che la lavoravano; poi, ovviamente, sugli affari commerciali, sugli appalti di varia natura, sulle carriere pubbliche (amministrative o militari) da trasmettersi ereditariamente, ecc. La politica era strettamente connessa alle questioni militari, soprattutto nella fase imperiale, quando la figura del "principe" (in genere un militare) diventa più importante di quella del Senato.
La religione era un mero strumento della politica, così come la diplomazia. Religione e diplomazia, oltre alla creazione di infrastrutture e di mercati, nonché all'imposizione di una lingua (il latino) e di un'unica legislazione (anche in relazione a pesi, misure, monete...), erano gli strumenti che i Romani usavano quando non erano costretti a usare le armi. Accettarono la lingua greca, in quanto non la ritenevano inferiore alla loro; accettarono buona parte della cultura e dell'arte greca, in quanto le ritennero superiori alla propria; accettarono molte divinità straniere, da aggiungersi alle loro, per dimostrare che nei confronti delle culture diverse dalla propria erano tolleranti.
Tuttavia del mondo ebraico non accettarono nulla; al massimo accondiscesero a concedere taluni privilegi o prerogative per ragioni di opportunità politica o militare. Il motivo di questo rifiuto era soltanto uno: gli ebrei mostravano chiaramente che la religione per loro non era una semplice fede, o un complesso di riti tradizionali, quanto piuttosto un tutt'uno con la politica. E il concetto di "politica", per un ebreo, voleva dire due cose fondamentali: costruire una nazione indipendente, libera da qualunque dominazione straniera; e, se si viveva nella diaspora, rivendicare diritti specifici, privilegi particolari che tutelassero l'identità ebraica, orgogliosa della propria diversità da quella pagana.
Gli ebrei erano disposti, quando costretti dalle circostanze, a fare affari coi pagani, ma non erano disposti a cercare compromessi su questioni di tipo etico-religioso. Il massimo che riuscirono a concedere, p.es. con Filone Alessandrino, fu d'incorporare dei princìpi filosofici del mondo greco all'interno della loro teologia monoteistica.
I Romani potevano tollerare gli ebrei solo a due condizioni: 1) che nella diaspora restassero una minoranza poco significativa; 2) che in Palestina si lasciassero politicamente e militarmente sottomettere. Nella diaspora i conflitti e le tensioni tra Romani ed ebrei erano ricorrenti, sicché spesso venivano perseguitati, se non addirittura espulsi dalle città; in Palestina si arrivò, dopo un secolo di oppressione nazionale, a una guerra vera e propria, che, a fasi alterne, si svolse per circa sessant'anni, dal 66 al 132.
Questo per dire che i Romani erano sì disposti ad accettare tutte le religioni che incontravano, ma solo a condizione che non avessero nulla di eversivo, nulla che potesse far sorgere il dubbio di un loro legame con una politica che non facesse gli interessi di Roma. Tutte le religioni dovevano considerarsi "strumenti" della politica imperiale.
(torna su)18) La condanna pontificia dell’apostolo Paolo
Quando Lutero si servì della figura di Paolo per contrapporla a quella di Pietro, usata, quest’ultima, oggi come allora, dal papato per rappresentare il proprio potere politico-religioso, la storia della chiesa romana conosceva già severe interdizioni nei confronti di coloro che avessero osato dare dell’apostolo Paolo un’interpretazione diversa da quella canonica.
Nel 1329 e nel 1351 i papi Giovanni XXII (1316-34), grande persecutore dei francescani spirituali e fautore della dittatura politico-militare di Carlo d’Angiò in Italia, e Clemente VI (1342-52), che trasformò Avignone, ove il papato aveva trasferito la propria sede, in un importantissimo centro finanziario della cristianità, e dove tenne prigioniero il tribuno del popolo romano Cola di Rienzo, avevano scomunicato e condannato ogni uomo e ogni teoria che avessero tentato di negare che l’apostolo Paolo aveva operato sotto gli incontestabili ordini e l’assoluto potere dell’apostolo Pietro (che allora, come oggi, veniva definito «primo dei papi»). Le sentenze si riferivano soprattutto alle «eresie» di Marsilio da Padova (Defensor Pacis l’opera principale) e Giovanni da Ianduno (Jandun), collaboratore di Marsilio. Per la stessa ragione papa Martino V (1417-31) aveva scomunicato Jan Huss nel sinodo di Costanza.
Nel 1647, in piena controriforma, un editto di papa Innocenzo X (1644-55), grande nepotista e avverso ai giansenisti, scomunicava quale eretico, condannandolo al rogo, ogni cristiano che osasse credere, seguire o comunicare ad altri l’insegnamento dell’apostolo Paolo circa l’autenticità della propria dignità apostolica, che, come noto, non dipese da quella degli altri apostoli di cui parlano i vangeli.
L’editto, che faceva parte dei documenti dell’Inquisizione, obbligava, in particolare, ogni fedele a credere, sotto la minaccia di severi castighi, che l’apostolo Paolo, in tutta la sua vita cristiana, non aveva esercitato la sua opera missionaria liberamente, ma alle strette dipendenze della monarchia di Pietro, il cui potere si trasmetteva per successione ereditaria, diretta e personale ai soli vescovi di Roma.
Per convincere la cristianità che il famoso «Primatus Petri» era cosa fondata, il papato elaborò tutta una serie di clamorosi falsi, di cui i più noti sono l’interpolazione del sesto canone del concilio di Nicea, che viene fatto iniziare con le parole: «La chiesa romana ha sempre avuto il primato…»; la famosa «Donazione di Costantino» (elaborata nell’VIII sec. per convincere i franchi a scendere in Italia contro i longobardi, permettendo alla chiesa di costituirsi come potente Stato della penisola), secondo cui l’imperatore Costantino avrebbe trasmesso al papa il potere temporale su Roma e su tutte le province dell’occidente; le cosiddette «Pseudo-Decretali isidoriane», che, fra le altre cose, affermano un’autorità pontificia sul mondo intero.
Meno note ma non meno efficaci sono anche tutte quelle interpretazioni strumentali, opposte all’esegesi tradizionale, di alcune opere dei padri della chiesa in cui determinati passi evangelici, come p.es. Mt 15,18 s., Lc 22,31 s., Gv 21,15 s., venivano utilizzati per giustificare il «primato di Pietro», presentato come una sorta di eccezionale privilegio concesso soltanto a Pietro e, per suo mezzo, ai soli pontefici romani, in virtù del quale costoro si arrogavano il diritto di esercitare una dittatura pressoché assoluta sulla chiesa universale e indirettamente sul mondo intero. La chiesa ortodossa, non meno cristiana della cattolica, veniva definita a tale proposito chiesa «ribelle» o «scismatica».
Nel concilio Vaticano I Pio IX (1846-78) stabilì che il primato del papa è la parte più significativa del cattolicesimo-romano e confermò definitivamente la teoria dell’infallibilità pontificia. Pio X (1903-14) nel 1907 e Benedetto XV (1914-22) nel 1920 hanno ripetuto le stesse cose nella maniera più categorica. E anche oggi nessun papa (Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger) ha mai messo in discussione il primato di Pietro e l’infallibilità pontificia.
L’apostolato indipendente di Paolo presso i Gentili è stato per molto tempo una spina nel fianco alla teoria del primato di Pietro. Difficilmente conciliabile con tale teoria apparivano infatti le parole di Paolo secondo cui egli «stimava di non essere in nulla inferiore ai sommi apostoli» (2 Cor 11,5 e 12,11). Nella lettera ai Galati egli scrisse espressamente di essere stato chiamato all’apostolato «non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo» (1,1).
Egli addirittura considerava Pietro come «secondo» dopo Giacomo, fra quelli «che sono reputati colonne» (Gal 2,9), e in ogni caso non attribuiva a quella triade particolare significato, trattandosi, per lui, di semplici preferenze contingenti, «perché Dio non bada a persona alcuna» (2,6), meno che mai a quelle dotate di poteri politici assoluti.
I padri della chiesa interpretarono correttamente la rivendicazione di Paolo, intuendo che fra i primi apostoli (i Dodici e Paolo) tutti avevano medesima dignità, identiche prerogative: non esisteva alcuna superiorità ipostatizzata, stabilita una volta per tutte. Così la pensavano Crisostomo, Cipriano, Basilio, Isidoro di Siviglia…: con assoluta unanimità essi insegnavano che tutti gli apostoli furono quello che era Pietro.
Lo stesso Ambrogio di Milano scrisse: «Se l’apostolo Pietro aveva qualche precedenza, fra gli altri, questa fu precedenza di confessione non di onore. Precedenza di fede e non di classe». Non a caso però in occidente, fino a qualche tempo fa, circolavano edizioni del suo libro Sulla penitenza nelle quali la parola «fidem» era stata sostituita con la parola «sedem», per cui il testo arriva a dire esattamente il contrario di quanto aveva scritto Ambrogio: «Non possono avere eredità di Pietro coloro i quali non siedono come lui sulla stessa cattedra»!
Sulla questione del primato e dell’infallibilità pontificia ancora oggi si discute pochissimo in ambito cattolico. Gli studi più significativi restano comunque quelli di H. Küng, L’infallibilità (ed. Mondatori, 1977); La Chiesa, (Queriniana, 1969); A. B. Hasler, Pio IX. L'infallibilità del Papa e il Concilio Vaticano I (Stuttgart 1977); Come il papa divenne infallibile. Retroscena del Vaticano I (Torino 1982); P. De Rosa, Vicario di Cristo. Il lato oscuro del papato (Armenia editore, 1985); Cullmann e altri, Il primato di Pietro (Bologna 1965).
(torna su)19) L’idea di resurrezione dei corpi
Perché i cristiani parlano di «resurrezione dei corpi», che dovrà avvenire il giorno del cosiddetto «giudizio universale»? Non bastava sostenere l'idea dell'immortalità dell'anima e della vita eterna? Questo famoso «giudizio» perché deve per forza riguardare un'anima con un corpo? Dante, nel suo Inferno, condanna le anime dannate prima ancora del «giudizio», dicendo che, alla fine dei tempi, quando riceveranno il corpo, soffriranno ancora di più.
L'idea di «resurrezione corporea» (a parte i suoi riferimenti a taluni culti pagani) bisogna farla risalire alle lettere paoline, dove si sostiene, a più riprese che, siccome Gesù è «morto e risorto» (da notare ch’egli non parla mai di «misteriosa scomparsa di un cadavere»), dovranno per forza «risorgere» anche tutti i morti della terra e che se questa idea di «resurrezione dei corpi» fosse falsa, allora neppure Cristo sarebbe risorto, sicché del tutto vana sarebbe la fede del cristiano, proprio perché la morte (simbolo della schiavitù del peccato), entrata nel mondo per colpa di Adamo, è stata costretta a uscirne per grazia di Cristo (definitivamente alla fine dei tempi, quand’egli ritornerà per il giudizio universale). Gli esseri umani sono stati creati da dio in anima e corpo e tali devono rimanere.
Paolo cioè non riteneva possibile che il corpo potesse restare eternamente separato dall'anima. Per lui solo la resurrezione del corpo di Cristo attestava che questi fosse «figlio di dio». Se non fosse risorto, non si poteva avere una certezza assoluta della sua speciale figliolanza. Al massimo – vien da pensare - si poteva intendere l'espressione «figlio di dio» in senso traslato, metaforico, come p.es. poteva esserlo in riferimento a un grande profeta come il Battista. Oppure ci si sarebbe dovuti accontentare di racconti di «riapparizione» di un Gesù la cui anima non poteva avere lo stesso corpo di un tempo. Se il corpo non fosse scomparso dalla tomba, non si sarebbe potuto parlare di resurrezione e quindi, inevitabilmente, i racconti di riapparizione non sarebbero stati presi come qualcosa di «realistico».
Invece quei racconti vengono scritti come se il lettore dovesse pensare a una loro assoluta veridicità. È quindi evidente che se non fosse stranamente scomparso, non si sarebbe potuto dire ch’era risorto, se non in senso metaforico, ma in tal caso i racconti di resurrezione sarebbero apparsi come qualcosa di «poetico».
La mistificazione del cristianesimo sta appunto in questo, che, pur non avendo alcuna prova certa della «resurrezione del corpo di Gesù», in quanto al massimo si sarebbe dovuto parlare di «scomparsa misteriosa di un cadavere», la si è data per scontata, facendo altresì credere che i racconti di riapparizione fossero realistici e non poetici.
La parola «resurrezione» è un'interpretazione mistica e quindi arbitraria della tomba vuota, non è certo una semplice constatazione di fatto, in quanto il corpo redivivo del Cristo nessuno l'ha mai visto. Le descrizioni che ne vengono fatte potevano convincere solo un lettore che avesse già la fede, pertanto vanno considerate tautologiche, cioè ad uso interno.
E tuttavia qui ci si vuol chiedere: se il corpo fosse rimasto nella tomba, dopo la sua morte, si sarebbe potuto parlare di sola «immortalità dell'anima», che è concetto abbastanza oscuro alla mentalità ebraica? Che prova si sarebbe avuta? Nessuna.
Non solo quindi non si sarebbe potuto parlare di «resurrezione finale dei corpi», ma neppure di «immortalità immediata delle anime». Cioè per parlare di «anima immortale», si sarebbero dovuti elaborare dei racconti di riapparizione di Gesù che i cristiani, inevitabilmente, avrebbero considerato più poetici che realistici.
Questo spiega il motivo per cui l'idea di «resurrezione del corpo di Gesù» fu usata da Pietro e soprattutto da Paolo per distogliere il movimento nazareno dal proseguire l'attività politico-rivoluzionaria del Cristo. Cioè fu usata consapevolmente come idea principale per tradire il suo messaggio originario, con la differenza che mentre per Pietro il ritorno politico trionfale del Cristo sulla terra avrebbe dovuto essere più o meno immediato, in Paolo invece questa parusia, ad un certo punto, venne posticipata alla fine dei tempi. Nessuno dei due però ha mai messo in dubbio che il ritorno glorioso sarebbe avvenuto in un Cristo in carne ed ossa.
Questo corpo glorioso viene descritto da Paolo e nel quarto vangelo come capace di fare cose che agli umani, finché vivono sulla terra, non è assolutamente possibile: attraversare porte chiuse (Gv 20,19), assumere le sembianze non immediatamente riconoscibili (Gv 20,14; 21,4), prevedere cose ignote agli uomini (Gv 21,6), sapere cose senza che nessuno l'avesse informato (Gv 20,26 ss.), trasmettere in qualunque momento i poteri dello Spirito Santo (Gv 20,22) e in genere poter apparire ovunque e senza preavviso (come p.es. sulla via di Damasco).
Il motivo per cui non fosse tornato subito in veste gloriosa, sconfiggendo gli occupanti romani e il clero collaborazionista, Paolo cercò di spiegarlo ai suoi discepoli col dire che il messaggio del Cristo doveva prima essere diffuso tra i pagani: il che doveva far capire agli ebrei che il loro «primato storico-politico» era irrimediabilmente finito e che, d'ora in avanti, la liberazione andava cercata insieme, ebrei e pagani, in forma esclusivamente «spirituale», in quanto a quella «politica» avrebbe pensato personalmente il Cristo alla fine dei tempi.
La tesi della resurrezione doveva appunto servire anche a questo, a trasformare il Cristo da liberatore politico-nazionale a redentore morale-universale. I primi cristiani o, quanto meno, la corrente petro-paolina, divenuta maggioritaria, s’era fatta dell'idea di «corpo risorto» il pretesto per rinunciare definitivamente all'idea dell'insurrezione popolare contro Roma. Questo perché, probabilmente, si riteneva che il fallimento dell'iniziativa del Cristo fosse stato una grande tragedia, una grande occasione perduta, e anche perché si riteneva la potenza romana, una volta giustiziato il leader Gesù, troppo forte per essere abbattuta.
Non è neppure da escludere che i molteplici tentativi fatti dal Cristo di tenere unite le varie componenti della Palestina per opporsi ai romani, avessero subito un'improvvisa battuta d'arresto subito dopo la crocifissione. Cioè non è da escludere che soprattutto i galilei e i samaritani avessero ripreso a detestare i giudei che nel momento cruciale, invece di liberare Gesù, avevano preferito Barabba, come si può dedurre dal finale del vangelo di Marco, ove viene detto che Gesù risorto avrebbe «preceduto» gli apostoli in Galilea (16,7).
Resta però da capire il motivo per cui Paolo non si limiti a parlare di «resurrezione del corpo di Gesù», ma anche di resurrezione di tutti i corpi umani. Che bisogno aveva di farlo? Non sarebbe bastato parlare di «immortalità dell'anima umana», assicurata proprio dalla resurrezione del Cristo? Evidentemente no. Per la mentalità ebraica non è pensabile che anima e corpo se ne stiano separati in eterno e neppure che non possa esistere una liberazione terrena.
Questo è forse l'aspetto più controverso della teologia paolina. Probabilmente, nella sua iniziale predicazione, Paolo, sulla scia di Pietro, attendeva una parusia imminente e, alla domanda che gli sarà stata posta circa la sorte di coloro che non avrebbero potuto beneficiare di tale parusia, essendo già morti, egli dovette inventarsi l'idea che i viventi, a lui contemporanei, non avrebbero avuto «alcun vantaggio» su quelli ch’erano già morti, in quanto questi sarebbero comunque «risorti nella carne»; sicché insieme, vivi e morti risorti, avrebbero regnato sulla terra (1Tess. 4,13 ss.).
Vi sono tuttavia delle difficoltà. Quali «vivi» e quali «morti risorti» avrebbero potuto regnare sulla terra? Se fossero stati solo i «cristiani», che ne sarebbe stato di tutti gli altri? I «cristiani in anima e corpo» avrebbero regnato in Cristo sulla terra impedendo a tutti gli altri di ostacolarli?
Man mano che la parusia tardava, Paolo sarà costretto a trasferire questa idea di regno liberato e pacificato dalla terra al cielo e sarà anche costretto a dare a tutti i non-cristiani una seconda possibilità, in cielo, di credere nel Cristo. Nella misura in cui portava il suo messaggio a una sempre più marcata astrazione spiritualistica, si rendeva conto che sarebbe stato meglio per lui uscire di scena nei panni del martire.
(torna su)Mappe dei viaggi di Paolo di Tarso
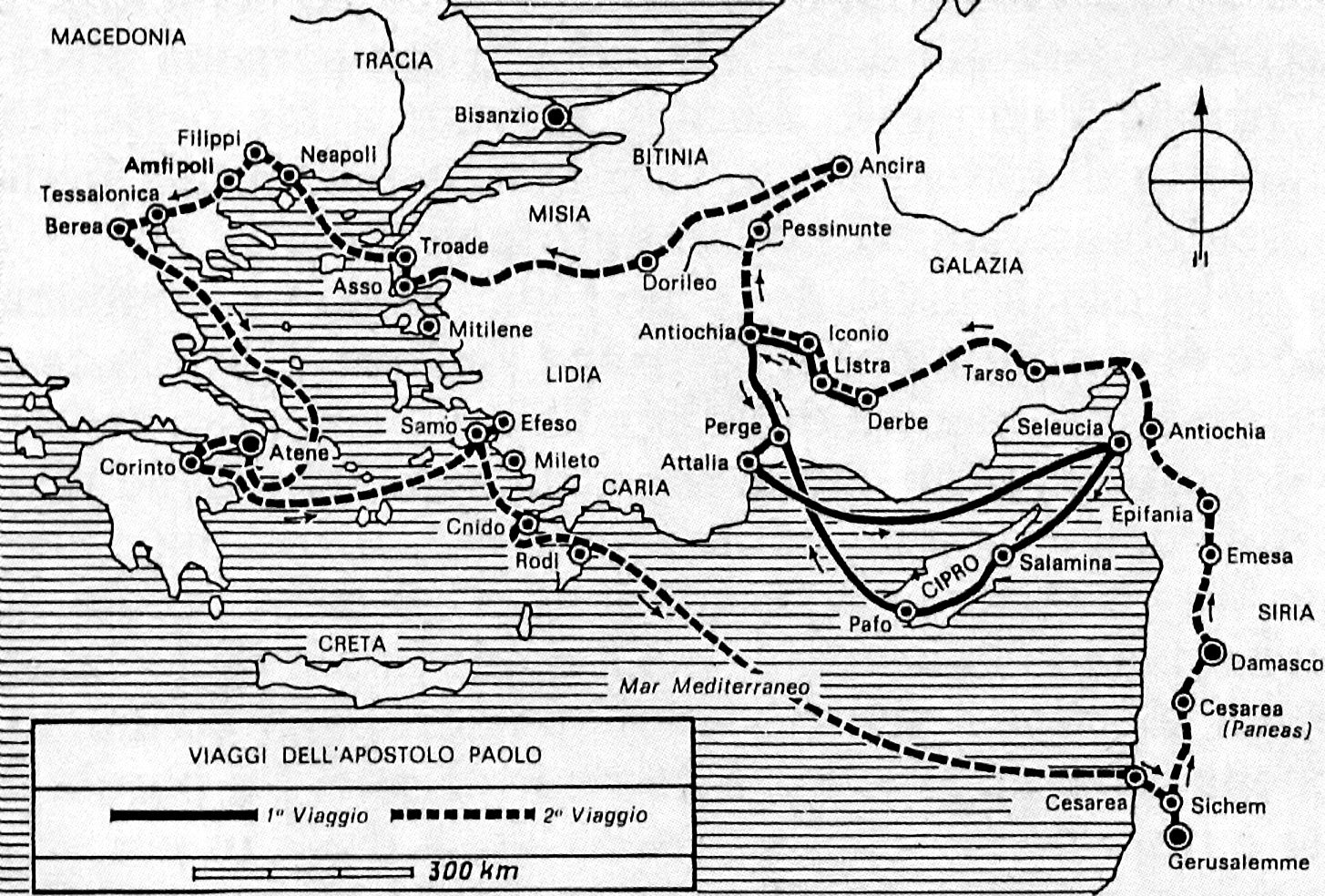

1 Da notare che anche la «gloria nei cieli» non va considerata - secondo Paolo - come un processo autonomo di costruzione positiva della personalità, ma come una «grazia» che gli «eletti» ricevono da dio (8,33). La giustizia, la libertà, la verità... non dipendono «dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericordia» (9,16).
2 cfr A. Moda, Il problema dell'autorità politica secondo Romani XIII, 1-17, in «Nicolaus», n. 2/1973, p. 278.
3 C'è addirittura chi ha visto, alle spalle della logica oggettiva dell’essenza, delineata da Hegel, la realtà spirituale della seconda Gerarchia (Kyriotetes, Dynameis ed Exusiai)!
4 Se ne cita uno per tutti, tra i più noti: O. Cullmann, La regalità di Cristo e la chiesa, A.V.E., Roma 1973, e Studi di teologia biblica, A.V.E., Roma 1968 (il cap. «Dio e Cesare»).
5 Secondo alcuni esegeti la più antica è quella dei Galati, che risalirebbe alla fine del primo viaggio missionario.
6 Nella cosmopolitica Tessalonica, punto d'incontro tra oriente e occidente, dominava il più ampio sincretismo religioso, coi culti pagani di Serapis, Cibele, Dioniso, Cabiro, ma anche di Roma e di Augusto, ivi incluse varie divinità greco-italiche, quali Diana, Atena, Afrodite... La scelta a favore di questa città doveva apparire, agli occhi di Paolo, di natura strategica, in quanto da qui facilmente la predicazione si sarebbe irradiata nelle province orientali dell'impero.
7 Si noti in tal senso che il termine «parusia» non ha lo stesso significato che aveva nel mondo pagano, ove s'intendeva l'arrivo solenne di un esercito, guidato da un generale o da un sovrano, cui faceva seguito l'accoglienza festosa da parte degli alti dignitari della città. Qui il significato è più bellicoso: è una resa dei conti nei confronti dei propri nemici. Ogniqualvolta si parla nelle lettere paoline di «giorno del Signore», di «quel giorno» o di «giorno dell'ira», «giorno del giudizio», «giorno della rivelazione», s'intende sempre qualcosa attinente a un evento di tipo escatologico, in uno scenario di catastrofe cosmica. Tuttavia, col passare degli anni, Paolo sarà costretto a trasformare il suo concetto di «parusia imminente» in «parusia ritardata» (a tale scopo, tra i segni premonitori, si sentirà indotto ad aggiungere, nella lettera ai Romani e nella seconda ai Corinti, anche quello della conversione degli ebrei al cristianesimo!). In particolare, proprio a partire dalla seconda lettera ai Corinti, accanto all'escatologia di carattere schiettamente apocalittico e collettivo, Paolo inserirà con insistenza, nella propria teologia, l'idea di una escatologia più individuale, in cui diventava possibile incontrarsi col Cristo dopo morti. Il termine «parusia» ricorre quattro volte nel cap. 24 del vangelo di Matteo e due volte nella lettera di Giacomo. Anche alcuni scrittori latini parlavano di «imminenza della fine»: Lucrezio, Livio, Ovidio, Seneca ecc. L'allontanarsi sempre più netto della parusia obbligherà i Padri della chiesa a concentrarsi sui destini dell'anima nell'aldilà.
8 Non pochi esegeti (i primi risalgono alla critica liberale del XIX sec.) la ritengono un falso della fine del I secolo, registrando una concezione differente dell'escatologia (nella prima risorgono solo i morti in Cristo, nella seconda tutti), una stretta dipendenza letteraria dalla prima, un frasario più ellenistico nella prima e più giudaico nella seconda, una diversa identità dei destinatari delle due missive, un presunto significato moralistico di alcuni termini, estraneo al comune pensiero paolino.
9 In genere nel mondo pagano soltanto l'adulterio, e solo quando questo era da parte della donna, veniva riprovato e punito. Persino lo stoicismo, in materia di licenza sessuale, si limitava a chiedere soltanto una certa moderazione.
10 Va tuttavia detto che la prigionia romana di Paolo consistette in una casa presa in affitto (At 28,30), con possibilità di ricevere visite e di svolgere persino una certa attività di apostolato (At 28,17.31).
11 Al tempo di Paolo, Filippi era una città della provincia romana di Macedonia. Era stata fondata nel 358-57 a.C. da Filippo II il macedone, e nel 42 a.C. essa fu teatro della celebre battaglia vinta da Antonio contro Bruto e Cassio, dopo l'assassinio di Cesare. Paolo l'aveva visitata durante il suo secondo viaggio missionario e questa in un certo senso fu la prima comunità cristiana ch'egli fondò su suolo europeo (50 d.C.), ovviamente sempre stando al computo degli Atti degli apostoli (16,11-40).
12 Paolo scrive la lettera in prigione, probabilmente da Roma (61-63), ma alcuni critici ritengono che la prigionia sia quella stessa di Efeso (45-47).
13 «Cani» erano denominati i gentili dagli ebrei. Qui Paolo capovolge l'applicazione del termine. Quando dice «il loro dio è il ventre» intende riferirsi alle minuziose prescrizioni dietetiche.
14 I. E. C. Schmidt, F. Schleiermacher, J. G. Eichhorn, W. L. M. de Wette, F. C. Baur, H. J. Holtzmann, P. Wendland, M. Dibelius, H. von Campenhausen. Altri invece si limitano a dire che nelle Pastorali vi sarebbe un fondo paolino, sommerso in una moltitudine di aggiunte posteriori (K. A. Kredner, P. N. Harrison, A. von Harnack, R. Bultmann). È curioso in tal senso notare come il più grande «manipolatore» del vangelo di Cristo sia stato destinato al medesimo trattamento da parte delle comunità ch'egli aveva fondato.
15 La Vulgata traduce così: «quia fideles sunt et dilecti qui beneficii participes sunt». In francese così: «mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien». La versione Darby: «mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés.». In inglese così: «but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit».
16 La teologia paolina si poneva anche il compito di superare l'idea filoniana secondo cui il logos va inteso come rappresentazione imperfetta di un'idea astratta, tale per cui al logos viene interdetta la facoltà creazionistica vera e propria, attribuibile solo a dio.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube