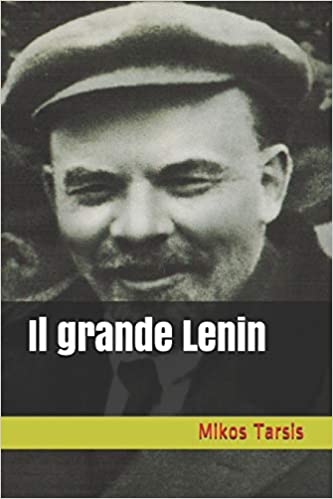
IL GRANDE LENIN
Per un socialismo democratico
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
La dittatura del proletariato
Introduzione
I testi di Lenin, pur essendo scritti in una forma linguistica molto più semplice di quella di Marx o di Hegel, con evidenti preoccupazioni “pedagogiche”, che è poi, se vogliamo, una caratteristica di tutta la letteratura russa, risultano incredibilmente complessi alla mente di chi si preoccupa di cercare delle coerenze logiche nell'interpretazione ch'egli diede dei fatti storici o delle vicende politiche.
La grande flessibilità che si riscontra nel suo modo di vedere le cose e di agire nel concreto può far pensare, di primo acchito, a una qualche forma di cinismo, di spregiudicatezza intellettuale. Se Lenin fosse stato un militare, sarebbe stato un grande generale, ma sarebbe stato anche un grande scacchista, se si fosse dedicato sistematicamente a questo gioco.
Questo perché il suo interesse principale era quello di trovare un'adeguata tattica e strategia per realizzare un determinato obiettivo, che per lui era eminentemente politico.
Lenin non è mai stato un filosofo, neppure quando ha scritto testi molto importanti di filosofia (uno per tutti quello sull'Empiriocriticismo), semplicemente perché vedeva nelle questioni filosofiche i riflessi ch'esse potevano avere sulle questioni ideologiche e pratiche di natura politica. Peraltro, proprio grazie a lui il termine “ideologia” perde la caratteristica negativa attribuitagli da Marx ed Engels, quale sovrastruttura teorica che legittima determinati rapporti di classe, per assumerne una positiva, quale sostrato di idee politiche volte a scardinare quegli stessi rapporti di classe.
Ogni suo scritto, dal più piccolo al più grande, nasce per rispondere a un problema concreto, contingente, di organizzazione o delle idee o dell'agire. Qui sta una delle caratteristiche più importanti di tutti i suoi scritti: l'estrema concretezza degli argomenti trattati, la loro precisa contestualizzazione nello spazio e nel tempo.
E le risposte ch'egli ogni volta dà ai singoli problemi non sono mai le stesse o non sono mai formulate allo stesso modo, spesso anzi risultano in contraddizione tra loro, al punto che si ha l'impressione che Lenin non scrivesse tanto per dimostrare la fondatezza delle proprie tesi, quanto, al contrario, per dimostrare la necessità di una loro continua rettifica.
Lo scrivere veniva mosso da esigenze che si sviluppavano nella concretezza dei rapporti sociali e politici, i cui risvolti contradditori, conflittuali, venivano percepiti con estrema lucidità e profondità e se vogliamo anche drammaticità di pensiero.
In particolare bisogna dire che in tutte le sue teorie gli aspetti economici non vengono mai trattati come fine a se stessi, ma come parte di aspetti sociali più generali, nei cui confronti bisogna porre delle soluzioni di tipo politico. Lui stesso dirà che il politico è una sintesi dell'economico e alla fine della sua vita, nella critica a Sukhanov, dirà che gli aspetti culturali sarebbero stati più facilmente sviluppati dopo la rivoluzione, in quanto la politica doveva anzitutto porre le basi, le condizioni esteriori di tale sviluppo.
Sono così pregnanti queste riflessioni che a volte si ha l'impressione che se Lenin non avesse scritto nulla e si fosse limitato a parlare (sempre che gliene avessero dato l'opportunità), sarebbe stato comunque un grandissimo personaggio. A tutt'oggi infatti è impossibile metterlo a confronto con un teorico della politica al suo livello. Anche Trotsky e Stalin sono stati dei teorici della politica, scrivendo decine di volumi, ma dov'è l'originalità del loro pensiero?
Se dovessimo limitarci a guardare la pura e semplice “originalità del pensiero politico”, dovremmo dire che Machiavelli è il più grande di tutti, avendo egli fondato una “scienza della politica” che fa testo ancora oggi nelle economie occidentali. Ma non si tratta soltanto di stabilire la grandezza di una teoria politica senza precedenti, anche in riferimento alla sua durata nel tempo. Qualcuno forse è in grado di sostenere che il Machiavelli sia stato più grande di Lenin sul piano più propriamente etico-politico?
Detto altrimenti, anche quando noi trovassimo un teorico della politica equivalente o persino superiore al genio di Lenin, resterebbe sempre da dimostrare l'effettiva consistenza pratica del suo pensiero, il suo valore normativo o, per dirla con altre parole “di sinistra”, la sua “ricaduta positiva sulle masse”.
Machiavelli infatti fu il teorico di una politica classista, per i pochi ceti forti, soprattutto borghesi o dell'aristocrazia illuminata. Lenin invece fu il teorico del proletariato, cioè l'organizzatore di una rivoluzione a favore dei ceti più deboli, ch'erano operai e contadini, di enorme consistenza numerica nella Russia post-feudale: una rivoluzione, peraltro, che uscì immediatamente dai confini nazionali per essere sentita come “propria” dal proletariato di tutto il mondo.
Lenin su questa scelta di campo era serissimo e ha sempre avuto in mente situazioni concrete di disagio da dover risolvere. Se fosse nato in uno Stato socialista avrebbe probabilmente esercitato la professione dell'avvocato, quella per cui si era laureato.
Viceversa il Principe del Machiavelli non corrisponde ad alcuna situazione reale, essendo soltanto un messaggio simbolico, metaforico, non molto diverso da quello dell'Utopia di Thomas More, con la differenza che quest'ultimo aveva capito sin dall'inizio la pericolosità sociale dello sviluppo capitalistico.
Machiavelli pensava che con un principe di “tipo nuovo” si sarebbe potuta superare la frammentazione di un paese diviso in tanti staterelli tra loro ostili, e formare una nazione che stesse alla pari di Spagna, Francia e Inghilterra, ma il fatto che vedesse nel corrotto e spregiudicato Valentino la possibile incarnazione dei suoi ideali, la dice lunga sull'effettivo valore etico-politico delle sue teorie.
Il concorso delle masse alla realizzazione del suo principale obiettivo politico-nazionale veniva visto da Machiavelli in maniera del tutto strumentale, e in questo il fiorentino può davvero essere considerato come il capostipite del fare politica nei moderni paesi borghesi dell'Europa occidentale.
Per Lenin invece le masse non sono uno strumento della politica, ma è la politica che deve porsi come strumento di liberazione delle masse. Lenin vuole agire come interprete e realizzatore di esigenze che sono anzitutto “vitali” e che riguardano milioni di persone (atteggiamento, questo, che poi Gramsci tradurrà col concetto di “intellettuale organico”). L'unica vera coerenza che si può trovare nel suo pensiero è proprio questo attaccamento costante, irriducibile, alle istanze emancipative degli oppressi, di qualunque nazionalità essi fossero.
Non dobbiamo infatti dimenticare che Lenin pagò caro questo suo atteggiamento “etico”, sia con gli anni del carcere in Siberia, sia coi molti anni di esilio e di clandestinità, per non parlare dell'attentato di cui fu oggetto e che lo portò a morte prematura, e non si dimentichi che il fratello maggiore fu impiccato per aver partecipato a un attentato contro lo zar Alessandro III. E questo senza considerare l'immediato tradimento dello stalinismo subito dopo la sua morte.
Se fosse stato un politico interessato soltanto alla “politica”, non avrebbe fatto la rivoluzione di “ottobre”, ma si sarebbe accontentato di quella di “febbraio” e nessuno avrebbe avuto nulla da rimproverargli, poiché, umanamente parlando, egli aveva già dato moltissimo alla causa rivoluzionaria.
Questo per dire che Lenin resta un personaggio molto particolare, talmente sui generis nella storia del pensiero politico mondiale che per poterlo capire bisogna prima sgombrare la mente da ogni pregiudizio proveniente dalla letteratura borghese, calandosi profondamente nelle vicende storiche che hanno caratterizzato la sua epoca e la sua vita, contestualizzando la sua teoria e rinunciando soprattutto a interpretarla col senno del poi, che è appunto quello della rivoluzione vittoriosa nei confronti dei nemici interni ed esterni alla nazione russa.
In effetti è una tentazione molto grande quella di interpretare le vicende di Lenin alla luce di quanto avvenne a partire dall'ottobre 1917. Sarebbe molto facile presentare le cose, mostrando quanto egli avesse ragione e quanto torto avessero i suoi avversari. In realtà le idee di Lenin riuscirono a farsi strada con incredibile fatica, e persino quando finalmente ebbero modo di essere messe alla prova con la realizzazione della rivoluzione, ci fu chi, ad un certo punto, preferì travisarle, pregiudicando in maniera gravissima (al momento apparentemente irreparabile) i risultati di immani fatiche.
Lenin arrivò a pensare come necessario il concetto di “dittatura del proletariato” quando si rese conto che con la democrazia borghese gli operai e i contadini avrebbero al massimo ottenuto le libertà politiche, certamente non quelle socio-economiche. Queste ultime infatti, per poter essere garantite, avrebbero avuto bisogno che la Russia diventasse come i principali Stati europei o come gli Stati Uniti, cioè un paese imperialista, facendo pagare alle colonie il prezzo del proprio benessere.
Ad un certo punto Lenin si chiese se si poteva evitare una soluzione del genere, dal momento che la Russia non aveva ancora raggiunto i livelli delle maggiori potenze industrializzate, e quali mezzi politici si sarebbero potuti usare.
In effetti l'impero zarista era stato sconfitto tardi dalla rivoluzione democratico-borghese. La Russia era ancora un paese debole dal punto di vista del capitalismo, ma, considerando la sua enorme estensione geografica e quindi le sue imponenti risorse naturali, aveva tutte le carte in regola per mettersi alla pari, potendo peraltro avvalersi delle conquiste tecnico-scientifiche più recenti dei paesi europei, senza doverne ripercorrere il loro faticoso cammino.
Lenin, che quasi tutta la sua vita da rivoluzionario l'aveva vissuta all'estero, proprio nei paesi europei più avanzati, sapeva bene che il modello di democrazia borghese delle economie occidentali non avrebbe potuto garantire alcun futuro alla classe operaia e a quella contadina del suo paese.
La Russia, se il capitalismo avesse definitivamente trionfato sul tardo feudalesimo, senza alcuna transizione al socialismo, sarebbe stata consegnata agli affaristi, agli speculatori, agli usurai, che avrebbero approfittato enormemente della miseria e dell'analfabetismo imperanti. Che cosa si poteva fare affinché un paese così grande e complesso non finisse nella trappola della democrazia borghese, capace solo d'illudere i lavoratori di trovarsi a vivere nella migliore democrazia di tutti i tempi?
Da tutti i rivoluzionari russi l'ex-impero zarista, che pur era stato il baluardo più forte della reazione feudale, veniva considerato come l'anello più debole del capitalismo mondiale, non ancora capace d'impedire al capitale straniero di entrare nel suo territorio e di devastarlo. Solo che mentre i riformisti, i socialisti rivoluzionari1, i menscevichi ritenevano che, proprio perché “debole”, l'anello non avrebbe potuto resistere al fiume in piena del capitalismo mondiale, per cui il massimo che si poteva fare, in quel momento, era di organizzare un sistema borghese più “democratico” di quelli occidentali, viceversa i bolscevichi, per la stessa ragione, pensavano che sarebbe stata più facile una rivoluzione comunista, con la quale, successivamente, si sarebbe potuta contrastare efficacemente la diffusione nazionale del capitalismo.
Due analisi identiche sulla questione dell'“anello debole”, che però portavano a due conclusioni radicalmente opposte. Lenin arrivò all'idea della necessità di una “dittatura proletaria” anche quando si rese conto che non sarebbe venuto nulla di positivo, ai fini della rivoluzione bolscevica, neppure dalla tradizione socialista e socialdemocratica maturata in Europa occidentale e che si riconosceva nella II Internazionale.
Ciò che lo fece disperare dal credere possibile ottenere aiuti da parte del socialismo europeo (quegli aiuti che nelle fasi iniziali di una qualunque rivoluzione sono sempre molto utili), fu proprio il fatto che nessun partito socialista era stato capace di opporsi allo scatenamento della prima guerra mondiale, nessuno aveva saputo bloccare la volontà imperialistica della borghesia del proprio paese e nessun partito, a guerra scoppiata, aveva accettato l'idea di trasformare la guerra imperialistica in guerra civile.
Lenin cominciò a parlare di “dittatura del proletariato” quando si rese conto che la rivoluzione russa avrebbe dovuto contare solo sulle proprie forze e che anzi avrebbe dovuto affrontare minacce controrivoluzionarie non solo al proprio interno ma anche da parte dell'interventismo straniero (come poi puntualmente si verificò).
Con la sua definizione di “dittatura” egli poteva facilmente porre una netta linea di demarcazione tra il socialismo bolscevico (poi definito “comunista” o “sovietico”) e tutte quelle altre forme di socialismo che nel migliore dei casi potevano essere definite “riformiste”.
Il concetto di “dittatura del proletariato” doveva servire per sgombrare il campo da un equivoco fondamentale relativo alla gestione del potere politico. Si trattava cioè di opporsi alla falsa democrazia borghese, che nei fatti era una vera e propria dittatura da parte di un'esigua minoranza di sfruttatori, ma anche al falso socialismo riformista, che a parole si diceva “marxista” e nei fatti era “anticomunista”. La “dittatura del proletariato” avrebbe dovuto essere il governo di una larga maggioranza su una piccola minoranza di parassiti, dotati di grandi poteri economici.
Col concetto di “proletariato” Lenin, sulla scia del marxismo classico, intendeva anzitutto la classe operaia, nullatenente per definizione, ma anche i braccianti rurali e altre categorie di lavoratori agricoli che di fatto non erano proprietari di nulla. Naturalmente anche l'intellettuale che rinunciava alla propria professione e si dedicava interamente alla causa della rivoluzione, veniva considerato un “proletario”.
Lenin aveva sempre sostenuto che i rivoluzionari dovevano essere dei “professionisti della politica”, cioè degli esperti organizzatori di movimenti di massa, e per tale ragione riteneva che dovessero esercitare le loro mansioni (agitazione, propaganda, attività culturale, politica, sindacale ecc.) a tempo pieno, stipendiati in un certo senso dalle stesse masse che, grazie a questa leadership competente, sarebbero dovute andare al potere.
Per Lenin l'intellettuale politicizzato non poteva porsi semplicemente il compito di migliorare le condizioni salariali o di vita dei lavoratori, ma doveva scardinare i meccanismi che obbligavano la maggioranza dei cittadini a vendere la loro forza-lavoro ai detentori della proprietà privata dei mezzi produttivi e dei capitali.
Nei suoi testi il concetto di “rivoluzione” va sempre di pari passo con quello di “conquista del potere politico”, di “socializzazione della produzione”, di “dittatura del proletariato” (contro la reazione della borghesia e degli agrari anzitutto) e di “progressiva estinzione dello Stato”, onde evitare la burocratizzazione della stessa rivoluzione.
Nel corso della sua breve ma intensa vita (a 52 anni era già gravemente malato), Lenin rispettò gli impegni che s'era dato, eccetto l'ultimo, per il quale non ebbe il tempo materiale per dedicarvisi, ma per la soluzione del quale offrì importanti indicazioni di metodo, che lo stalinismo – come sappiamo – non volle tenere in considerazione. Infatti, Stalin, con la sua idea secondo cui all'aumentare della forza del socialismo, aumenta anche la volontà del capitalismo di distruggerlo, non fece che trasformare lo Stato in un organo di forte repressione.
Anche Lenin spesso ebbe atteggiamenti intransigenti nei confronti dei coltivatori diretti (piccoli proprietari), legati com'erano agli ambienti clericali e ai partiti riformisti; egli sapeva bene che, anche se piccolo-borghesi, essi, di fronte alle prime difficoltà della rivoluzione, avrebbero inevitabilmente fatto in modo di reintrodurre in Russia il capitalismo. Però non volle mai espropriarli, come invece fece coi grandi latifondisti; si limitò a obbligarli a vendere allo Stato a prezzi politici o di favore i loro prodotti nel periodo del cosiddetto “comunismo di guerra” (segnato dalla controrivoluzione interna e dall'interventismo straniero), ma poi si rese conto che, se non avesse introdotto la Nep, la gran massa dei contadini gli si sarebbe rivoltata contro.
Era tuttavia convinto che con un paziente lavoro di educazione i contadini, ad un certo punto, avrebbero preferito l'idea di un “socialismo proletario” a quella di un “capitalismo democratico”, che da tempo aveva dimostrato di voler scardinare tutte le migliori tradizioni rurali del paese. I grandi esodi dalla campagna alla città e alle industrie erano sotto gli occhi di tutti.
Lenin si fidava soltanto di chi non possedeva nulla e, tra questi, solo di chi voleva impegnarsi contro lo sfruttamento del lavoro altrui. Ma non per questo amava applicare metodi “amministrativi” contro chi la pensava diversamente.
Dittatura personale e popolare
Lenin era convinto che una dittatura del popolo sugli sfruttatori non avesse bisogno di fare riferimento ad alcuna legge o norma morale e che dovesse basarsi esclusivamente sulla forza del popolo. Ne parla nel 1920 in Per la storia della questione della dittatura.
Indubbiamente non gli si può dar torto quando spiega la differenza tra “dittatura personale” e “dittatura popolare”, tra “dittatura di una classe di sfruttatori” e “dittatura di una classe di sfruttati”, cioè tra “dittatura di un'infima minoranza” e “dittatura di una grande maggioranza”.
Tuttavia bisogna stare attenti a non fare del “popolo oppresso” uno strumento per abusare della propria libertà o della propria verità. Una volta compiuta la rivoluzione si dovrebbe dimostrare non che la legge è inutile, ma che finalmente le leggi possono davvero essere applicate per gli interessi del popolo (ammesso e non concesso che il popolo abbia davvero bisogno di “leggi scritte”, non ritenendo sufficienti le consuetudini).
In tempo di pace la borghesia esercita la propria dittatura economica dietro il paravento della democrazia parlamentare e costituzionale. La borghesia è una classe necessariamente contraddittoria, in quanto non riesce ad essere coerente con gli ideali o i princìpi che professa in sede giuridica, politica, etica. Però, andando al potere, il proletariato non può negare qualunque valore a questi princìpi. Deve anzi dimostrare ch'esso è in grado di applicarli con maggiore coerenza. Altrimenti si rischia che, fatta la rivoluzione, gli intellettuali strumentalizzino il proletariato proprio sulla concezione della dittatura e della violenza rivoluzionaria. Cioè alla fine rischia di diventare un “nemico del popolo” chiunque si opponga a una determinata concezione di dittatura rivoluzionaria. Non era forse lo stalinismo che considerava “agenti della borghesia” o “nemici del popolo” quanti avevano fatto la rivoluzione comunista?
Viceversa, nessuno può pretendere di avere il monopolio interpretativo del concetto di “violenza rivoluzionaria”. Lo “Stato rivoluzionario” non può sostituirsi allo “Stato di diritto”, anche perché il socialismo deve portare lo Stato a estinguersi e ciò non può certo avvenire in nome di una dittatura o di una violenza rivoluzionaria.
Il proletariato non deve soltanto capire che la borghesia va sottomessa con la forza, ma deve anche capire che nell'uso di questa forza esso non può perdere la propria umanità. Cioè non si può venir meno a dei princìpi umani solo perché si ha politicamente ragione. La reazione del popolo all'oppressione, allo sfruttamento non può essere considerata sempre giusta, a prescindere dalle forme e dai modi, solo perché fatta dal “popolo”. La categoria di “popolo oppresso” non rende di per sé meno importante il rispetto dei valori umani universali, anche se questi valori vengono recepiti come formali, in quanto gestiti in maniera contraddittoria da una classe sfruttatrice.
La storia dell'umanità “democratica” non inizia nel momento in cui si eliminano le classi sfruttatrici, ma nel momento in cui si dimostra d'essere in grado di vivere meglio i loro stessi ideali democratici.
Dittatura del proletariato e democrazia operaia
Perché Lenin parla così di frequente e senza mezzi termini di “dittatura del proletariato”? Perché ha così tante riserve a usare una formula come “democrazia proletaria od operaia”, che pur verrà usata molto di frequente nel dibattito interno al Pcus negli anni 1923-24? Le ragioni sono più di una e non riguardano soltanto i rapporti tra il sistema politico socialista e quello capitalista, ma anche i rapporti tra le correnti politiche all'interno dello stesso socialismo.
Lenin ha sempre contrapposto la “dittatura proletaria” alla “democrazia borghese” come avrebbe contrapposto qualcosa di “vero” a qualcosa di “falso”, qualcosa di “coerente” a qualcosa di “ambiguo” o di “ipocrita”, come appunto era (ed è) ipocrita la società borghese, che predica sul piano teorico la democrazia, mentre su quello pratico fa esattamente il contrario, con la sua dittatura “sul” proletariato nazionale, sui lavoratori delle colonie e con la guerra alle potenze rivali e la guerra al socialismo.
La parola “democrazia” appariva a Lenin in tutta la sua “falsità” proprio per gli abusi ch'essa astutamente celava. Egli la considerava troppo screditata perché la si potesse usare per qualificare, politicamente, una società, quella socialista, che si voleva superiore a quella borghese, una società economicamente giusta e non soltanto politicamente democratica.
In nome della “democrazia” l'occidente aveva distrutto non solo le tradizioni pre-borghesi, ma stava distruggendo anche quelle post-borghesi, quelle socialiste, stava inoltre saccheggiando il mondo intero e aveva fatto scoppiare la prima guerra mondiale, cui avrebbe potuto essercene una seconda – diceva Lenin – se nuovi competitori capitalistici si fossero affacciati sulla scena internazionale.
Peraltro la democrazia borghese era “parlamentare” e Lenin non amava che gli interessi della borghesia e dei latifondisti o ricchi agricoltori fossero rappresentati dai rispettivi partiti politici in un parlamento. Una rappresentanza del genere avrebbe inevitabilmente rallentato i tempi della costruzione del socialismo. Ecco perché riteneva, sotto questo aspetto, del tutto inutile anche il parlamento.
Egli non aveva paura di negare rappresentanza politica a delle classi che in Russia erano già molto osteggiate, anche se numericamente ancora consistenti. La stragrande maggioranza della popolazione russa era contadina, la quale aveva appoggiato la rivoluzione guidata dagli operai delle grandi città.
Lo Stato da costruire (o meglio la “società”, in quanto lo Stato avrebbe dovuto progressivamente “estinguersi”) doveva realizzare praticamente una sorta di transizione dal feudalesimo al socialismo, saltando la fase del capitalismo, che pur si stava velocemente imponendo nella Russia europea del primo decennio del Novecento e che gli stessi bolscevichi saranno costretti a favorire con la Nuova Politica Economica, per far fronte alla crisi del comunismo di guerra.
L'Ottobre bolscevico voleva essere una “rivoluzione proletaria”, come mai in Europa (se si esclude la breve parentesi della Comune parigina) s'era riuscito a fare; voleva porsi come un tentativo politico, sociale, economico infinitamente superiore a qualunque “rivoluzione borghese”, ognuna delle quali non aveva mai messo in discussione il diritto alla proprietà privata come diritto naturale. Nessuna rivoluzione borghese aveva mai riconosciuto legittimità universale ai diritti economici, che non fossero quelli già acquisiti (dalla stessa borghesia).
Ma c'è un'altra ragione che spiega in Lenin l'uso della parola “dittatura” al posto di quella di “democrazia”. La dittatura permetteva un governo centralizzato, una ferrea disciplina di partito, che in effetti tornarono molto utili nel momento della controrivoluzione interna e dell'interventismo straniero.
Più volte Lenin aveva detto di non volersi legare le mani col rispetto dei princìpi teorici della democrazia, meno che mai nel momento in cui la stessa democrazia borghese avrebbe fatto di tutto per liquidare la rivoluzione bolscevica. Egli faceva capire a chiare lettere alle potenze occidentali che avrebbe usato ogni mezzo per impedire che i loro eserciti conquistassero l'ex-impero zarista. Essendo vissuto per molto tempo, come esule politico, in vari paesi europei, Lenin sapeva bene che i capitalisti avrebbero fatto di tutto per impedire in qualunque parte del mondo la realizzazione del socialismo.
L'ex-impero andava trasformato in uno Stato confederato di nazionalità autonome, in cui la preoccupazione fondamentale doveva essere l'edificazione del socialismo. Al di fuori di questo obiettivo vi era soltanto quello delle potenze europee e degli Stati Uniti di fare della Russia una terra di conquista da spartirsi in zone d'influenza, come si cercò appunto di fare con l'interventismo militare in appoggio alla reazione dei bianchi.
Lenin era convinto che il concetto di “dittatura proletaria” includesse tutti i migliori valori politici della democrazia borghese e molto di più. Il fatto che fosse appunto “proletaria” garantiva di per sé alla dittatura il suo carattere “democratico”.
Bisogna tuttavia rendersi conto che per Lenin il concetto di “democrazia” aveva scarso significato, poiché in tutta la storia della civiltà occidentale (da quella schiavistica a quella borghese) la “democrazia politica” era servita soltanto a garantire il dominio della classe proprietaria dei mezzi produttivi e quindi lo sfruttamento dei lavoratori. Pertanto egli era più che convinto che i lavoratori russi non avrebbero fatto obiezione a che il partito bolscevico usasse la parola “dittatura” al posto di “democrazia”.
La domanda che a questo punto sorge spontaneo porsi è la seguente: con la suddetta impostazione del problema della transizione politica al socialismo, Lenin aveva posto le premesse per la successiva degenerazione burocratica e autoritaria staliniana, in cui praticamente un governo di intellettuali si sostituì a quello dei proletari, oppure vi erano in essa dei margini sufficienti per impedire una tale degenerazione? In altre parole: Lenin era riuscito a porre le basi “sistemiche” per un uso “proletario” della democrazia, oppure aveva confidato troppo nelle proprie indubbie capacità soggettive (flessibilità, concretezza, lungimiranza, realismo politico...) per ovviare alle possibili involuzioni autoritarie o amministrative nell'edificazione del socialismo?2
Soggettivamente Lenin sapeva scorgere in tempo reale i limiti di un'edificazione del socialismo non sufficientemente “democratica”, ma oggettivamente seppe davvero porre le basi perché, anche dopo la sua morte, si potesse proseguire sulla medesima strada? O forse più in generale ci si potrebbe chiedere: è possibile porre “oggettivamente” delle basi del genere? È davvero possibile offrire garanzie sicure per una coerenza tra pratica e ideali? Certo, noi possiamo chiederci perché gli ultimi scritti di Lenin siano sostanzialmente rimasti lettera morta, ma la democrazia avrebbe forse potuto essere “garantita” senza per questo ledere ciò che unicamente la rende legittima, e cioè la libertà? Il concetto di “democrazia” non sfugge forse, in ultima istanza, a qualunque astratta definizione?
Quando nel 1923 egli chiese, poco prima di morire, che Stalin fosse sostituito alla guida del partito (alla carica di segretario generale), in quanto lo riteneva troppo rozzo e intollerante, per quale ragione la sua richiesta non venne presa in considerazione? Forse il motivo va individuato nel fatto che Lenin era troppo abituato a comandare e che nella sua condizione di “malato grave”, la sua volontà non poteva apparire così stringente, così persuasiva come un tempo?
Negli ultimi anni della sua vita egli era giunto alla conclusione che il raddoppio dei membri del CC avrebbe aiutato il partito a vivere più democraticamente il proprio sviluppo, a sentirsi più unito nell'affrontare i problemi dell'edificazione del socialismo. Non era forse tardiva una proposta del genere?
Lenin era un uomo dall'intelligenza assolutamente straordinaria e si rendeva perfettamente conto di aver avuto poco tempo per costruire dei rapporti “umani” coerenti con gli ideali del socialismo. Egli aveva speso tutta la sua vita per una battaglia politica, altamente conflittuale, come neppure Marx ed Engels messi insieme erano mai riusciti a fare. Sapeva bene che un'edificazione del socialismo in tempo di pace avrebbe comportato interventi di natura più “democratica” e “umanistica” in campo politico, ma il destino non gli diede modo di misurarsi in questa direzione, che purtroppo non venne presa in sufficiente considerazione dai suoi seguaci.
La questione del centralismo in Lenin è la più complessa, anche perché è stata affrontata in un periodo di alta tensione politica e militare (guerra mondiale, controrivoluzione interna, interventismo straniero).
Lenin sapeva bene che la rinascita del capitalismo è sempre possibile là dove esiste la piccola produzione mercantile, cioè egli sapeva che anche dopo aver eliminato il potere della grande borghesia imprenditrice, non è possibile eliminare con la forza anche quello della piccola borghesia (ivi incluso quello degli agricoltori proprietari di terre che utilizzano per vendere prodotti sul mercato).
Nei confronti di questo potere, piccolo potere commerciale, che nella Russia di allora era enormemente più diffuso dell'altro, e che condiziona sempre il proletariato, occorreva adottare – secondo la linea di Lenin – una strategia più duttile, di lunga durata, una strategia che doveva basarsi sul centralismo politico e statale più rigoroso.
È sulla natura di questo centralismo che possono essere colti i limiti più significativi del “leninismo in tempo di pace”. “Per parte nostra, temiamo un eccessivo allargamento del partito, perché in un partito di governo tentano, inevitabilmente, di insinuarsi arrivisti e avventurieri, che meritano soltanto di essere fucilati”, scrisse nell'Estremismo. Il partito era così centralizzato che il CC si aprì a nuovi iscritti (operai e contadini) solo quando la guerra civile minacciava di far fallire la rivoluzione. Solo nel periodo della malattia, quando ormai si rese conto che non avrebbe più potuto far nulla per le sorti del partito, si decise a chiedere un allargamento dei componenti del CC, onde evitare che i dissidi tra Stalin e Trotsky degenerassero al punto da distruggere lo stesso partito.
Successivamente però lo stalinismo avrà buon gioco nell'affermare che l'ambiente piccolo-borghese, che spinge il proletariato russo verso l'individualismo, poteva essere tenuto sotto controllo solo dal centralismo organizzativo del partito al potere, cui le amministrazioni statali avrebbero fatto da mero supporto.
Faremmo però un torto all'intelligenza di Lenin se sostenessimo che questa soluzione era la “sola” possibile. Egli sapeva bene che il socialismo avrebbe avuto bisogno di trasformarsi in un'esigenza sociale di tutta la nazione. E tuttavia in lui non prevalevano le idee relative alla necessità che il proletariato ha di autogovernarsi contro le tendenze borghesi sempre presenti nella società, cioè di autogestirsi anche a prescindere dalle direttive centralizzate del partito al governo, il quale non può certo aver la pretesa di dirsi democratico solo perché nel suo statuto si pone a favore dei nullatenenti.
Nell'ideologia “centralista democratica” del bolscevismo ha purtroppo avuto un peso maggiore l'aspetto del centralismo e si è rifiutata l'idea che il comunismo deve sempre essere messo nelle condizioni di rischiare una sconfitta, se questa sconfitta è il risultato di un processo democratico di autoconsapevolezza. La “coscienza dall'esterno”, di cui Lenin iniziò a parlare in Che fare?, non può essere data ad libitum.
Critica dei fondamenti ontologici della civiltà borghese
Cos'è che differenziava Lenin dagli altri grandi marxisti occidentali? Il fatto che lui non si faceva illusioni sulla natura della democrazia borghese.
Ma perché i grandi teorici del marxismo occidentale, seguaci di Marx ed Engels, erano così condizionati dai successi della democrazia borghese?
Anzitutto perché non si riusciva a mettere in stretta relazione il benessere delle società europee con lo sfruttamento coloniale. Cioè si riteneva che quel livello di benessere sarebbe avvenuto anche senza quello sfruttamento, essendo principalmente dipendente dalla rivoluzione tecnico-scientifica.
In secondo luogo va detto che nel periodo cosiddetto “pacifico” del capitalismo europeo (che fu peraltro “pacifico” solo in Europa, certamente non nelle colonie d'oltreoceano), la sinistra acquisì un relativo riconoscimento istituzionale da parte della borghesia imprenditoriale, e questo permise la formazione da un lato della cosiddetta “aristocrazia operaia”, dall'altro dei partiti riformisti favorevoli a tale aristocrazia.
In terzo luogo, ma questo limite caratterizzò anche tutta l'ideologia bolscevica, nessun marxista mise mai in discussione la legittimità della rivoluzione tecnico-scientifica e la sua applicazione indiscriminata all'industria, cosa che procurò danni irreversibili all'ambiente naturale.
In Europa occidentale la democrazia borghese, nel periodo che va dalla Comune di Parigi alla prima guerra mondiale, s'era dimostrata relativamente tollerante nei confronti della classe lavoratrice che rivendicava migliori condizioni di vita e di lavoro, proprio perché il peggio di sé lo stava dando nei territori soggetti a conquista coloniale.
Nei confronti di questa pratica imperialistica, la sinistra europea non ha mai espresso in modo chiaro, inequivocabile, il suo netto dissenso. Spesso anzi si vedevano le colonie come un'opportunità per i disoccupati delle società industriali, per gli emarginati, i contadini senza terra...
Inoltre la sinistra europea non ha mai messo in discussione la superiorità della civiltà europea in senso lato, rispetto a tutte le altre civiltà mondiali. Ciò che affascinava era proprio la rivoluzione tecnico-scientifica, l'alto livello culturale, la grande capacità di produzione economica...
Il marxismo criticava il capitalismo come un difetto strutturale dell'economia, che la borghesia, avendo la proprietà privata dei mezzi produttivi, non avrebbe mai potuto risolvere, né per capacità né per interesse. Per tutto il resto il marxismo non aveva difficoltà ad accettare le conquiste scientifiche, tecnologiche e produttive, nonché commerciali, della stessa borghesia. Il marxismo non ha mai messo in discussione che il valore di scambio dovesse avere un primato su quello d'uso, o che l'esigenza del mercato dovesse prevalere su quella dell'autoconsumo.
Il marxismo oggi va considerato un'ideologia superata semplicemente perché non è riuscito a fare un discorso generale, complessivo, sull'alternativa a un'intera forma di civiltà, ma si è limitato a fare un discorso parziale, riguardante la soluzione a un difetto strutturale dell'economia borghese, quello riguardante il rapporto tra capitale e lavoro.
Il marxismo (e il leninismo lo ha anche dimostrato) ha capito che per risolvere questo problema occorreva con la rivoluzione togliere il potere alla borghesia, ma, non avendo fatto un discorso più complessivo sui fondamenti ontologici della civiltà borghese (e del concetto più generale di civiltà), ha poi finito con l'ereditare, di questa civiltà, altri difetti strutturali, relativi a valori, comportamenti ecc. (che poi, in gran parte, sono i difetti di tutte le civiltà basate sugli antagonismi sociali).
La civiltà borghese va distrutta completamente, non solo nelle sue forme economiche e politiche, ma proprio nel modo di porsi nei confronti della natura. Essa non è in grado di garantire alcun futuro non solo a chi non dispone di proprietà privata, ma neppure all'essere umano in generale.
Dittatura proletaria e democrazia borghese
Il testo di riferimento sono le Tesi sulla democrazia borghese e la dittatura del proletariato, presentate il 4 marzo 1919 al I Congresso dell'Internazionale comunista (contenute nel libro antologico Sulla dittatura del proletariato, ed. Progress, Mosca 1980). Scopo del testo è quello di dimostrare che la dittatura proletaria, per quanto imposta da cause di forza maggiore, resta sempre più democratica della democrazia borghese, in quanto quest'ultima non è che la maschera della dittatura di un'infima minoranza di capitalisti industriali e agrari.
La III Internazionale comunista ambiva a porsi in alternativa alla II Internazionale dei partiti socialdemocratici dell'Europa occidentale, clamorosamente fallita nel corso della I guerra mondiale, e che tali partiti avevano tentato di far rinascere alla Conferenza di Berna nel febbraio 1919, chiamata dai comunisti col nome spregiativo di “gialla” o di “due e mezzo”.
L'obiettivo principale di questa “Internazionale gialla”, sostenuta dai partiti centristi della socialdemocratica, i cui leader più significativi erano Kautsky e Hilferding, è quello di recuperare credibilità agli occhi del proletariato industriale, soprattutto dopo la riuscita rivoluzione bolscevica e dopo l'assassinio dei dirigenti del partito comunista tedesco, Rosa Luxemburg, Liebknecht e Jogiches. Lenin ne riassume i punti fondamentali alla fine delle sue Tesi: 1) il governo socialdemocratico di Scheidemann è borghese perché vuole abolire i “soviet” che si sono formati in Germania; 2) i soviet invece – secondo i “centristi” – vanno legalizzati, anche se non come organizzazioni statali, con funzioni politiche, ma solo come organizzazioni economiche; 3) i soviet devono dipendere politicamente dall'Assemblea Costituente o Nazionale (che darà vita alla Costituzione del Reich tedesco nell'agosto 1919, detta “Costituzione di Weimar”); 4) il bolscevismo è antidemocratico perché ha rifiutato la Costituente e perseguita le opposizioni politiche; 5) la guerra civile va rifiutata come mezzo politico del proletariato per giungere al potere.
In opposizione a tali punti salienti Lenin fa capire chiaramente che i soviet rappresentano la democrazia diretta contro quella delegata del parlamento e della Costituente3: sono due forme di democrazia inconciliabili. Ovviamente i soviet dovevano diffondersi anche nelle campagne, tra i contadini, soprattutto tra il proletariato agricolo, altrimenti la rivoluzione non sarebbe riuscita a mettere radici. Infatti essa era avvenuta permettendo a tutti i contadini di avere in proprietà la terra, al fine di eliminare il lavoro salariato nelle campagne, ma il vero obiettivo del socialismo era la socializzazione di tutta la proprietà, per una gestione comune delle risorse. Avere un lotto in proprietà privata è una rivendicazione di tipo borghese. I contadini non possono però essere obbligati a capire che una collettivizzazione della terra è una soluzione migliore. Lo possono capire solo attraverso l'esempio. L'Internazionale “gialla”, che non capisce queste cose, va considerata decisamente anti-comunista; quindi è peggiore della II Internazionale, il cui principale difetto era il riformismo, che si concluderà col tradimento del proletariato nell'agosto del 1914, quando i socialisti si dichiararono a favore della guerra.
Ecco dunque riassunta la parte finale delle Tesi. Ma come era arrivato Lenin a tali conclusioni? La sua preoccupazione principale era quella di dimostrare che la “democrazia in generale” (detta anche “pura”), considerata in astratto, è soltanto una finzione della borghesia, che evita accuratamente di collegarla a una classe particolare. I socialisti riformisti non capivano nulla di “comunismo”, in quanto ritenevano il parlamentarismo la quintessenza della democrazia in generale.
Alla fine della I guerra mondiale la spaccatura tra comunisti e socialisti era nettissima. I vecchi partiti socialisti o socialdemocratici, di ispirazione marxista, avevano evitato di fare una profonda autocritica del loro atteggiamento tenuto qualche anno prima in tutti i parlamenti europei. Mancando un ripensamento critico delle loro assurde posizioni politiche, questi partiti non avevano dubbi nell'opporsi all'unica esperienza rivoluzionaria, davvero socialista, compiuta con successo in Russia. Di conseguenza ostacolavano in tutti i modi i tentativi che in Europa occidentale venivano fatti per imitare quell'esperienza.
L'Internazionale “gialla” rappresentava un tradimento perfettamente in linea con quello compiuto dalla Seconda, di cui aveva radicalizzato l'orientamento borghese. Infatti quest'ultima, votando a favore dei crediti di guerra, nella convinzione di favorire la fine dell'autocrazia russa e del sultanato ottomano, aveva fatto finta di non sapere che la guerra aveva una finalità imperialistica di ampio respiro per il capitalismo europeo, in quanto si aveva intenzione di stabilire definitivamente il ruolo delle potenze europee nella ripartizione dell'intero pianeta in tante colonie da sfruttare. Inoltre l'Internazionale si era guardata bene dall'approfittare della guerra per rovesciare i governi borghesi al potere. Era il trionfo assoluto delle idee borghesi in ambito socialista, dopo che quelle idee avevano portato a morire circa 10 milioni di soldati, per non parlare dei feriti e dei mutilati e delle devastazioni ambientali.
Come si spiega un atteggiamento del genere da parte dei dirigenti che professavano idee socialiste? La fine della guerra, che fu in Europa un disastro assoluto, tanto che a partire da quel momento l'egemonia del continente nel mondo verrà seriamente messa in discussione dagli Stati Uniti, poteva tranquillamente essere usata per mettere la borghesia alle corde, estromettendola da tutti i suoi poteri e sostituendola con una democrazia proletaria. Invece furono proprio i socialisti a permettere alla democrazia borghese di risorgere, e per di più in funzione nettamente anti-comunista. Cosa aveva di “socialista” una posizione del genere? Come si spiega una tale miopia politica? un tradimento così ostinato e generalizzato?
L'unica spiegazione possibile risiede nella grande capacità che ha la borghesia, in forza degli alti livelli di benessere (almeno rispetto al periodo feudale) che assicura, di influenzare lo stile di vita e la mentalità anche di quelle classi sociali che patiscono lo sfruttamento economico della stessa borghesia e da cui, in teoria, dovrebbero liberarsi. I rappresentanti politici di tali classi oppresse si limitano ad essere dei semplici riformisti, ritenendo impossibile o prematura una qualunque rivoluzione proletaria.
Questi politici non sono minimamente interessati a porre in relazione il benessere dei Paesi capitalisti con lo sfruttamento delle colonie, proprio perché si accontentano di garantire, grazie appunto alle progressive riforme sociali, alle battaglie sindacali, all'istituzione delle cooperative, degli enti assistenziali e previdenziali, ecc., ciò di cui i lavoratori hanno bisogno per un'esistenza relativamente tranquilla. Ritengono che lo sfruttamento economico dei salariati, in rapporto a tali garanzie sociali, non sia così “eticamente riprovevole”, benché esso permetta alla borghesia di ottenere un plusvalore enorme. Essere opportunisti significa vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie, e trovare tutti i motivi possibili per criticare chi non accetta queste forme di accomodamento.
Poste le cose in questi termini, vien da pensare che il socialismo autenticamente proletario sia impossibile da realizzare nei Paesi del capitalismo avanzato, almeno finché in questi Paesi il benessere rimane a certi livelli, ovvero almeno finché le colonie non si emancipano da tutti i punti di vista. La chiave di volta per capire il motivo per cui non si rinuncerà mai spontaneamente al benessere materiale o economico sta nella parola “comodità”. Tutta la rivoluzione tecnico-scientifica è stata fatta per permettere una vita più facile, agevole, appunto più “comoda”, senza preoccuparsi minimamente che tale comodità venisse pagata, oltre che dalla natura, anche dai territori colonizzati (i primi dei quali sono stati gli ambienti rurali delle stesse metropoli occidentali).
Il proletariato dei Paesi capitalisti potrà prendere coscienza dell'assurdità di uno stile di vita basato anzitutto sulla “comodità” quando la natura comincerà a desertificarsi, a impoverirsi sempre di più o quando inizierà a reagire con improvvisi cataclismi alla violenza che subisce. Sarà interessante vedere se la sinistra continuerà ad opporre il diritto al lavoro al diritto alla salute, a un'esistenza sana ed equilibrata. Ancor più interessante sarà vedere questa sinistra, posta di fronte ai movimenti di liberazione terzomondiali, se avrà la faccia tosta di chiedere al proletariato dei Paesi capitalisti di appoggiare la borghesia per riaffermare i princìpi del colonialismo. Avrà il coraggio questo proletariato, che, nell'ambito dell'imperialismo, fruisce di privilegi di non poco conto, di muovere guerra contro la propria borghesia nazionale, o preferirà scendere a patti per assicurarsi che non venga meno il relativo e consueto benessere?
I
Perché consideriamo la democrazia borghese superiore all'aristocrazia feudale? Il feudalesimo in Europa venne creato dai cosiddetti “barbari”. Ebbene, non erano forse queste tribù provenienti dall'Asia più democratiche degli schiavisti romani? Lo erano certamente. E queste tribù non avevano forse i loro organi collegiali, in cui prendevano decisioni dopo ampio dibattito? Certamente le avevano. Non erano forse loro che eleggevano un sovrano solo in tempo di guerra e che in tempo di pace vivevano la democrazia diretta e praticavano l'autoconsumo? Dunque, perché diciamo che il feudalesimo non aveva nulla di democratico? Sappiamo che la borghesia accusava i feudatari di aver occupato le terre degli schiavisti romani con l'uso della forza militare, ma come avrebbero potuto farlo senza l'uso di tale forza? Dove stava l'antidemocraticità della società feudale? La nascita della pratica “borghese”, cioè il formarsi degli scambi commerciali non controllati dai poteri costituiti, non nacque forse all'interno della società feudale dell'Europa occidentale?
Indubbiamente tutto questo è vero, ma lo è anche il fatto che ad un certo punto i poteri costituiti del mondo feudale volevano vivere di rendita, sia in economia che in politica, cioè essi non volevano lavorare, in quanto preferivano affidarsi unicamente allo sfruttamento del lavoro dei contadini, in forza della proprietà privata della terra. Tutte le classi superiori volevano la terra in eredità. Anche i poteri politici, esattamente come la proprietà terriera, si voleva che venissero trasmessi per via ereditaria. E tutto era giustificato dall'ideologia religiosa di una Chiesa di potere, che non amava stare sottomessa agli imperatori e che aveva fatto dell'obbedienza gerarchica, del rapporto di dipendenza personale uno stile di vita.
Il sistema feudale, per quanto non conoscesse l'egemonia del mercato e quindi del denaro, per quanto fosse estraneo alla burocrazia asfissiante dei moderni Stati capitalistici, per quanto non avesse strumenti adeguati per praticare lo sfruttamento selvaggio della natura, era un sistema orribile, che andava assolutamente superato, e proprio nei suoi valori aristocratici di ereditarietà della terra e del potere politico in virtù delle differenze di ceto, di casta, di sangue, di stirpe o di lignaggio.
Riuscirono a farlo i contadini, realizzando una sorta di “socialismo agrario”? Per quanto lunghe e cruente siano state le loro battaglie, non vi riuscirono. In compenso vi riuscì la borghesia, anche con l'aiuto dei contadini e degli operai urbani. Dopo essersi arricchita economicamente, essa riuscì a compiere delle rivoluzioni che mutarono completamente il sistema sociale, politico e culturale. Non ci furono solo le rivoluzione culturali, con cui si pose fine al dominio ideologico della Chiesa romana, né soltanto le rivoluzioni politiche, con cui si pose fine all'idea di “impero feudale”, al dominio incontrastato e plurisecolare degli aristocratici, delle monarchie assolute ed ereditarie; ci fu anche la rivoluzione tecnico-scientifica, con cui si modificò completamente il rapporto dell'uomo con la natura.
Si fecero rivoluzioni di portata storica e mondiale, sul piano ideologico, giuridico, culturale e scientifico, con cui si pose fine al dominio assoluto della teologia, del diritto canonico, trasformando la religione, nel migliore dei casi, in uno strumento totalmente al servizio della borghesia, la quale, una volta affermatasi come classe, avrebbe anche potuto, in teoria, farne a meno, in quanto era in grado di sostituirla con una nuova forma di misticismo ad oltranza, assai più laica e prosaica: il culto per il dio denaro, per il mercato, per il capitale che si autovalorizza. La filosofia, il diritto civile e penale, amministrativo e commerciale e costituzionale, l'economia politica e tante altre “scienze” subentrarono a ciò che veniva considerato “pseudo-scientifico”, superstizioso, obsoleto. L'esperienza prevalse sull'autorità, sul dogma, sulla “verità rivelata”.
Soprattutto un aspetto mutò radicalmente: nell'epoca borghese l'unica cosa che davvero conta sono i capitali. La borghesia non poteva arricchirsi attraverso le terre, poiché non le possedeva: riuscì a farlo attraverso i commerci, poi passò alle manifatture, all'industria e alla finanza, trasformando altresì l'uso delle stesse terre. Attraverso i commerci poteva mentire sul valore degli oggetti da vendere, acquistati in luoghi remoti del pianeta, che pochissimi conoscevano. Poi arrivò a capire che ci si poteva arricchire ancora di più, infinitamente di più, sfruttando il lavoro altrui, esattamente come facevano i nobili con le loro terre e i loro contadini.
Non avendo però la terra, né la possibilità di un rapporto di “dipendenza personale” con cui sottomettere i servi della gleba, la borghesia fu come costretta a inventarsi due cose: la macchina e il contratto di lavoro. Inizialmente la macchina fu il telaio, che usavano le donne per produrre tutto il tessile di cui le loro famiglie avevano bisogno. Con la nascita della borghesia, le donne iniziano a produrre beni per un mercato. Ottengono materia prima dal mercante-imprenditore, riconsegnandola come prodotto finito. Il borghese si arricchisce col tessile, soprattutto quando i telai vengono trasferiti in città, posti in un unico opificio e perfezionati sempre di più. Dal tessile si passò a tanti altri generi merceologici.
Perché la vita borghese dava l'impressione d'essere più “libera” di quella feudale? Perché si svolgeva in città, non in campagna. In città non vi era la proprietà della terra, ma quella dei capitali. Ci si poteva emancipare più facilmente. In città si lavorava sotto “contratto”, non perché si era costretti a farlo. In città si era giuridicamente o formalmente “liberi”, anche nel caso in cui socialmente si viveva di stenti e si era costretti ad accettare qualunque tipo di lavoro.
Riuscì la nobiltà ad opporsi a questo nuovo stile di vita? Assolutamente no. D'altra parte come avrebbe potuto? La rendita non era forse qualcosa di moralmente ignobile? La corruzione morale della nobiltà non era forse cosa nota a tutti? Nel mondo medievale tutti gli uomini di potere erano “titolati”: conti, visconti, duchi, marchesi... Eppure nessuno era “titolato” a impedire alla borghesia di creare un sistema sociale basato sull'egemonia del mercato, del denaro, dello sfruttamento del lavoro altrui per mezzo di un contratto giuridico.
La borghesia riuscì a creare un sistema sociale che poi legalizzò sul piano giuspolitico, chiamandolo con un termine che, prima di allora, nel feudalesimo non era mai stato usato: democrazia. E non si trattava di una democrazia come quella che si esercitava nelle poleis greche o nel senato romano, poiché non era connessa alla schiavitù “fisica”, ma a un nuovo tipo di schiavitù, che prima non era mai esistita: la schiavitù salariata di soggetti giuridicamente liberi che lavorano usando macchine. Ecco su quale ossimoro si basa tutta la civiltà borghese.
Questa cosa venne capita sin dagli esordi del capitalismo (“Le pecore si mangiano gli uomini”, diceva Thomas More per indicare la trasformazione capitalistica degli arativi in prativi, che comportava espulsioni di massa dei contadini dalle terre). Tuttavia, per quanti sforzi si siano fatti per por fine a questo assurdo sistema di vita, a tutt'oggi esso risulta dominante. Come al tempo dello schiavismo romano (il peggiore nella storia dello schiavismo), il tentativo più significativo di realizzare la democrazia sociale fu compiuto da Gesù Cristo; così al tempo dell'imperialismo capitalistico (il peggiore nella storia del capitalismo) il tentativo più significativo di realizzare il socialismo scientifico fu compiuto da Lenin. Entrambi i casi risultarono fallimentari a seguito del tradimento dei loro seguaci. Due tentativi compiuti in quasi duemila anni di storia. Si può dire, senza ombra di dubbio, che fino ad oggi il “male” ha nettamente trionfato. Che lo schiavismo sia stato pubblico o privato, fisico o personale o contrattuale, la storia dell'umanità ha dimostrato, negli ultimi 6000 anni di storia, di non essere più capace di ritornare a quel comunismo primitivo che aveva irresponsabilmente abbandonato.
Detto questo, quali sono i motivi per cui in Europa occidentale il socialismo, pur avendo contezza dei limiti strutturali del capitalismo, che la borghesia non è assolutamente in grado di superare, non è mai riuscito ad affrontare in maniera risoluta il problema dell'abbattimento definitivo di questo sistema, procedendo a realizzarne uno completamente diverso? I motivi sembrano essere i seguenti: 1) i socialisti sono sempre stati affascinati dai progressi della rivoluzione tecnico-scientifica della borghesia e non vorrebbero rinunciarvi per tutto l'oro del mondo; 2) essendo la loro ideologia nata in un contesto urbano, non hanno mai avuto un rapporto privilegiato col mondo contadino, giudicato ideologicamente e culturalmente arretrato (anche perché troppo legato alla religione), tecnologicamente dipendente dalla classe operaia e sostanzialmente piccolo-borghese, a causa del desiderio di possedere un lotto di terra in proprietà privata.
Tutti gli esperimenti industriali dei socialisti utopistici sono falliti perché ambivano a realizzare “isole di socialismo” all'interno del sistema borghese, senza preoccuparsi di abbatterlo politicamente. Viceversa, il socialismo scientifico è nato pensando che la classe operaia, essendo priva di tutto, sarebbe stata la più disposta a compiere la rivoluzione politica. Tuttavia in Europa occidentale, a parte qualche tentativo (p.es., tra i più noti, la Comune di Parigi), ciò non è mai avvenuto, e il motivo, probabilmente, è dovuto al fatto che, a partire dalla nascita dell'imperialismo, i capitalisti industriali, tenendo alti i salari, erano in grado di dissuadere i propri operai dal compiere la rivoluzione. Inoltre i dirigenti sindacali e politici della classe operaia tendevano a “imborghesirsi” nei periodi di pace sociale, di assenza di guerre o di acuti conflitti di classe. Si accontentavano di limitate o settoriali riforme sociali, rivendicate in parlamento o, al massimo, attraverso lo strumento dello sciopero. Addirittura questi socialisti non sono mai stati capaci di opporsi allo sfruttamento delle colonie, e quando iniziò a scoppiare la I guerra mondiale si misero dalla parte delle rispettive borghesie nazionali, dietro il pretesto della “difesa della patria”.
Il socialismo europeo, salvo eccezioni (di cui la più significativa è stata quella bolscevica), si è preoccupato soltanto di “migliorare” il sistema dominante, cioè di renderlo più umano (ultimamente si preoccupa di renderlo anche più ecologico). Ma i risultati sono sempre stati molto deludenti, sia perché la borghesia minaccia lo spettro della disoccupazione, quando le richieste di riforme le paiono troppo onerose; sia perché gli svantaggi di queste riforme vengono fatti pagare ai popoli del Terzo mondo.
L'unico dirigente socialista di spicco che non si è mai fatto alcuna illusione sulla capacità di “miglioramento” del sistema borghese, restando all'interno di questo sistema, è stato Lenin. Lui non ha mai creduto al valore “risolutivo” del parlamento. Anzi, ha sempre pensato che un vero partito rivoluzionario si costruisce soprattutto in maniera clandestina, in quanto uno dei compiti che ha da realizzare è proprio quello di abbattere il parlamento borghese e tutte le altre caratteristiche fondamentali dello Stato capitalistico: la burocrazia, l'esercito permanente (staccato dal popolo), i servizi segreti, la democrazia meramente rappresentativa o delegata, senza alcuna esperienza di quella diretta (che in Russia si realizzò attraverso i soviet di operai, contadini e soldati). Qualunque tentativo si voglia fare di abbattere il sistema dominante non può in alcun modo prescindere da ciò che Lenin ha detto e ha fatto. Semmai, partendo da lui, si può pensare di realizzare qualcosa che renda il socialismo ancora più democratico.
II
Quando Lenin scrive che “in nessun paese civile capitalistico esiste la 'democrazia in generale', ma soltanto la democrazia borghese...” (punto 2), bisognerebbe riscrivere, sulla base di tale affermazione, tutti i manuali scolastici, a partire da quelli di storia. Se c'è una cosa, infatti, che la borghesia è riuscita a far passare nelle menti di tutti i cittadini, inclusi i socialisti, è proprio l'idea che la forma borghese di democrazia rappresentativa costituisca la quintessenza della democrazia in generale, superiore alla stessa democrazia greco-romana, poiché oggi non si è in presenza dello schiavismo “fisico” o “diretto”.
Oggi nessun autore di alcun testo scolastico avrebbe il coraggio di qualificare la democrazia borghese come una “schiavitù salariata”. Infatti l'idea di “schiavitù” è antitetica a quella di “libertà”, e non a caso viene associata al mondo antico. Nella democrazia borghese tutti i cittadini sono, per definizione, “liberi”. Il rapporto contrattuale viene accettato da persone giuridicamente “libere”. Sul piano formale la differenza dalla schiavitù antica è abissale. Peccato che sul piano sociale la schiavitù non sia molto diversa. Oggi chi non è proprietario di terre o di capitali è soltanto “libero” di morire di fame.
È singolare il fatto che Lenin dovesse convincere di queste verità elementari del marxismo i teorici e i leader della II Internazionale e di tutti i partiti socialisti europei. Com'era possibile nutrire delle illusioni in una questione così evidente nella sua falsità? Qualunque socialista dotato di raziocinio e con un minimo di onestà intellettuale avrebbe dovuto evitare di contrapporre la democrazia borghese alla dittatura proletaria. Non è minimamente paragonabile la dittatura di una classe oppressa con la democrazia di una classe oppressiva. Sono due piani completamente diversi. Semmai si possono confrontare le due democrazie, borghese e proletaria, o le due dittature, borghese e proletaria, per cercare di capire le profonde differenze che le contraddistinguono.
Se si vuole confrontare la democrazia borghese con la dittatura proletaria, si è già partiti col piede sbagliato, poiché è evidente che chi è abituato a vivere nel sistema capitalistico considererà la dittatura proletaria un qualcosa da abbattere con la forza o quanto meno da evitare come la peste. La democrazia borghese non è altro che una dittatura mascherata, una finzione giuridica. Sul piano sociale non ha nulla di democratico, e su quello etico nulla di umano.
D'altra parte tra la fine dello schiavismo antico e l'inizio di quello moderno sono trascorsi ben mille anni di storia, in cui l'ideologia dominante è sempre stato il cristianesimo, che ha proposto un concetto di “persona”, dotata di coscienza, di libero arbitrio, di capacità decisionale, che di sicuro all'epoca dello schiavismo antico non poteva riguardare la classe schiavile. Su questo concetto di “persona” si è fondato quello di “libertà personale”, che nel mondo borghese però non è mai stato disgiunto dal principio della “proprietà privata”. La libertà personale viene usata per accaparrare una proprietà altrui o per difenderla da chi vorrebbe impadronirsene. Senza proprietà la libertà non vale nulla.
La differenza tra capitalismo e feudalesimo sta nel fatto che la proprietà borghese non è necessariamente terriera: può essere anche soltanto monetaria. Nel Medioevo la terra veniva trasmessa per via ereditaria o in forma di lascito o donazione (la Chiesa si era arricchita così), oppure veniva concessa provvisoriamente in feudo, a titolo di riconoscimento per un servizio prestato (anche se poi chi la riceveva in questa maniera cercava sempre di legittimarla come proprietà privata). La disponibilità monetaria, invece, può essere acquisita, virtualmente, da chiunque: la trasmissione ereditaria non è un imperativo categorico. Ecco perché la democrazia borghese appare più “libera” dell'aristocrazia feudale; ecco perché, per poter sfruttare il lavoro altrui e vivere di rendita, la borghesia ha avuto bisogno d'inventare il fenomeno del macchinismo. Se una persona non può essere fisicamente comprata sul mercato degli schiavi, può essere però comprata la sua forza-lavoro (manuale e/o intellettuale), sempre sul mercato del lavoro, tramite una contrattazione legale (che prevede uno stipendio o un salario, che la borghesia, ovviamente, pattuisce prima, onde permetterle di estorcere il massimo plusvalore possibile, un contratto ch'essa vorrebbe sempre a tempo determinato, in maniera da poterlo rinnovare alle proprie condizioni). Considerare la democrazia borghese, visti tali presupposti, come la democrazia per antonomasia, è da ipocriti. Chiunque, un minimo onesto, è in grado di vedere che si tratta di un raggiro. Non c'è bisogno d'essere “socialisti”.
Ora, se al tempo di Gesù Cristo non si è riusciti a sopprimere la schiavitù fisica, al fine di riportare l'umanità al comunismo primitivo, le cui ultime tracce si facevano ancora sentire, figuriamoci quanto maggiori devono essere le difficoltà odierne, in cui nessuno ha più sentore dell'esistenza di un comunismo primitivo. Oggi, chi pensa di dover realizzare il socialismo democratico, può basarsi unicamente su una certa istanza di liberazione. Non può rifarsi ad alcuna memoria storica, poiché questa è andata irrimediabilmente perduta. Di qui gli errori colossali nei tentativi che si compiono per superare la schiavitù salariata. A volte si possono creare delle alternative che, per molti aspetti, sono anche peggiori, come p.es. quella stalinista o quella maoista.
L'unica speranza che abbiamo, per il futuro, è quella di non ripetere gli errori del passato. Ma è solo una speranza, non una certezza. Bisogna dire che, in questi ultimi 2000 anni di storia, la persona che ha fatto meno errori è stato Lenin, anche se questo non ha impedito ai suoi seguaci di tradirlo. Il tradimento sembra essere connaturato a qualunque esperienza di liberazione dalla schiavitù. Forse l'unico vantaggio che oggi possiamo avere è relativo alla capacità distruttiva delle nostre armi. Sono così potenti che il loro uso potrebbe riportarci di colpo all'età della pietra, naturalmente con la differenza che gran parte del pianeta sarà del tutto invivibile.
Si pensi sempre, a titolo puramente esemplificativo, a come è ridotta oggi l'area intorno a Chernobyl, dopo lo scoppio accidentale nel 1986 di uno dei quattro reattori di una centrale nucleare a scopo civile. Il deserto regna sovrano; il combustibile continua a emanare radiazioni e non si sa per quanto tempo potrà farlo; il sarcofago di copertura va periodicamente rifatto; non si ha la più pallida idea di dove mettere le scorie radioattive (e non solo di quella centrale ma anche di tutte quelle dismesse nel mondo); le mutazioni genetiche nel mondo animale, vegetale e umano sono ancora all'ordine del giorno; e si pensa che tale situazione sia destinata a durare per molti e molti “secoli”. In una guerra nucleare mondiale i primi luoghi da colpire sarebbero le città, le aree militari e gli obiettivi “sensibili” (come p.es. le dighe, i mezzi di comunicazione e di transito, ecc.). I sopravvissuti dovrebbero per forza rifugiarsi nelle grotte o nelle caverne, come gli uomini primitivi, oppure nelle ultime foreste rimaste, o rinchiudersi in qualche bunker per dei mesi, o rintanarsi nel sottosuolo o nelle miniere, o navigare nei sottomarini o nelle navicelle spaziali, fino all'esaurimento del carburante e dei viveri.
Quante persone riuscirebbero a sopravvivere e in quali condizioni riuscirebbero a farlo? Con quali capacità autonome? Gli abitanti delle città, disabituati a produrre da soli il cibo di cui si nutrono, sarebbero i primi a morire. Tutta la loro tecnologia sarebbe completamente inutile. Quanto tempo può resistere una persona civilizzata in un luogo dove deve procurarsi il cibo come un primitivo? Una settimana? Un mese? Sei mesi? Difficilmente arriverebbe all'anno.
III
È piuttosto naturale che la democrazia borghese giudichi negativamente, in assenza di conflitti di classe, la parola “dittatura”. La borghesia ama la democrazia perché vuol far credere che la pratica dello sfruttamento del lavoro viene accettata liberamente, paventando l'idea che un giorno lo sfruttato potrà emanciparsi senza avvertire il bisogno di uscire dal sistema. Si deve far credere che lo sfruttamento sia una condizione sociale provvisoria, da cui individualmente ci si può anche liberare, passando dall'altra parte della barricata: è solo questione di “volontà” o di capacità a saper cogliere le occasioni propizie (a meno che uno non si accontenti di uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età).
Sul piano storico la borghesia ha accettato la dittatura quando ha dovuto lottare contro l'aristocrazia (e anche contro la monarchia, se questa stava esplicitamente dalla parte dei nobili). Oggi vi ricorre soltanto quando deve reprimere il proletariato in rivolta, sia esso agricolo o industriale, o quando le colonie vogliono togliersi dal collo il cappio che le strangola da mezzo millennio. P.es. nel corso della formazione degli Stati nazionali la borghesia era addirittura favorevole alla monarchia assoluta, se questa era intenzionata a ridimensionare di molto lo strapotere dei nobili, che si esprimeva soprattutto nel possesso di regni separati e in concorrenza tra loro. La borghesia, infatti, voleva un unico mercato nazionale, che facilitasse enormemente gli scambi commerciali (il che implicava un'unica moneta, misurazioni standard nei pesi, nelle misure, ecc., e soprattutto l'abolizione dei dazi interni, che gravavano sui prezzi delle merci e che garantivano entrate supplementari alla nobiltà).
La borghesia chiese anche alle monarchie di requisire i beni immobili del clero regolare, per potersi fare un patrimonio agrario da sfruttare in maniera capitalistica. Ma prima di poterlo chiedere, dovette laicizzare notevolmente la mentalità, le idee, gli usi e i costumi della popolazione urbana.
La borghesia aveva bisogno di una nazione sufficientemente omogenea all'interno, libera da influenze esterne, con una legislazione valida per tutti, dotata di un esercito regolare (non mercenario), di una burocrazia efficiente, di una lingua ufficiale, obbligatoria nelle scuole statali, e soprattutto aveva bisogno di una nazione che fosse capace di occupare delle colonie per poter allargare il più possibile il proprio mercato.
Infatti, una caratteristica fondamentale della borghesia è che non si accontenta mai di ciò che ha. Essa è convinta che in un regime di forte competizione, se i capitali che si possiedono non aumentano di continuo, si rischia di uscire dal mercato, di essere schiacciati dai rivali più forti. La nobiltà, invece, avendo a che fare con servi della gleba, non poteva sfruttarli oltre un certo limite, anche perché non avrebbe avuto senso ottenere più derrate alimentati di quel che si potevano consumare. La nobiltà si incattiviva quando vedeva che altri nobili volevano allargare, per motivi di prestigio, i propri possedimenti. Generalmente però si trovavano degli accordi in virtù della politica matrimoniale.
La nobiltà cominciò a diventare molto più esigente nei confronti dei contadini solo quando in città si affermò la pratica borghese. Siccome sui mercati le merci si potevano acquistare solo con monete pregiate (almeno nella fase iniziale del capitalismo), la nobiltà fu indotta a trasformare la rendita da naturale a monetaria. La nobiltà amava acquistare le merci della borghesia per motivi di vanità personale, poiché era una classe abituata a vivere nel lusso, a ostentare la propria ricchezza, il proprio lignaggio altolocato. La nobiltà era “razzista” per definizione, non in senso biologico ma culturale: “nobili si nasce, non si diventa”, si diceva. Era il cosiddetto “sangue blu” che indicava l'origine aristocratica di una persona: di qui l'importanza attribuita agli alberi genealogici. Solo quando la nobiltà cominciò a trovarsi in serie difficoltà economiche, a seguito dello sviluppo del capitalismo, si convinse che i titoli nobiliari potevano essere venduti dietro congruo compenso.
La borghesia cominciò a pretendere un potere politico effettivo soltanto dopo aver acquisito un sicuro successo economico. Le rivoluzioni borghesi, scoppiate sotto la bandiera di una confessione protestantica o sotto quella di una filosofia politica laicistica, avvengono per togliere definitivamente alla nobiltà il potere di decidere o anche soltanto condizionare la vita di una nazione. Nel migliore dei casi (per la borghesia ovviamente) si riduce a zero il potere della nobiltà (come p.es. negli Stati Uniti); in altri casi (quelli ove esiste una monarchia ereditaria soggetta alle disposizioni della Costituzione) si permette alla nobiltà di avere una certa rappresentanza, più che altro formale in verità, in un ramo del parlamento (il Senato o la Camera dei Lords).
Il potere effettivo viene sempre esercitato in parlamento, sulla base di diverse tipologie istituzionali, a seconda degli avvenimenti storici che l'hanno generato. P.es. negli Stati Uniti, che sono un Paese federato, il Senato rappresenta la volontà dei singoli Stati “associati” che lo compongono, mentre la Camera dei Rappresentanti è quella dei deputati eletti, ed è questa che conta di più; in altri Paesi il Senato può essere composto da senatori scelti dal sovrano o da senatori eletti con un sistema elettorale diverso da quello della Camera. Tutte queste differenze contano poco, poiché di fatto è la borghesia che comanda: la nobiltà, se ancora esiste, deve adeguarsi, e lo fa ben volentieri se ha interessi di tipo borghese. I governi in carica rappresentano un esecutivo che, se beneficia di un forte premio di maggioranza, non tiene in alcuna considerazione la volontà delle minoranze. Le leggi vanno tenute sotto controllo dalla magistratura, per assicurarsi che non violino la Costituzione, che è la Carta fondamentale di qualunque Stato politico-democratico. Ma la magistratura fa gli interessi della borghesia, esattamente come la Costituzione. Sotto il capitalismo non esistono governi, parlamenti, costituzioni, magistrature, forze armate o di polizia che facciano gli interessi del proletariato. Ecco perché Lenin ha sempre sostenuto che “tutto” il parlamentarismo borghese andava eliminato dalla democrazia diretta dei soviet. Non si poteva conservare neppure la separazione dei tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario.
La rappresentanza della nobiltà manca là dove sono presenti le repubbliche democratiche, le quali si sono imposte quasi sempre perché la monarchia aveva assunto atteggiamenti del tutto antidemocratici. In questi casi le Costituzioni tendono ad abolire persino i titoli nobiliari.
Le repubbliche possono essere di due tipi: parlamentari e presidenziali. Generalmente quelle presidenziali si sono affermate come forma di contrappeso a uno Stato federalista (ma p.es. nella Svizzera, da sempre favorevole al federalismo, non è mai esistita una repubblica presidenziale).
Diciamo che nel modo di esercitare la politica parlamentare, nel modo di governare non esiste per la borghesia una regola precisa. Ad essa interessano poche cose sul piano politico, essendo prevalentemente una classe di tipo “economico”: 1) la legislatura deve sempre essere favorevole al commercio, il più libero e il meno tassato possibile, cioè il meno tenuto sotto controllo, ma anche il più protetto dalla concorrenza straniera; 2) lo Stato deve reprimere chi usa la forza per opporsi allo sfruttamento del lavoro altrui (p.es. occupando le fabbriche, vietando la proprietà privata dei mezzi produttivi, proclamando scioperi che paralizzano la nazione, ecc.); 3) lo Stato deve aiutare la borghesia a estendere il più possibile i propri affari, anche a costo di occupare territori altrui, di scatenare delle guerre o di creare “paradisi fiscali” di qualsivoglia natura.
Poste queste tre condizioni, il cittadino può fare ciò che vuole. La borghesia è interessata a educare al rispetto del bene privato, non tanto a quello del bene comune. La borghesia chiederà sempre, oltre a pagare poche tasse e ad avere leggi a proprio favore, di ridurre il più possibile il peso dello Stato sociale e di poter fare della natura ciò che vuole. E potrà ottenere tutte queste cose se avrà a che fare con un proletariato, nazionale e internazionale, “buono, calmo e tranquillo”.
Solo quando queste condizioni vengono meno la borghesia assume atteggiamenti dittatoriali. Essa infatti ha usato la dittatura quando ha avuto bisogno di affermarsi come classe politica, ma di nuovo la usa quando vede che il suo potere economico viene seriamente minacciato dal proletariato. Il suo volto “democratico” è apparso solo in due casi: nella fase iniziale della sua ascesa economica, quando doveva farsi largo in un sistema politico gestito completamente dalla nobiltà; e poi quando, una volta conquistato il potere politico, non ha avuto a che fare con un proletariato industriale in grado di minacciare il suo potere economico.
È evidente, infatti, che se gli operai cominciano a chiedere la fine della proprietà privata dei principali mezzi produttivi, ovvero la realizzazione del socialismo davvero democratico, la borghesia non può che reagire molto negativamente. La faccia bonaria e paciosa la perde subito a favore di uno sguardo truce e torvo.
Tutte queste cose – diceva Lenin – il socialismo le ha dette milioni di volte: com'è stato possibile che in occasione di una guerra mondiale, scatenata dalla borghesia per motivi imperialistici, si sia fatto finta di non averle mai sentite? Per quale ragione il socialismo ha preferito tradire se stesso, mettendosi dalla parte della borghesia? Per quale motivo non ha approfittato del momento favorevole per rovesciarla, trasformando la guerra imperialistica in guerra civile? E soprattutto per quale motivo ha deciso di opporsi alla dittatura del proletariato, cui il partito bolscevico ha dovuto ricorrere in Russia per reprimere la furiosa resistenza della borghesia e della nobiltà? Come è stato possibile che nel momento più favorevole allo scoppio di una rivoluzione, il socialismo europeo abbia tradito così profondamente, così impunemente, i propri ideali?
Guardando il comportamento del socialismo riformistico europeo, Lenin aveva dovuto constatare un duplice tradimento: uno nei confronti della classe sociale rappresentata politicamente, sia nella società civile che in parlamento; un altro, ancora più grave, nei confronti dell'unica esperienza socialista rivoluzionaria risultata vittoriosa, quella bolscevica. Il primo tradimento poteva essere interpretato come frutto inevitabile di un eccessivo riformismo come prassi politica, in contrasto con le idee rivoluzionarie professate sul piano teorico.4 Ma il secondo tradimento come andava interpretato? Opponendosi radicalmente all'Ottobre, i socialismi riformisti finivano col negare gli stessi princìpi, gli stessi ideali di vita in cui credevano dai tempi della nascita del socialismo scientifico.
Tra socialismo e comunismo il divario diventerà sempre più netto, e riuscirà a ricomporsi solo dopo il crollo del muro di Berlino e il fallimento della svolta gorbacioviana. Si ricomporrà nel senso che in tutta Europa non esisterà più alcun partito comunista; e anche tutti i partiti socialisti verranno risucchiati dalle posizioni democratico-borghesi del centro-sinistra.
IV
Nel testo di Lenin vi è una frase che sembra necessitare di una spiegazione; è la seguente: “lo sviluppo della democrazia non attenua ma acuisce la lotta di classe”.
Ci chiediamo: lo diceva come una constatazione di fatto, guardando quello che accadeva in tutta Europa subito dopo la fine della guerra mondiale, quando gli animi erano esasperati contro le rispettive borghesie nazionali, che avevano provocato immani tragedie e devastazioni, e quando i governi in carica, vedendo la rivoluzione russa, temevano che la cosa potesse ripetersi nei loro Stati?5 Oppure dobbiamo considerarlo un principio teorico-politico valido per la democrazia borghese in generale, soprattutto quando questa non è più in grado di garantire un benessere generalizzato o quando non è in grado di affrontare una crescente protesta di massa causata dalla miseria? O forse lo diceva per giustificare il fatto che, pur avendo sempre detto che la democrazia proletaria è infinitamente superiore a quella borghese, si era visto costretto a ricorrere alla dittatura più rigida per far fronte alla controrivoluzione?
Quella era un'affermazione che, considerata astrattamente, era obiettivamente esagerata. Poteva avere un senso solo se contestualizzata. È vero, “la borghesia, quand'era rivoluzionaria, sia in Inghilterra nel 1649 che in Francia nel 1793, non ha mai concesso 'libertà di riunione' ai monarchici e ai nobili, che avevano chiamato gli eserciti stranieri e che si 'radunavano' per organizzare un tentativo di restaurazione”. Così Lenin.
A ciò però si sarebbe potuto obiettare: “La borghesia non concedeva nulla proprio perché era nella fase della dittatura. Se avesse definitivamente vinto i tentativi reazionari, avrebbe anche aumentato le libertà democratiche”. Al che forse Lenin avrebbe risposto: “La storia ha dimostrato che proprio nel momento in cui la borghesia si è radicalizzata nelle proprie idee democratiche, è stata altresì costretta a ricorrere alla dittatura, a fronte del deciso rifiuto di tali idee da parte dei ceti aristocratici, e oggi fa lo stesso nei confronti del proletariato, quando vede unire il massimo della democrazia possibile alla volontà di realizzare praticamente il socialismo”.
È quindi difficile commentare quella frase, che in astratto ricorda quella stalinista secondo cui quanto più aumenta il socialismo, tanto più forte diventa l'opposizione del capitalismo (col che giustificava la necessità di conservare uno Stato dittatoriale). Negli anni del suo esilio Lenin aveva potuto vivere un'esistenza relativamente tranquilla in vari Paesi europei. Lo stesso Marx nel 1850 aveva scelto di trasferirsi a Londra, in un Paese che appariva il più democratico di tutti. Forse questi Paesi erano democratici perché il vero volto dittatoriale lo mostravano solo nelle loro colonie?
Quando cerca un'emancipazione meramente economica la borghesia è democratica, soprattutto se ha a che fare con un potere politico oppressivo, di tipo clerico-feudale. La borghesia inizia a combattere politicamente un potere del genere soltanto quando si sente economicamente abbastanza forte. E quando lo combatte diventa aggressiva. Poi, una volta ottenuto il potere politico, inizia a manifestare la propria aggressività nei confronti del proletariato, poiché vuole sfruttare la forza-lavoro in grande stile, a livello nazionale, confidando nella protezione dei governi in carica e delle loro leggi. L'aggressività diminuisce in patria se si riesce a decentrarla verso la conquista delle colonie, cosa che diventa tanto più urgente quanto più i mercati nazionali si saturano e quanto più i lavoratori tendono a ribellarsi. In tal caso si può garantire al proletariato metropolitano un'esistenza più tranquilla e quindi alzare il livello della democrazia politica.
Generalmente la borghesia al potere diventa molto aggressiva quando la concorrenza di altre nazioni borghesi le vuole sottrarre le colonie, oppure quando il proletariato (sia quello metropolitano che quello coloniale) non è più disposto a farsi sfruttare. Ma tutto ciò non giustifica, in astratto, la frase secondo cui “lo sviluppo della democrazia acuisce la lotta di classe”.
Forse quella frase ha un senso, sempre in astratto, se si considera che in una democrazia altamente sviluppata, dove il benessere è piuttosto elevato, la borghesia potrebbe assumere un atteggiamento improvvisamente aggressivo se si accorgesse di non poter più garantire i consueti standard vitali (sempre che, beninteso, vi sia un proletariato che glielo faccia notare).
Quando esiste una concorrenza borghese internazionale, quando le colonie vogliono emanciparsi, quando si devono affrontare dissesti finanziari, crac borsistici, devastazioni ambientali, crescenti forme di criminalità, folli spese militari, quando una buona fetta della popolazione comincia a mostrare tutta la propria insoddisfazione per il tenore di vita che conduce – ecco, in questi casi la borghesia al potere deve chiedersi se usare il pugno di ferro, cioè se trasformare la finta democrazia in un'aperta dittatura (aumentando p.es. di molto i poteri del Presidente del Consiglio o della Repubblica), oppure se allargare le prerogative dello Stato sociale e assistenziale, riducendo i profitti privati.
È difficile però dire in anticipo come la borghesia si comporterà. P.es. in Europa occidentale, dove sono già state vissute due disastrose guerre mondiali, la borghesia si è ammorbidita; se ne scoppiasse una terza, avrebbe timore di essere scalzata dal “trono”. Invece la borghesia americana, che non ha mai sperimentato all'interno del proprio Paese le conseguenze di una guerra mondiale, è sicuramente più aggressiva di quella europea. È abituata a comandare mezzo mondo sin dalla fine della II guerra mondiale, e ad assicurarsi alti livelli di benessere, che le hanno permesso di avere un proletariato docile. Se qualcosa potesse mettere in discussione questo trend consolidato, facilmente essa potrebbe diventare molto violenta.
Le idee del socialismo (per non parlare di quelle del comunismo) sono sempre state aspramente combattute: la borghesia nordamericana non vuol neanche sentirne parlare nel proprio territorio. Questo tipo di borghesia può essere definita politicamente “matura” soltanto perché economicamente è molto forte. Ma quando gli standard economici elevati iniziano a calare vistosamente, la borghesia nordamericana diventa molto aggressiva, soprattutto in politica estera, fomentando continue guerre regionali, imponendo embarghi commerciali alle nazioni considerate “nemiche”, e via dicendo.
Gli Stati Uniti, acquisita l'indipendenza dagli inglesi e dai francesi, realizzata l'unificazione nazionale a spese delle tribù indigene, eliminata la schiavitù dei negri attraverso la guerra civile, hanno avuto una borghesia in continua ascesa, che ha vissuto pochi traumi (forse i più sentiti dalla popolazione sono stati i crac borsistici, più che le due guerre mondiali; la stessa guerra perduta in Vietnam causò meno di 60.000 morti). L'ascesa ininterrotta dipese non soltanto dalla conquista (più che altro economica) dell'America latina e del Medio oriente (ricco di petrolio), ma anche dalla vittoria indiscussa nelle guerre mondiali, per non parlare dell'enorme vastità del territorio nazionale, che per la prima volta poteva essere sfruttato in maniera capitalistica.
Certo è che, vedendo l'assenza di una esplicita dittatura politica, sarebbe ostico affermare che negli Stati Uniti la borghesia è stata tanto più aggressiva quanto più aumentava il suo livello di democrazia politica. A differenza delle dittature politiche dei Paesi sudamericani e per buona parte europei, la dittatura americana è stata piuttosto di tipo economico (la “dittatura del dollaro”).
D'altra parte gli Stati Uniti sono un Paese fortemente “individualistico”: non riuscirebbero a tollerare una dittatura politica esplicita. L'individualismo è ben visibile nella Costituzione, che è di tipo chiaramente federalista, in cui ognuno dei 50 Stati ha prerogative impensabili in molti Stati europei altrettanto federalisti. Inoltre vi sono articoli costituzionali che prevedono per chiunque il libero uso del possesso di armi, il diritto alla “felicità personale”, il diritto alla scarcerazione dietro il pagamento di una cauzione in attesa del processo, il diritto a mantenere i propri beni se, quando vengono espropriati per uso pubblico, non sono adeguatamente indennizzati, ecc. Il bello è che molti di questi articoli individualistici, pur essendo costituzionali, sono spesso soggetti all'interpretazione soggettiva dei giudici, i quali naturalmente sono condizionati da pregiudizi dovuti alla classe sociale d'appartenenza.
Insomma la suddetta frase di Lenin, scritta nel marzo 1919, può essere considerata giusta se la si contestualizza. Era appena terminata la guerra mondiale, che aveva provocato milioni di morti, feriti e mutilati, per non parlare delle distruzioni materiali. La borghesia dei Paesi sconfitti rischiava d'essere rovesciata dal proletariato in rivolta (e in alcuni Paesi era anche successo: Ungheria, Finlandia...). La resistenza dei capitalisti era furiosa. Anche quelli dei Paesi vittoriosi non se la passavano meglio, poiché il salasso della guerra era stato enorme. La borghesia di tutto il mondo, vedendo quel che era successo in Russia, effettivamente ebbe paura che la cosa potesse ripetersi all'interno delle loro rispettive nazioni. Questo spiega il motivo per cui negli Stati Uniti, che in quel momento rappresentavano la quintessenza della democrazia mondiale, la repressione nei confronti dei comunisti fu durissima. Quel paese appariva più democratico soltanto perché, pur avendo vinto la guerra, non dava l'impressione, come invece la Francia e il Regno Unito, di volersene approfittare per spartirsi il mondo intero; anzi i governi americani erano disposti a finanziare i Paesi europei per risollevare la loro economia semidistrutta.
È stata proprio questa tattica apparentemente magnanima che ha permesso agli statunitensi di poter invadere economicamente l'America latina e il Medio oriente: passavano come più “democratici” rispetto agli europei colonialisti e imperialisti, nonostante che al loro interno reprimessero i comunisti molto di più di quanto stava avvenendo in Europa occidentale.
Questo dimostra che mentre la borghesia ha potuto svilupparsi economicamente all'interno del sistema feudale, il proletariato non può pensare di costruire il socialismo restando all'interno del sistema borghese: tutti gli esperimenti del socialismo utopistici sono falliti (fanno parte del “romanticismo economico”); tutte le rivendicazioni del socialismo riformistico non hanno risolto alcun problema strutturale del capitalismo: sono servite soltanto a illudere il proletariato che sia possibile un'esistenza degna d'essere vissuta nell'ambito del sistema.
V
La cosa che non si è mai capita della rivoluzione comunista compiuta in Russia è forse stata una sola, quella che ha maggiormente tradito tutto l'operato di Lenin e dei bolscevichi della prima generazione: lo smantellamento progressivo del potere effettivo dei soviet, cioè il loro svuotamento come organi dirigenziali in ambito locale.
Lo stalinismo ha costruito un Paese che aveva le stesse caratteristiche di uno Stato dittatoriale dell'occidente, con alcune differenze sostanziali: 1) bisognava impedire alla borghesia di rinascere, cioè di dare una propria autonomia ai mercati (e questo è stato possibile statalizzando tutta la proprietà dei mezzi produttivi, sicché anche lo scambio monetario venne ridotto a un nulla); 2) bisognava far sì che l'ideologizzazione dello Stato fosse una conseguenza del fatto che la direzione generale della nazione, in tutti i suoi aspetti, era stata assunta da un unico partito (il che comportava che la classe degli intellettuali, sia politici che funzionari amministrativi, dominava nettamente tutte le altre). Da un lato l'ideale politico sembrava essere più importante dell'interesse economico della borghesia occidentale; dall'altro veniva vissuto col massimo della costrizione possibile.
Si tradì proprio ciò che Lenin avrebbe voluto realizzare dopo la fine della controrivoluzione e dell'interventismo straniero, cioè la progressiva estinzione dello Stato tramite la democrazia diretta dei soviet. Si legga questa sua importante affermazione: “la dittatura del proletariato deve inevitabilmente portare con sé non solo un mutamento delle forme e degli istituti democratici in generale, ma un mutamento tale che implichi un'estensione senza precedenti dell'effettiva utilizzazione della democrazia da parte di coloro che sono oppressi dal capitalismo”. E qui cita, oltre ai soviet russi, il Sistema dei Consigli tedesco e i Comitati dei delegati di fabbrica inglesi, cioè esperienze di democrazia diretta.
In pratica la dittatura del proletariato avrebbe dovuto favorire la democrazia diretta, non quella delegata di tipo parlamentare. Lenin non stava dicendo che i soviet dovevano essere interpretati soltanto come strumento per compiere la rivoluzione; né stava dicendo che sull'esempio dei soviet si sarebbe dovuto semplicemente riformulare la configurazione delle vecchie istituzioni borghesi. Ma stava dicendo che l'esperienza dei soviet avrebbe dovuto “sostituire” le vecchie istituzioni borghesi. Parla di un “mutamento” nella direzione politica della società, che avrebbe dovuto comportare, grazie all'esperienza dei soviet, una “estensione della democrazia senza precedenti”. Questo significava che del passato politico borghese non si poteva conservare nulla.
Stava dicendo che i lavoratori avrebbero dovuto imparare ad autogovernarsi. I soviet costituivano l'esempio da imitare per tutte le vecchie istituzioni, un'esperienza politica e sociale da approfondire e da allargare il più possibile all'intera nazione. Quando Lenin parla della Comune di Parigi (punto 6) il suo pensiero è esplicito a riguardo: la Comune tentò di “distruggere dalle fondamenta l'apparato statale borghese, burocratico, giudiziario, militare, poliziesco, sostituendolo con l'organizzazione autonoma delle masse operaie, che non conosceva distinzioni tra il potere legislativo e il potere esecutivo”. Ha usato l'espressione “dalle fondamenta”.
Democrazia diretta per lui voleva dire “organizzazione autonoma delle masse operaie”, cioè dei lavoratori (inclusi quelli agricoli), tale per cui persino la separazione borghese dei tradizionali poteri dello Stato non avrebbe avuto più alcun senso. Era impossibile equivocare su questa fondamentale finalità della rivoluzione russa. Sarebbe stata una contraddizione in termini che tale democrazia diretta venisse garantita dalle istituzioni statali del nuovo potere proletario.
Purtroppo le cose, sotto lo stalinismo, andarono in maniera opposta: invece di considerare permanenti gli organi della democrazia diretta e provvisori quelli delle istituzioni statali, si fece esattamente il contrario. Il compito di non permettere la rinascita della proprietà privata non è stato riconosciuto alla volontà della democrazia diretta, ma è stato assunto direttamente dalla dittatura permanente di uno Stato burocratico e poliziesco. I cittadini non si sono garantiti da soli l'uguaglianza sociale, economica, culturale, “indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla nazionalità” – come scrive Lenin –, ma hanno dovuto demandarla alla volontà di un ente esterno, a loro superiore.
In questa forma di democrazia eterodiretta qual era la fondamentale differenza tra società borghese e quella proletaria? Nelle democrazie borghesi sono i mercati (da cui anche gli Stati, in ultima istanza, dipendono) che decidono la soggezione dei cittadini-lavoratori, e possono farlo solo se garantiscono un certo benessere materiale. Nella democrazia proletaria è il partito-stato che la decide, il quale ha, necessariamente, un alto tasso di ideologizzazione. Nel socialismo statale i capitalisti vengono semplicemente sostituiti dai funzionari di partito e dello Stato. Tutti hanno bisogno di controllare le masse, ma mentre per i capitalisti la finalità è l'organizzazione del consumo, per gli stalinisti (e i maoisti) è stata quella di controllare l'aderenza a una ideologia statalizzata (di qui i processi contro i “nemici del popolo”, in cui la sentenza era stabilita a priori, come al tempo dell'Inquisizione cattolica). Alla lotta di classe che il proletariato vive in occidente si sostituisce la burocrazia con cui si eseguono direttive calate dall'alto.
Sarebbe assurdo pensare che quanto Lenin diceva al I Congresso dell'Internazionale comunista fosse solo una tattica per giustificare gli inevitabili abusi compiuti durante la dittatura proletaria. Stava parlando di obiettivi generali della rivoluzione: “La soppressione del potere dello Stato è il fine che tutti i socialisti, e Marx per primo, si sono posti”. Sono parole molto chiare. Lenin voleva “la sostituzione delle circoscrizioni elettorali territoriali con le unità elettorali fondate sui luoghi di produzione: fabbrica, officina, ecc.”. Stava dicendo che la democrazia proletaria, “facendo partecipare in modo permanente e necessario le organizzazioni di massa dei lavoratori alla gestione dello Stato, comincia a preparare immediatamente la completa estinzione di ogni Stato”. Il proletariato doveva persino “fondersi” con l'esercito. Lenin voleva, contro la borghesia, “l'effettivo armamento del proletariato”.
Il problema principale che doveva risolvere lo stalinismo, dopo la morte di Lenin, era soltanto quello di come porre le condizioni per realizzare una progressiva estinzione dello Stato. Invece pose soltanto quelle che servirono per rafforzarlo.
Se fosse chiaro a tutti che nessuno può essere o sentirsi obbligato a “vendersi”, cioè a vendere la propria capacità lavorativa, fisica o intellettuale, per poter vivere, indipendentemente dalla forma o entità del corrispettivo che si ottiene; se a tutti fosse chiaro che questa forma di “prostituzione” è indegna per qualunque persona, è immorale sotto ogni punto di vista (anche se ovviamente non per quello economico della borghesia) e che, per il bene complessivo della società, andrebbe aspramente combattuta, anzi, assolutamente vietata, nulla potrebbe impedire l'esistenza della proprietà privata dei mezzi produttivi.
Infatti non è la proprietà “in sé” (pubblica o privata) che fa nascere o che impedisce l'antagonismo sociale, proprio perché tale antagonismo sorge quando uno si serve dei propri mezzi produttivi per sfruttare il lavoro altrui. Non serve a niente costruire una comunità in cui, pur essendo vietata la proprietà privata dei singoli suoi componenti, la comunità, nel suo insieme, può assumere un personale lavorativo privo di proprietà, che viene pagato, in qualsivoglia forma, per il lavoro che svolge, e che può essere licenziato quando tale lavoro è ultimato. Non ha senso vietare la “prostituzione lavorativa” all'interno di una comunità, e legalizzarla nei rapporti col mondo esterno (come facevano i monasteri cattolici).
Non solo quindi tutti dovrebbero avere la proprietà dei mezzi lavorativi, ma nessuno dovrebbe impiegarli per sfruttare il lavoro di chi non ha proprietà, cioè il lavoro di chi ha perduto, per qualche motivo, tale proprietà o non è in grado di metterla a frutto in maniera sufficiente per la propria esistenza. Questo vuol dire che, in presenza di una proprietà privata, tutti dovrebbero accontentarsi di ciò che serve per riprodursi, per avere quanto è necessario per vivere.
In presenza di proprietà privata ci si dovrebbe accontentare di una società basata sull'autoconsumo e sul baratto delle eccedenze (compiuto solo tra persone ugualmente proprietarie e quindi libere). Parlare di “libertà” senza “proprietà” è un controsenso, ma anche parlare di “proprietà” e di “libertà giuridica”, cioè quella libertà formale, inventata dalla borghesia, che non implica, di necessità, il possesso di una proprietà. Non ha senso che una libertà giuridica implichi il libero possesso del proprio corpo, per poi essere costretti a venderlo, subito dopo, rendendolo schiavo per mancanza di proprietà. Non conta niente, quindi, ai fini della libertà personale, che una proprietà sia sociale o privata: conta che non venga usata per sfruttare il lavoro altrui o per togliere agli altri la legittima proprietà.
Semmai è un'altra cosa che ci si deve chiedere: in presenza di proprietà privata, equamente distribuita in base alle necessità dei soggetti che la lavorano, quali sono le garanzie che permettono a un sistema del genere di funzionare nel tempo? Purtroppo non esistono garanzie “assolute”. La storia ha dimostrato che laddove si afferma la proprietà privata, pur in assenza di sfruttamento del lavoro altrui, possono sempre accadere eventi imprevedibili, come p.es. la morte per malattia di un componente (animale o umano) della comunità, oppure un disastro ambientale. In casi del genere, se la comunità è piccola e quindi debole, facilmente si finisce nella tragedia. Un evento fortuito può portare qualunque persona, che fino a un momento prima stava bene, ad essere costretta a chiedere un lavoro dietro compenso.
Questo spiega il motivo per cui la concessione dei mezzi produttivi in proprietà privata a nuclei troppo ristretti di persone, non è conveniente. Il concetto di “famiglia” è un'astrazione priva di senso. Quanto meno si deve parlare di una comunità composta almeno da 50-100 elementi. Molte famiglie, poste di fronte ai principali mezzi produttivi, gestiti collettivamente, possono garantire a tutti la sopravvivenza, previa rinuncia a qualunque proprietà privata (al massimo è possibile tollerare una proprietà “personale”, relativa a mezzi che non sono di uso comune o che comunque non incidono ai fini della sopravvivenza dell'intera comunità).
Cerchiamo ora di spiegare bene questo punto, poiché la differenza tra questa forma di socialismo autogestito e quella del socialismo industriale o mercantile o statale o “scientifico”, è netta.
L'assenza totale di proprietà privata nell'ambito di una vasta comunità di famiglie, in relazione esclusiva ai mezzi produttivi che garantiscono la sussistenza, va vista come una questione interna a tale collettivo, che solo quest'ultimo è titolato ad affrontare. Non possono esserci direttive piovute dall'alto, siano esse politiche o economiche. La coordinazione degli interessi trasversali alle varie comunità va affrontata autonomamente dalle stesse comunità, che si terranno in rapporto tra loro. Quindi lo Stato va eliminato, come pure tutte le istituzioni che lo rappresentano, per non parlare dei Mercati, che ci condizionano sin nei più piccoli particolari.
Non solo, ma le comunità rurali non possono sentirsi vincolate al mantenimento delle comunità urbane, neppure se queste offrissero in cambio mezzi tecnici sofisticati con cui sfruttare la natura. L'idea di avere mezzi e strumenti tecnici del genere, da usare nel nostro rapporto di dominio con la natura, è completamente sbagliata: è nata nell'ambito delle civiltà antagonistiche e, come tale, va rimossa. L'esigenza riproduttiva della natura va considerata superiore a quella produttiva degli esseri umani, proprio perché noi siamo “enti di natura” e non è la natura che appartiene a noi, ma il contrario.
Un altro aspetto di fondamentale importanza è che la vita urbana, priva di riferimenti alla natura, va considerata come una forma di “alienazione”. Bisogna pertanto pensare a come chiudere le città, a come trasferire i suoi abitanti nelle campagne, a come far di nuovo crescere i boschi e le foreste, a come proteggere da qualunque forma d'inquinamento l'aria e l'acqua. L'industria va ridotta al minimo indispensabile, anzi, possibilmente va ricondotta ai limiti dell'artigianato. Dobbiamo recuperare tutte le aree agricole abbandonate da uno sviluppo scriteriato dell'industrializzazione. Dobbiamo smantellare progressivamente il macchinismo applicato all'industria, poiché esso è la fonte principale dell'inquinamento del pianeta, ed è illusorio pensare che si possa risolvere un problema tecnologico con una nuova tecnologia, ancora più sofisticata della precedente. Il vero problema è come ripensare completamente le categorie tipiche della nostra attuale forma mentis: “benessere”, “comodità”, “agio”, “sviluppo”, “crescita”, “sicurezza materiale”...
Ci vorrà un tempo lunghissimo per tornare a un tipo di esistenza simile a quella del “comunismo primitivo”, ma se non facciamo partire la transizione, se non cominciamo a pensarci da adesso, ci vorrà un tempo molto più breve per arrivare a un'apocalisse di immani proporzioni. Ed è evidente che per realizzare una transizione del genere, occorrerà rovesciare con decisione qualunque forma di potere che rende schiavi gli esseri umani.
Nel libro antologico curato dalla Progress di Mosca nel 1980, Sulla dittatura del proletariato, vi sono due testi che dovrebbero essere messi a confronto, stando ai loro titoli, Abbozzo del progetto di programma del Pc russo e Progetto di programma del Pc russo. Il primo (molto dettagliato) fu distribuito ai delegati del VII Congresso del partito il 23 febbraio 1918; il secondo invece fu approvato dall'VIII Congresso il 18-23 marzo 1919 ed è molto meno significativo dell'altro, nonostante sia stato suddiviso in 18 punti. L'ultimo programma del partito era stato approvato dal II Congresso del Posdr nel 1903. In realtà un confronto è quasi impossibile, in quanto i due testi sono molto diversi tra loro, benché gli obiettivi fondamentali restino quelli della dittatura proletaria.
Entrambi i testi sono stati scritti mentre infuriavano la controrivoluzione interna e l'interventismo straniero, quindi in un momento di grave difficoltà.
*
L'Abbozzo non ha un respiro internazionalista come il Progetto, poiché ha come preoccupazione fondamentale quella di inquadrare i principali problemi da risolvere.
Nella Premessa si ribadisce l'idea di espropriare “i grandi proprietari fondiari e la borghesia”, intendendo, con quest'ultima, l'intera classe proprietaria dei mezzi produttivi e di scambio: “fabbriche, officine, ferrovie, banche, flotta...”. Il tutto era stato preso in carico dalla “repubblica sovietica”, in quanto si trattava di un esproprio “statale”, cioè una nazionalizzazione.
Si faccia però attenzione: chi dovrebbe gestire tale imponente esproprio proletario? Non viene detto esplicitamente lo Stato sovietico. Lenin non può dirlo, almeno non senza precisare che lo Stato è destinato a estinguersi, così come aveva già scritto, estesamente, in Stato e rivoluzione. Parla di “repubblica sovietica” e, subito dopo, di “unione degli operai urbani e dei contadini poveri”. Un'unione del genere in quel momento era costituita dai soviet. Lenin stava forse dando per scontato che il nuovo gestore di quell'immensa proprietà requisita ai capitali e ai proprietari fondiari sarebbero stati gli organismi fautori della democrazia diretta? Non pare neanche questo, almeno non in maniera così esplicita.
Lenin si rende conto che se questa democrazia diretta è relativamente facile nelle città, tra gli operai concentrati nelle industrie, non è così facile nelle campagne, dove esiste la dispersione nel lavoro e una notevole borghesia agraria. In questa premessa ha appena detto che l'alleanza che gli operai devono fare è coi “contadini poveri”, inoltre che i “grandi proprietari fondiari” vanno completamente espropriati, infine che la “piccola azienda contadina” deve passare, in modo “graduale ma inflessibile, verso la coltivazione collettiva della terra e verso la grande azienda socialista in agricoltura”.
Facciamo attenzione alle parole, senza trascurare il fatto che, mentre venivano scritte, infuriava la controrivoluzione in tutta la Russia. Il passaggio dall'individualismo nella gestione della terra al collettivismo deve essere “graduale”, oltre che “inflessibile”: graduale perché bisogna convincere i piccoli coltivatori (si presume con l'esempio) che una gestione “sociale” della terra è più efficiente, più conveniente. Ma non devono esserci forzature di sorta: cosa che lo stalinismo non capirà. Inoltre ha usato l'aggettivo “inflessibile”, poiché teme che il capitalismo rinasca proprio tra i contadini “proprietari privati” della terra. Gli operai sono alleati (naturali) dei contadini poveri (gli stessi operai sono ex contadini), ma devono convincere quelli ricchi o benestanti o comunque non poveri, che la socializzazione della terra è un obiettivo del partito comunista, della repubblica sovietica.
Questo è un argomento decisivo. Ora dobbiamo vedere come lo svolge, in maniera più approfondita, nel resto dell'Abbozzo e nel Progetto (naturalmente si rimanda anche al commento delle sue Tesi agrarie).
È indubbio, per Lenin, che fino a quando permane la proprietà privata della terra, è impossibile eliminare il “commercio privato” delle derrate agricole. Finché esiste commercio privato, resta la possibilità che il capitalismo rinasca. Cioè dopo la rivoluzione d'Ottobre il rischio maggiore di tale rinascita non può più provenire dalle città, ma solo dalle campagne, che i bolscevichi ancora non controllano adeguatamente. Il bolscevismo è stato un fenomeno essenzialmente urbano.
I bolscevichi avevano cercato un'alleanza coi socialisti-rivoluzionari, ma questi rappresentavano la borghesia rurale. Un'alleanza invece fu possibile coi socialisti-rivoluzionari di sinistra, più interessati al destino dei contadini poveri. La rivoluzione fu fatta insieme a loro. L'alleanza si ruppe soltanto quando quel partito cominciò a compiere atti di terrorismo contro eminenti personalità del governo prussiano presenti in Russia, in quanto non aveva accettato per nulla la pace di Brest-Litovsk, con cui i bolscevichi permettevano alla Germania d'impadronirsi di molti territori dell'ex impero zarista. Non tenendo conto dei pericoli della controrivoluzione interna e dell'interventismo straniero, volevano, in maniera assolutamente irresponsabile, indurre il governo sovietico a riprendere la guerra contro i tedeschi. Questo partito agrario scomparve dalla scena politica intorno al 1922.
Dunque, al posto del commercio privato Lenin voleva “uno scambio regolare e pianificato di prodotti fra le comuni di produzione e quelle di consumo”. In pratica stava dicendo che la distribuzione delle merci andava tenuta sotto controllo, nel senso che andava regolamentata. “Pianificare” significa che si deve sapere prima cosa e quanto produrre in maniera regolare.
Lenin qui sta parlando di “comuni di produzione” distinte da quelle di “consumo”. Tra queste comuni deve esserci uno “scambio regolare e pianificato di prodotti”. Sta dicendo che il valore di scambio va sottratto alla logica del mercato, alla dinamica della compravendita, quella per cui un bene ha tanto più valore quanto più è scarso sul piano quantitativo, pur essendo molto richiesto. Sta dicendo che nel socialismo il valore di scambio deve essere sottomesso al valore d'uso e che i beni di uso comune, quelli fondamentali alla sopravvivenza della popolazione, vanno scambiati in maniera equa tra le comuni di produzione e quelle di consumo. Sta introducendo il tema del baratto, pur non avendo ancora detto che, in prospettiva, non dovrà esserci differenza tra produzione e consumo, in quanto ogni comunità dovrà essere una cosa e l'altra.
Si faccia bene attenzione a quanto dice, poiché qui si sta parlando di collaborazione o di interazione tra le varie comuni. Lenin sta chiedendo di organizzare lo scambio dei beni in maniera razionale, cioè preventivata. Lo scambio deve avvenire conoscendo in anticipo i bisogni. In un certo senso il mercato capitalistico non esiste più, o comunque è destinato a perdere progressivamente la sua importanza. Di conseguenza deve ridimensionarsi di molto l'uso del denaro come mezzo per lo scambio dei beni. Non solo diventa impossibile arricchirsi a spese altrui, ma viene eliminato anche il mezzo per diventarlo alla maniera borghese.
Su questi aspetti si può essere “graduali” quanto si vuole, ma bisogna anche essere “inflessibili”. Lenin usa questi aggettivi in coppia due volte in poche righe, in quanto è ben consapevole che l'origine del capitalismo sta nella proprietà privata dei mezzi produttivi e nel commercio privato sul mercato, al fine di accumulare capitali.
Qui si chiude la Premessa, apparentemente favorevole non solo alla democrazia diretta ma anche a una sorta di socialismo autogestito, in cui il valore d'uso ha nettamente più importanza sul valore di scambio. Poi vi sono altri tre capitoli, dedicati alla politica, all'economia e alla questione agraria. Ce n'è abbastanza per capire cosa Lenin pensa del socialismo democratico.
Che egli consideri più importanti (politicamente e culturalmente) gli operai delle fabbriche, che non i contadini, è pacifico. Gli operai rappresentavano, per lui, l'“avanguardia” di tutta la società, a condizione naturalmente che fossero consapevoli del loro ruolo strategico nell'ambito della produzione. Essi sono più “concentrati, uniti, istruiti e temprati nella lotta”, e questo grazie allo stesso capitalismo industriale, che pur cerca di dividerli, favorendo l'aristocrazia operaia e gruppi in concorrenza tra loro. Viceversa, i contadini sono “arretrati [culturalmente] e dispersi [socialmente]”: sono “influenzati” dalla borghesia rurale.
Prima però di parlare di economia, vediamo la questione agraria, seguendo il percorso inverso da lui delineato, ch'era partito dalla politica. Questo perché, secondo noi, tutta la democrazia politica ed economica dipende da come si imposta la questione agraria.
Lenin qui fa differenza tra obiettivo massimo e provvedimenti transitori. Il primo, per lui, è racchiuso nella priorità che va concessa alle “grandi aziende collettive”. La terra va socializzata, ma non tanto nel senso che ogni contadino deve avere in proprietà un lotto che permetta alla sua famiglia di sopravvivere. Un'economia basata sull'unità familiare non andrebbe oltre il livello di autosussistenza. Le campagne non sarebbero di nessun aiuto per le città e per gli operai. Lenin vuole “grandi aziende collettive” per permettere alle città di esistere. Infatti queste grandi aziende useranno i macchinari provenienti dalle fabbriche urbane. Vuole superare il “contrasto tra città e campagna”, che presentava “gravi difficoltà”, ma è convinto che ciò non sia possibile “senza prima elevare notevolmente la produttività del lavoro”, in virtù della quale è possibile il “passaggio definitivo” dal socialismo al comunismo.
Ebbene, questa ideologia “produttivista ad oltranza”, pur sviluppandosi nell'ambito del socialismo, oggi va superata, alla luce dei disastri ambientali provocati dalla tecnologia. Ma restiamo fermi alla questione agraria, poiché è proprio qui che Lenin contraddice le proprie premesse. Quel che lui teme è la rinascita del capitalismo nelle campagne. Cioè da un lato ritiene che l'esproprio dei grandi latifondisti vada fatto nel più breve tempo possibile; dall'altro però vuol venire incontro alle esigenze dei contadini medi, anch'essi proprietari, poiché sa che il proletariato urbano non avrebbe le forze sufficienti per indurli ad accettare la gestione collettiva della terra, né sarebbe giusto farlo, in quanto vi sono, negli stili di vita, delle abitudini che solo col tempo, sulla base del buon esempio, potranno essere superate.
Paradossalmente abitudini del genere, in campagna, si riscontrano persino nei contadini privi di tutto, i quali infatti aspirano ad avere un pezzo di terra in proprietà privata. Infatti dice, parlando di questi contadini proletari: “Bisogna prima di tutto organizzarli in una forza autonoma, avvicinarli al proletariato urbano e strapparli all'influenza della borghesia rurale e degli interessi inerenti alla piccola proprietà”. Poi elenca tutta una serie di misure che sono già state prese.
Per quanto riguarda il mondo rurale Lenin ha fiducia solo negli “elementi proletari e semiproletari”. Tutti gli altri li vede come potenziali nemici, poiché, ora che l'industria è stata nazionalizzata, il capitalismo può rinascere solo dagli agricoltori abituati a commerciare.
Chiediamoci, tuttavia: se anche questo pericolo fosse stato reale, quale capitalismo sarebbe potuto rinascere? Quale forza avrebbe potuto avere un capitalismo semplicemente “rurale”? Quando mai è esistito un capitalismo rurale che non fosse anche urbano? Il processo storico che ha portato alla nascita del capitalismo non è forse nato prima di tutto nelle città? Come potrebbe accadere il percorso inverso quando al commercio e al denaro si preferisce il baratto? Come potrebbero gli agricoltori speculare sui loro prodotti in un regime di pianificazione dei bisogni?
Forse Lenin teme che gli operai vadano (o meglio, tornino) a vivere in campagna, chiedendo un lotto di terra in proprietà? Ma se le città si svuotassero di lavoratori produttivi (industriali o meno), a chi venderebbero gli agricoltori le loro derrate alimentari? Non sarebbero forse anch'essi costretti a tornare all'autoconsumo e a barattare le eccedenze? Di che cosa aveva paura Lenin? Che si formasse un “socialismo della miseria” solo perché post-industriale? Solo perché del tutto agrario? Facevano così paura i contadini ricchi (kulaki)? anche dopo aver nazionalizzato le industrie, le banche, i trasporti, il commercio estero, le miniere e tutte le risorse energetiche?
Dov'è che l'ideologia leninista va superata? Solo in un punto: il “monopolio statale” di tutta la produzione. Lenin non voleva affrettare i tempi, ma se anche avesse avuto più tempo, la sua idea di statalizzare la produzione era sbagliata, non foss'altro che per una ragione: lui stesso aveva accettato la tesi dei fondatori del socialismo scientifico secondo cui lo Stato andava superato.
Ora, è questo il modo migliore per porre le basi del superamento dello Stato? Statalizzare tutta la produzione affinché non si possa più parlare di proprietà privata? La necessità dello Stato andava forse giustificata proprio perché era presente ancora la proprietà privata nel mondo rurale? Avrebbe dovuto essere lo Stato a garantire che da quella proprietà privata non sarebbe più risorto il capitalismo? Lo Stato avrebbe dovuto concepirsi in antitesi alle “piccole aziende contadine”? Ovvero avrebbe dovuto limitarsi a fare delle concessioni parziali, in attesa che fossero vinte le inveterate abitudini al commercio? La realizzazione del socialismo democratico avrebbe dovuto essere garantita dallo Stato e non dalla società? Per impedire il commercio lo Stato avrebbe avuto il diritto di esigere “la consegna di tutti i prodotti eccedenti”? Non dimentichiamo che la statalizzazione della proprietà, da gestirsi tramite appositi ministeri, andava di pari passo con la centralizzazione dei poteri, fatti passare per indispensabili contro la resistenza antirivoluzionarie. Lo stalinismo aumenterà tanto più la propria dittatura quanto più la sua politica economica si rivelerà del tutto fallimentare. I successi industriali di cui vantava erano stati pagati con lo sterminio dei dissidenti, economici e politici.
*
Per rispondere a queste domande proviamo a leggere il capitolo dedicato all'economia. Per Lenin tutte le direttive della produzione dovevano essere date dall'alto, cioè da organi statali. La mediazione tra Stato e società doveva essere svolta dai sindacati. L'idea che egli ha di sindacato è quello di una “cinghia di trasmissione” dello Stato, una specie di “longa manus” nell'ambito della società civile. Sono “organismi di educazione professionale e socialista”, oltre che di “direzione di tutta l'economia nazionale”. A questi organismi affida il compito della transizione. Per il resto sa benissimo che nella fase iniziale ci vorrà molta pazienza, bisognerà fare molte concessioni.
L'idea di fondo che ha Lenin è quella di un socialismo urbano e industrializzato, che considera le forze rurali come alleati di seconda categoria, almeno finché non si saranno imposte le “grandi aziende rurali” (collettivizzate). In quel frangente (storico) per lui la parola “collettivizzazione rurale” voleva dire “statalizzazione”, ma è impossibile interpretare ciò come qualcosa di definitivo, proprio perché lo Stato doveva estinguersi e non rafforzarsi sotto il socialismo maturo.
Che quella fosse una fase transitoria lo si comprende anche dal fatto che Lenin prevedeva di fare “concessioni” anche agli “specialisti della scienza e della tecnica”, i quali avrebbero addirittura potuto pretendere dei “premi per il lavoro migliore e soprattutto per il lavoro organizzativo”.
Vediamo ora il punto 4. Anzitutto è compito dei sindacati fare in modo che tutti lavorino. Sotto il socialismo il lavoro non è semplicemente un diritto che si può rivendicare, ma piuttosto un dovere per tutti. Lenin esige “la più grande e la più rigida centralizzazione del lavoro su scala statale”, ovvero “il superamento della dispersione e del frazionamento dei lavoratori sul piano professionale e locale”.
Che cos'ha in mente? Di costruire uno Stato-caserma? È possibile burocratizzare il lavoro? Non bastava dire alla società che lavorare è un obbligo per tutti? E poi lasciare alla stessa società il compito di definire i limiti, le caratteristiche di tale dovere?
L'immagine che Lenin ha dello Stato rischia d'essere paternalistica. Voleva forse che la transizione venisse realizzata da uno Stato padre e padrone? Non vuole, ovviamente, che si formino le corporazioni di arti e mestieri, ma è contrario anche ai sindacati di categoria e alle associazioni di professionisti. In questa maniera lo Stato finisce col sovrapporsi alla società civile, e proprio perché il fine del socialismo è quello di sviluppare l'industrializzazione. Ma che tipo di sviluppo industriale può esserci se tutti i lavoratori vengono irreggimentati nella loro professione?
Supponendo anche che l'obiettivo dell'industrializzazione sia primario per il socialismo, come si sarebbe potuta sviluppare l'industria leggera (che dipende molto dalla creatività di persone ingegnose, di talenti individuali) in una transizione così fortemente statalistica? Lenin voleva forse solo un socialismo della grande industria, alimentato dalla campagna? Come avrebbe potuto svilupparsi la ricchezza, il benessere generalizzato senza industria leggera? I prezzi delle merci della grande industria sarebbero stati improponibili per gli agricoltori. Per evitare il rischio di una “forbice” del genere (tra prezzi industriali e prezzi agricoli), Lenin pensava di “sostituire il commercio con una distribuzione dei prodotti pianificata e organizzata su scala statale”.
Tuttavia, che senso avrebbe avuto per un agricoltore proprietario privato, abituato a vendere le proprie derrate sul mercato, “scambiare” i suoi prodotti con quelli industriali quando poi non avrebbe potuto vendere nulla sul mercato o comunque non a condizioni per lui vantaggiose? Introdurre le macchine in agricoltura significa avere rese maggiori. Le macchine, peraltro, durano parecchio: non avrebbe avuto senso sostituirle molto velocemente. A che pro industrializzare l'agricoltura, quando poi gran parte delle eccedenze non potevano essere vendute, ma dovevano essere consegnate allo Stato? È vero, nel mondo rurale della Russia vi era ancora molta proprietà privata e quindi sfruttamento del lavoro. Ma come avrebbe potuto non apparire una forma di ingiustificato paternalismo il fatto d'impedire lo sviluppo di tali condizioni borghesi favorevoli a un ritorno del capitalismo, servendosi dell'autoritarismo degli organi statali? Che fine avevano fatto i soviet? Erano diventati anch'essi, come i sindacati, uno strumento nelle mani dello Stato?
Al punto 6 parla dell'armamento di tutti gli operai e dei contadini proletari, senza specificare che tale situazione andava considerata provvisoria. È giusto far capire agli sfruttatori che devono aver paura del popolo armato, ma ancora meglio è far capire che la maggiore sicurezza si ottiene quando tutti sono disarmati. Né ha senso sostenere che, siccome la nazione potrebbe essere attaccata in qualunque momento dalle nazioni borghesi, il popolo deve restare perennemente armato, o che lo Stato deve impiegare gran parte delle proprie risorse a perfezionare continuamente i propri armamenti, trasformandoli da puramente difensivi a offensivi.
Al punto 7 ribadisce uno dei princìpi fondamentali della Comune di Parigi: l'unità dei poteri legislativo ed esecutivo. Nel socialismo chi si fa carico di questa cosa devono essere i soviet. Tuttavia come si possa conciliare questa importante attività con quella del parlamento (o con quella degli organi centrali dello Stato) non viene detto. In effetti, se si riconosce ai soviet, che sono organi locali, un potere del genere, che è della massima importanza, non si capisce fino a che punto siano indispensabili gli organi statali. Qual è la loro funzione? Di indirizzo generale e di coordinamento delle istanze locali o di gestione diretta di tutte le risorse?
La democrazia diretta è incompatibile con quella delegata, meno che mai quando questa si pone in maniera permanente. È notorio che la democrazia diretta può essere esercitata solo a livello locale-territoriale, in comunità ristrette. Non ha senso una democrazia diretta a livello nazionale. Quanto più ci si allontana dalla comunità locale, tanto meno forti devono essere i poteri che si esercitano in maniera delegata; oppure, se questi poteri vengono esercitati in tutta la loro pienezza, il mandato ricevuto deve avere una durata molto limitata. Se il socialismo, nella sua fase transitoria, vuol tenere in piedi delle istituzioni parlamentari nazionali, queste devono concepirsi come temporanee, provvisorie, aventi poteri decisionali piuttosto circoscritti (i poteri dovrebbero essere più che altro consultivi). Il mandato del deputato deve avere un peso inversamente proporzionale alla distanza dalla comunità che lo delega, cioè quanto maggiore questa tanto minore quello; non solo, ma il mandato dovrebbe sempre essere specifico, per una questione particolare, trasversale a varie comunità. Ciò in quanto i veri poteri sono soltanto quelli locali. Non è possibile che una struttura o ente nazionale o statale, che di per sé è qualcosa di astratto, di burocratico, dica alle comunità locali, radicate da tempo in territori specifici, come bisogna comportarsi là dove esse esistono.
Lenin affronta esplicitamente la questione della democrazia diretta al punto 8. E subito si mette a spiegare d'aver timore che la burocrazia statale possa approfittare del fatto che il proletariato è in guerra contro le forze reazionarie del Paese. Mostra d'essere ben consapevole che la burocrazia è un'arma fondamentale che la borghesia utilizza per tenere i lavoratori sottomessi sul piano amministrativo. E sa anche che in quel momento così drammatico per l'intera nazione non è possibile smantellare lo Stato.
Poiché si rende conto che il problema della burocrazia statale è non meno gravoso di quello della proprietà privata dei mezzi produttivi (non a caso sono strettamente intrecciati), si sente in dovere di affermare, al punto 9, che “ogni membro di un soviet deve compiere assolutamente un determinato lavoro nell'amministrazione dello Stato”, un lavoro che “deve variare, in modo da abbracciare tutto il ciclo degli affari relativi all'amministrazione dello Stato, tutte le sue branche”; anzi, “si deve invitare tutta la popolazione lavoratrice a partecipare in modo autonomo all'amministrazione dello Stato”.
Questo punto è poco chiaro, anche perché sembra essere affetto dal solito paternalismo moralistico di chi vuol scongiurare i difetti di una democrazia, forzatamente immatura, con mezzi inadeguati. Oltre al lavoro in fabbrica, un operaio avrebbe dovuto compiere un lavoro amministrativo? Supponendo che i lavori amministrativi vengano fatti da lavoratori non impegnati in fabbrica, è possibile (è realistico) passare da un'amministrazione all'altra con relativa disinvoltura? Non ci vuole forse un certo tempo per acquisire delle competenze? E che senso ha, una volta che sono state acquisite, essere trasferiti in altra amministrazione?
Lenin teme fortemente il potere della burocrazia, ma siccome non vuole, in quel momento così drammatico, smantellare lo Stato, non sa bene come fare. Propone una cosa (la rotazione degli incarichi e l'assegnazione di tali incarichi a un personale non specializzato) che ha il sapore di una mezza misura, una toppa nuova su un vestito vecchio. Sembra, stranamente, non capire che nell'ambito della democrazia diretta e dell'autogestione della comunità locale, la burocrazia è ridotta al minimo, non avendo alcuna rilevanza nazionale. È semplicemente la burocrazia che riguarda l'amministrazione delle cose locali. L'amministrazione delle persone dovrebbe essere simile a quella che un tempo esercitavano le parrocchie: nascite, morti, matrimoni. A ciò si possono aggiungere i contratti, le eredità, i confini territoriali, le sanzioni, i titoli di studio e cose del genere, validi sul piano giuridico o amministrativo o statistico.
Il punto 10, nella sua prima parte, vuole essere riassuntivo delle cose dette in precedenza, ribadendo che lo Stato va considerato al servizio della popolazione nazionale (e non il contrario, come nelle democrazie liberali, dove una classe, quella borghese, usa lo Stato come un proprio strumento di dominio).
Poi prosegue in ulteriori tre parti, diverse tra loro: la questione nazionale, la politica religiosa e quella scolastica. La questione nazionale, in un Paese plurinazionale come l'ex impero zarista, era ovviamente molto importante, in quanto i cosiddetti “grandi russi” volevano esercitare una certa egemonia su tutte le altre nazionalità. Lenin esige che la Russia socialista sia un Paese federato, in cui tutte le nazionalità, tutte le etnie dovranno considerarsi pariteticamente.
Inutile però ricordare che là dove esiste uno Stato centralizzato e un'unica capitale della nazione, è impossibile garantire l'uguaglianza delle nazionalità. Infatti sotto lo stalinismo non si riuscì mai a farlo. L'uguaglianza può esistere solo se si elimina qualunque “segno distintivo” che possa essere utilizzato per indicare la maggiore importanza di una nazionalità (o etnia) rispetto a un'altra. È illusorio pensare di poter risolvere l'ineguaglianza limitandosi ad “aiutare” le nazionalità (o etnie) più arretrate culturalmente o più svantaggiate economicamente. I concetti di “arretratezza” o di “svantaggio” vanno totalmente ripensati, soprattutto in considerazione del fatto che i termini di paragone non possono essere l'urbanizzazione e l'industrializzazione. Una nazionalità deve decidere per suo conto come vivere la propria esistenza. Non può sentirsi obbligata a ricevere dall'esterno i criteri relativi al proprio sviluppo. Lo stesso concetto di “sviluppo” va profondamente rivisto. Parlare di “nazioni arretrate e deboli”, dando per scontato che il modello da seguire sia l'industrializzazione urbana, significa negare, ipso facto, sul piano dei princìpi l'uguaglianza federativa che si vorrebbe realizzare.
Riguardo alla politica religiosa Lenin ribadisce che non ci si può limitare alla separazione giuridico-istituzionale tra Stato e Chiesa (o meglio Stato e “Chiese”, in quanto la Russia era già sotto lo zarismo un impero pluriconfessionale), la quale comunque implica anche quella tra Chiesa e scuola. Lo dice in via preliminare, poiché sa benissimo che anche la democrazia borghese avrebbe voluto realizzare queste cose, senza però riuscirvi a causa dei limiti strutturali della proprietà privata dei mezzi produttivi, che è una realtà impopolare per definizione.
Altrove Lenin aveva detto che compito del partito comunista, non dello Stato, è quello di educare la popolazione all'ateismo scientifico, per cui è sbagliato sostenere che il partito deve restare indifferente alle questioni religiose, al pari dello Stato, che mette tutte le religioni sullo stesso piano giuridico e le subordina alle istanze della laicità (come comportamento generale del cittadino). I pregiudizi vanno combattuti, non ci si può limitare a sopportarli, in attesa che scompaiano da soli quando il socialismo economico sarà pienamente realizzato.
L'importante – prosegue Lenin con tatto pedagogico – è che, nel fare propaganda dell'ateismo, il partito eviti di “offendere i sentimenti dei credenti”, per non crearsi dei nemici in più. A ciò si può aggiungere che il partito non deve utilizzare lo Stato per fare propaganda dell'ateismo. Uno Stato ateo è necessariamente ideologico, e questa caratterizzazione paradossalmente “confessionale”, considerando che è un organismo burocratico-amministrativo, destinato a estinguersi nel socialismo maturo, non ha davvero alcun senso. È sufficiente che lo Stato si ponga in maniera “laica”, che è una forma di ateismo implicito, indiretto, non dichiarato. Un credente può sentirsi tale nei confronti della propria confessione, ma deve comportarsi come “laico” nei confronti dello Stato, proprio perché lo Stato socialista non può essere confessionale.
L'insegnamento della religione può essere presente nella scuola statale? Evidentemente no. Al massimo si può tollerare un insegnamento “sulla” religione, come fenomeno storico-culturale da spiegarsi in maniera laico-razionale.
Ma la vera domanda è un'altra: in presenza di una democrazia diretta ha ancora senso parlare di una “scuola statale”? La scuola dovrebbe essere “pubblica” (pagata con le tasse di tutti i cittadini, essendo un servizio collettivo), cioè non privata (quella per chi se la può permettere), né statale (altrimenti si rischia di trasformare lo Stato in una nuova “chiesa”). Una scuola pubblica, nell'ambito del socialismo, dovrebbe essere gestita dalla comunità locale. Solo questa comunità può decidere che tipo di insegnamento impartire nelle proprie scuole.
Lenin voleva statalizzare l'insegnamento, sottraendolo all'influenza della Chiesa e delle classi sfruttatrici del lavoro altrui, ma è evidente che questa soluzione era in contrasto con l'idea di eliminare progressivamente le funzioni dello Stato a vantaggio dell'autonomia della società civile. Trasformare una soluzione temporanea in una permanente di questo tipo significa fare del paternalismo autoritario, un difetto che rende incapaci di avere fiducia nella popolazione (cosa che lo stalinismo erigerà a “sistema”).
Il terzo aspetto riguarda appunto la scuola statale, globalmente intesa. Al primo punto Lenin mette “l'istruzione generale e politecnica, che fornisca i fondamenti teorici e pratici delle principali branche della produzione”. Lenin voleva una scuola funzionale alle esigenze produttive della nazione, cioè voleva la fine della separazione tra teoria e pratica, tra scuola e mondo del lavoro. Voleva uno “stretto legame tra l'insegnamento e il lavoro socialmente produttivo”. Oggi avremmo detto, in riferimento alla situazione italiana, che voleva una grande diffusione degli istituti tecnici e professionali a scapito di quelli liceali. Come dargli torto? Un Paese da ricostruire completamente, su basi del tutto diverse, avrebbe considerato i licei un lusso che non poteva permettersi.
Forse per questo Lenin chiedeva che alla formazione educativa e scolastica dei giovani partecipasse l'intera cittadinanza, non solo il corpo docente. Una grande idea, questa, che farebbe uscire la scuola dal suo storico isolamento. In nome della “formazione permanente” tutti, nessuno escluso, avrebbero dovuto sentirsi, in momenti diversi, docenti e discenti.
Lenin aveva forse una concezione troppo strumentale dell'istruzione pubblica? Oppure aveva capito come combattere il nozionismo astratto? Di sicuro non era affatto avverso alla formazione di una cultura superiore.
*
Vediamo ora il Progetto di Programma del Pcr, del 25 febbraio 1919.
Il Progetto ha un respiro più internazionalista dell'Abbozzo, forse perché si parla di inizi rivoluzionari anche in Austria-Ungheria e in Germania. In tal modo Lenin può giustificare meglio l'idea di rendere possibile il socialismo in un Paese economicamente arretrato come la Russia, contraddicendo la tesi marxista dominante, secondo cui il socialismo si sarebbe potuto sviluppare solo dopo l'esaurimento della spinta propulsiva del capitalismo, cioè solo quando le contraddizioni fossero venute a piena maturazione. Tutti infatti si chiedevano come fosse possibile realizzare un socialismo basato sull'industria e quindi su una vasta presenza della classe operaia, quando questa in Russia era un'esigua minoranza rispetto all'insieme dei lavoratori.
Lenin invece voleva saltare, in virtù della coscienza soggettiva dell'avanguardia dei lavoratori, le tappe dell'evoluzione oggettiva. E aveva ragione. Non c'era bisogno di aspettare una sviluppo delle “sofferenze” dovuto allo sfruttamento del lavoro, quando la stessa rivoluzione industriale si sarebbe potuta fare in assenza di proprietà privata. La sua parola d'ordine era “socialismo + elettrificazione”.
Strano che qui non dica nulla del fatto che l'impetuoso sviluppo della tecnologia era strettamente correlato a quello della proprietà privata dei mezzi produttivi, dei mercati, del denaro, e ovviamente di una nuova classe sociale, la borghesia, che si serviva dello strumento del contratto per sfruttare il lavoro di persone giuridicamente libere.
Nell'ambito di una statalizzazione del socialismo non può esserci sviluppo dell'industria leggera, ma solo di quella pesante, imposta a tutta la società. Nell'attuale Cina è potuto avvenire lo sviluppo dell'industria leggera semplicemente perché il partito-stato ha permesso, bonariamente, il formarsi del capitalismo nell'ambito della società civile, riservandosi la gestione esclusiva di tutti i poteri politici e amministrativi.
Lenin si sente in dovere di spiegare che nella Russia arretrata gli operai han potuto fare la rivoluzione politica grazie “all'aiuto dei contadini più poveri e del semiproletariato”. Ma non arriverà mai a dire che la vita rurale, una volta socializzata la proprietà, avrebbe dovuto avere un'importanza maggiore delle città industrializzate. Non arriverà mai a capire che per il ritorno al comunismo primitivo l'industria sviluppatasi sotto il capitalismo, preposta a saccheggiare le risorse naturali e a inquinare l'ambiente, è tutto meno che utile, anzi va considerata molto pericolosa, da ridursi al minimo.
I punti 2 e 3 sembrano essere scritti da un sognatore, sia perché non si può parlare con sicurezza di una transizione “inevitabile” dal capitalismo al socialismo; sia perché è una forzatura affermare che “l'imperialismo accelera il crollo del capitalismo”. Che senso aveva dire cose del genere quando prima della guerra tutti i partiti socialisti avevano votato a favore dei crediti imperialistici delle loro rispettive nazioni colonialistiche e persino i crediti militari per permettere lo scoppio della guerra mondiale? E che dire del fatto che durante la guerra nessuno di loro aveva accettato la sua proposta di trasformare la guerra imperialistica in guerra civile per abbattere i rispettivi governi nazionali? Proprio la rivoluzione bolscevica aveva dimostrato che, pur in presenza in tutta Europa delle condizioni oggettive per ribaltare il sistema, solo in Russia ciò era potuto avvenire con successo. Il fattore soggettivo era stato determinante in ultima istanza.
A partire dal punto 4 sino al numero 11 Lenin non fa che riportare il precedente Programma del suo partito, cercando di mostrare una evidente coerenza nell'analisi delle dinamiche del capitalismo. In questi punti si condanna l'idea di vivere sfruttando il lavoro altrui, cioè il fatto di potersi avvalere di una proprietà privata per obbligare la stragrande maggioranza delle persone a vendere la propria forza-lavoro.
Si constata inoltre che la grande produzione (i monopoli) tende a eliminare i piccoli produttori indipendenti. E che lo sviluppo della tecnologia è così impetuoso che gli imprenditori non si fanno scrupoli a utilizzare le donne e i bambini. Tale sviluppo porta ad aumentare enormemente la quantità di merci sui mercati, che però restano per gran parte invendute, generando crisi di sovrapproduzione. I salari, infatti, per acquistarle sono troppo esigui. Sicché la rivalità delle nazioni borghesi per la conquista delle colonie è molto forte.
È proprio lo sviluppo incontrollato della tecnologia che acuisce il divario tra produzione e consumo, che è la fondamentale antinomia tra capitale e lavoro. D'altra parte è la stessa industria che crea un proletariato in grado di svolgere qualunque tipo di lavoro e quindi di sostituirsi alla borghesia. Socialismo altro non vuol dire che rimuovere l'anarchia produttiva, lo sfruttamento del lavoro, la presenza della proprietà privata, la differenza tra i ceti o tra le classi sociali, al fine di organizzare la produzione in maniera razionale, pianificata, in modo da soddisfare le esigenze di tutti. Per ottenere ciò occorre che il proletariato, una volta conquistato il potere politico, se ne serva per reprimere gli sfruttatori.
Difficile qui non vedere che una certa idea di evoluzionismo sociale dominava anche nell'ideologia leninista, benché questa non avesse i limiti del socialismo riformistico. Sembra che lo sviluppo tecnico-scientifico dell'Europa occidentale (trasmesso agli Stati Uniti e al Giappone) sia stato, a quel tempo, un motivo sufficiente per considerare il socialismo una diretta prosecuzione del capitalismo, fatta salva, ovviamente, la questione della proprietà privata. Oggi diremmo che i disastri ambientali della seconda metà del Novecento si sono preoccupati di mettere in discussione questa ingenua interpretazione dei processi storici, per non parlare del fatto che qualunque esperienza “statalistica” del socialismo è destinata a un sicuro fallimento.
I punti che vanno dal 12 al 18 sono una breve caratterizzazione dell'imperialismo e una denuncia della politica riformistica dei partiti socialisti europei. D'altra parte cosa avrebbe dovuto fare il socialismo europeo? Là dove esiste un diffuso benessere, per quale motivo desiderare di compiere una rivoluzione politica? Chiunque avrebbe potuto dire che tale rivoluzione si era resa necessaria in un Paese come la Russia, proprio a motivo della sua arretratezza. Oppure chiunque avrebbe potuto dire che in un Paese arretrato come quello sarebbe stata sufficiente la rivoluzione borghese del febbraio 1917: che bisogno c'era di compierne un'altra di tipo socialista? In entrambi i casi il socialismo europeo si rifiutava ostinatamente di mettere in relazione il benessere dei Paesi occidentali con lo sfruttamento coloniale dei Paesi tecnologicamente arretrati.
In sintesi, il Progetto di programma del Pcr si riduce a poche indicazioni di massima, cioè a enunciati di principio, che di programmatico non hanno quasi nulla. In pratica, mentre nella parte iniziale dello scritto Lenin sostiene l'inevitabilità del passaggio dal capitalismo al socialismo, oltre alla tesi che l'imperialismo è la fase suprema del capitalismo, l'anticamera del suo definitivo crollo, alla fine è costretto ad ammettere che il socialismo europeo non è assolutamente preparato ad abbattere il sistema. E questo perché, proprio in forza dell'imperialismo, i capitalisti occidentali sono stati in grado di corrompere, con alti salari e stipendi, buona parte del proletariato industriale e dei politici e dei sindacalisti che lo rappresentano in parlamento e nelle aziende.
Dunque, finché esiste sfruttamento delle colonie, la realizzazione del socialismo sembra essere diventata molto difficile, quasi impossibile. In Russia era stata possibile forse perché non esisteva un elevato sfruttamento delle colonie interne all'ex impero zarista, quando la Russia europea sfruttava la sua area asiatica (siberiana).
Tuttavia Lenin non arriva a dire che, visto che la rivoluzione bolscevica è stata compiuta in un Paese molto arretrato, la stessa cosa potrebbe accadere anche nelle colonie. In quel momento vedeva le colonie ancora troppo arretrate (culturalmente e materialmente) per compiere una rivoluzione comunista. Eppure molte di queste colonie erano più vicine al comunismo primitivo della stessa Russia: avevano una memoria storica da salvaguardare. Tant'è che nel Novecento tutte le rivoluzioni comuniste sono avvenute al di fuori dei territori dei tre poli dell'imperialismo mondiale: Stati Uniti, Europa occidentale e Giappone. Quindi l'unica speranza che possiamo avere di veder realizzato il socialismo, dobbiamo rivolgerla ai Paesi colonizzati. Il socialismo occidentale è troppo colluso con la borghesia: è opportunistico, revisionistico, sciovinistico... È tutto meno che vero socialismo.
1 I socialisti-rivoluzionari furono un partito democratico piccolo-borghese sorto in Russia a cavallo tra il 1901 e il 1902, sulla scia di quelli che a fine Ottocento si chiamavano ancora “populisti”. Rivendicavano l'abolizione della grande proprietà fondiaria, ma nella lotta contro l'autocrazia zarista ricorrevano al terrorismo individuale. Dopo la sconfitta della rivoluzione del 1905-1907 la direzione del partito passò su posizioni liberal-borghesi. Dopo la rivoluzione borghese del febbraio 1917 alcuni leader fecero parte del governo provvisorio, attuando una politica di repressione del movimento contadino e sostenendo la borghesia nella lotta contro la classe operaia che stava preparando la rivoluzione comunista. Dopo l'Ottobre bolscevico condussero la lotta armata contro il popolo sovietico.
2 Lo Stato sovietico nel 1921 aveva due milioni di funzionari, contro i 600.000 dell'apparato statale zarista. Il partito bolscevico nel 1920 aveva 150 funzionari, ma nel 1922 ne aveva già 15.000. Nel 1921 il numero complessivo degli iscritti al partito era composto per il 95% da gente entrata dopo la rivoluzione!
3 Della convocazione dell'Assemblea Costituente il governo provvisorio di Kerenskij cominciò a parlare nella dichiarazione del 2 (o 15, secondo il calendario gregoriano) marzo del 1917. Le elezioni però si svolsero il 12 (25) novembre, sulla base di liste composte prima della rivoluzione d'Ottobre, sicché la maggioranza dei seggi andò ai socialisti-rivoluzionari di destra e ai menscevichi. L'Assemblea cominciò i suoi lavori nel gennaio 1918, ma, dopo che la maggioranza si rifiutò di approvare la “Dichiarazione dei diritti dei lavoratori e del popolo sfruttato”, nonché i Decreti sulla terra e sulla pace, essa fu sciolta con decreto del Comitato Esecutivo Centrale di tutta la Russia.
4 La storia ha comunque dimostrato che, nell'ambito del socialismo, quando si pratica per molto tempo il riformismo, anche le idee smettono d'essere rivoluzionarie, com'è naturale che sia (in tal senso il revisionismo di Bernstein, tanto per fare un esempio, non poteva certo essere considerato un fulmine a ciel sereno).
5 Negli Stati Uniti o in Svizzera – i Paesi che lui cita – l'odio per i comunisti appariva non meno forte che in altri Paesi europei, anche se quelli non avevano subìto dalla guerra danni rilevanti.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube