

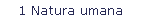
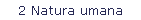
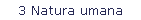
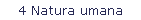
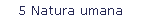

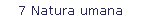
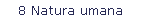
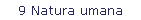
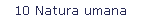










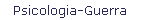

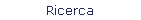
|
|
Il processo di individuazione nel Vecchio Testamento
“La historia es nuestra, y la hacen los pueblos” (30)
Salvador Allende
“Non tocca a te portare a termine il compito,
ma non hai neanche alcun diritto a ritirarti”
R. Tarfon in Pirkei (Mishnah, Aviot II, 21)
Fromm vede nel Vecchio Testamento una metafora del divenire dell’uomo nel
processo storico, la simbologia dell’umano percorso dalle sue origini verso
l’individuazione. Tale percorso ha inizio, nella Genesi, con il primo atto umano
di libertà: la libertà di disobbedire. (31)
Come si è visto, Fromm considera condizione necessaria dello sviluppo umano
la rottura dei legami incestuosi (32), costituiti da quei vincoli primari che
impediscono all’uomo di emergere dalle sue condizioni animali: solo la rottura
di tali vincoli consente all’uomo di muovere i primi passi nel processo di
individuazione. Fromm osserva come la Bibbia in generale, e la Genesi in
particolare, siano ricche di riferimenti metaforici alla rottura di tali legami:
la caduta di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, simbolo del ventre materno,
segna la necessità di rompere il vincolo con la madre e con la natura, atto
indispensabile affinché sia possibile la libertà individuale e lo stesso amore
tra uomo e donna.
Con la violazione del divieto divino di mangiare il frutto dell’albero della
conoscenza, l’uomo acquisisce consapevolezza della propria esistenza, ma al
tempo stesso spezza la propria originaria armonia con la natura: l’uomo, che una
volta era parte di essa, ne diviene nemico, ma avrà la possibilità di
riconciliarvisi a patto che riesca a rendersi completamente umano ed a
raggiungere un nuovo e più elevato stadio di armonia.
Il serpente dell’Eden rappresenta dunque per Fromm non il demonio, il male,
bensì la saggezza, colui che incitando alla disobbedienza induce l’uomo a
rendersi simile a Dio. L’intera tradizione ebraica risulta secondo Fromm
caratterizzata dall’imitazione di Dio, in luogo della discussione sulla sua
natura: è opinione di Fromm che nell’ebraismo l’azione sostituisce la teologia;
la qualità di essere santo è ciò che di principio distingue Dio dall’uomo, e se
l’uomo vuole santificarsi, deve perciò imitarlo. Ciò si concretizza sia nel
testo biblico, sia nella tradizione ebraica successiva, nell’osservanza della
legge di Dio, osservanza che rende l’uomo simile a Dio, un Dio che non è da
considerarsi un oggetto cui sottomettersi.
Nell’insegnamento profetico l’imitazione di Dio si concretizza nelle regole
dell’agire, nella halakah, la strada, nel seguire i suoi principi di amore e
giustizia.
Come espresso anche in Maimonide, citato più volte da Fromm, si può
conoscere Dio soltanto imitando le sue azioni, rendendosi simili a lui; questo
tipo di conoscenza assume quindi un senso ben diverso da quello di una sterile
speculazione sulla sua essenza; in altre parole la vera conoscenza di Dio
rappresenta per Fromm la negazione della teologia. Anche nella tradizione
ebraica infatti, osserva Fromm, la teologia è stata sostituita dallo studio
della legge e dalla sua osservanza.
Fromm interpreta alcune affermazioni rabbiniche come espressione della
possibilità che la differenza tra Dio e l’uomo venga eliminata: pur nascendo
mortale ed oppresso dal conflitto tra la sua natura animale ed al tempo stesso
divina, l’essere umano è tuttavia un sistema aperto, e come tale ha la
possibilità di svilupparsi, di dispiegarne le potenzialità, fino a condividere
con Dio la capacità di creare.
Un altro passo nella rottura dei legami incestuosi può secondo Fromm
ritrovarsi all’inizio della storia nazionale degli ebrei: Dio dice ad Abramo di
lasciare la casa paterna e di dirigersi verso la terra che egli gli mostrerà.
Anche la liberazione degli ebrei dall’Egitto secondo Fromm può leggersi
nella stessa ottica: la condizione sociale di schiavitù sarebbe un altro dei
legami che l’uomo deve spezzare.
Fromm considera l’obbedienza a Dio, simbolo di un’autorità razionale, come
la condizione che consente l’emancipazione dall’irrazionale sottomissione
all’uomo, ed in ciò vede la ragione dei numerosi richiami all’obbedienza, specie
a Dio e al padre, presenti nel Vecchio Testamento. (33)
A questo proposito Fromm puntualizza la differenza tra obbedienza, un atto
conscio di sottomissione all’autorità, e fissazione, un legame emotivo che
vincola affettivamente una persona. L’obbedienza, spiega Fromm, è un
comportamento più che un sentimento, che può mettersi in atto anche quando i
sentimenti verso l’autorità sono in realtà ostili; la fissazione è invece
generalmente inconscia, mentre coscientemente si avverte solo un sentimento di
amore o paura.
La persona fissata teme di essere abbandonata, e la sua libertà è limitata
da un legame che essa non può spezzare per il timore di perdere l’amore di cui
ha bisogno; la persona che obbedisce è invece spinta dal semplice timore di una
punizione. La fissazione è fissazione alla madre, raggiungendo nei casi estremi
l’intensità della fissazione simbiotica, capace di bloccare il processo di
individuazione, oppure, come si è visto, al sangue e alla terra, legami con il
passato comunque di ostacolo al completo sviluppo. L’obbedienza, nel mondo
patriarcale della Bibbia e della letteratura ebraica successiva, è obbedienza al
padre, simbolo di ragione, coscienza, legge, principi morali e spirituali. (34)
Nella interpretazione radicale che da del Vecchio Testamento, Fromm pone a
meta dello sviluppo umano il raggiungimento dell’indipendenza e di uno stato di
libertà, ossia il compimento del processo di individuazione. Condizioni
necessarie di un successo in tale percorso sono ‘il taglio del cordone
ombelicale’ e l’acquisizione della capacità di dovere la propria esistenza solo
a se stessi.
In questo processo il primo passo è rappresentato nel testo biblico dalla
liberazione dei legami incestuosi con la natura (il paradiso terrestre) e con il
sangue ed il clan (l’Esodo), tramite rispettivamente, il primo atto di libertà
fonte di autocoscienza, e l’obbedienza all’autorità razionale di Dio e
l’osservanza delle sue leggi.
Il passo successivo dello sviluppo dovrebbe consistere nell’acquisizione di
convinzioni e principi propri, giungendo finalmente ad essere ‘fedele a se
stesso’ (35). L’autorità, prima esterna, eteronoma seppur razionale, grazie alla
quale è stato possibile emanciparsi dai vincoli incestuosi si fa interna ed
autonoma: l’ultima ed estrema conseguenza del processo di individuazione, della
lotta per la conquista della libertà e dell’indipendenza, auspicata dal Dio del
Vecchio Testamento, è la libertà e l’indipendenza persino dallo stesso Dio.
Tale indipendenza, tuttavia, non coincide con la semplice disobbedienza,
sebbene quest’ultima sia condizione necessaria per il suo raggiungimento:
l’indipendenza è possibile soltanto nella misura in cui l’uomo coglie
attivamente il mondo, e nell’entrarvi in rapporto trova l’armonia con esso. Come
Fromm più volte afferma nei suoi scritti, non possono svilupparsi indipendenza e
libertà finché l’uomo non abbia raggiunto uno stadio di completa attività e
produttività interne.
La caduta di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre rappresenta dunque per
Fromm l’inizio della storia dell’umanità: l’originaria armonia
pre-individualistica fra uomo e natura e fra maschio e femmina è seguita dalla
lotta e dal conflitto. La sofferenza per tale perdita genera nell’uomo il
desiderio di rinunciare a ragione, autocoscienza, libertà di scelta e
responsabilità, aspirando a ritornare al paradiso perduto: il mondo dell’unione,
il ventre materno, la ‘Madre Terra’.
Ma lo sforzo di sfuggire dalla libertà conquistata col suo primo atto di
disobbedienza non può costituire una soluzione soddisfacente: l’uomo non può
tornare indietro, per quanto egli desideri perdere quella stessa consapevolezza
che lo rende umano. Ma questa autoconsapevolezza, la conoscenza del bene e del
male, sono irreversibili.
La dicotomia esistenziale che sconvolge l’uomo non è cancellabile, e può
essere superata solo andando avanti. Perché ciò sia possibile è necessario che
egli, come il popolo di Israele, faccia esperienza di se stesso come straniero
nel mondo: solo sperimentando l’essenziale frattura tra sé come soggetto ed il
mondo come oggetto potrà sperare di raggiungere un nuovo e più elevato stadio di
armonia, ridiventando uno con se stesso, il prossimo e la natura ad un livello
più elevato.
Il ‘peccato originale’ di Adamo ed Eva è per Fromm simbolo di questa
frattura esistenziale: dal momento in cui egli ha acquisito consapevolezza di se
stesso questa ‘corruzione’ è giunta a far parte della stessa natura umana, e
solo divenendo pienamente umano l’uomo può sperare di superarla. Il momento
storico in cui dovrebbe avere culmine questo processo nel quale l’uomo crea se
stesso e raggiunge la nuova armonia è espresso nella letteratura profetica e
rabbinica nel concetto di tempo messianico, talvolta anche chiamato ‘la fine dei
giorni’.
Il tempo messianico non è per Fromm uno stadio necessario, predeterminato da
Dio o dalle leggi del destino o da un finalismo implicito nella storia, ma potrà
raggiungersi solo con lo sforzo dell’uomo. Solo l’uomo ha la possibilità, almeno
finché non l’abbia perduta (36), di scegliere tra la propria auto-distruzione ed il
progredire verso la realizzazione di se stesso e verso la nuova armonia. Il
concetto di tempo messianico è dunque interpretato da Fromm come la logica
risposta all’esistenza dell’uomo, conseguenza della sua attività produttiva nel
corso della storia, ed il protendere verso di esso come unica vera alternativa
alla barbarie.
La filosofia biblica esprime per Fromm l’idea di un uomo che crea la sua
storia, sviluppando nel corso di essa i poteri di ragione e di amore cui è
affidata la compiutezza della propria umanità, riconquistando l’armonia perduta,
ma ad un più alto livello di individuazione. Questa armonia, rappresentata dal
tempo messianico, è l’armonia di un uomo completamente conscio di sé: l’armonia
di un uomo libero, rinato nella capacità di distinguere il giusto dall’ingiusto,
il bene dal male; l’armonia di un uomo finalmente divenuto ciò che
potenzialmente è. Nel concetto di tempo messianico Fromm vede dunque il
compimento della promessa del serpente, simbolo di saggezza e di ribellione: in
esso l’uomo può finalmente diventare come Dio.
Il tempo messianico non è dunque la ‘fine dei tempi’, come è stato
interpretato dall’ebraismo moderno e dal cattolicesimo, bensì un tempo
successivo della storia, ma sempre un tempo dentro la storia: è il tempo in cui
l’uomo è rinato completamente e in cui l’uomo, perdutosi dopo la caduta dal
paradiso, farà ritorno al mondo.
Nella concezione dei profeti, osserva Fromm, il tempo messianico non è mai
il prodotto di un atto di grazia divino, né l’espressione di un innato finalismo
storico; è piuttosto la conseguenza dello sforzo produttivo dell’uomo liberato
da ogni idolatria. In esso l’esistenziale dicotomia umana, generatrice di
conflitto e sofferenza, si risolve, attraverso la mobilitazione delle risorse
umane, nella ricerca di nuove e sempre più efficaci soluzioni, sino a sviluppare
la propria umanità, le proprie facoltà razionali ed il proprio amore per la vita
e per il mondo e raggiungere finalmente l’essere-in-uno.
Naturalmente Fromm non corre il rischio di suggerire al lettore una
interpretazione deterministica di tale processo che, precisa, può giungere a
compimento solo a patto della costante ed attiva scelta da parte dell’uomo
dell’indipendenza e della libertà, e non come inevitabile conseguenza del
trascorrere della storia.
Fromm mette in evidenza il sussistere di un rapporto dialettico, nella
filosofia biblica, tra paradiso terrestre e tempo messianico: il paradiso
terrestre rappresenta l’età dell’oro passata, il tempo messianico quella a
venire; la pace e l’unione regnano in entrambi i tempi, ma nel primo caso esse
sono l’armonia di un uomo non ancora nato, mentre nel secondo sono il risultato
della sua completa (ri)nascita.
Vi sarebbero differenze tra i vari profeti circa la figura del redentore che
dovrebbe precedere il tempo messianico: mentre alcuni descrivono il messia come
un ‘maestro’, che ha i caratteri di una figura individuale, altri parlano di un
messia collettivo; in alcuni altri il messia sarebbe addirittura assente, solo
l’uomo potendo redimere se stesso.
Ad ogni modo, osserva Fromm, il messia non è mai inteso come un salvatore,
come colui che con un atto di grazia cambierà il cuore dell’uomo, bensì come il
simbolo di un nuovo periodo storico che giungerà quando sarà il momento. In
questa idea di fondo Fromm individua anche una delle sostanziali differenze tra
il concetto ebraico di messia e quello sviluppato in seguito dalla Chiesa
cattolica.
Seguendo Baeck (37), Fromm osserva come nel mondo profetico il messia, l’atteso,
è un discendente della casa di David. La linea del desiderio è dunque
orizzontale: sarà un uomo tra gli uomini colui che compirà la storia. Dal
profeta Daniele (164 a.C. circa) in poi, sotto l’influsso della filosofia
ellenistica alessandrina, l’idea messianica diviene invece quella di un regno
ideale al di là di questo mondo, ed il contenuto delle speranze apocalittiche la
resurrezione dei morti e la vita eterna. La linea del desiderio diviene dunque
verticale: l’oggetto del desiderio, l’atteso, è un essere soprannaturale che
verrà inviato da Dio a porre fine alla storia. (38)
Concetto fondamentale del tempo messianico è la pace come risultato di un
cambiamento interno all’uomo grazie al quale l’unione ha sostituito
l’alienazione, ed il baratro che separa l’individuo dai suoi simili e dalla
natura finalmente si colma. Questo concetto di pace, spiega Fromm, trascende il
mondo dei rapporti umani, coinvolgendo anche la relazione tra uomo e natura:
l’uomo può finalmente essere se stesso nel mondo della natura, e la natura
diviene parte del mondo umano; essa diviene la madre che tutto ama e tutto
nutre, giammai sterile, mentre la natura interna dell’uomo non sarà più
mutilata.
Questa idea di pace universale è individuata da Fromm nelle parole dei
profeti. Ad esempio, in Michea (4:3), la dichiarazione “forgeranno le spade in
vomeri e le loro lance in falcetti” esprime l’idea della distruzione di tutte le
armi da guerra; lo stesso profeta annuncia come assieme alla guerra scompaia
anche la paura, poiché la guerra scomparirà proprio quando nessuno proverà più
il desiderio di dominare l’altro incutendo timore.
Ancora in Michea (4:5), l’affermarsi “Sì tutti i popoli s’incamminano,
ciascuno nel nome del suo Dio” manifesta la speranza della scomparsa del
fanatismo religioso, fonte di lotte e distruzione: nel concetto di tempo
messianico è insita, secondo Fromm, la necessaria contingenza dei concetti di
pensiero adoperati dal genere umano per esprimere i suoi scopi e valori supremi,
e non vi è dunque il bisogno di un concetto specifico di Dio.
Corollario di questo concetto di pace è, ad opinione di Fromm, anche
l’universalismo: il superamento della solitudine non solo tra uomo e uomo, ma
anche tra una nazione e l’altra. A ciò vengono secondo Fromm le prescrizioni
bibliche di amore per il nemico e per lo straniero: quando lo straniero cessa di
essere tale si annulla la narcisistica percezione di una differenza qualitativa
tra un popolo e l’altro, e nessun popolo può proclamare con ragione di essere
l'eletto.
Dell’insegnamento messianico Fromm pone in evidenza la posizione dei profeti
nei confronti del potere e della forza: essi, afferma Fromm, sono i
rivoluzionari che smascherano i potenti dalla loro apparenza morale e religiosa,
grazie alla quale ricche minoranze tengono assoggettate larghe maggioranze di
oppressi e di sfruttati, facendo loro credere come la propria condizione sia
decretata da Dio o sia insita nel naturale andamento delle cose.
Nel Talmud caratteristiche del tempo messianico sono l’emancipazione
politica associata a quella religiosa e spirituale, il concetto di un messia
completamente umano e non di natura divina e la scomparsa del merito e della
colpa come conseguenza del raggiungimento della completa umanità da parte
dell’uomo. Il divenire completamente umano esclude ogni bisogno di
giustificazione.
A questo proposito Fromm nota che il termine ebraico tradotto come ‘peccare’
nella Bibbia concordata, significa in realtà ‘perdere’ (la strada, ‘halakah’),
ed il termine tradotto come ‘pentimento’, ‘shuv’, o ‘teshuvah’, significa in
realtà ‘ritorno’. Il vero significato dei due termini svela secondo Fromm
l’assenza di un Super-Io sadico o di un Io masochista nella concezione ebraica
di peccato e pentimento, dalla quale è esclusa ogni tristezza o colpevole
sottomissione.
La concezione di un uomo libero e indipendente come meta del processo
storico comporta, in ultima analisi, l’indipendenza persino da Dio, perciò il
peccato dell’uomo è il suo peccato, il ritorno è il suo ritorno. Nel Talmud si
afferma addirittura che il peccatore pentito, indicato col termine ‘baal
teshuvah’ (letteralmente ‘maestro del ritorno’), è addirittura spiritualmente
superiore a colui che non ha mai peccato: egli è colui che, facendo affidamento
solo su se stesso, è riuscito a redimersi ed a comprendere che non c’è vergogna
nell’aver peccato, essendo la capacità di peccare insita nella stessa natura
della quale ogni essere umano è partecipe.
Tale visione credo sia caratteristica anche della concezione che Fromm, ma
anche altri psicoterapeuti, come Ronald Laing, avevano di malattia mentale:
neanche nel disagio mentale c’è vergogna, essendo comunque un’espressione di
caratteristiche umane; la malattia di un certo paziente potrebbe essere anche la
mia, e quella di ognuno.
Il peccare, così come la malattia, non ha niente a che fare con la
malvagità. Dalla lettura della Bibbia, afferma Fromm, non è infatti possibile
evincere alcuna conclusione definitiva circa una innata malvagità o bontà
dell’uomo. Dalla interpretazione del Vecchio Testamento Fromm trae conferma
della sua idea di una natura umana che possa svilupparsi, come regredire; che
possa cioè procedere in entrambe le direzioni. Ciò che il Dio geloso e
patriarcale della Genesi rimprovera ad Adamo ed Eva, cioè di aver mangiato del
frutto proibito, non ha niente a che fare con la malvagità. Quello che è in
questione è solo il loro atto di disobbedienza, atto che, come si è visto, nella
versione originale della Bibbia non viene mai definito come peccato.
Tuttavia, nella Bibbia si ritrova l’idea secondo la quale l’uomo è dotato di
‘immaginazioni malvagie', ossia di una tendenza a concepire e compiere il male.
Il termine utilizzato nel testo ebraico per denotare questa tendenza è ‘yetzer’,
dalla radice ‘yzr’, che ha il significato di ‘formare’, ‘modellare’. La
traduzione corretta del sostantivo ‘yetzer’ dovrebbe dunque essere, secondo
Fromm, quella di ‘immaginazione’ (sia buona che malvagia).
Ciò è espressione, afferma Fromm, dell’idea secondo la quale ogni atto
cosciente, buono o malvagio che sia, è possibile solo sulla base
dell’immaginazione, attributo tipicamente umano. Anche qui Fromm rinviene una
conferma della peculiarità dell’uomo che sta anche alla base della sua
concezione della libertà: a differenza degli altri animali, l’uomo può scegliere
tra il bene ed il male, nutrendo la propria immaginazione di pensieri buoni o
malvagi, e sviluppandosi così in funzione della propria umanità.
L’uomo ha la possibilità di peccare, ma anche di fare il bene, solo in virtù
della sua emancipazione dall’originaria unità, solo in seguito alla caduta dal
paradiso terrestre che esprime in forma metaforica il primo passo mosso nel
processo di individuazione. In virtù della sua ‘caduta’, egli ha acquisito
l’immaginazione, e può dunque scegliere: può peccare, ma può anche redimersi
senza alcun intervento divino. L’unico ruolo attribuito a Dio è quello di
mostrare, per mezzo dei profeti, l’esistenza di queste alternative, e di mettere
in guardia circa le conseguenze dell’una e dell’altra scelta.
Pur tuttavia è possibile individuare nell’Antico Testamento espressioni che
manifestano l’inevitabilità del verificarsi di certi eventi; tali espressioni
non sono per Fromm da interpretarsi come espressione di una volontà o
dell’intervento divino, bensì come conseguenza del persistere dell’uomo sulla
via del male. Coerentemente a quanto afferma trattando del problema della
libertà umana, Fromm scorge nella Bibbia l’idea di un uomo libero sì di
scegliere, ma che, quando sia andato oltre nello scegliere il male o nel farsi
guidare dalle ‘tentazioni’, può perdere questa libertà.
Questa idea si ritrova anche negli scritti e nelle parole dei profeti:
anch’essi prevedono la rovina quando si rendono conto che la libertà dell’uomo è
perduta, e che egli si è perduto a tal punto da non poter più ‘tornare’.
Nella letteratura rabbinica sono presenti numerosi avvertimenti contro
l’attesa del messia ad una data prestabilita, ed anche nel Talmud è espressa la
posizione secondo la quale bisogna aspettare il messia in ogni momento della
propria esistenza.
L’atteggiamento appropriato, l’essenza della vera fede, avente il carattere
della immediatezza, è dunque per Fromm non quello di un’attesa passiva, né
quello di una compulsiva impazienza, bensì quello che Fromm definisce di
‘speranza dinamica’ (39) che implica l’aspettarsi la salvezza in ogni momento, ma
allo stesso tempo essere disposti ad accettare che essa non giunga nel corso
della propria vita, e forse neanche per molte generazioni future. Non cogliere
questo paradosso, ossia non accettare i due aspetti tra loro in conflitto e
separarli, fa sì che la speranza dinamica degeneri in attesa passiva,
conseguenza di una speranza mutilata della fede nella sua immediata
realizzazione.
Lungi dall’essere una pallida fede, la speranza nell’avvento del messia era
ciò che sosteneva gli ebrei nelle loro sofferenze di popolo più volte sottomesso
alla dominazione straniera. Tale speranza si espresse in periodiche ribellioni,
che sempre si conclusero in tragiche disfatte.
Osservo che lo stesso sentimento di speranza, nella sua versione laica, è
stato probabilmente alla base delle numerose rivolte contadine verificatesi in
Europa a partire dalla metà del XIX secolo, da quando cioè una versione laica
del concetto di tempo messianico, la rivoluzione sociale, ebbe la sua
formulazione nelle idee socialiste di carattere marxista e nell’anarchismo.
Così come fallirono le ribellioni degli ebrei contro l’oppressore straniero,
così anche tali speranze insurrezionali furono soffocate nel sangue. Ed anche
qui non sono mancati falsi messia ed abili sacerdoti che hanno cavalcato
l’onesta spontaneità delle rivolte di oppressi e sfruttati a proprio vantaggio
personale.
Ed anche in tempi più recenti, una certa interpretazione del marxismo, ha
portato ad abbandonare l’attiva speranza rivoluzionaria in favore di goffe
speculazioni improntate ad un bieco determinismo, tramutando così l’attività
politica e l’appoggio al ribellismo spontaneo dei ceti più oppressi nella cieca
fede e nella paziente credulità in qualche meccanismo, insito nella stessa
natura del sistema economico, secondo il quale i mali della società dovrebbero
magicamente risolversi da soli, nella illusa speranza che qualcuno serva l’uomo
nuovo e la società nuova su di un piatto d’argento.
Quando la speranza perde la sua immediatezza essa tende ad alienarsi, ed il
futuro si trasforma anch’esso in un idolo da adorare ed a cui sottomettersi.
Fromm lamenta come ciò si possa osservare in numerosi movimenti politici e
religiosi: ciò ha portato, afferma Fromm, alla idolizzazione della posterità nel
pensiero di Diderot e di Robespierre, al tramutarsi del concetto messianico
nell’attesa di una vita dopo la morte nella quale si sarà ricompensati delle
nostre sofferenze, ed alla distorta visione del marxismo diffusa da Stalin,
secondo il quale era legittimo compiere ogni atrocità perché sono le leggi della
storia a giudicare il valore morale di ogni azione (mentre lo stesso Marx aveva
già messo in guardia contro una simile attitudine dicendo che non la storia, ma
l’uomo, fa ed agisce, e quindi giudica delle proprie azioni).
La conseguenza della speranza delusa è secondo Fromm simile nella sfera
religiosa ed in quella politica: vi è sempre chi, nel tentativo di mascherare il
fallimento accogliendolo come una vittoria, sostiene che, in un certo senso
provvisorio, l’oggetto del desiderio è già stato raggiunto, e costruisce una
organizzazione che diviene essa stessa lo strumento di salvezza. Così la Chiesa,
nello sviluppo cristiano dell’ebraismo, divenne la sola a poter garantire
l’accesso al regno dei cieli; così il Partito Comunista, in Unione Sovietica ma
non solo, divenne il sostituto delle speranze di rivoluzione.
Non appena l’organizzazione costituita va a sostituire l’oggetto del
desiderio, osserva Fromm, la via è aperta ai burocrati, che possono così
esercitare le loro meschine funzioni di potere e di controllo.
Ogni sistema di pensiero può partorire una siffatta organizzazione, e Fromm
ritiene che ciò sia dovuto all’innata tendenza umana a completare e
sistematizzare, generata per effetto dell’umano bisogno di un sistema di
riferimento con il quale orientarsi nel mondo. In tal modo, però, la vera
essenza del concetto va perduta, e il suo posto viene preso da un sistema di
idee nel quale il concetto stesso viene assolutizzato e reso anch’esso un altro
idolo cui sottomettersi. E’ questo secondo Fromm il procedimento con il quale
filosofia, religione, idee politiche, e talvolta persino la scienza vengono
tramutate in vuote ideologie.
La differenza che Fromm ritiene discriminante tra profeti e sacerdoti (40) è
appunto quella tra i creatori di un’idea e, rispettivamente, gli illegittimi
promulgatori di idee altrui, in una versione propagandistica, da essi
convenientemente riadattata.
I veri profeti invece, proprio in quanto tali, non avrebbero bisogno di fare
proseliti, essendo votati ad incoraggiare, con il loro esempio, lo sviluppo di
idee proprie negli altri.
Questa differenza è espressa nell’Esodo nel diverso comportamento di Mosè e
di suo fratello Aronne: Mosè è il profeta, colui che intuisce e che sa, ma che
tuttavia teme di non poter raggiungere con le sue parole l’animo del suo popolo;
Aronne, nella cui figura Fromm vede appunto l’istituzione del sacerdozio, è
colui che può rendere comprensibile al popolo le parole del profeta,
falsificandone tuttavia il messaggio.
L’ambiguità del rapporto tra profeta e sacerdote si esprime eloquentemente
nella Bibbia durante il pellegrinaggio di Mosè sul monte Sinai: gli ebrei, persa
la relativa sicurezza garantita dalla presenza di una guida visibile e
carismatica, convincono Aronne a costruire per loro un nuovo idolo da adorare,
nell’impazienza di trovare in esso un simbolo rassicurante. In fondo, nel cedere
a tale richiesta, Aronne non fa altro che comportarsi come molti sacerdoti e
politici faranno dopo di lui: egli compie, cioè, un estremo tentativo di salvare
l’idea, distruggendola; forse egli è spinto dalla speranza di salvaguardare
l’unità del suo popolo, ma nel far ciò egli paga il caro prezzo di sacrificare
la verità che, essa sola, da un senso all’unità.
Il vitello d’oro costruito da Aronne si presta ad essere assunto come
oggetto tangibile di adorazione che, in quanto tale, non necessita di fede:
significativo è il fatto che il popolo non possa sopportare la privazione di un
simbolo cui sottomettersi, ossia l’assenza di un’autorità visibile alla quale
inchinarsi. E’ questo l’atteggiamento del popolo verso il potere ed i suoi
simboli che costituisce secondo Fromm l’essenza dell’idolatria.
Le stesse prescrizioni che Dio da a Mosè, quali la venerazione dell’Arca
dell’alleanza, le cerimonie sacre e la sua stessa definizione, sono interpretate
da Fromm come semplici concezioni che Dio fa all’idolatria del suo popolo, un
popolo ancora impreparato ad accettare un Dio senza simboli e senza nome. (41)
L’emancipazione dall’idolatria è in effetti, secondo Fromm, l’essenza stessa
dell’ebraismo ed il suo messaggio più importante: il Dio senza nome dell’Antico
Testamento è in realtà l’espressione della negazione della sottomissione ad ogni
idolo, ad ogni autorità irrazionale. Nella Bibbia, secondo Fromm, il richiamo
all’obbedienza a Dio implica la negazione della sottomissione all'uomo.
Ma la fondamentale differenza tra Dio e gli idoli non starebbe per Fromm
nella unicità di Dio rispetto alla moltitudine degli idoli: “se l’uomo adorasse
un solo idolo e non molti” afferma Fromm, “sarebbe ancora un idolo e non Dio”. (42)
Il concetto di idolatria, la lotta contro la quale è rappresentata dal lungo
cammino del popolo ebraico verso la liberazione, è da Fromm interpretato in
riferimento al concetto introdotto da Feuerbach e sviluppato da Marx di
alienazione.
L’uomo trasferisce negli idoli le proprie passioni e qualità, adorando in
essi un aspetto parziale di se stesso, che egli ha reso esterno, alienato
rispetto a sé; nell’identificarsi con questo aspetto di sé che egli ha riposto
nell’idolo, l’uomo risulta limitato a questo aspetto, e perde la sua totalità di
essere umano, arrestando il proprio sviluppo. (43)
Gli idoli, spiega Fromm, sono morti, mentre l’uomo è vivo; adorando un
idolo, un aspetto parziale e limitato alienato rispetto a sé e di cui l’idolo è
investito, l’uomo manifesta amore per la morte. Al contrario, il riconoscimento
di quello che nella tradizione giudaico cristiana ha preso il nome di Dio è
l’espressione dell’amore per la vita.
L’essenza del monoteismo, la negazione dell’idolatria, comporta per Fromm
l’assurdità della stessa teologia. “Se Dio non ha un nome” egli afferma, “non
c’è niente di cui parlare”. (44)
Gli idoli invece hanno un nome: nei tempi antichi essi erano animali,
alberi, figure umane in legno, pietra o metallo, oggi sono divenuti lo stato, la
patria, la bandiera, il successo, il prestigio, il consumo, il denaro, ed anche
le stesse idee che negavano in origine ogni adorazione e sottomissione sono
state spesso tramutate in nuove idolatrie.
L’essenza del processo di liberazione del popolo ebraico descritto nel
Vecchio Testamento è appunto per Fromm la lotta contro le tendenze idolatriche:
esse sono l’unico vero peccato di cui si parli nella Bibbia e costituiscono la
più grande minaccia alla libertà. L’importanza che si da alla fede in tale
processo di liberazione sembra trascendere la passiva fede in Dio, se lo si
intende semplicemente come un altro idolo cui sottomettersi.
Essa sembra essere piuttosto una fede nell’uomo, determinata dal confidare
nel fatto che egli possa liberarsi e sviluppare un giorno le proprie
potenzialità più umane.
L’inizio, il presupposto della liberazione sta per Fromm nella capacità di
provare sofferenza: si soffre se si è oppressi, fisicamente e spiritualmente, ma
i più sensibili possono provare sofferenza anche per l’oppressione altrui. La
sofferenza porta al desiderio di porvi fine, generalmente tramite l’azione
contro gli oppressori, azione che consente l’acquisizione di nuovi poteri di cui
gli oppressi possono servirsi per raggiungere la libertà. Ma in tale percorso vi
è il rischio di ricadere nei vecchi schemi della schiavitù, e talvolta gli
stessi oppressi di oggi possono diventare gli oppressori di domani. (45)
La capacità di provare sofferenza è una dote specificatamente umana, e
niente unisce gli uomini più di essa; ma una volta che si sia perduta la
capacità di soffrire la possibilità di cambiare ci è preclusa, e sbarrato è il
sentiero che conduce alla libertà.
Nel pensiero ebraico, il ruolo di Dio in questo percorso di liberazione non
è quello di dispensare magici interventi volti a cambiare il cuore dell’uomo o
ad annientare i suoi oppressori: egli aiuta, ma mai facendo ciò che solo l’uomo
può fare per sé. L’uomo è nella storia, tanto individuale quanto in quella
dell’umanità, lasciato a se stesso: nessuno può fare per lui ciò che egli è
incapace di fare da solo.
Mi permetto di osservare che questo è lo stesso limite riconosciuto da Fromm
al processo terapeutico: esso è mirato, tramite le tecniche psicoanalitiche di
investigazione dell'inconscio, a mobilitare le risorse interne del paziente che
possono portarlo alla guarigione, mentre sarebbe del tutto inutile alimentare in
questi la speranza di una ‘guarigione magica’ impartita dall’esterno. (46)
Anche nell’apparizione a Mosè nella forma del rovereto che brucia ma non
consuma, simbolo dell’esistenza spirituale che, al contrario di quella
materiale, non diminuisce la sua energia con l’uso, Dio si rivela non come Dio
della natura, bensì come Dio della storia: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco,
il Dio di Giacobbe. (47) Egli non sarebbe dunque una volontà posta al di fuori della
storia, ma la storia stessa e le sue leggi, e l’esperienza di essa che ogni
persona dotata di sufficiente sensibilità può fare, in modo per ognuna
sensibilmente diverso da quello in cui è esperita da altri. La fede in un simile
Dio è dunque fede nell’uomo e nelle sue capacità di creare la propria storia.
Fromm individua infatti come principio fondamentale del concetto di storia
biblico e post-biblico l'uomo come fautore della sua storia, nella quale non vi
è un Dio che interferisca con atti di grazia volti a cambiare le sue condizioni,
il suo cuore e la sua natura.
L’uomo è libero di scegliere la propria strada, ma pertanto è anche
responsabile delle conseguenze della sua scelta. I miracoli compiuti in Egitto,
di cui si parla nel Vecchio Testamento, lungi dall’essere magici interventi
volti a salvare l’uomo ed a cambiare la sua sostanza, sono per Fromm da
interpretarsi come manifestazioni volte ad impressionare chi, come ebrei ed
egiziani e quanti altri procrastinino nell’idolatria, solo è sensibile al
linguaggio della forza.
Fromm nota come tale idea sia espressa già in Maimonide, secondo il quale la
natura dell’uomo non è mai mutata per i miracoli compiuti da Dio: l’unico
miracolo che possa incidere sul cuore dell’uomo è quello che egli compie per se
stesso, cambiando la propria natura e sfuggendo alla determinazione cui è
costretto dalle proprie tentazioni, dalle proprie passioni irrazionali.
Il ruolo di Dio nella storia biblica è, in opinione di Fromm, semplicemente
quello di annunciare, per mezzo dei profeti, la sua esistenza: l’esistenza
dell’Uno che ha rivelato se stesso e che svela il vero scopo dell’esistenza
umana, quello dello sviluppo produttivo delle facoltà che consentano all’uomo di
divenire completamente umano, cioè a dire, simile a lui.
I profeti mostrano all’uomo le alternative e le conseguenze di queste,
talvolta esprimendo metaforicamente tali conseguenze in termini di punizioni e
ricompense divine. Essi sono la coscienza del popolo, coloro che lo mettono in
guardia quando esso perde la strada, ma senza abbandonarlo.
Caratteristica essenziale dei profeti è che essi non parlano in termini di
salvezza individuale, ma promuovono l’idea che alla salvezza individuale di
ognuno sia indissolubilmente connessa la salvezza dell’intera umanità. I loro
sforzi sono volti alla creazione di una società sorretta dai principi di amore,
libertà e giustizia, per questo, osserva Fromm, la loro missione non è mai
limitata al piano spirituale, ma si estende alla dimensione sociale e politica.
Il regno auspicato dai profeti non è il regno dei cieli, ma è sempre di
questo mondo: un regno dove la politica della società e l’azione dei suoi membri
siano giudicate sulla base dei più alti valori morali, sulla base di quell’etica
umanistica costituente per Fromm il presupposto di ogni legittimo giudizio.
Parlando del futuro i profeti non annunciano eventi già scritti da una
volontà al di fuori della storia, ma semplicemente deducono le necessarie
conseguenze di una realtà presente che essi osservano e comprendono. Le loro
profezie, sempre espresse in termini di alternativa almeno fin quando l’uomo non
abbia ormai perso la sua libertà di scelta, esprimono ciò che avverrà se le
forze in gioco in un dato momento storico non saranno mutate.
Il profeta vede la realtà e riferisce la propria visione. Egli vede la
realtà morale e spirituale dietro a quella sociale e politica: come Fromm
afferma, fintantoché l’uomo intraprende la strada sbagliata nell’azione politica
e sociale, il profeta non può fare a meno di essere un rivoluzionario.
“La storia ha le sue leggi, e Dio non vi interferisce: sono allo stesso
tempo le leggi di Dio. L’uomo, comprendendo le leggi della storia, comprende
Dio. L’azione politica è azione religiosa. Il capo spirituale è un capo
politico.” (48)
(30) “La storia è nostra, e la fanno i popoli.”
(31) E. Fromm, “Disobedience as Psychological and Moral Problem” (1963); trad.
it. “La disobbedienza come problema psicologico e morale”, in “La disobbedienza
e altri saggi”, Mondadori, Milano, 1982.
(32) Come già esposto nel paragrafo dedicato ai vincoli primari, per Fromm il
legame incestuoso alla madre non è come per Freud primariamente sessuale, ma
essenzialmente emotivo.
(33) Ciò è solo apparentemente in contraddizione con la concezione di Fromm della
disobbedienza come precondizione della libertà umana: i richiami all’obbedienza
a Dio di cui qui si parla, infatti, rappresentano l’accettazione di un’autorità
razionale, che rende possibile l’emancipazione dalla schiavitù, mentre il Dio
della Genesi, come Fromm afferma, è ancora un Dio geloso e patriarcale, che sul
modello dell’assolutismo orientale sta a simboleggiare un’autorità irrazionale.
(34) Molto interessante a questo proposito ritengo sia l’opera di Bachofen,
ripresa da Fromm in diversi contesti del suo pensiero. Bachofen teorizza
l’esistenza di una società matriarcale anteriore a quella patriarcale, basata
sui principi di amore e di fratellanza, alla base anche di dottrine come il
socialismo, che secondo Fromm dovrebbero caratterizzare il nuovo e più elevato
livello di armonia che egli pone come meta del processo di individuazione. Nella
società matriarcale teorizzata da Bachofen erano pure più rilevanti i legami
primari, alla terra, alla madre, al clan, alla natura, mentre in quella
patriarcale prevarrebbero la legge ed il pensiero, ed i legami spirituali
sarebbero più importanti dei vincoli di sangue. Purtroppo non posso qui esporre
la teoria di Bachofen che richiederebbe assai più spazio e la cui trattazione
esula dai contenuti di questa tesi, mentre il riassumerla non farebbe giustizia
della profondità dei concetti in essa espressi e degli sviluppi da essa favoriti
nel pensiero di Fromm. Per una esposizione dettagliata vedi E. Fromm “Bachofen e
la scoperta del matriarcato”(1955), “La teoria del diritto matriarcale e in suoi
rapporti con la psicologia sociale”(1934), “La creazione maschile”(1933),
“Significato attuale della teoria del matriarcato”(1970), in “Amore, sessualità,
matriarcato” (Mondadori, Milano, 1997); vedi anche E. Fromm, “Anatomia della
distruttività umana” (Mondadori, Milano, 1978, pagg.203-204) e “Psicoanalisi
della società contemporanea” (Edizioni di Comunità, Milano, 1981, pagg. 50-65).
(35) Noto che qui Fromm sembrerebbe considerare analoghe la genesi della
coscienza autoritaria e di quella umanistica, ma forse ciò è riferito solo
all’espressione metaforica dell’evoluzione storica dell’uomo e non al livello
individuale di formazione della coscienza, il che sarebbe in contraddizione con
le idee dello stesso Fromm circa la differenza genetica tra coscienza
autoritaria e coscienza umanistica che ho esposto nel paragrafo dedicato
all’etica umanistica, mentre sarebbe assai più in linea con la teoria freudiana
sulla genesi del Super-Io.
(36) Vedi il paragrafo “Determinismo e libertà”.
(37) Leo Baeck, “Judaism and Christianity” (1958), citato da Fromm in “You shall
be as Gods. A radical interpretation of Old Testament and its tradition” (1966);
trad. it. “Voi sarete come dei. Un’interpretazione radicale del Vecchio
Testamento e della sua tradizione” (Astrolabio, Roma, 1970, pagg. 83-104).
(38) Nei due concetti di salvezza Fromm ravvisa comunque un elemento comune:
questa non è mai individuale, ma collettiva; che sia intesa come un nuovo
periodo storico o come la fine apocalittica di tutta la storia essa non riguarda
mai il destino di un solo individuo, ma quello di tutta l’umanità.
(39) Fromm osserva come tale atteggiamento sia espresso nell’ambiguità del verbo
spagnolo esperar, che significa sia ‘aspettare’ che ‘sperare’.
(40) E. Fromm, “Prophets and priests” (1963); trad. it. “Profeti e sacerdoti”, in
“La disobbedienza ed altri saggi” (op. cit.).
(41) Anche la risposta che Dio da a Mosè, alla sua richiesta di una definizione
da dare agli ebrei del suo Dio, è interpretata da Fromm come una concezione alla
idolatria del popolo: egli accetta di definirsi, sebbene lo faccia per mezzo di
una negazione, “Il mio nome è Senzanome” (tradotto come “Io sono colui che sono”
nella Bibbia concordata; “Bibbia concordata”, Mondadori, Milano 1968).
(42) E. Fromm, “Voi sarete come dei. Un’interpretazione radicale del Vecchio
Testamento e della sua tradizione”, op. cit., pag.32.
(43) Fromm considera l’idolatria anche alla base del fenomeno clinico del
transfert. Diversamente da Freud, Fromm non considera tale fenomeno come la
semplice ripetizione di un affetto su di una persona, l’analista, diversa da
quella verso la quale tale affetto era stato originariamente manifestato, bensì
come l’espressione di un rapporto irrazionale con l’altro, come la
manifestazione del bisogno di una figura alla quale l’individuo possa affidare
la responsabilità di se stesso; il verificarsi di tale fenomeno scaturisce dal
fallimento della libertà individuale, e costituisce per Fromm uno dei fatti
psicologici più rilevanti, non soltanto in analisi, ma anche nella vita
quotidiana.
(44) E. Fromm, Ibid., pag.35.
(45) E. Fromm, “Escape from Freedom”, op. cit..
(46) E. Fromm, “Von der Kunst des Zuhörens”, a cura di R. Funk (1991), trad. it.
“L’arte di ascoltare”, Mondadori, Milano, 1996.
(47) A questo proposito Fromm cita l’interessante osservazione hasidica secondo
la quale Dio non dice “Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, ma
“Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”, ad evidenziare
che non esistono due persone che abbiano lo stesso Dio, non potendo l’esperienza
di Dio essere scissa dall’esperienza individuale.
(48) E. Fromm, “Voi sarete come dei. Un’interpretazione radicale del Vecchio
Testamento e della sua tradizione”, op. cit., pag. 82.
|
|