
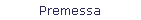
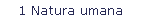
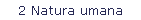
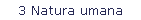
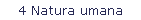
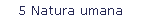
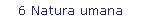
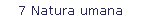
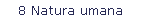
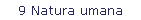
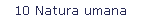
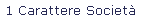
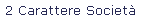
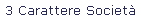
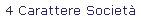
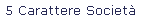
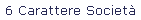
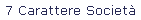
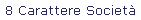
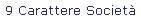



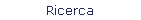
|
|
Psicologia della guerra: violenza, distruttività e narcisismo
sociale
1.
Contrariamente a quanto si possa pensare e a quanto illustri studiosi hanno
pressoché unanimemente sostenuto, sembra che la violenza non possa considerarsi
una caratteristica innata nella specie umana.
Dall'analisi antropologica, psicologica e sociale compiuta da Fromm in
"Anatomia della distruttività umana", risulta infatti come in certi gruppi
sociali 'primitivi', ossia 'non evoluti' nel senso che a questi termini si dà
nella cultura occidentale, la distruttività fosse praticamente assente, e
laddove questa si manifestasse, ciò avveniva come conseguenza di particolari
circostanze ambientali, quali un eccessivo affollamento o la competizione per
l'approvvigionamento di risorse primarie determinata da uno stato di carenza
materiale, con la conseguente lotta per la sopravvivenza.
La guerra potrebbe dunque essere considerata un costrutto prevalentemente
culturale, poiché sono gli schemi culturali ai quali più o meno coscientemente
aderiamo che ci portano, oggi, a ritenere giusto che certi interessi, che spesso
si fanno pretenziosamente assorgere al rango di valori, possano essere
conquistati, difesi e propagati seminando morte e distruzione.
La più consueta giustificazione a ciò è, appunto, la convinzione pressoché
generalizzata che la guerra (ma si potrebbe dire lo stesso del carcere, dello
sfruttamento, delle diseguaglianze sociali, e mille altri eccetera) sia sempre
esistita, e che quindi non sta certo a noi porre fine o anche solo mettere in
discussione un ordine naturale che si propaga da millenni.
A questo proposito si può far riferimento alla distinzione proposta da Fromm
in "Dalla parte dell'uomo. Indagine sulla psicologia della morale" tra
'dicotomie storiche' e 'dicotomie esistenziali': mentre le dicotomie
esistenziali sono insolubili, poiché inerenti lo stesso paradosso dell'esistenza
umana (ad es. vita/morte), le dicotomie storiche sono contingenti e socialmente
condizionate, e per questo risolvibili, se non nell'epoca in cui queste si
manifestano, in un periodo storico ad essa successivo.
Ciò che i pensatori conservatori e autoritari fanno ed hanno fatto, è ed è
stato il far passare per dicotomie esistenziali ogni dicotomia socialmente
condizionata che potesse essere oggetto di discussione e fonte di lotta sociale.
Così si è sostenuto, ad esempio, che lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la
divisione in classi della società, la proprietà dei mezzi di produzione nelle
mani di una ristretta minoranza, eccetera eccetera siano una condizione, seppur
dolorosa, irrinunciabile; così si sostiene che l'istituzione del carcere si
perda nella notte dei tempi, mentre, anche se ciò è misconosciuto, esso è
un'invenzione relativamente recente nella storia dell'umanità essendo stato
introdotto, nelle sue diverse forme, parallelamente all'evoluzione della società
industriale. E, allo stesso modo, così si sostiene che, da quando mondo è mondo,
i membri di ogni popolo si siano sempre massacrati, per un qualche oscuro
impulso naturale, fra di sé e con quelli dei popoli vicini.
Dall'analisi compiuta da Fromm risulta invece ribaltato il preteso rapporto
inverso tra guerra e civilizzazione: i popoli più belligeranti risultano essere
spesso anche i più industrializzati e la guerra, ben lungi dall'essere sempre
esistita, risulta per lo più un prodotto della storia, almeno in riferimento
alle proporzioni ed ai costi umani dei conflitti moderni.
2.
In "Psicoanalisi dell'amore. Necrofilia e biofilia nell'uomo", Fromm distingue
tra differenti forme di violenza, sulla base delle rispettive motivazioni
inconsce ad esse sottese:
Violenza ludica. E' una forma non patologica di violenza, riscontrabile in
quelle attività il cui scopo è dimostrare la propria abilità, come negli sport
da combattimento. Benché dietro la logica esplicita del gioco possano talvolta
nascondersi motivi per lo più inconsci di aggressione e distruttività, questo
tipo di violenza è la più lontana dai propositi di distruzione.
Violenza reattiva. E' un tipo di violenza al servizio della vita, non della
morte. Essa è volta a difendere la vita, la libertà e la dignità umane, e si
esprime nella forma della lotta contro l'aggressore. A questa forma di violenza
si potrebbero ricondurre i vari movimenti di liberazione nazionale, la
resistenza contro il fascismo, e più in generale ogni forma di ribellione
violenta e di lotta non convenzionale contro il potere e l'ingiustizia sociale.
Ciononostante a queste stesse motivazioni possono ricorrere leaders politici
e religiosi, che attraverso l'abile manipolazione delle menti dei loro adepti
possono persuadere individui e popoli di essere minacciati da un nemico, in modo
tale da innescare in essi il meccanismo di questa ostilità reattiva. I risultati
psicologici derivanti dall'accettare come veritiera una presunta minaccia sono
infatti gli stessi di quelli derivanti da una minaccia reale.
Naturalmente questa persuasione non ha effetto allo stesso modo su ogni
individuo, ma la sua efficacia sarà direttamente proporzionale alla dipendenza
emozionale della persona ed alla sua carenza di convinzioni proprie e sentimenti
autentici.
Sembra comunque che in generale non sia difficile convincere la maggioranza
delle persone dell'esistenza di un'imminente pericolo di essere attaccati e
quindi motivarle a difendersi: su questo meccanismo si è basata ad esempio la
propaganda di guerra sia della Germania nazista agli inizi della seconda guerra
mondiale che degli Stati Uniti d'America nei più recenti conflitti di
Afghanistan ed Iraq, ed è impressionante notare le similitudini tra i proclami
di Goebbels e quelli di Powell o di Rumsfeld, praticamente equivalenti e
addirittura intercambiabili, basati entrambi sul motivo dominante della 'difesa
contro l'aggressore straniero'.
Violenza vendicativa. E' quel tipo di violenza che consegue da un'offesa
arrecata e che si manifesta posteriormente ad essa, e che pertanto non ha alcuna
funzione di difesa.
Per Fromm il fine di questo tipo di violenza sarebbe l'irrazionale pretesa di
annullare magicamente, per tramite di essa, l'offesa subita.
L'esigenza della vendetta sembra comunque soccombere di fronte ad uno stile
produttivo di vita: quanto più una persona o un gruppo vivono produttivamente,
tanto meno essi si faranno trasportare da questo spirito di rivalsa, e lo
sviluppo delle proprie capacità sarà sufficiente a far dimenticare l'offesa
subita.
Al contrario, l'individuo nevrotico può essere portato ad imperniare la
propria intera esistenza sul desiderio di vendetta e motivare lo stesso
desiderio di rivalsa a livello collettivo come base della propria autostima e
dell'immagine del proprio gruppo sociale.
Violenza compensativa. E' una forma di violenza assai più patologica delle
precedenti.
In essa consiste quel tipo di violenza che si manifesta come sostituto delle
attività produttive, esercitata da un individuo, o da un gruppo, impotente.
Sarebbe un'esigenza intrinseca della natura umana quella di esercitare una
propria influenza sul mondo: se ciò non può essere fatto per mezzo
dell'esercizio delle proprie capacità creative, l'individuo (o il gruppo) sarà
spinto a farlo tramite la distruzione; se la vita non può essere trascesa
creando, lo si farà quindi distruggendo la vita stessa, poiché il distruggere la
vita è comunque un modo, benché irrazionale, di trascenderla, ed il trascendere
la vita è un bisogno innato di ogni membro della specie umana.
La violenza compensativa è la violenza degli inetti: di coloro che, avendo
la vita negato loro la capacità di esprimere creativamente le proprie facoltà,
si vendicano sulla vita distruggendo la vita stessa.
Nella violenza compensativa sta anche l'essenza del sadismo: in esso non
sarebbe tanto il desiderio di infliggere dolore il punto essenziale, quanto
l'impulso al controllo assoluto su di un essere vivente. La sofferenza inflitta
sarebbe perciò un mezzo, poiché non esiste controllo più totale di quello di
costringere un altro a soffrire senza che egli possa difendersi. L'essenza della
spinta sadica sarebbe dunque quella di ridurre l'animato all'inanimato, poiché
nell'esercizio del sadismo si degrada un essere vivente ad oggetto privandolo di
una delle sue qualità essenziali: la libertà.
Sembra quasi superfluo rilevare come l'atteggiamento sadico tipico della
violenza compensativa sia riscontrabile nei cosiddetti tutori dell'ordine di
ogni regime, totalitario e non. Naturalmente non si vuole qui generalizzare ad
un'intera categoria i difetti di alcuni singoli, ma appare evidente come senza
la spinta sadica delle polizie dei vari stati non sarebbe stato possibile il
verificarsi di numerosi eventi storici più o meno recenti ed il rendersi
operative di alcune disposizioni la cui provenienza dalle alte cariche dello
stato viene sovente addotta dai loro esecutori a motivo di giustificazione.
Per debellare sul nascere l'accusa che si stiano dando sentenze immotivate
sulla base del pregiudizio e della partigianeria, si possono portare numerosi
esempi concreti che vanno dall'irruzione nella scuola Diaz a Genova nel Luglio
2001, alle torture dei manifestanti nella caserma di Bolzaneto sempre a Genova
ed a quelle operate a Napoli nel febbraio del 2000 (dove diversi manifestanti
furono addirittura strappati alle cure dei medici, per essere trasferiti
dall'ospedale alla caserma sede delle torture), a quelle insolitamente rese
pubbliche eseguite per puro diletto e senza la classica scusante degli ordini
dei superiori (almeno così ci dicono) dai soldati americani nel carcere di Abu
Graib, in Iraq.
E senza scomodare, per non essere accusati, oltre che di faziosità, anche di
anacronismo, i lager per ebrei e dissidenti nella Germania nazista, i Gulag
nella Russia "comunista" e, più recentemente, i contras antirivoluzionari che la
CIA addestrava alla tortura in Nicaragua contro il popolo ed i sandinisti, e gli
orrori consumatosi negli stadi cileni durante la dittatura del generale Pinochet,
instaurata successivamente all'assassinio, anch'esso sponsorizzato dalla CIA,
del presidente democraticamente eletto Salvador Allende.
La violenza compensativa, costituente l'essenza del sadismo, è dunque il
risultato necessario di una vita non vissuta, il sostituto patologico della
vita, indice della sua inefficienza e dell'impotenza di chi la compie. La
repressione sociale di questo tipo di violenza può soffocarne l'espressione per
timore della punizione o dell'ostracismo che ne deriva, ma essa torna a
manifestarsi non appena la forza repressiva risulta indebolita o qualora sia
possibile sottrarsi al suo influsso.
La sua repressione si rivela dunque inefficace, sempre ipotizzando che chi
occupa una posizione di potere nella società senta l'esigenza di reprimere
questa forma di violenza, poiché, come si è visto, essa sembra piuttosto
costituire un valido coadiuvante nel mantenimento dell'ordine e dello status quo
del sistema sociale.
Poiché la violenza compensativa è la conseguenza dell'impotenza, la sola
cura capace di debellarla è lo sviluppo produttivo delle proprie facoltà e
l'esercizio creativo del proprio pensiero e del proprio sentimento, base di una
vita non alienata ed autentica.
Sete di sangue. E' una forma arcaica di violenza, nella quale si afferma la
vita, ma al più profondo livello di regressione. Con essa si dà una risposta al
problema dell'esistenza rinnegando la ragione e regredendo ad uno stadio
pre-umano: uccidere diviene così la suprema affermazione di se stessi, e
l'essere uccisi l'unica alternativa.
Questa forma di violenza può essere riscontrata nella pratica dei sacrifici
umani presso alcuni popoli, come gli Atzechi, dove lo spargimento di sangue era
considerato necessario affinché il cosmo continuasse a funzionare e la madre
terra potesse produrre i suoi frutti.
3.
Sempre in riferimento all'opera di Fromm risulta importante il nesso tra guerra
e narcisismo.
Il narcisista risolve il problema del proprio rapporto con il mondo
sostituendo a quest'ultimo se stesso; non avendo sviluppato il proprio io come
centro della sua relazione con gli altri il suo ego crolla quando il suo
narcisismo viene ferito, reagendo con rabbia o cadendo in uno stato di
depressione.
Il narcisista tenta quindi in ogni modo di evitare tali ferite, e nel far
ciò può seguire essenzialmente due strategie: può aumentare il proprio
narcisismo, ponendosi sempre più al di sopra di ogni critica o eventuale
insuccesso, soluzione che equivale ad aggravare la propria malattia mentale fino
agli estremi della psicosi; può altresì tentare, qualora ne abbia la
possibilità, di rendere la realtà conforme alla narcisistica immagine di sé,
cercando di guadagnarsi il consenso di un'altra persona che viene così resa
partecipe della sua malattia (folie à deux), o addirittura, nel caso il
narcisista occupi una posizione di leadership, di migliaia o milioni di persone
(folie a millions).
Quest'ultima situazione è purtroppo tutt'altro che rara, e sono proprio gli
individui profondamente narcisisti a risultare i più "adatti" a ricoprire una
posizione di potere, sia in quanto aspirano essi stessi al potere per le proprie
caratteristiche caratteriali, sia in quanto, essendo privi di dubbi riguardo
alla convinzione della propria grandezza, meglio di ogni altro si prestano ad
assorgere ad immagine proiettata del narcisismo di coloro che non hanno la
possibilità di soddisfarlo a livello individuale.
Mentre infatti leaders politici e capi di ogni tempo hanno ed hanno avuto
innumerevoli occasioni di alimentare la narcisistica immagine di sé, questa
possibilità non è concreta per la persona media, che cerca quindi di esprimere
il proprio narcisismo per mezzo del proprio gruppo.
Caratteristica del gruppo narcisista è il bisogno di un leader in cui i suoi
membri possano identificarsi: nel sottomettersi al leader gli individui
proiettano su di esso il proprio narcisismo e vivono per mezzo di lui,
considerando i suoi successi come i propri successi e godendo di essi come
fossero il risultato del proprio sforzo personale.
E' questo il meccanismo che sta alla base del fenomeno del 'narcisismo
sociale', e gli atteggiamenti narcisistici di cui il leader o il gruppo sono
investiti saranno naturalmente considerati virtù all'interno del gruppo stesso,
poiché è proprio su tali proiezioni che si fonda la sua forza, e da esse dipende
la sua stessa sopravvivenza.
Il sintomo più evidente del narcisismo è la mancanza di oggettività e di
giudizio razionale. A livello collettivo questo si traduce nella comune
convinzione della superiorità del proprio gruppo rispetto a tutti gli altri, nel
disprezzo della diversità e delle minoranze e, quando ciò non basta a soddisfare
l'immagine grandiosa del gruppo, nella brama di conquista e nel desiderio di
assoggettamento dei gruppi alieni.
In questa logica, al narcisismo di gruppo ferito si può rispondere solo
annientando l'offensore per cancellare magicamente l'offesa subita (v. 'violenza
vendicativa' in 2.), annullare la percezione della propria vulnerabilità e
ristabilire l'immagine di grandezza che l'affronto ha messo in discussione.
Quanto descritto ha forse qualcosa ha che vedere con il fatto che, come hanno
dimostrato le recenti ultime elezioni statunitensi, la politica estera di Bush
della cosiddetta 'guerra preventiva' riscuota un largo consenso, al di là degli
interessi lobbystici dell'economia nordamericana, anche tra gli appartenenti ai
ceti inferiori, che sarebbero senz'altro i meno avvantaggiati dalla difesa di
tali interessi?
|
|