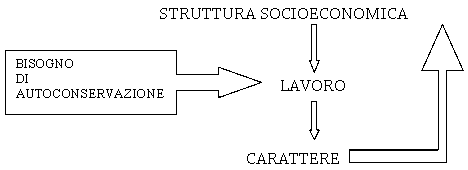Il rapporto dinamico tra società e carattereIl predominio di uno specifico orientamento nella maggior parte degli individui è correlato in buona misura alla società in cui il singolo vive. Lo studio di tale correlazione, oltre ad aiutarci a comprendere le cause della formazione del carattere, ci svela quelle potenti forze emotive, scaturite dal fatto che un dato orientamento sia predominante entro una certa cultura o classe, che influenzano notevolmente il funzionamento della struttura sociale.Secondo Fromm l’intera struttura caratteriale dell’individuo è modellata dalla struttura socioeconomica della società in cui vive. Essa influenza notevolmente il modo in cui le persone entrano in relazione, determinandone per buona parte il modo caratteristico di socializzazione oltre che di assimilazione, e ciò si ripercuote sulla loro personalità.Per soddisfare l’esigenza primaria di autoconservazione, l’uomo deve lavorare e produrre, e per far ciò egli è costretto a relazionarsi ai propri simili ed a collaborare con loro. Ma lo specifico tipo di lavoro che potrà essere efficace per appagare le proprie necessità vitali è determinato dal tipo di sistema socioeconomico della società in cui si trova a vivere. Non potendo scegliere dove e quando nascere, l’individuo dovrà accettare quelle particolari modalità di lavoro dettate dal sistema di produzione caratteristico della società in cui vive; ma modalità diverse del lavoro richiedono una diversa struttura caratteriale, comportando un diverso modo di ottenere ciò di cui si ha bisogno per soddisfare le proprie necessità (assimilazione), e un modo diverso di relazionarsi agli altri (socializzazione).Coloro che meglio potranno adattarsi al modo di vita determinato dal sistema di produzione di una data società saranno dunque coloro i quali possederanno quelle particolari modalità richieste dalla struttura socioeconomica di essa. Al tempo stesso la società provvederà a creare le modalità richieste nella struttura caratteriale della maggior parte dei suoi membri: sia in quanto la possibilità di soddisfazione delle proprie necessità vitali è fonte di soddisfazione psicologica per gli individui, sia in conseguenza dell’adattamento dinamico di questi alle sue esigenze, con la conseguente creazione di nuovi bisogni nella soddisfazione dei quali gli sforzi degli individui vanno a coincidere con quelle attività richieste dalle esigenze sociali.Il carattere, movente principale di sentimenti, pensieri ed azioni degli individui, è dunque definito da Fromm in senso dinamico come la forma specifica in cui l’energia umana viene plasmata nel processo di adattamento degli individui alle condizioni socioeconomiche di una data cultura; esso costituisce dunque per Fromm il prodotto dell’interazione tra tali condizioni e le esigenze umane, tanto innate che acquisite nel corso della storia.L’uomo sviluppa così quei tratti caratteriali che lo spingono ad agire, ed a desiderare di farlo, come egli deve agire, tramutando così le proprie energie in forze utili al consolidamento della società e della sua struttura socioeconomica.La funzione oggettiva del carattere è dunque quella di far sì che gli individui possano interiorizzare le necessità esterne, indirizzando le proprie energie verso mete funzionali al sistema di produzione in cui svolgono la propria attività, producendo, consumando, entrando in relazione secondo specifiche modalità da esso massicciamente influenzate; una volta che tali esigenze siano state interiorizzate, ogni sforzo che l’uomo compia in armonia con esse è fonte al tempo stesso di soddisfazione psicologica, in quanto approvato dalle ideologie dominanti e condiviso dalla maggior parte degli altri individui, e al tempo steso può apportargli vantaggi materiali.Da un punto di vista soggettivo il carattere, adattandosi dinamicamente alla società, permette alla persona di essere disposta ad accettare quelle modalità con le quali può far fronte alle proprie necessità di sopravvivenza, assolvendo così l’imprescindibile funzione di autoconservazione.Fromm, come si è detto in precedenza, considera il carattere sociale come il nucleo della struttura caratteriale comune alla maggior parte dei membri di una data società, generatosi come conseguenza di esperienze comuni al gruppo stesso e del suo modo di vita, ed il carattere individuale di ogni membro del gruppo costituirà una variazione attorno a tale nucleo, sulla cui qualità influiscono le particolari esperienze di vita di ciascun individuo.Finché il carattere sociale continua ad essere in armonia con la struttura socioeconomica, l’uomo sente le proprie azioni come utili ed al tempo stesso come vantaggiose ed adeguate a soddisfare i propri bisogni. Ma talvolta tra società e carattere sociale può aprirsi un divario, per il perdurare di una stessa struttura caratteriale, mutabile ma lenta nell’adattarsi, di fronte a mutate condizioni socioeconomiche e culturali. In tal caso le persone, perseverando nell’attività più conforme alla propria struttura caratteriale, dovranno prima o poi prendere atto di come le loro azioni non risultino più adeguate a soddisfare i propri bisogni; di fronte al conflitto creatosi tra le mutate tendenze economiche ed il nucleo della struttura caratteriale oramai consolidatasi nella maggior parte degli individui di una determinata società e classe sociale, tra cultura e carattere sociale, si renderà necessario un nuovo mutamento nella struttura caratteriale dominante.L’uomo reagisce dunque a situazioni esterne in mutamento mutando egli stesso, e così facendo contribuisce a plasmare il processo socioeconomico della sua cultura di appartenenza; in tale processo, come marcatamente precisa Fromm, le forze socioeconomiche non si identificano con le motivazioni psicologiche, e quindi non costituiscono il movente ultimo dell’agire umano, essendo piuttosto quelle condizioni obiettive cui l’uomo si trova a far fronte attraverso le proprie forze psicologiche, a loro volta socialmente condizionate.Pur godendo di una certa autonomia, forze psicologiche e socioeconomiche risultano dunque intimamente correlate, ed a tale correlazione partecipano pure le ideologie, ammortizzatori sociali che, nella misura in cui si radicano nella struttura caratteriale di una certa società o gruppo sociale, contribuiscono anch’esse a influenzare il suo comportamento, e per suo tramite la struttura socioeconomica della società.Il carattere sociale deriva dunque dall’adattamento dinamico della natura umana alla struttura sociale ed economica; al mutare di tale struttura le azioni dettate dal carattere precedentemente affermatosi come dominante risulteranno inadeguate alla soddisfazione delle necessità degli individui (e della società), e si manifesteranno nuove ansietà e nuovi bisogni, che condurranno ad un mutamento del carattere sociale.Da tale mutamento sorgeranno nuove ideologie, che a loro volta contribuiranno ad indirizzare il processo sociale ed a consolidare il carattere sociale incipiente.Le condizioni sociali agiscono dunque sul carattere, e tramite la loro influenza conducono alla formazione di nuove idee, che a loro volta plasmano il processo sociale; il carattere, tuttavia, non si lascia modellare indiscriminatamente dalle esigenze della società, ma vi si adatta sviluppando un proprio dinamismo, sulla base di quegli elementi biologicamente intrinseci nella natura umana o divenuti parte di essa nel corso della storia dell’umanità.Il bisogno di autoconservazione può essere soddisfatto grazie al lavoro, le cui modalità sono determinate dalla struttura socioeconomica della società. Nel lavoro si manifestano specifiche modalità di assimilazione correlate a specifiche modalità di socializzazione, la cui combinazione costituisce la struttura caratteriale. I modi di assimilazione e socializzazione specifici del nucleo della struttura caratteriale dominante in una data società influenzano a loro volta il processo sociale ed economico.fig. 2
|