

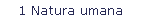
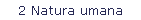
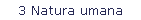
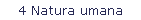
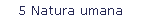
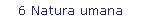
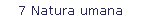
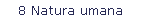
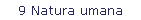
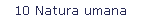
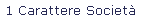
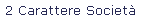
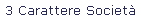
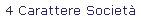
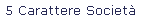
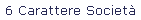
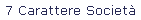
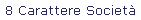
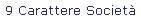

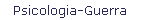

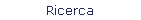
|
|
Questa tesi parte da una lettura dell’opera di Fromm che intende dare maggior
rilevanza a quegli aspetti che sono riconducibili a quello che ritengo essere
uno dei motivi principali del suo pensiero: il lungo percorso dell’esistenza
umana, dalle origini arcaiche verso una nuova armonia con il mondo, attraverso
la progressiva emancipazione da quei vincoli che, pur dando all’uomo la
sicurezza di cui ha bisogno, limitano al tempo stesso la sua libertà.
|
 |
Questo percorso, quello che Fromm definisce ‘processo di individuazione’, è
tutt’altro che determinato: l’uomo si crea nel corso della storia, ma non
bisogna dimenticare che, come afferma Fromm, la storia è creata dall’uomo. E’
solo attraverso il proprio sforzo attivo, e a patto che l’uomo non rinneghi la
propria consapevolezza che egli può progredire in tale processo. Ma d’altra
parte progredire è l’unica scelta ragionevole che l’uomo abbia a disposizione.
L’alternativa è lasciarsi travolgere da quelle passioni irrazionali che, pur non
essendo innate nella sua natura, si sviluppano come perversione delle
potenzialità umane frustrate.
Ciò porta a considerare il problema della natura umana. E’ l’uomo essenzialmente
buono, e le sue manifestazioni maligne sono da ascriversi alla negativa
influenza sociale che perverte le sue più nobili passioni, o è piuttosto l’uomo,
come si è a lungo sostenuto e come anche Freud riteneva, un essere
fondamentalmente malvagio e antisociale?
Volendo trovare risposta a questo dilemma non si può prescindere da un altro
aspetto essenziale dell’opera di Fromm: quello della libertà umana. Infatti,
qualunque sia la risposta che si vuol dare a tale quesito essa comporta
l’abbandono di una concezione strettamente deterministica, poiché se si nega
all’uomo la libertà di scelta, impossibile e insensato risulterà ogni giudizio
etico delle sue azioni. Vedremo come nell’opera di Fromm, che pur non trascura i
risvolti etici, tale posizione non costituisca una semplice esigenza teorica, ma
appaia invece ben giustificata. Altrettanto nettamente egli rifiuta la posizione
indeterministica: non potendosi considerare la libertà come libertà in astratto,
poiché essa si concretizza comunque nella facoltà di operare una scelta in una
situazione definita, l’uomo consapevole si renderà conto di come le sue
possibilità di azione non siano illimitate.
Le scelte fondamentali sono dunque riconducibili a quella tra il percorrere la
via progressiva e quella regressiva, ed un valido indicatore del livello
raggiunto dall’individuo nell’una o nell’altra direzione è il suo carattere.
Puntualizzando un aspetto rimasto poco chiaro nella caratterologia di Kretchmer
e di Sheldon, Fromm definisce la personalità come composta da carattere e
temperamento, distinzione assai feconda per ogni successivo studio
psicoanalitico su questo tema.
Fromm introduce anche il concetto di ‘carattere sociale’, con il quale egli
intende “il nucleo della struttura caratteriale condiviso dalla maggior parte
delle persone di una medesima cultura”(1), distinto dal ‘carattere individuale’,
nel quale persone appartenenti ad una stessa cultura differiscono l’una
dall’altra.
Dalla sua esposizione di questi concetti, risulta chiaro il ruolo che nel
pensiero di Fromm, ampiamente influenzato da alcune tesi marxiste, la società
assolve: nell’influenzare attraverso il suo spirito ed i modi di produzione ad
essa sottesi il carattere degli individui, essa può essere di ostacolo
all’individuazione ed alla libertà umane, ma può anche costituire una spinta in
tale direzione.
Affrontando questi problemi antropologici, psicologici, sociali, Fromm non perde
mai di vista i risvolti etici di ogni questione da lui affrontata. Egli fa
riferimento ad un etica umanistica, un’etica ‘biofila’ della quale vede gli
illustri precursori in Aristotele, Spinoza e Dewey, nella quale la base di ogni
principio, norma e giudizio di valore sia l’uomo.
Carattere, società, sistemi di pensiero, nella misura in cui ostacolano o
favoriscono la crescita dell’individuo e lo sviluppo delle sue potenzialità,
sono dunque oggetto di giudizio etico.
Considerando i miti come espressione simbolica di esperienze del passato, Fromm
rinviene nell’antico testamento e nella letteratura ebraica successiva la
rappresentazione metaforica del processo di individuazione, del cammino
dell’uomo dalle sue origini arcaiche verso una crescente consapevolezza, in un
percorso che potrebbe anche definirsi ‘dalla idolatria alla libertà’.
(1) E. Fromm, “The Sane Society”, Rinehart and Company, New York, 1955 (trad. it.
“Psicoanalisi della società contemporanea”, Edizioni di comunità, Milano, 1983,
17a ed., pag.82)
|
|
