
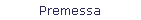
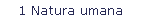
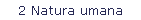
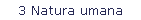
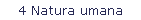
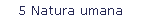
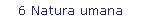
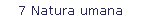
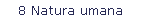
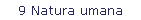
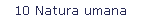
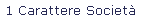
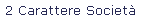
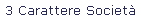

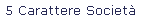
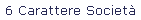
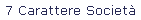
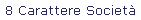
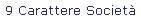

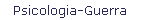

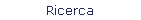
|
|
Carattere
Orientamento produttivo
L’orientamento produttivo del carattere, di cui Fromm lamenta
l’insufficiente attenzione da parte della psicoanalisi, può essere considerato
analogo al ‘carattere genitale’ descritto da Freud. Esso è il carattere della
persona normale, sana e matura; Freud pone come precondizione al raggiungimento
di tale struttura caratteriale l’emancipazione dalle fissazioni orali ed anali
della libido per giungere al conseguimento di una sessualità che funzioni sotto
il primato del sesso genitale, il cui scopo è l’unione con membri del sesso
opposto.
Mentre la descrizione fornita da Freud si limita appunto a considerare il
carattere genitale come risultato della normale evoluzione ontogenetica della
sessualità, grazie alla quale l’individuo diviene capace di funzionare
sessualmente e socialmente, Fromm parla del carattere produttivo in un’accezione
più ampia, intendendo con esso il carattere dell’individuo che abbia sviluppato
pienamente se stesso; tale carattere costituisce per Fromm lo scopo
dell’evoluzione umana e al tempo stesso l’ideale cui tende l’etica umanistica.
(20)
Oltre alla produttività sessuale, comune anche agli animali, un
atteggiamento produttivo nell’uomo coinvolge ogni aspetto della sua personalità,
fino a caratterizzare la sua specifica modalità di relazione in ogni campo
dell’esperienza umana. Fromm intende la produttività come la capacità dell’uomo
di realizzare le proprie potenzialità, di far uso di ‘poteri’ rispetto ai quali
l’uomo non sia alienato, ma che siano al contrario da lui percepiti come un
tutt’uno con se stesso, come parte di sé.
Tuttavia, avverte Fromm, è bene non confondere la produttività con
l’attività in senso lato: esistono infatti svariati tipi di attività non
produttiva motivati da passioni irrazionali dell’uomo e simili solo
superficialmente alla vera produttività. Tra queste vi è l’attività determinata
da una reazione all’ansia, spesso alla base degli affanni dell’uomo moderno;
l’attività svolta in virtù della propria sottomissione ad una autorità,
esplicita od anonima che sia; lo sforzo compiuto unicamente in funzione del
proprio successo, a prescindere dal benessere personale e dalla felicità che
tale sforzo possa apportare a chi lo compie. Quando, come in questi casi, sono
le passioni irrazionali dell’uomo a costituire la vera ragione delle sue azioni,
la sua attività non sarà né libera né razionale, ma sarà necessariamente
idiosincratica con lo sviluppo delle sue più nobili facoltà.
Al contrario, l’attività produttiva prescinde completamente dal successo;
essa si radica nel carattere stesso dell’uomo, nel suo approccio nei confronti
di se stesso e del mondo, e non necessariamente è svolta in funzione del
conseguimento di un risultato pratico.
Definendo la produttività come l’uso dei propri poteri da parte dell’uomo,
ossia come l’esercizio della sua ‘potenza’, costituendone invece l’impotenza il
loro mancato uso, Fromm sottolinea la differenza tra ‘potere su’ e ‘potere di’.
Secondo Fromm il ‘potere su’ costituisce una perversione del ‘potere di’: nella
misura in cui l’uomo è impotente, ossia incapace di esercitare il proprio
‘potere di’, egli sviluppa il desiderio di dominio e di controllo sugli altri,
pretendendo così di avere ‘potere su’, che a sua volta contribuisce a
paralizzare la sua capacità produttiva.
La produttività è posta da Fromm in antinomia anche con due opposti
atteggiamenti dell’uomo: l’insania, caratterizzata dalla perdita della capacità
di percepire la realtà nella sua concretezza, tipica dello psicotico, e ciò che
viene comunemente definito come ‘realismo’, ossia il percepire le cose ‘quali
esse sono’, astraendo completamente dalla propria soggettività.
Mentre la persona che abbia perso ogni contatto con il mondo esterno
sostituendo a questo il suo mondo soggettivo è comunemente considerata malata (21),
il cosiddetto ‘realismo’, non comportando la perdita della capacità della
persona di funzionare socialmente e sessualmente, non è considerato alla stregua
di una malattia mentale. Ma sebbene ciò non lo squalifichi sul piano sociale, il
realista ha perduto la capacità specificatamente umana di penetrare oltre la
superficie delle cose cogliendone la profondità: egli può solo percepire la
realtà per manipolarla in funzione dei propri fini, esercitando quindi la sua
intelligenza, non la ragione, e ciò lo impoverisce come essere umano.
Secondo Fromm il ‘realismo’ non è dunque l’opposto dell’insania, ma il suo
complemento: questi due atteggiamenti apparentemente contrapposti non sono altro
che due diverse forme che può assumere l’attitudine verso se stesso ed il mondo
di un individuo che abbia paralizzato la propria produttività.
La persona produttiva è in grado di relazionarsi al mondo cogliendone tanto
l’aspetto oggettivo che percependolo in funzione della propria soggettività; non
si relaziona al mondo semplicemente per manipolarlo, né si rifugia completamente
nella propria dimensione interiore, perdendo con esso ogni contatto.
Queste due capacità costituiscono poli opposti dalla cui interazione
dinamica sorge la produttività, che non ne è semplicemente la somma, ma un
qualcosa di diverso che scaturisce dalla loro unione.
La produttività dell’uomo può generare nuovi sistemi di pensiero, creare
opere d’arte o costruire cose materiali, ma risulta ben chiaro nell’opera di
Fromm che l’oggetto più importante della produttività umana è l’uomo stesso.
Tramite l’attività produttiva l’uomo dà vita alle proprie potenzialità
razionali ed emotive, e nel fare ciò egli rinasce incessantemente. Dramma della
sua condizione è che nella limitatezza temporale della sua esistenza possano
dispiegarsi soltanto una parte di queste facoltà.
Dice Fromm, che l’uomo muore quando non è più in grado di continuare a
nascere; e la tragedia sta proprio nel fatto che i più muoiano prima di essere
completamente nati.
Nell’orientamento produttivo le qualità umane si sviluppano nel processo
stesso di essere in relazione con il mondo; la produttività costituisce per
Fromm la risposta al paradosso umano di ricercare simultaneamente l’unione con i
propri simili ed al tempo stesso sentire l’esigenza di preservare la propria
integrità.
Attraverso l’amore e la ragione l’uomo è capace di comprendere il mondo
mentalmente ed emotivamente. Amore e ragione, espressione rispettivamente delle
capacità umane dell’emozione e del pensiero, consentono all’uomo di comprendere
gli altri, di penetrare oltre la superficie degli oggetti e dei fenomeni e di
porsi in relazione attiva con il mondo.
L’amore genuino, ciò che Fromm chiama ‘amore produttivo’, si radica nella
conoscenza dell’oggetto amato, nel suo rispetto, nella responsabilità della sua
presenza e nella sollecitudine verso di esso.
L’amore privo di responsabilità e sollecitudine rimane una passione dalla
quale si è sopraffatti, mentre la mancanza di rispetto e di curiosità per il suo
oggetto fa sì che degeneri in dominio e possessività. Il rispetto comporta la
capacità di vedere la persona ‘quale essa è’, ed implica la sua conoscenza in
quanto persona unica ed irripetibile. Sollecitudine e responsabilità implicano
la preoccupazione per la vita della persona amata e per la sua crescita e lo
sviluppo delle sue qualità umane.
Analogamente, il ‘pensiero produttivo’ non è mai distaccato ed indifferente
rispetto al suo oggetto, ma comporta un profondo interesse verso di esso.
Mentre l’intelligenza è lo strumento di cui si è dotati per manipolare il
mondo e piegarlo alle proprie finalità pratiche, la ragione coinvolge la
dimensione della profondità di oggetti e fenomeni, e permette di penetrare
nell’essenza di essi, scoprirne le relazioni nascoste e il loro reale
significato.
Ma l’essenza delle cose non è da considerarsi un qualcosa che stia al di là
di esse, ma ne costituisce invece l’essenziale, i loro tratti più pervasivi e
generali, prescindendo dagli aspetti superficiali e accidentali, logicamente
irrilevanti.
Nel pensiero produttivo, più intima è la relazione con l’oggetto, più il
pensiero ne risulta fruttuoso, essendo questo stimolato proprio dalla profondità
di tale relazione. L’oggetto del pensiero produttivo è tale proprio in quanto
sentito da parte dell’osservatore come rilevante per la propria vita individuale
o per la stessa esistenza umana.
Ciononostante caratteristica peculiare del pensiero produttivo è
l’obiettività, della quale Fromm ha una concezione particolare dal momento che,
a suo avviso, la contraddizione tra questa e la soggettività è solo apparente: è
infatti proprio rispettando l’oggetto, ossia vedendolo nella sua vera essenza e
non come si vorrebbe che esso fosse o come ci è stato detto che debba essere,
che è possibile coglierlo nella sua singolarità e scoprirne l’interconnessione
con altri oggetti.
Altro aspetto basilare del pensiero produttivo è quello di cogliere la
totalità di un fenomeno: isolando un aspetto specifico di un oggetto sarà
impossibile infatti far luce non soltanto su di esso nella sua interezza, ma
anche su quel singolo elemento che si è inteso studiare.
Tale atteggiamento nei confronti dell’oggetto è da estendersi anche nei
confronti di se stessi: è infatti indispensabile essere consapevoli di se stessi
e della condizione in cui ci si trova nel relazionarsi all’oggetto osservato.
Parlando del pensiero produttivo Fromm coglie l’occasione per criticare una
falsa idea di obiettività scientifica, alla cui base starebbero il distacco e il
disinteresse per i fenomeni studiati. Ogni pensiero, secondo Fromm, se privo di
interesse per i suoi oggetti, diviene sterile e quindi inutile: l’obiettività,
anche in campo scientifico, non deve dunque intendersi come distacco, ma come
rispetto per gli oggetti di cui va colta l’essenza senza farsi condizionare da
pregiudizi su di essi, come capacità di non distorcere i fenomeni osservati.
Ogni esperimento scientifico condotto sulla base di un simile concetto di
scientificità, in realtà, secondo Fromm, non dimostra assolutamente niente, o
comunque si dimostrano eventi dei quali non si capisce la ragione del perché
debbano essere dimostrati.
Il pensiero produttivo, caratterizzato dall’interesse e dalla sollecitudine
per i suoi oggetti, e al tempo stesso dal rispetto verso di essi, è dunque tutt’altro
che incompatibile con il perseguimento della verità.
Benché Fromm descriva i diversi orientamenti come entità separate, egli
precisa che la struttura caratteriale di un individuo non è mai costituita
esclusivamente da uno di questi, ma è piuttosto il risultato di una mescolanza
tra orientamenti diversi.
Alcuni di essi, come quello ricettivo ed appropriativo, si mescolano più
frequentemente, ma è possibile che il carattere di un individuo risulti composto
anche da elementi caratteriali di orientamenti tra loro meno affini o
caratterizzati da un diverso tipo di socializzazione. Ad ogni modo in ogni
individuo uno di questi orientamenti risulta predominante.
Oltre alla mescolanza di orientamenti non produttivi tra di loro incide
sulla struttura caratteriale pure l’orientamento produttivo, in una certa misura
sempre presente, ed il cui maggior o minor peso determina la qualità
dell’orientamento predominante. Qualora esso prevalga, i diversi tratti degli
orientamenti non produttivi presenti non assumono necessariamente il significato
negativo precedentemente esposto, ma manifestano invece proprietà costruttive.
Gli orientamenti non produttivi possono infatti considerarsi come una
perversione di elementi caratteriali che normalmente fanno parte della natura
umana. Soltanto qualora l’assimilazione di ciò di cui si ha bisogno e la
modalità tipica di relazione siano essenzialmente non produttive, l’accettare,
il prendere, il conservare e lo scambiare, si manifesteranno rispettivamente
come sottomissione, dominio, recessione o distruttività e superficialità.
Ciascun elemento negativo di ogni orientamento non produttivo ha un suo
corrispondente positivo, che si manifesta in funzione del grado di produttività
presente nella struttura caratteriale totale. L’insieme degli elementi positivi
o negativi di ciascun orientamento non costituiscono sindromi separate; gli
elementi corrispondenti sono piuttosto da considerarsi come punti opposti di un
continuum: l’atteggiamento fiducioso del ricettivo può assumere i tratti
dell’ingenua credulità; la fiducia in se stesso dell’appropriativo può volgersi
in arroganza; la metodicità del tesaurizzante può divenire ossessiva; la
tolleranza del mercantile può sfociare nell’indifferenza.
Considerando dunque la differenza qualitativa di tali orientamenti in
funzione del grado di produttività presente, ed il fatto che i vari orientamenti
non produttivi possono avere un peso diverso nella struttura caratteriale totale
della persona ed operare con energia diversa in diverse sfere di attività
(materiale, intellettuale, emotiva), appare dunque chiaro come, combinandosi con
i diversi temperamenti e doti innate degli individui, gli elementi di tali
orientamenti possano determinare innumerevoli variazioni nella personalità: ogni
persona, pur essendo partecipe della stessa natura umana e quindi soggetta agli
stessi processi che coinvolgono i suoi simili, costituisce dunque un fenomeno
unico ed irripetibile.
(20) Vedi il paragrafo “L’etica
umanistica”.
(21) Questa idea è espressa anche da Laing, ad esempio in
“The Divided Self ”, Tavistock Publications Limited, London (1959), trad. it.
L’Io diviso”, Einaudi, Torino (1977, 8a ed.).
|
|