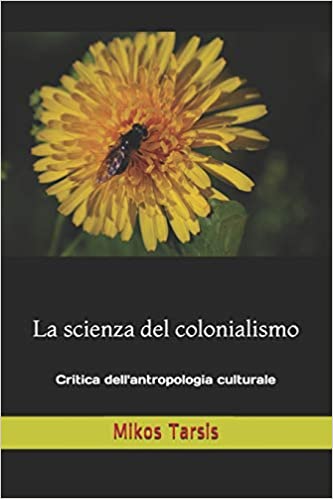
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Introduzione
1 - 2
- 3
- 4 - 5
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 15 -
16 - 17
- 18
- 19
- 20
- 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Questo libro non ha alcuna pretesa. È la prima volta che ci interessiamo di etnologia o di antropologia socioculturale. L'ultimissimo Marx ci scrisse qualcosa sopra, riuscendo a intuire che il socialismo democratico avrebbe dovuto avere molte affinità col comunismo primitivo, soprattutto nel concetto di “valore d'uso”, di autoproduzione. Ma la malattia non gli diede il tempo di approfondire la cosa. Poi Engels, come al solito, svolse questa felice intuizione secondo modalità più vicine all'evoluzionismo positivistico, fatta salva l'abolizione della proprietà privata.
Noi siamo arrivati a studiare queste scienze partendo dal presupposto che qualunque esperienza di “socialismo statale” è, prima o poi, destinata a fallire, e non è possibile evitare tale fallimento dando al socialismo una veste “mercantile”, come sta facendo l'attuale Cina. Per noi quindi la vera, ultima alternativa non è tanto tra capitalismo e socialismo (questa la diamo per scontata), quanto quella tra socialismo statale (in cui le direttive partono dall'alto) e socialismo autogestito (in cui le comunità locali svolgano dei poteri totalizzanti). Lo studio delle comunità primitive deve servire per capire fino a che punto si può fare a meno e dello Stato e del Mercato, cioè delle due massime entità che impediscono qualunque forma di autonomia sul piano sociale e, servendosi della Tecno-scienza, qualunque forma di rispetto delle esigenze riproduttive della natura, la quale è ben di più di una semplice fonte di risorse. È giusto che l'uomo “antropizzi” la natura, ma non fino al punto da impedirle di rigenerarsi. La natura è un ente che ha bisogno di riprodursi agevolmente per fornire risorse rinnovabili. L'uomo dovrebbe limitarsi a utilizzare tali risorse. L'unica fonte non rinnovabile usata dall'uomo primitivo era la pietra, che si trovava sulla superficie del pianeta, a vista d'occhio.
In tal senso un'attività lavorativa vale l'altra: l'importante è che chi controlla le risorse produttive (la loro gestione, ripartizione, consumo, stoccaggio, riciclo) sia la stessa persona che le produce o che le ricava da un determinato territorio. Non può esistere un personale specializzato che si limita a controllare e non produce nulla. Se produttore e consumatore coincidono, sarà il collettivo a decidere come comportarsi nei confronti della natura. La responsabilità deve poter essere attribuita all'intera comunità locale, preposta a utilizzare delle risorse esclusivamente locali. Al giorno d'oggi sarebbe impossibile limitarsi alla semplice raccolta di frutti spontanei e alla caccia degli animali selvatici. L'enorme popolazione mondiale, che cresce di circa 75 milioni di persone ogni anno, non lo consentirebbe: in presenza dell'attuale devastazione ambientale, ci ammazzeremmo a vicenda.
Il criterio generale per “uscire dalla civiltà” è quello di praticare qualunque attività umana che permetta alla natura di riprodursi senza troppa fatica. Ciò che dobbiamo evitare è la desertificazione. (1) Per realizzare questo obiettivo la prima cosa da fare è quella di uscire progressivamente dalla dipendenza dai mercati e dagli ambienti alienanti delle città, cioè è quella di iniziare a praticare l'autoconsumo, espropriando la terra agli agricoltori che vogliono usarla in forma privata e mercantile.
Su queste cose, a dir il vero, abbiamo già scritto altri testi, uno storico-didattico (Homo primitivus. Le ultime tracce di socialismo) e l'altro filosofico-politico su Rousseau e l'arcantropia, entrambi pubblicati in Amazon, ma non ci siamo mai accinti a criticare le analisi degli etnoantropologi. Tuttavia, siccome questa vuole essere soltanto un'introduzione all'argomento, qui ci limiteremo a considerazioni di carattere generale, aventi più che altro un valore metodologico. L'antropologia culturale viene vista nel suo insieme, soprattutto nel modo come viene presentata nelle scuole superiori dello Stato italiano. (2)
*
Fatte salve alcune cose approssimative su Freud e Lévy-Bruhl. in questo libro non abbiamo dedicato un capitolo specifico all'antropologia religiosa, sia perché non riteniamo debba esistere una disciplina del genere che pretenda dirsi “scientifica” (una qualunque antropologia dev'essere “laica”), sia perché riteniamo che la religione, in sé, sia un fenomeno oscurantistico, almeno per come essa è stata vissuta a partire dalla nascita delle civiltà schiavistiche.
È bene però fare delle precisazioni. Anche ammessa l'utilità di un'antropologia laica “sulla” (non “della”) religione, non riteniamo che la religione sia soltanto – come dicono tanti antropologi – una fede (e ovviamente un rituale) rivolta a esseri o poteri o forze sovrannaturali, posti al di fuori del mondo, in una dimensione straordinaria, in grado di influenzare gli eventi umani. Per noi la religione è una forma di misticismo e quindi di mistificazione che va ben oltre una definizione così semplicistica. Esistono atteggiamenti “mistici” ogniqualvolta si ritiene che le cose debbano funzionare in maniera per così dire “magica” (o “automatica”), a prescindere dalla volontà umana. Quando il serpente dell'Eden disse alla donna che l'albero della conoscenza li avrebbe resi “come Dio”, il fatto stesso di credere possibile che un'esperienza del genere potesse dipendere dal frutto di un albero (seppur qui inteso simbolicamente), stava appunto a indicare che si era in presenza di un atteggiamento “mistico” (indotto dall'esterno in maniera mistificante). Col passare del tempo quell'albero si è poi trasformato in tante cose.
Credere che la soluzione dei problemi possa dipendere “magicamente” da un'entità esterna, più o meno “divinizzata”, sia essa un duce, il denaro, la scienza, la tecnica, il mercato, un'ideologia, uno Stato politico, dei mezzi militari, delle sostanze psicotrope o il sesso, o una qualunque altra cosa che possa procurare “dipendenza”, significa nutrire degli atteggiamenti “mistici”, equivalenti a quelli di chi crede che esista un dio onnipotente e onnisciente in grado di leggere il pensiero degli esseri umani o di decidere in qualche maniera il destino dell'umanità.
Edward B. Tylor, fondatore dell'antropologia della religione, disse che l'animismo rappresentava un universale in tutte le religioni. Questo può certamente esser vero, ma una cosa è credere, mentre si vive in maniera “naturale”, che la natura sia un “essere vivente”; tutt'un'altra è credere, mentre si vive un'esistenza artificiosa, che la “scienza”, con cui si pretende di “dominare” la natura, sia onnipotente. Sono due forme di “animismo” che comportano conseguenze molto diverse. Anzi, se la moderna scienza avesse davvero considerato la natura un “essere vivente” e non un semplice oggetto da sfruttare, avrebbe avuto un atteggiamento “religioso” del tutto condivisibile da una concezione “laica” dell'esistenza. Noi infatti non dovremmo vergognarci di considerare la natura come facevano i primitivi, poiché l'animismo è il migliore atteggiamento possibile nei confronti della natura, l'unico che possa rispettarla integralmente. Cosa che Tylor non avrebbe potuto ammettere, in quanto riteneva, ingenuamente, che un giorno la scienza avrebbe sostituito la religione: come se un certo atteggiamento “scientifico” non potesse essere paragonato a uno “religioso”!
Se tutte le cose hanno un'anima – come voleva l'antico panpsichismo –, tutte vanno rispettate, a prescindere da come quest'anima venga intesa. E di ogni cosa “vivente”, per poterla davvero rispettare, occorre sapere ciò che le permette di esistere e di riprodursi in maniera relativamente tranquilla, e cosa invece la ostacola in maniera significativa. L'essere umano è un ente di natura che, a differenza degli animali, ha consapevolezza delle cose, cioè non le vive solo in maniera istintiva. Il fatto che, in tale consapevolezza, si possa essere convinti che la natura abbia un'anima o uno spirito o un'essenza vitale, non dovrebbe essere considerato antitetico a una visione “laica” della vita. Anzi, se per questo, noi riteniamo che anche il culto per i propri defunti sia una forma di religione accettabile, all'ovvia condizione che non ci si aspetti da ciò che non esiste su questo pianeta un intervento in grado di risolvere dei problemi per i quali solo la nostra volontà può fare qualcosa.
Nell'universo nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Questa è una definizione scientifica sommamente laica. Ad essa però si dovrebbe aggiungere che una qualunque cosa trasformata conserva le proprie intrinseche qualità solo in rapporto a delle precise condizioni (soprattutto di spazio e di tempo), al di fuori delle quali essa non può far nulla. La libertà è tale solo all'interno di determinati limiti, oltre i quali diventa una pura astrazione.
*
A scanso di ogni equivoco vogliamo qui precisare subito una questione terminologica. Siccome i confini tra antropologia, etnologia, etnografia sono piuttosto labili, il lettore ci scuserà se questi termini tendiamo a considerarli sinonimi. In genere si afferma che mentre l'etnografo è colui che compie una ricerca, della durata di circa un anno, nel territorio di qualche comunità primitiva, di cui offre un resoconto scritto, l'etnologo invece è colui che studia a livello comparativo il materiale raccolto dagli etnografi, per fare delle generalizzazioni utili a capire il mondo primitivo. Dal canto suo l'antropologo culturale non fa che inserire i dati etnografici ed etnologici in una più vasta ricerca sull'uomo, primitivo e non, avvalendosi di molteplici ambiti disciplinari (linguistica, psicologia, sociologia, filosofia...).
A noi interessa fare un discorso “politologico” di carattere generale, verificando fino a che punto l'antropologia può essere utilizzata per compiere una transizione dal capitalismo a un socialismo davvero democratico, superiore a quelli fino ad oggi “realizzati”. Sotto questo aspetto, non ci interessano, al momento, le ricerche sul folklore, sulle sopravvivenze ancestrali di comunità che nella loro interezza originaria probabilmente non esistono più. Noi tendiamo a escludere che la cultura primitiva possa essere vista in maniera “folklorica”.
Anzi, se vogliamo dirla proprio tutta, ci mette a disagio il fatto di parlare della natura con gli strumenti della cultura, il primo dei quali è la scrittura. Per noi questa è una posizione sbagliata in via preliminare. La civiltà non s'accorgerà mai che la natura ha ragione se non smettiamo d'essere civilizzati. Tuttavia, per smettere di esserlo non c'è, al momento, che una soluzione: abbattere politicamente la civiltà, al fine di porre le condizioni perché si possano creare delle alternative anche in settori non politici. Se ci limitiamo a criticarne i difetti, non riusciremo mai a superarla. Se ci limitiamo a uscire dalle città per andare a vivere in campagna, saremo soltanto degli illusi. All'intero della civiltà non è possibile realizzare alcuna utopia, alcuna esistenza ecologica.
La civiltà va politicamente rovesciata, e questo è possibile solo organizzando partiti e movimenti disciplinati, in cui la minoranza rispetta il volere della maggioranza, e insieme ci si prepara alla conquista del potere. Non ci può essere alcuna anticipazione ideale di un'esistenza extra-civilizzata se prima non si abbatte la civiltà. La natura non ha bisogno che si parli “bene” di lei; ha bisogno che l'uomo civilizzato parli male di se stesso e faccia di tutto per autonegarsi, per autosuperarsi in tutto ciò che gli permette di non essere né umano né naturale. Gli anarchici dicono parole sagge sull'importanza della natura, ma non sanno costruire alcuna vera opposizione alla civiltà: vogliono tutto e subito, per non ottenere nulla. Anche Nietzsche parlava di “fedeltà alla terra”, ma in una maniera così individualistica da uscirne pazzo. Certo, diecimila anni, a partire dal Neolitico, possono sembrare un'inezia rispetto ai milioni di anni in cui l'uomo ha vissuto come raccoglitore e cacciatore. Eppure quel che è stato fatto negli ultimi due secoli è qualcosa di assolutamente sconvolgente, da cui non è possibile prescindere in alcun modo.
*
Da ultimo una nota personale. Per molto tempo ho pensato che l'alto Medioevo potesse costituire, privato ovviamente del servaggio e del clericalismo, una valida alternativa al capitalismo nato intorno al Mille e protrattosi fino ad oggi. Con questo libro ho rinunciato anche a questa idea, a motivo del fatto che l'agricoltura può costituire un rischio troppo grande per l'incolumità dell'ambiente naturale. Senza poi considerare che dalla proprietà collettiva della terra agricola, che produce eccedenze alimentari in quantità significative, si passa sempre, prima o poi, a quella individuale e quindi ai conflitti di classe. Certo, ci può essere un controllo statale, ma se è troppo stringente, non c'è sviluppo economico. La gente potrebbe accontentarsi di vivere modestamente, alle dipendenze di uno Stato centralista proprietario della terra, ma quando vede che in altre parti del pianeta la gestione individualistica della terra porta grandi benefici, si lascia condizionare, soprattutto se a quella gestione si affiancano attività produttive ancora più remunerative, come quella commerciale, industriale e finanziaria. Le comodità – si sa – uccidono la democrazia.
Al massimo, dunque, possiamo accettare l'orticoltura, ma come attività ausiliaria a caccia, pesca e raccolta, e senza rinunciare al nomadismo. Tuttavia anche questa idea ha una precisa condizione per realizzarsi: riforestare l'intero pianeta. Quando avremo il pianeta interamente ricoperto di boschi e foreste, possiamo anche rinunciare alla caccia, in quanto ci basterà la raccolta dei frutti spontanei (questo perché anche la caccia è una forma di violenza alla natura). Anzi, non avremo neppure bisogno del nomadismo: avendo già visto quel che si può combinare uscendo dalle foreste, saremmo pazzi a farlo di nuovo.
Note
(1) È nella memoria collettiva dell'occidente ciò che successe nella cosiddetta “Isola di Pasqua” (in lingua nativa Rapa Nui). Allo sbarco sull'isola dei primi colonizzatori polinesiani, intorno all'800-900 d.C., l'isola si presentava come un'immensa foresta di palme. Fino al 1200 d.C. la popolazione rimase numericamente modesta e in equilibrio con le risorse naturali presenti. In seguito però nacque da parte degli abitanti la necessità di realizzare delle statue gigantesche, il cui sistema di trasporto richiedeva notevoli quantità di legname. Cominciò pertanto un importante lavoro di disboscamento dell'isola, che fu ulteriormente intensificato dopo il sensibile aumento della popolazione dovuto a nuovi sbarchi. Verso il 1400 d.C. la popolazione toccò i 15-20.000 abitanti e l'attività di abbattimento degli alberi raggiunse il picco. La riduzione della risorsa forestale provocò un inasprimento dei rapporti sociali interni, che sfociarono in violente guerre civili. Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull'isola, Jakob Roggeveen, nel 1722, al tempo del suo arrivo l'isola si presentava brulla e priva di alberi ad alto fusto.
(2) In tal senso i manuali di riferimento sono stati i seguenti: Elisabetta Clemente e Rossella Danieli, La prospettiva antropologica, ed. Paravia-Pearson, Milano-Torino 2016; Barbara Miller, Antropologia culturale, ed. Pearson, Milano-Torino 2014; Cecilia Pennacini, Antropologia culturale, Etnologia, Genere, ed. McGraw-Hill Create, Torino 2016.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube